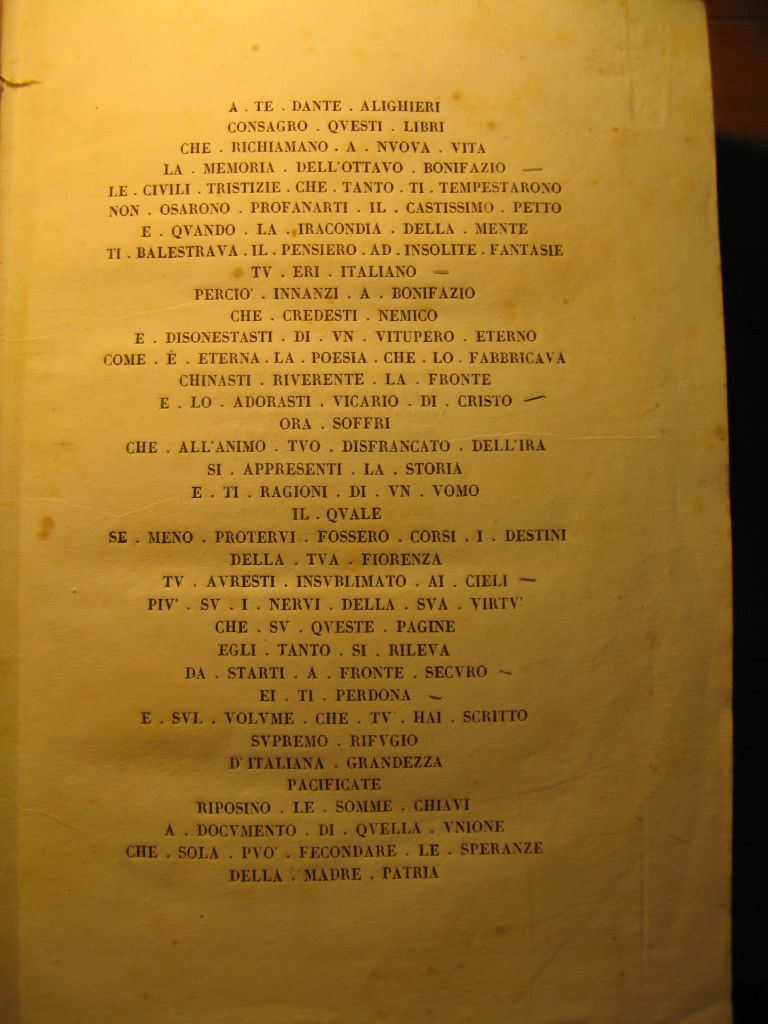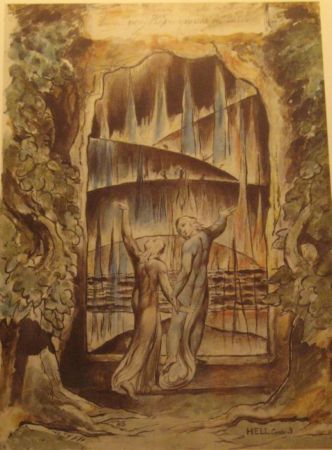“La figura di Bonifacio non è mai presentata direttamente nell’opera dantesca, e soprattutto, ovviamente, nella Commedia, data la collocazione temporale del viaggio di Dante, vivente quindi il Caetani. Ciò contribuisce senza dubbio a rendere più ambigua, tenebrosa, sinistra l’immagine di lui, esecrata da un papa, da un frate, dal trisavolo del poeta, infine dallo stesso s. Pietro, in una serie di obliqui scorci di ritratto e d’invettiva dai quali il nemico è sentito in tutta la sua proterva e nefanda possanza … il papa appare nella luce di un corruttore di coscienze oltre che di un capo temporale spietato …”.
Così nell’Enciclopedia Dantesca si legge in un’aggiunta redazionale alla voce Bonifacio VIII di Ernesto Sestan, e le fosche tinte, degne di un personaggio byroniano, delineate con l’autorità di Francesco D’Ovidio, si fanno nere con una citazione di Ettore Bonora:
“… e capiamo perché Dante ha così ingrandito la figura del pontefice: non per farne un personaggio capace di quei sentimenti di rivolta che, anche in chi ha intrapreso la via del male, possono rivelare qualche cosa di altamente umano. In Bonifazio la vita morale è così ottusa che egli non appare nemmeno sfiorato dal pensiero che il peccato esista; il suo è un cinismo che disumana, e se, a questo punto, un altro passo della Commedia torna alla mente del lettore, sono i versi del Paradiso (xxix 118-120) nei quali dentro il cappuccio dei predicatori di ciance che ingannano il volgo dei fedeli s’intravede la figura sinistra del demonio” [**].
Seguendo in controluce l’esegesi della Lectura super Apocalipsim [LSA] di Pietro di Giovanni Olivi, alla quale i versi della Commedia rinviano con procedimento di arte della memoria, vestendo la dottrina teologica con exempla contemporanei – rileggendo cioè i versi secondo i “sensi mistici” come avrebbe potuto intenderli uno Spirituale conoscitore della Lectura –, potremo verificare – al di là del senso letterale – gli intendimenti più profondi del poeta nei confronti di Bonifacio VIII. Come abbiamo più volte ribadito nei saggi presentati su questo sito e nelle pubblicazioni a stampa [1], l’intertestualità che accompagnò l’intera stesura del “poema sacro”, con un procedimento analogico su singole parti della Lectura assimilabile alle “distinctiones” dei predicatori, costituisce anche un eccezionale esempio di arte della memoria, per cui le singole parole si leggono, nel contesto dei versi, come segni che conducono all’altro testo dottrinale consentendo così il passaggio dal senso letterale, che è per tutti, a quelli mistici in esso racchiusi, riservati ai depositari della chiave di tanto alta crittografia. Così, come per ogni personaggio della Commedia, anche per Bonifacio VIII è possibile risalire, lì dove la figura del Caetani viene toccata, alle parti dottrinali dell’esegesi apocalittica oliviana che gli sono appropriate. Bisogna tener conto che questi significati avrebbero dovuto essere compresi da un pubblico di ecclesiastici riformatori e predicatori in volgare; essi pertanto costituiscono come un diario intimo di Dante al quale egli affidò la sua visione della Chiesa. Partendo dalla bolgia dei simoniaci (Inf. XIX), dove l’immagine di Bonifacio viene esecrata da Niccolò III, passeremo, percorrendo i labirinti del significante, all’esecrazione per bocca di Guido da Montefeltro, uomo d’arme inutilmente cintosi in tarda età della corda francescana (Inf. XXVII). Vedremo poi se le parole con cui Ugo Capeto condanna l’attentato di Anagni (Purg. XX) siano da configurare come una debita reverentia verso il Vicario di Cristo e quindi come un mutamento della posizione di Dante nei confronti del Caetani. Esamineremo, infine, la condanna emessa da san Pietro (Par. XXVII) e come da Cacciaguida prima (Par. XVII) e dal principe degli Apostoli poi (Par. XXVII) Dante venga insignito delle prerogative di “nuovo Giovanni”, inviato nuovamente a predicare e a convertire il mondo con il suo poema, nuova Apocalisse. La sua idea di Chiesa, in effetti, era all’opposto di quella di Bonifacio VIII.
1. La Scrittura che non erra (Inf. XIX). 1.1. L’infallibile regola di Cristo. 1.2. I moderni dottori della Chiesa contro le nuove eresie. 1.3. Il fiammeggiante amore fraterno. 2. La donna che siede sulla bestia scarlatta (Inf. XIX, XXVII). 3. “Un tempo, due tempi e la metà di un tempo” (Inf. XIX). 4. “Lo principe d’i novi Farisei”. 4.1. I Gentili senza pace (Inf. XXVII, Purg. XIV). 4.2. L’agone del dubbio, ovvero il moderno martirio (Inf. V, XXVII). 5. La corona di Francia: un nido di locuste (Purg. XX). 6. La sede vacante (Par. XXVII). 7. Il nuovo Giovanni (Par. XVII, XXVII). 8. Una debita reverentia per le somme chiavi? (Inf. XIX, Purg. XIX).
Tabelle: Tab. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI


1. La Scrittura che non erra
(Inf. XIX)
1.1. L’infallibile regola di Cristo
All’apertura del terzo sigillo (seconda visione apocalittica), mostratagli dal terzo animale, quello che ha il volto di uomo, Giovanni vede un cavallo nero, che designa l’esercito degli eretici, oscuro per fallace astuzia e fatto nero per gli errori contrari alla luce di Cristo (LSA, Ap 6, 5). Colui che siede sopra di esso – designante gli imperatori o i vescovi ariani – ha in mano una bilancia. La stadera misura la quantità dei pesi, e qui sta a indicare la misurazione degli articoli di fede. Quando la misurazione avviene secondo la retta e infallibile regola di Cristo, allora il peso è giusto, come si dice nei Proverbi: “Il peso e la bilancia sono i giudizi del Signore” (Pro 16, 11) e nell’Ecclesiastico: “Le parole dei prudenti sono pesate sulla bilancia” (Ecli 21, 28). Quando invece la misurazione si fonda sull’errore e sul falso e torto accoglimento della Scrittura, allora la stadera è dolosa, e a questa si riferiscono i Proverbi: “La bilancia falsa è in abominio al Signore” (Pro 11, 1), i Salmi: “Sono una menzogna tutti gli uomini sulla bilancia” (Ps 61, 10) e Michea: “Potrò giustificare le false bilance e la borsa dei pesi falsi?” (Mic 6, 11).
Nella terza bolgia, le gambe dei simoniaci confitti a capo in giù nei fori della pietra guizzano così forte, per la fiamma che si muove sulle piante dei piedi, “che spezzate averien ritorte e strambe”, cioè legami attorcigliati o funi (Inf. XIX, 25-27). Dante domanda chi sia colui che si cruccia guizzando più degli altri, e Virgilio risponde che, una volta portato là giù nel fondo della bolgia, “da lui” saprà “di sé e de’ suoi torti” (ibid., 36). Invitata dal poeta a parlare, l’anima confitta di Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini, papa dal 1277 al 1280), che erroneamente crede sia arrivato Bonifacio VIII a prendere il suo posto, grida proseguendo le variazioni del tema della retta e torta misurazione della Scrittura: «Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto, / se’ tu già costì ritto, Bonifazio? / Di parecchi anni mi mentì lo scritto”» (ibid., 52-54). Lo stare “ritto”, che nell’esegesi scritturale corrisponde al giusto peso che misura secondo la retta e infallibile regola di Cristo (ma “lo scritto” ha mentito al papa Orsini), si contrappone alla pena comminata per i “torti”, e il tema viene ripreso poco dopo dallo spirito che, chiarito l’equivoco in seguito alla risposta di Dante imposta da Virgilio, “tutti storse i piedi” (ibid., 64). Nella bolgia è punita la borsa (saccellus) dei pesi falsi di cui dice il profeta Michea (Mic 6, 11), come confermato da Niccolò III: “che sù l’avere e qui me misi in borsa” (Inf. XIX, 72).
Lo “scritto” menzognero non è solo, come si è soliti interpretare, il libro del futuro nel quale i dannati leggono l’avvenire, oppure un vaticinio anti-Orsini come Genus nequam [2]. Queste probabili conoscenze di Dante sono ‘armate’ da ben altra corazza. I simoniaci – usando l’ “intorta statera” tenuta in mano dagli eresiarchi designati dal cavallo nero in apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5) – hanno male pesato la regola evangelica, quella osservata da Cristo, imposta agli apostoli e scritta nel Vangelo. Questa regola o scritto è quella francescana, come solennemente attestato dalla Lectura nell’esordio dell’esegesi relativa all’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12, passo simmetrico ad Ap 6, 5 per il comune riferimento alla vera scrittura o regola di Cristo). L’angelo del sesto sigillo, che sale da oriente e che ha il segno del Dio vivente (Ap 7, 2), viene infatti identificato con Francesco piagato dalle stimmate, totalmente trasformato in Cristo e a lui configurato, secondo una tradizione che Olivi ascoltò da san Bonaventura predicante nel 1266 a Parigi nel capitolo generale dei Frati minori. Che la regola di Francesco sia quella veramente evangelica risulta da inconfutabili testimonianze dei libri del Vangelo e delle altre sante scritture. Ne consegue che l’imporre agli apostoli la regola evangelica, come detto ad Ap 6, 12, si trasforma nell’imporre di Virgilio a Dante la risposta a Niccolò III che ripristina la verità dello scritto: «Allor Virgilio disse: “Dilli tosto: / ‘Non son colui, non son colui che credi’ ”; / e io rispuosi come a me fu imposto» (Inf. XIX, 61-63; cfr. tab. XIV). Più avanti sarà Dante a rispondere all’Orsini “a questo metro” (ibid., 89), con la giusta misura cantandogli “cotai note” (ibid., 118).
Nella terza età del mondo (prefigurazione del terzo stato della Chiesa), a causa della superba torre di Babele, le lingue furono confuse e divise e la lingua prima e retta rimase nella casa di Eber e degli Ebrei, e poi, mentre le altre lingue precipitavano nell’idolatria diabolica, la fede e il culto di un solo vero Dio rimase nella casa di Abramo. Così nel terzo stato della Chiesa, a causa della superbia di molti fedeli, la lingua e la confessione della sola vera fede di Cristo venne divisa e confusa in più eresie, mentre la prima e vera lingua e confessione rimase nella casa di Pietro (LSA, prologo, notabile XIII). Rispondendo a Niccolò III, il poeta prorompe in “parole … gravi” contro i papi simoniaci: il cantare tali note al pontefice, che fu in vita “veramente … figliuol de l’orsa”, è “suon de le parole vere espresse” (Inf. XIX, 70, 103, 123), confessione dell’unica fede di Cristo nella lingua vera che è quella che rimase nella casa di Eber, poi in quella di Abramo, e che avrebbe dovuto essere custodita nella casa romana di Pietro. È proprio dei dottori del terzo stato della Chiesa suonare la tromba (LSA, prologo, notabile I), e ai simoniaci che stanno nella terza bolgia il poeta dichiara che “or convien che per voi suoni la tromba” (Inf. XIX, 1-6). È probabile che alla stessa tematica appartengano l’atteggiarsi di Dante, piegato col capo sul dannato confitto come palo nel foro della pietra, a frate confessore del “perfido assessin” [3] e il suo restare ‘scornato’, cioè confuso, alle prime incomprensibili parole di Niccolò che l’ha scambiato per Bonifacio VIII arrivato a prendere il suo posto prima del tempo (ibid., 49-51, 58-60). “Scornati” è infatti termine singolarmente consonante con l’interpretazione (“dividens cornua”) del nome (Pergamo) della terza chiesa d’Asia, la chiesa dello stato dei dottori che confondono, appunto, l’eresia.
(Tab. I)
[avvertenza]
1.2. I moderni dottori della Chiesa contro le nuove eresie
Per Dante, come per Tommaso d’Aquino (Summa theologiae II/2, qu. 11, a. 2), l’eresia consiste in un’errata interpretazione della Scrittura. Ciò è ben verificabile in luoghi dove l’eresia non è specificamente punita.
Nella bolgia dei simoniaci, Dante sta di fronte a Niccolò III (il quale crede trattarsi di Bonifacio VIII venuto a prendere il suo posto nel foro della pietra) come sta un dottore della Chiesa, che possiede la verità evangelica scritta e imposta da Cristo, di fronte a un eresiarca. Ancor più, parla a un pontefice romano in quanto depositario di quella “prima et vera lingua et confessio fidei” che avrebbe dovuto essere custodita “in domo Petri”. Virgilio partecipa di quest’alto patrimonio nell’imporre al discepolo la retta risposta, come Cristo impose ai discepoli la regola evangelica.
È proprio del terzo stato della Chiesa il tema del tagliare, dividere, rompere o scindere: si rinviene in diverse zone della Commedia, quasi fosse un motivo dall’andamento interno, sotterraneo e insieme ciclico. Cerbero (Inf. VI), nel graffiare, scuoiare e squartare i peccatori, è figura che anticipa il colloquio tra Dante e Ciacco sulle divisioni politiche fiorentine. Nella prima cantica, la tematica torna in evidenza nella selva dei suicidi, la cui anima feroce si è divisa dal corpo (Inf. XIII); nella terza bolgia dei simoniaci, che hanno straziato “la bella donna”, cioè la Chiesa (Inf. XIX); nella nona dei seminatori di scandalo e di scisma, dove sta anche il Mosca che fu causa delle discordie fiorentine (Inf. XXVIII); in Lucifero che con ognuna delle sue tre bocche “dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla”, cioè Giuda, il traditore di Cristo, e Bruto e Cassio, i traditori del volere di Roma (Inf. XXXIV, 55-67).
Questo dividere l’uomo, nei suoi vari aspetti, da Dio e dalla sua giustizia è assimilabile alle antiche eresie, che divisero l’umanità di Dio dalla sua divinità, degradando la prima o confondendola con la seconda, come quelle di Ario e di Sabellio, i quali, secondo quanto dice Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole, “furon come spade a le Scritture / in render torti li diritti volti” (Par. XIII, 127-129). Posizione propria della Summa theologiae (I, qu. 31, a. 2), ma ripresa dall’Olivi nell’esegesi della terza chiesa d’Asia (Ap 2, 12) e dell’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5), dove sono presenti i temi, assenti nell’Aquinate, della spada e del retto o torto pesare la Scrittura.
Nei celebri versi di Purg. XVI, 106-114, relativi ai “due soli” di Roma, il periodo storico rimpianto da Marco Lombardo, in cui il “pasturale” (il potere spirituale) non aveva spento e congiunto a sé la “spada” (il potere temporale), corrisponde alla concorrenza nel tempo di due stati distinti, il terzo (i dottori, che razionalmente confutano le eresie con la spada e danno le leggi) e il quarto (gli anacoreti, che per la santa e divina vita fondata sull’affetto sono dediti al pastus eucaristico), nel periodo in cui (da Costantino a Giustiniano) entrambi erano due stati di sapienza solare e concorrevano per due diverse strade a infiammare il meriggio dell’universo, prima che nel quinto stato i beni temporali invadessero la Chiesa trasformandola quasi in una nuova Babilonia. Quell’improprio congiungere da parte del potere spirituale è eresia assimilabile a quella di Ario, che divise il Figlio dal Padre ritenendolo non consustanziale, a livello di creatura, o, ancor meglio, a quella di Sabellio, che unificò il Padre e il Figlio nella stessa persona.
L’ordine dei dottori del terzo stato, cui spetta suonare la tromba per antonomasia, predicò e insegnò nel mondo già convertito da Costantino. Quanto male seguì al suono della terza tromba (terza visione apocalittica) viene mostrato con queste parole: “e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì la terza parte dei fiumi e le fonti delle acque” (Ap 8, 10). Al tempo di Costantino, Ario, presbitero di Alessandria, anch’egli “grande stella e ardente” per la dottrina scolastica ed ecclesiastica in cui eccelleva, inflato dagli errori del suo maestro Origene, insegnò che il Figlio di Dio non è consustanziale o uguale al Padre bensì una pura creatura. Dalla sua dottrina vennero contaminati non solo molti laici, ma anche grandi chierici, vescovi, religiosi e molti imperatori costantinopolitani nonché i re e i regni dei Goti, dei Vandali e dei Longobardi.
Origene e Ario caddero così sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti. La prima parte della dottrina è infatti la lettera della Scrittura, propria dei semplici e inferiori, siano dottori o discepoli; la seconda consiste nell’alta e profonda sapienza mistica di Cristo che compete solo ai perfetti; la terza è la dottrina erronea.
La caduta di Ario fu in parte concomitante con la predicazione dei dottori, in parte la precedette, in parte fu da essa provocata e aumentata. Fu concomitante perché Ario errò e insegnò l’errore solo a causa della propria temerarietà e presunzione. La precedette in quanto Origene, che storicamente visse prima di Costantino e dunque nel secondo stato della Chiesa, fu fonte e seminatore dell’errore di Ario. L’errore prestò ai dottori l’occasione di cercare in modo più sottile la verità della fede per poterlo impugnare e condannare, e in tal senso precedette la tubicinazione magistrale.
La retta predicazione dei santi dottori fu pure causa dell’errore perché Ario, volendo superbamente imitare le loro sottili ricerche e conseguire con ambizione autorità e fama di magistero, per degno giudizio di Dio cadde in errore e ne divenne maestro. La successiva impugnazione e condanna lo fece indurire e ancor più ostinare nel suo maligno errore, che difese e diffuse insieme ai suoi discepoli.
L’ostinarsi nell’errore di fronte alla condanna dei dottori si trasforma nello scalciare di Niccolò III con entrambi i piedi accesi, morso dall’ira o dalla coscienza mentre Dante lo rimprovera della sua simonia (Inf. XIX, 118-120). L’errore del papa Orsini ebbe inoltre dei predecessori, come Ario fu preceduto da Origene; costoro sono precipitati sotto il suo capo, “per le fessure de la pietra piatti”, lì dove lui stesso cadrà quando verrà Bonifacio VIII a prendere il suo posto (ibid., 73-75). Come Ario errò e insegnò l’errore solo a causa della propria temerarietà e presunzione, così Niccolò III fu causa della sua dannazione: “e veramente fui figliuol de l’orsa, / cupido sì per avanzar li orsatti, / che sù l’avere e qui me misi in borsa” (ibid., 70-72).
Come sempre avviene nel rapporto fra Commedia e Lectura super Apocalipsim, un medesimo luogo della seconda conduce, tramite la compresenza degli elementi semantici, a più luoghi della prima; cioè la medesima esegesi di un punto del commento apocalittico è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del “poema sacro” che ad essa rinviano. Così il tema dell’imitare le sottigliezze dei maestri famosi che precedettero è dal poeta appropriato con ironia alla misera patria sua: “Atene e Lacedemona, che fenno / l’antiche leggi e furon sì civili (la legge data dai dottori è uno dei temi fondamentali del terzo stato)[4], / fecero al viver bene un picciol cenno / verso di te, che fai tanto sottili / provedimenti, ch’a mezzo novembre / non giugne quel che tu d’ottobre fili” (Purg. VI, 139-144). Alla cittadinanza, che muta aspetto secondo la fazione che vi predomina e manda le altre in esilio, bene si applica il motivo delle perpetue rivoluzioni origeniste e del passare dell’anima da un corpo all’altro: “Quante volte, del tempo che rimembre, / legge, moneta, officio e costume / hai tu mutato, e rinovate membre!” (ibid., 145-147).
Una variazione del medesimo tema è nel parlare di Giustiniano, il quale spiega che nel cielo di Mercurio si presentano le anime di coloro che sono stati attivi “perché onore e fama li succeda”, desiderio che erra per difetto del vero amore (Par. VI, 112-117).
“E il nome della stella è assenzio” (Ap 8, 11), poiché dopo la caduta quella stella fu amarissima come l’assenzio e per questo restò famosa. “E molti uomini morirono nelle acque”, a causa cioè dell’erronea esposizione della Scrittura molti persero la vita della fede e della grazia per cadere in peccato mortale e nella morte eterna. Qui non parla di “terza parte degli uomini”, ma dice “molti uomini” per indicare che in tutto il mondo furono innumerevoli coloro che morirono a causa dell’eresia di Ario e degli altri eresiarchi, che in un primo tempo erano apparsi grandi stelle ardenti in cielo.
Il tema del morire nelle acque della fede erronea trova la sua metamorfosi in un episodio della propria biografia che Dante racconta in Inf. XIX, 16-21, nel canto dei simoniaci che stanno nella terza bolgia, il cui ordito mostra in più punti la prevalenza di fili del terzo stato, cioè di parole-chiave che indirizzano la memoria del consapevole lettore verso l’esegesi apocalittica oliviana relativa a quello stato della storia della Chiesa. I fori della pietra in cui sono confitti i peccatori, dice il poeta, “non mi parean men ampi né maggiori / che que’ che son nel mio bel San Giovanni, / fatti per loco d’i battezzatori; / l’un de li quali, ancor non è molt’ anni, / rupp’ io per un che dentro v’annegava”. Dante, nel rompere la pietra del pozzetto battesimale per salvare dalle acque la persona che sta annegando, assume su di sé la veste del dottore che possiede la rumphea (Ap 2, 12), cioè la spada acuta da entrambi i lati, ed è terribile confutatore dell’erronea dottrina che conduce alla morte molti uomini. Quello che è un episodio autobiografico anticipa in tal modo le gravi parole di condanna usate nei confronti del simoniaco Niccolò III il quale, nel mal ponderare la regola evangelica, ha dato della Scrittura un’interpretazione mendace e distorta, assimilabile all’eresia.
I “molti uomini” morti per l’errore sono ricordati due volte da Virgilio: la prima a proposito delle arche degli eresiarchi, nel sesto cerchio loro dedicato – “e molto / più che non credi son le tombe carche” (Inf. IX, 127-129) -; la seconda con le turbate parole dette in Purg. III, 34-45 nell’invitare l’ “umana gente” a stare “al quia”, a non desiderare cioè di conoscere con la ragione le cose trascendenti, come fecero invece coloro ai quali questo desiderio inappagato è dato come pena eterna nel Limbo – “io dico d’Aristotile e di Plato / e di molt’ altri”. Ciò non significa, naturalmente, che Dante non distingua fra eretici ed erranti (si ricordi l’ “errante” Averroè a Purg. XXV, 61-66), ma che i motivi dei primi invadono parzialmente l’ambito dei secondi.
(Tab. II)
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 10 (IIIa visio, IIIa tuba)] Unus autem de primis corruptoribus eius fuit Origenes, primo quidem vita et sapientia preclarus et celebris et maxime auctoritatis in tota ecclesia sicut “stella magna” et “ardens” (Ap 8, 10) ad zelum animarum et eruditionis earum et etiam ad martirium “tamquam facula”, prout patet ex libro ecclesiastice ystorie et etiam ex ystoria tripartita, in tantum ut se ipsum castrasse feratur ut caste et secure posset docere virgines et ob zelum apostolice vite nudis pedibus ambulasse. Errores tamen eius, ante impium dogma Arrii, fuerunt in eius libris sepulti et paucis noti, quorum magnam partem recitat Ieronimus in epistula ad Avitum quantum spectat ad duos libros eius qui dicuntur ‘peri archon’, id est ‘de principiis’. In quibus dicit Filium et Spiritum Sanctum esse minores Patre et substantialiter ab eo diversos et ab eo creatos. Negat etiam veram resurrectionem humane carnis, nec unionem anime ad corpus dicit esse naturalem sed potius penalem. Ponit enim animas substantialiter non differre ab angelis, et omnes cum eis simul fuisse creatas ante mundi corporalis creationem, quem ob solam carceralem punitionem spirituum peccantium dicit esse creatum. Ponit enim animas peccasse antequam corporibus unirentur; ponit etiam eas de uno corpore in aliud, puta de corpore humano in corpora bestiarum, revolvi et postmodum expurgari ab eis. Ponit etiam nullum in statu glorie esse immobiliter sed exinde per culpam cadere et in corpora iterum recludi, nec aliquem eternaliter in inferno esse sed exinde per penitentiam educi gradatim usque ad statum glorie. Has autem revolutiones dicit esse infinities per futura secula fiendas. Dicit etiam Christum non solum occidi in terra pro hominibus sed etiam in aere pro demonibus.
|
|
Et nota quod casus Arrii fuit partim incidentaliter concomitans tubicinatione<m> sanctorum doctorum tertii status, et partim precedens et partim per accidens causatus et augmentatus ab ipsa.
|
Inf. XIX, 70-75, 118-120:concomitanse veramente fui figliuol de l’orsa,
|
1.3. Il fiammeggiante amore fraterno
Appartengono al sesto stato della Chiesa, quello più conforme a Cristo, alla sua vita e alla sua evangelica regola, il fiammeggiare dello Spirito e l’unzione spirituale (Ap 3, 7: sesta chiesa). Questa è propria anche dell’estremo sacramento, che conviene alla soave pace del settimo e ultimo stato (LSA, prologo, notabile XIII). La sesta chiesa (Filadelfia) viene interpretata, oltre che “colei che salva l’eredità”, anche come “amore fraterno”, verificandosi in essa quanto scritto nel Cantico dei Cantici (Cn 8, 1-2) sulla sposa che desidera l’amato come un fratello che succhia il seno della madre, da poter baciare e introdurre nella casa materna (Ap 3, 7). Questi temi sono appropriati in modo sarcastico a Niccolò III, “colui … che si cruccia / guizzando più che li altri suoi consorti, / … e cui più roggia fiamma succia”, più rossa di quella che accende i piedi degli altri simoniaci, la quale, “qual suole il fiammeggiar de le cose unte / muoversi pur su per la strema buccia”, si muove “dai calcagni a le punte” (Inf. XIX, 28-33). L’estrema unzione toglie la febbre (prologo, notabile XIII, con riferimento alla guarigione in Giovanni 4, 52), ma Bonifacio VIII (del quale Niccolò III è prefigurazione) è affetto dalla “superba febbre” di distruggere i Colonna, come afferma Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 97).
I temi dell’ “amor fratris” si rinvengono in altri luoghi del poema, come nelle parole di Beatrice a Par. VII, 58-60 e nel duetto fra Stazio e Virgilio (Purg. XXI, 130-136).
A Niccolò III è ancora appropriato il tema della Chiesa della fine del quinto stato: “a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta” (prologo, notabile VII). Il tema tornerà con i due falsari “dal capo al piè di schianze macolati” (Inf. XXIX, 75) e con la “puttana” flagellata dal gigante “dal capo infin le piante” (Purg. XXXII, 156).
(Tab. III)
[LSA, prologus, Notabile VI] Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix visionum proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. Nunc tamen in generali breviter demonstretur. Constat enim quod totum imperium potestatis ecclesiastice (I), ac sacerdotale sacrificium martirizationis sue (II), et sapientiale magisterium sue doctrine (III), ac altivolum supercilium vite anachoritice (IV), et condescensivum contubernium vite domestice seu cenobitice (V), et nuptiale connubium seu familiare vinculum singularis amicitie (VI), ac beatificum convivium divine glorie (VII), sunt in Christo exemplariter et etiam contentive et effective. Contentive quidem, tum quia ab eterno est presens omnibus futuris, tum quia virtus, per quam unumquodque in suo tempore efficit et conservat et continet, est sibi essentialis et eternaliter presens.[LSA, prologus, Notabile VII; V status] Ad istum autem reditum valde, quamvis per accidens, cooperabitur non solum multiplex imperfectio in possessione et dispensatione temporalium ecclesie in pluribus comprobata, sed etiam multiplex enormitas superbie et luxurie et symoniarum et causidicationum et litigiorum et fraudum et rapinarum ex ipsis occasionaliter accepta, ex quibus circa finem quinti temporis a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta.[LSA, prologus, Notabile XIII; VII status] Unctio autem extrema congruit suavitati et paci septimi et ultimi status, in quo verificabitur illud de filio reguli: “Heri hora septima reliquit eum febris” (Jo 4, 52).[LSA, cap. III, Ap 3, 7 (VIa ecclesia)] […] sic in tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum et ut tripudium spiritualium iubilationum et iocunditatum, per que non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris. […] Unde congrue nomen huius sexte ecclesie, scilicet Philadelphia, non solum interpretatur salvans hereditatem, prout tactum est supra, sed etiam amor fratris, prout dicit Ricardus. Nam in sexto statu, qui est tertius generalis status populi Dei, anthonomasice complebitur illud quod in tertia parte Cantici Canticorum dicit sponsa ad sponsum (Cn 8, 1-2): “Quis michi det te fratrem meum suggentem ubera matris mee, ut inveniam te solum foris et <de>obsculer? Apprehendam te et ducam in domum matris mee”, scilicet sinagoge tunc temporis convertende. |
|
Inf. XIX, 28-33:Qual suole il fiammeggiar de le cose unte
|
Inf. XXIX, 73-75:Io vidi due sedere a sé poggiati,
|
2. La donna che siede sulla bestia scarlatta (Inf. XIX, XXVII)
Papa Caetani viene nominato solo nella bolgia dei simoniaci – “Bonifazio”, un nome, come si vedrà, altamente significante per sarcasmo -; l’immagine che doveva presentarsi al lettore spirituale era di un papa errante, se non eretico, nell’interpretazione del Vangelo come lo erano stati i suoi predecessori simoniaci. Questa moderna forma di eresia veniva validamente confutata dai nuovi dottori della Chiesa, impersonati da Dante e dal suo maestro Virgilio, depositari della vera fede e regola che Cristo lasciò a san Pietro. Ma, oltre a quelle che rinviano all’esegesi del terzo stato della storia della Chiesa, Inf. XIX contiene parole-chiave che indirizzano la memoria del lettore ad altri luoghi della vastissima dottrina apocalittica oliviana. Ad esempio al capitolo XVII, dove a Giovanni viene mostrata la dannazione della grande meretrice.
La meretrice designa la gente e l’impero dei Romani sia nello stato del paganesimo sia in quello cristiano, durante il quale colpevolmente fornicò molto con questo mondo. Viene chiamata “grande meretrice” (Ap 17, 1) poiché venendo meno al culto fedele, al sincero amore e ai piaceri del suo sposo aderisce alle ricchezze e alle delizie di questo mondo e al diavolo, come pure ai re, ai magnati, ai prelati e a quanti amano questo secolo. Inoltre, nello stato del paganesimo, adorò falsi dèi quasi fossero suoi mariti adulterini (gli “dèi falsi e bugiardi” al tempo dei quali visse Virgilio, Inf. I, 71-72). Si dice che “siede sopra molte acque” poiché si fonda e domina sopra molti popoli, i quali fluiscono come l’acqua. Più avanti, ad Ap 17, 15, viene spiegato a Giovanni che “le acque”, cioè l’acqua che cade, “che vedesti dove siede la meretrice”, sopra le quali domina, “sono i popoli e le genti e le lingue”, in quanto come le acque labili scorrono giù, così i popoli passano morendo e ondeggiano come acque nei loro costumi e passioni. Con la prostituta “fornicarono i re della terra” (Ap 17, 2), da intendere sia secolari che ecclesiastici, i quali si unirono ad essa per partecipare della sua gloria carnale. “E coloro che abitano la terra”, cioè gli amanti delle cose terrene, “si inebriarono del vino della sua prostituzione”, ossia dell’abominevole gloria della sua prostituzione. L’angelo conduce quindi Giovanni “nel deserto” della contemplazione e del disprezzo delle cose terrene e “in spirito”, per mezzo cioè di una visione spirituale (Ap 17, 3). Secondo Gioacchino da Fiore, sono due le cose che non permettono all’uomo di vedere la rovina dei figli di questo mondo: la sollecitudine delle cose terrene e il mortifero senso della lettera. Conviene pertanto abbandonare le prime e trarsi all’intelligenza spirituale e al desiderio delle cose celesti.
Esplicito il riferimento all’Apocalisse in Inf. XIX, 106-108, nelle dure parole rivolte dal poeta al simoniaco Niccolò III: “Di voi pastor s’accorse il Vangelista, / quando colei che siede sopra l’acque / puttaneggiar coi regi a lui fu vista”. La terzina cuce rinvii ad Ap 17, 1 (“que sedet super aquas multas”), 17, 2 (“cum qua fornicati sunt reges terre”) e ancora 17, 1/3 (il vedere in spirito di Giovanni). Di per sé, come sostenne polemicamente Michele Barbi, Dante avrebbe potuto fare a meno del commento dell’Olivi e fondarsi sul solo testo scritturale. Ma alla Lectura conduce subito il tema dell’adulterio dallo sposo, suonato dalla tromba all’inizio del canto contro i miseri seguaci di Simon Mago “che le cose di Dio, che di bontate / deon essere spose, e voi rapaci / per oro e per argento avolterate” (Inf. XIX, 1-4). L’unirsi dei carnali alla prostituta per molte colpe (Ap 17, 2) corrisponde all’ammogliarsi della lupa con molti animali (Inf. I, 100).
Gli ornamenti della donna, che siede sulla bestia dalle sette teste e dalle dieci corna (Ap 17, 3), possono essere anche intesi come i doni intellettuali che la Chiesa carnale scialacqua con la sua superbia, come rimproverato da Dio in Ezechiele 16, 10-19 alla Sinagoga (e quindi alla Chiesa in essa prefigurata) per avere fatto immagini idolatre delle vesti d’oro e d’argento che le aveva dato e per avere offerto a quelle ogni ornamento e ricchezza precedentemente avuti (Ap 17, 3-6). È quanto Dante rimprovera a Niccolò III, nella bolgia dei simoniaci che attristano il mondo con la loro avarizia idolatra: “Fatto v’avete dio d’oro e d’argento” (Inf. XIX, 112-114). Avarizia e idolatria sono congiunte nella lettera di san Paolo agli Efesini (5, 5: “avarus, quod est idolorum servitus”); contro gli avari idolatri parole gravi e interrotte per l’ira vengono scritte ad Ap 9, 20-21 (come Dante interrompe il suo rimprovero a Niccolò III perché, se non fosse per “la reverenza de le somme chiavi”, userebbe “parole ancor più gravi”; Inf. XIX, 100-103). La Chiesa, la “bella donna”, fu “quella che con le sette teste nacque (fu cioè dotata dei doni dello Spirito), / e da le diece corna ebbe argomento” finché ebbe mariti virtuosi, cioè pontefici ligi al decalogo (ibid., 109-111; il rapporto fra “corna” e “argomento” è presente, in senso negativo, ad Ap 13, 11 a proposito della bestia che sale dalla terra). Il motivo dei doni dissipati si riverbera sulla condanna della donazione di Costantino, “quella dote / che da te prese il primo ricco patre” (ibid., 116-117), dove risuonano parzialmente i temi dell’esegesi della terza tromba (Ap 8, 10).
(Tab. IV)
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 1-3 (VIa visio)] Et nota quod hec mulier stat hic simul pro romana gente et imperio tam prout fuit quondam in statu paganismi quam prout fuit postmodum in fide Christi, multis tamen criminibus cum hoc mundo fornicata. Vocatur ergo ‘meretrix magna’, quia a fideli cultu et sincero amore et deliciis Christi sponsi sui recedens adheret huic mundo et divitiis et deliciis eius et diabolo propter ista, et etiam regibus et magnatis et prelatis et omnibus aliis amatoribus huius mundi, et etiam quia quondam per fornicationem idolatrie coluit falsos deos quasi viros suos seu potius adulteros. Dicitur etiam quod “sedet super aquas multas”, id est principatur seu fundatur super populos multos fluxibiles sicut aque. Infra enim exponitur quod “aque” iste “sunt populi et gentes” (Ap 17, 15). Sequitur (Ap 17, 2): “Cum qua fornicati sunt reges terre”, scilicet tam seculares quam ecclesiastici, qui ut eius carnales glorias et delicias et divitias participent, sibi carnaliter et cum multis criminibus adherent. “Et inebriati sunt qui inhabitant terram”, id est terrena amantes, “de vino prostitutionis eius”, id est de fornicaria et abhominanda gloria eius. “Et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam” (Ap 17, 3), id est sanguine et colore coccineo tinctam et rubricatam. […] “Habentem capita septem et cornua decem”. […] Nota quod per predicta ornamenta possunt mistice intelligi omnia intellectualia dona quibus carnalis ecclesia abutitur in superbiam, iuxta quod et Ezechielis XVI° improperat Deus sinagoge et ecclesie per eam figurate quod de vestimentis et auro et argento, que dederat ei, fecit sibi excelsa et imagines idolorum, et omnia ornamenta et divitias quas sibi dederat obtulit eis (Ez 16, 10-19).[LSA, cap. XIII, Ap 13, 11 (IVa visio, VIum prelium)] “Et habebat duo cornua similia Agni”, id est Christi. Per hec cornua intelliguntur hic primo apparens similitudo gemine perfectionis Christi, scilicet scientie et sanctitatis Christi et suorum electorum. Secundo, apparens fulcimentum seu argumentum ex scientia et auctoritate duorum testamentorum, que utique sunt Christi, id est de Christo et a Christo.[LSA, cap. IX, Ap 9, 20-21 (IIIa visio, VIa tuba)] Sequitur (Ap 9, 20): “Et ceteri homines, qui non sunt occisi in hiis plagis neque penitentiam egerunt de operibus manuum suarum, ut non adorent demonia et simulacra aurea et argentea et erea et lapidea et lignea, que neque videre possunt neque audire neque ambulare, (Ap 9, 21) et non egerunt penitentiam ab homicidiis suis neque a veneficiis suis neque a fornicatione sua neque a furtis suis”, supple, occidentur in flagellis adhuc venturis nisi penitentiam egerint. […] Nota autem quod per simulacra non videntur hic ad litteram designari illa que proprie vocantur idola et quorum adoratio proprie vocatur idolatria, sed potius quecumque erronea dogmata, que quis tunc adorat cum ea credit, veneratur et colit ac si fidem catholicam Dei. Per idola etiam intelliguntur quecumque temporalia que per avaritiam adorantur, unde ad Ephesios V° dicitur quod avaritia “est idolorum servitus” (Eph 5, 5). Locutus est autem sic defective in signum gravissime ire et comminationis penarum ineffabilium. Solent enim multum irati interrumpere verba pre nimio impetu et multitudine spiritus iracundi, et aliquando significamus nos graviora minari per huiusmodi defectivas locutiones. […] Nota etiam quod predictam idolatriam describit et exprob<r>at tripliciter. Nam primo vocat eam adorare opera manuum suarum, secundo adorare demonia, tertio adorare simulacra, id est imagines corporales aliis rebus opere manuum assimilatas. Omnis enim error et peccatum est opus nostrum, non autem Dei. Quecumque etiam nos falso attribuimus quibuscumque personis vel rebus, quas estimamus et veneramur quasi ut deos, sunt in solo falso actu vel habitu estimationis et affectionis nostre. Turpis autem cecitas est proprium opus adorare ut Deum suum, nec minus turpe est adorare malitiam demonum nostre saluti semper invidam et hostilem; sensibilior autem dementia est adorare corpora exteriora a nobis diversimode mobilia et fabricabilia.[LSA, cap. XXI, Ap 21, 8 (VIIa visio)] […] “idolatris”, in quibus et subintelliguntur avari secundum Apostolum (Eph 5, 5) […]. |
|
Inf. XIX, 1-6, 100-117:O Simon mago, o miseri seguaci
|
Inf. I, 71-72, 100-101:e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto
|
La donna che siede sopra la bestia scarlatta (Ap 17, 3), tinta di sangue, un tempo dominò e regnò sulle bestiali genti del mondo e ancora domina su molte di esse a lei suddite, e per questo viene detta sedere sopra la bestia. Questa bestia al tempo dei pagani e degli eretici fu macchiata del sangue dei martiri, ora è macchiata del sangue abominevole della sua lussuria, della strage delle anime e dell’empia persecuzione dello spirito e degli spirituali. È ornata, in modo studioso e pomposo, di adornamenti carnali e mondani (Ap 17, 4). La porpora e il colore scarlatto designano la sua crudeltà verso i martiri e verso quanti la macchiarono col loro sangue. Ha in mano una coppa d’oro, colma degli abomini e delle immondezze della sua prostituzione. Sebbene per ‘prostituzione’ si possa intendere qualsiasi peccato mortale immondo e abominevole per Dio e per i santi, il termine indica tuttavia soprattutto la simonia e la lussuria per il tempo cristiano e l’idolatria e la lussuria per il tempo pagano, allorché maestra e regina diede da bere a sé e alle genti soggette. Tiene in mano un calice aureo perché la sua gloria e il suo potere temporali appaiono a lei e a tutti i mondani preziosissimi e gloriosissimi come l’oro. “Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso” (Ap 17, 5), di grande mistero e significato: “Babilonia la grande, la madre delle prostituzioni e degli abomini della terra”. Si dice che il nome le stava scritto in fronte – sul luogo del corpo e del volto elevato ed evidente – poiché non nasconde la confusione delle sue colpe e della sua lussuria, ma anzi la rende pubblica, la impone e di essa si gloria e gode e ne porta un nome famoso presso tutti. Scrive Giovanni: “E vidi la donna ebbra” (Ap 17, 6), cioè saziata oltre misura, “del sangue dei santi”, cioè dell’uccisione dei santi minori, secondo l’interpretazione di Riccardo di San Vittore, “e del sangue dei martiri di Gesù”, ossia dei maggiori. Poiché li vinse uccidendoli nel tempo del paganesimo, esultò come ebbra. Nel tempo cristiano, si saziò del sangue dei santi in quanto la Chiesa carnale si inebriò della gloria temporale acquisita per i loro meriti e perché disprezzò e conculcò spiritualmente con le sue colpe il sangue di Cristo e dei santi. Il tema dell’ebbrezza compare anche ad Ap 14, 8, sempre riferito a Babilonia, che “ha abbeverato tutte le genti col vino del furore della sua fornicazione”.
Il simoniaco Niccolò III, credendo che Dante sia Bonifacio VIII giunto per farlo cadere più giù nella fessura della pietra, gli si rivolge coi temi della sazietà (Ap 17, 6), della sfrontatezza (Ap 17, 5-6) e della strage (Ap 17, 3): “Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio / per lo qual non temesti tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio?” (Inf. XIX, 55-57; cfr., a Purg. XX, 91-93, Filippo il Bello, “novo Pilato” non saziato dal rinnovarsi della passione di Cristo nel misfatto di Anagni, per cui porta “nel Tempio le cupide vele”).
Il tema dell’ebbrezza è pure nelle parole di Virgilio che chiudono Inf. XVIII – “E quinci sian le nostre viste sazie” – per le quali interviene il passo da Isaia 66, 24 citato ad Ap 19, 17-18 a proposito della dannazione dell’Anticristo e dei suoi seguaci: “Usciranno e vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, e saranno per tutti le viste sazie”. Taide, l’antica “puttana” – della quale Virgilio ha parlato in precedenza nella seconda bolgia, dove stanno i lusingatori -, è figura della nuova, cioè della Chiesa carnale e simoniaca, vista “puttaneggiar coi regi” e ripresa con parole gravi nel canto e nella bolgia seguenti.
Nel riferire al poeta come fu “cruda” la sua morte, il conte Ugolino racconta che, facendo il “mal sonno” che gli squarciò il velo del futuro, vide l’arcivescovo Ruggieri, “maestro e donno” della caccia al monte pisano – come Babilonia fu maestra e dominatrice delle genti -, nella quale inseguiva “il lupo e ’ lupicini … con cagne magre, studïose e conte” (la prostituta è “studiose … ornata”). Il tema della sfrontatezza appare nell’arcivescovo che “s’avea messi dinanzi da la fronte”, cioè in prima fila, le famiglie ghibelline dei Gualandi, Sismondi e Lanfranchi (Inf. XXXIII, 19-20, 28-33). All’opposto della prostituta stanno le donne della Firenze antica rimpianta da Cacciaguida (Par. XV, 100-102, 112-114).
Ad Ap 17, 1 Olivi afferma che la grande meretrice designa la gente e l’impero dei Romani sia nello stato del paganesimo come in quello cristiano, durante il quale colpevolmente fornicò molto con questo mondo. Questa continuità viene sviluppata ad Ap 17, 6, dove il francescano pone la questione del perché vengano menzionate le colpe commesse da questa donna nel suo primo e antico periodo, al tempo dei pagani: per esse non dovrebbe essere infatti condannata la gente carnale e semicristiana che vive nel sesto tempo della Chiesa. La risposta sta nelle parole di Cristo in Matteo 23, 35: “perché venga su di voi il giusto sangue effuso dal sangue di Abele il giusto”. Come un fiume che dura per molto tempo viene sempre considerato uno, per quanto l’acqua dei suoi primi anni sia diversa dall’acqua di questo anno che corre – al modo con cui diciamo che sono ormai cent’anni che questo fiume ha straripato o si è fatto sangue -, così il continuo succedere del popolo romano viene considerato una gente e un popolo, in modo che si possa dire che questo popolo fu prima pagano e poi cristiano, così da attribuire, quasi per sineddoche, quel che è di una parte all’altra parte o al tutto. Così la colpa della prima parte ridonda nella successiva, in quanto recidiva e fatta ingrata della grazia di Cristo che con misericordia l’ha lavata e santificata. Questa donna, pertanto, che dopo i molti e gravi giudizi fatti nella prima parte del suo popolo non temette di cadere in peccati simili o peggiori, deve essere giudicata per il dispregio di tutti i primi giudizi, anche misericordiosi, dati da Dio sui primi suoi padri, e dunque anche su di essa, su cui sarebbero ricaduti se non avesse demeritato. Imitando i peccati dei padri, li ha abbracciati e proseguiti, e pertanto è rea di tutto, come dice Cristo agli Ebrei del suo tempo: “Guai a voi che edificate i monumenti dei profeti, i vostri padri li hanno uccisi, poiché con la vostra opera date testimonianza che consentite alle opere dei vostri padri” (Luca, 11, 47- 48).
Questo passo contenente l’immagine del fiume “per multa tempora durans”, che giustifica teologicamente il connubio fra tempo pagano e tempo cristiano nel giudizio divino, si presta nel poema a molte variazioni [5]. La storia umana che corre al giudizio come un unico grande fiume, anche se le sue acque non sono le stesse attraverso i secoli, rende partecipe – come in una sineddoche – il paganesimo di tutto il bene e il male che ridondano di secolo in secolo e ricadono infine sul sesto stato della Chiesa, cioè sull’età moderna. Questo passo, insieme ai precedenti versetti del capitolo XVII, assume rilievo in Inf. XXVII, l’altro canto nel quale Bonifacio VIII – nominato come “il gran prete” e “lo principe d’i novi Farisei” – è protagonista.
Il consentire alle opere dei padri, cioè alle precedenti colpe, ha condotto alla dannazione Guido da Montefeltro. I motivi dell’esegesi del fiume da Ap 17, 6 punteggiano tutto l’episodio (senza che il fiume sia mai citato). Già nel primo rivolgersi della fiamma al poeta, che Guido ritiene “caduto … di quella dolce terra / latina ond’ io mia colpa tutta reco” (Inf. XXVII, 25-27), si riconoscono il “cadere in peccata” e l’essere “omnium rea” della donna-fiume antica e nuova. Il Montefeltrano accusa Bonifacio VIII – “se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!, / che mi rimise ne le prime colpe” (ibid., 70-71) – in quanto istigatore alla colpa recidiva: domandandogli consiglio su come gettare a terra Palestrina, lo ha fatto ricadere nel vecchio peccato di frode per cui si era acquistato fama con le sue opere volpine. La risposta data al pontefice dal vecchio uomo d’arme, che ora porta la corda francescana per fare ammenda del passato, è una testimonianza di consenso alle opere dei padri che caddero in peccato, ossia un edificare, nonostante il divieto di Cristo, un monumento ai profeti: «e dissi: “Padre, da che tu mi lavi / di quel peccato ov’ io mo cader deggio”» (ibid., 108-109). Guido chiama Bonifacio “padre”, ed è motivo che concorda col cadere nel peccato antico. Erroneamente crede che da esso il pontefice possa lavarlo, cioè assolverlo: le parole di ammonimento di Beatrice sulla leggerezza nel far voti – “e non crediate ch’ogne acqua vi lavi” (Par. V, 75) – risuonano, a molti versi di distanza dall’episodio infernale, come un suggello. Se Guido ha consentito peccando alle opere dei padri, “la contradizion … nol consente” che ci si possa pentire della colpa e insieme volerla commettere, come argomenta il diavolo “löico” di fronte a san Francesco, venuto invano a prendere l’anima del frate dopo la morte (Inf. XXVII, 112-120). È da notare che cadere nuovamente nella colpa antica è proprio anche dei simoniaci: “Di sotto al capo mio son li altri tratti / che precedetter me simoneggiando, / per le fessure de la pietra piatti. / Là giù cascherò io altresì quando / verrà colui ch’i’ credea che tu fossi, / allor ch’i’ feci ’l sùbito dimando” (Inf. XIX, 73-78).
Non mancano nell’episodio del Montefeltrano altri riferimenti alla meretrice. Alla fiamma di Guido il poeta chiede di rivelarsi augurandole fama tra gli uomini – “se ’l nome tuo nel mondo tegna fronte” (Inf. XXVII, 55-57) – e Guido, credendo di parlare a persona che mai sarebbe tornata al mondo, risponde “sanza tema d’infamia”, non nasconde cioè, come la prostituta apocalittica, il suo nome famoso (ibid., 64-66; cfr., a Inf. XIX, 56-57, le parole di Niccolò III al presunto Bonifacio VIII: “per lo qual non temesti tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio”). Le parole di Bonifacio VIII, che chiede al francescano consiglio su come distruggere Palestrina, paiono “ebbre” al vecchio uomo d’arme (Inf. XXVII, 98-99: unica occorrenza dell’aggettivo).
Quanto il papa dice a Guido – «E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti; / finor t’assolvo, e tu m’insegna fare / sì come Penestrino in terra getti. / Lo ciel poss’ io serrare e diserrare, / come tu sai; però son due le chiavi / che ’l mio antecessor non ebbe care”» (Inf. XXVII, 100-105) – per indurlo a dare “’l consiglio frodolente” su come prendere Palestrina ai Colonna – rinvia sinistramente a due precisi passi della Lectura. Papa Caetani, nelle sue parole ebbre, ripete l’invito dato da Cristo alla seconda chiesa, quella dei martiri, a non diffidare poiché egli è Colui che tutto precede e conclude (Ap 2, 8): “Tuo cuor non sospetti; / finor t’assolvo”. La potestà delle chiavi, in virtù della quale il papa può sciogliere e legare – “Lo ciel poss’ io serrare e diserrare” –, è perfezione di Cristo sommo pastore di cui ad Ap 1, 18 [6], passo simmetrico ad Ap 2, 8 per la comune espressione con la quale Cristo dice di essere “primus et novissimus”. Il presentarsi di Cristo alla chiesa di Smirne come “Colui che antecede” viene appropriato in tono beffardo a Celestino V, “ ’l mio antecessor”, che rinunciando “non ebbe care”, cioè non si curò delle chiavi che aprono e chiudono la salvezza. Figura perversa di Cristo in quanto sommo pastore: tale l’immagine che avrebbe dovuto imprimersi nella mente degli Spirituali francescani, riformatori della Chiesa.
3. “Un tempo, due tempi e la metà di un tempo” (Inf. XIX)
Esaminiamo ora le metamorfosi che nel “poema sacro” assume l’espressione apocalittica “per (un) tempo, (due) tempi e la metà di un tempo” – “per tempus et tempora et dimidium temporis”). Queste parole sono riferite al periodo (si tratta, nella quarta visione, dell’esegesi congiunta della terza e della quarta guerra) in cui la donna (la Chiesa) venne nutrita lontano dal serpente nel deserto dei Gentili, il luogo preparatole da Dio come suo, e dove le vennero date le due ali di una grande aquila (Ap 12, 14). Su di esse, secondo Olivi, Gioacchino da Fiore ha fondato tutta la sua Concordia. L’espressione indica un periodo di tre anni e mezzo, formati da quarantadue mesi (12 mesi x 3 anni + 6 mesi) nei quali i trenta giorni dei singoli mesi corrispondono a trenta anni: si ha così una permanenza della donna nel deserto di 1260 anni. “Tempus” sta per un anno, “tempora” per due anni e “dimidium temporis” per sei mesi. I “due anni” derivano dal duale greco, lingua nella quale scrisse Giovanni. Questo numero compare anche ad Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra) per indicare il periodo in cui la donna venne nutrita nel deserto (dove era fuggita dalla durezza dei Giudei), mentre in Daniele 7, 24-25 si dice che il re undicesimo distruggerà i santi dell’Altissimo che gli saranno dati in mano “per un tempo, due tempi e la metà di un tempo” e in Daniele 12, 6-7 che “fra un tempo, due tempi e la metà di un tempo si compiranno tutte queste cose meravigliose”.
Questo numero mistico ha vari significati. I tre anni e mezzo designano il mistero della trinità di Dio unitamente alla perfezione delle sue opere, che rispetto al loro artefice sono qualcosa di dimidiato, imperfetto, parziale e quasi nulla: le opere furono infatti compiute in sei giorni, che corrispondono alle sei età del mondo e ai sei mesi del mezzo anno. Designano anche la perfezione che deriva dalla fede, dalla speranza e dalla carità unita alla pregustazione non completa della gloria eterna, oppure i tre principali consigli di Cristo (povertà, castità, obbedienza) uniti ad una partecipazione non perfetta della vita eterna. I tre anni e mezzo coincidono con il periodo in cui Cristo esercitò il suo magistero e la sua predicazione. Essi sono anche distinti in “un anno” (“tempo”) e “due anni” (“tempi”), in quanto nel secondo e nel terzo anno Cristo predicò da solo dopo l’incarcerazione di Giovanni Battista e in modo più solenne. Questa distinzione, tenendo conto della profezia di Daniele, si verificherà forse anche nella predicazione e persecuzione dell’Anticristo. Con Giovanni Battista, come dice Cristo in Matteo 11, 11-12 e in Luca 16, 16, inizia il tempo in cui i violenti si impadroniscono del regno dei cieli (cfr. quanto dice l’aquila a Par. XX, 94: “Regnum celorum vïolenza pate”).
Una delle metamorfosi del numero mistico espresso con “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” sta nelle tre facce della testa di Lucifero: “L’una dinanzi, e quella era vermiglia [un tempo]; / l’altr’ eran due [la nera e quella tra bianca e gialla: due tempi], che s’aggiugnieno a questa / sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla [la metà di un tempo]” (Inf. XXXIV, 39-41). È da notare che la prima faccia viene presentata separatamente dalle altre due [7]. Il tema continua con i tre peccatori che Lucifero fa dolenti rompendoli coi denti a guisa di maciulla. Anche in questo caso, il primo – Giuda – viene separato dagli altri due, Bruto e Cassio: “A quel dinanzi [un tempo] il mordere era nulla / verso ’l graffiar [l’esser nulla è motivo che distingue la metà di un tempo] … De li altri due c’hanno il capo di sotto, / quel che pende dal nero ceffo è Bruto … e l’altro è Cassio …” [due tempi] (ibid., 58-67).
Viene riproposto il medesimo tema in apertura di Inf. XXVIII (7-21), nella complessa similitudine cui il poeta ricorre per descrivere la sozza condizione della nona bolgia, dove sono i seminatori di scandalo e di scisma: se si mettessero insieme tutti i morti e i feriti che insanguinarono nel corso dei secoli le terre del Mezzogiorno d’Italia, e questi mostrassero le loro membra forate o mozze, non si offrirebbe un’idea adeguata alla circostanza. Viene prima “tutta la gente / che già, in su la fortunata terra / di Puglia, fu del suo sangue dolente” a causa dei “Troiani” (per la venuta di Enea in Italia) e della lunga seconda guerra punica, che a Canne “de l’anella fé sì alte spoglie” (gli anelli strappati dalle dita dei Romani caduti). A questo primo gruppo delle genti di Puglia (con la quale si intende la parte continentale del Regno di Sicilia) si dovrebbe aggiungere un secondo, formato a sua volta da due gruppi: la gente che tentò invano di contrastare Roberto il Guiscardo e la gente caduta nelle guerre tra Angioini e Svevi. Questo secondo sottogruppo si divide ancora in due parti: la gente caduta a Ceprano, abbandonata per tradimento – “là dove fu bugiardo ciascun Pugliese” (indiretta allusione alla battaglia di Benevento dove fu sconfitto Manfredi) -, e quella caduta a Tagliacozzo, dove Corradino venne sconfitto per via di un accorto consiglio dato a Carlo d’Angiò dal “vecchio Alardo”. Il primo gruppo – le genti di Puglia – corrisponde al “tempo” (un anno); il secondo, doppio gruppo – i caduti o i feriti nei combattimenti contro Roberto il Guiscardo e quelli nelle guerre svevo-angioine – a “tempi” (due anni); la “metà di un tempo” (mezzo anno) sta nel “nulla” che la riunione di tutti e tre i gruppi di caduti offre rispetto a quanto visto dal poeta nella bolgia: il mezzo anno designa infatti qualcosa di dimidiato, imperfetto e parziale (con “dimidium” concorda anche il “mezzul” del fondo della botte, di cui si dice al verso 22). È da notare la simmetria del motivo dei “due tempi”, che rispecchia il duale greco, in Inf. XXVIII e in Inf. XXXIV: “S’el s’aunasse ancor tutta la gente … con quella … e l’altra … quel che pende dal nero ceffo è Bruto … e l’altro è Cassio …”.
Una variante del tema sembra presente anche in quanto dichiarato dal simoniaco Niccolò III in Inf. XIX, 79-84: il tempo da lui trascorso nella posizione di piantato sottosopra coi piedi accesi nel foro della livida pietra è già quasi di venti anni (agosto 1280 – marzo/aprile 1300), un “tempo” più lungo di quello in cui vi resterà Bonifacio VIII, che alla morte nell’ottobre 1303 prenderà il suo posto e lo farà cadere più giù nelle fessure della pietra, perché Bonifacio, dopo quasi undici anni, verrà a sua volta sostituito nel 1314 da Clemente V, “pastor sanza legge” che ricoprirà entrambi i suoi predecessori per “più laida opra”. Il motivo della “metà di un tempo” si può considerare applicato sia a Bonifacio VIII, che trascorrerà piantato come palo circa la metà del tempo toccato a Niccolò III, sia, nel significato di un’opera parziale e imperfetta che assume qui un sapore amaro, a entrambi i pontefici, l’Orsini e il Caetani, la cui opera, alla fine, risulterà meno laida di quella del guascone Bertrand de Got. È comunque da notare come il medesimo tema venga appropriato sia ai papi simoniaci sia a Lucifero, figure che designano, attraverso un numero mistico loro applicato, la durata della tribolazione (tre anni e mezzo) sotto il regno dell’Anticristo (l’undicesimo re di Daniele 7, 24-25). L’espressione “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” sarà ancora utilizzata da Botticelli alla fine dell’anno 1500, come datazione della Natività mistica ispirata ai sermoni sull’Apocalisse del Savonarola [8].
Un’altra variazione è nella spiegazione data da Manfredi della penitenza impostagli come scomunicato: chi muore in contumacia di Santa Chiesa, ancorché si penta in fin di vita, “per ognun tempo” che è stato “in sua presunzïon”, ostinato cioè nel non volersi sottomettere all’autorità ecclesiastica, deve restare fuori del Purgatorio trenta volte (il numero trenta fa parte del numero mistico 1260), a meno che questo decreto non venga abbreviato (la “metà di un tempo”) per l’intervento delle buone preghiere (Purg. III, 136-141) [9].
Il motivo della “metà di un tempo”, cioè di un’opera parziale e imperfetta, viene ancora ironicamente appropriato al vivere civile di Atene e Sparta, “picciol cenno” rispetto alle sottili leggi fiorentine che varate ad ottobre non durano alla metà di novembre (Purg. VI, 139-144). Con esso viene vestita la reminiscenza ovidiana della “folle Aragne”, la tessitrice che sfidò Minerva, raffigurata sul pavimento del primo girone dei superbi “già mezza ragna, trista in su li stracci / de l’opera che mal per te si fé” (Purg. XII, 43-45; cfr. quanto afferma Niccolò III del ‘futuro’ papa Clemente V: “ché dopo lui verrà di più laida opra, / di ver’ ponente, un pastor sanza legge”: Inf. XIX, 82-83). A Par. XIX, 133-138, l’aquila dice di Federico II d’Aragona (re di Sicilia dal 1296 al 1337) che nel libro della vita (cfr. Ap 20, 12) le sue opere saranno scritte con lettere abbreviate per “dare ad intender quanto è poco” [‘metà di un tempo’]; pure all’apertura del libro “parranno a ciascun l’opere [‘metà di un tempo’] sozze / del barba [Giacomo, re di Maiorca] e del fratel [Giacomo re di Sicilia e poi di Aragona], che tanto egregia / nazione [l’Aragona: ‘un tempo’] e due corone [Maiorca e Aragona: ‘due tempi’] han fatte bozze”.
I tre anni e mezzo designano il mistero della trinità di Dio unitamente alla perfezione delle sue opere, che rispetto al loro artefice sono qualcosa di dimidiato, imperfetto e parziale e quasi nulla: così nella visione finale il poeta vede “tre giri / di tre colori e d’una contenenza”, ma il suo dire è “corto” e “fioco”, inadeguato rispetto al concetto, a quanto cioè la mente ha ritenuto della visione, concetto che a sua volta è “poco”: il corto, il fioco, il poco esprimono il significato contenuto nella “metà di un tempo” (Par. XXXIII, 115-123).
La vicinanza del verbo “pertractare”, riferito nell’esegesi di Ap 12, 6 al quinto libro della Concordia di Gioacchino da Fiore, con il numero mistico “per tempus et tempora et dimidium temporis” (da Daniele, 12, 6-7; cfr. gli incisi “… sub uno quam brevi coart[ar]emus sermone … nisi hoc quod sonat versiculus iste …” con Par. XXXIII, 74, 106 : “e per sonare un poco in questi versi … Omai sarà più corta mia favella”) conduce a Inf. XI, 79-84, dove Virgilio ricorda al discepolo le tre disposizioni peccaminose odiate da Dio – “incontenenza, malizia e la matta bestialitade” – esposte ampiamente (‘pertrattate’) dall’Etica di Aristotele. Una di queste tre disposizioni, l’incontinenza, offende meno Dio e suscita minor biasimo, e pertanto gli incontinenti stanno fuori della città di Dite meno martellati nelle pene dalla divina vendetta. All’incontinenza è applicato il tema della “metà di un tempo”, mentre la malizia sembra corrispondere a “tempi” (il duale greco), considerato che ai vv. 22-24 si dice che il fine di ogni malizia, che consiste nell’ “ingiuria”, cioè nell’infrazione delle leggi divine o naturali, si consegue in due modi, con la forza (i violenti) o con l’inganno (i fraudolenti); quest’ultimo, a sua volta, si distingue nella frode verso chi si fida e in quella verso chi non si fida, con andamento bipartito riscontrabile in principio di Inf. XXVIII (Inf. XI, 52-66: “Questo modo di retro … Per l’altro modo …”). La “matta bestialitade” corrisponderebbe pertanto a “(un) tempo”. Da notare che i violenti hanno un andamento ternario, per non dire trinitario: “ma perché si fa forza a tre persone … a Dio, a sé, al prossimo” (Inf. XI, 28-33).
(Tab. VI)
[LSA, cap. XII, Ap 12, 14 (IVa visio, III-IVum prelium)] Dicit autem “per tempus et tempora et dimidium temporis”, id est per tres annos et dimidium ex quadraginta duobus mensibus triginta annorum, id est mille ducentis sexaginta annis constantes. Eundem enim numerum sub aliis verbis intendit hic ponere, quem posuit paulo ante (cfr. Ap 12, 6). Per “tempus” enim intelligitur unus annus, et per “tempora” duo ann[i]. Nam Greci, in quorum lingua iste liber est editus, habent tres numeros in suis articulis, scilicet singularem et dualem et pluralem. Quod autem “tempus et tempora et dimidium temporis” sumatur alibi pro tribus annis et dimidio, patet quia Danielis VII° dicitur quod rex undecimus, designatus per undecimum cornu, “sanctos Altissimi conteret et tradentur in manu eius usque ad tempus et tempora et dimidium temporis” (Dn 7, 25). In hoc autem libro et infra, XIII° capitulo, dicitur quod “data est illi potestas facere malum per menses quadraginta duos” (Ap 13, 5) et idem dicitur supra, XI° (Ap 11, 2/9/11). Quod autem “tempus et tempora”, id est tres anni, non sumantur hic pro annis dierum seu mensium ex solis triginta diebus constantium, se[d] potius pro annis duodecim mensium ex triginta annis quasi ex triginta diebus constantium, patet non solum ex supradictis, sed etiam quia in tertio et quarto statu ecclesie non apparuit talis persecutio vel mansio in deserto per solos tres annos dierum perdurans. Preterea hic non dicit ‘ubi aletur per tempus et tempora’, sed “ubi alitur”, tamquam monstrans se loqui de toto tempore pastus eius, de quo supra dixerat quod “habet” in deserto “locum paratum a Deo, ut ibi pascat eam mille ducentis sexaginta diebus” (Ap 12, 6).
|
|
Inf. XXXIV, 22-24, 37-45, 55-67:Com’ io divenni allor gelato e fioco,
|
Inf. XXVIII, 7-24:S’el s’aunasse ancor tutta la gente
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio, III-IVum prelium)] Notandum autem quod Ioachim totum librum suum Concordie veteris et novi testamenti fundavit super numero hic posito. Unde libro V° Concordie, circa finem pertractans verba illa angeli dicta Danieli, quod “in tempus et tempora et dimidium temporis” erit “finis horum mirabilium” (Dn 12, 6-7), dicit: «Verba hec Danielis ita a lectore huius operis pensari debere vellem, ut quicquid a principio huius operis usque huc late et diffuse contulimus sub uno quam brevi coart[ar]emus sermone. Nichil enim aliud nos intimasse credimus, nisi hoc quod sonat versiculus iste: ‘in tempus et tempora et dimidium temporis omnium istorum mirabilium esse finem’. Quia sicut iam per multas vices nos dixisse meminimus, in hiis quadraginta duabus generationibus septem signacula continentur, nichilque aliud est dicere “in tempus et tempora et dimidium temporis” complebuntur quam illud quod, sub sexto angelo tuba canente, alter angelus aut forte unus et idem ait: “tempus iam non erit amplius, sed in voce septimi angeli, cum ceperit tuba canere” (Ap 10, 6-7)». |
|

Roma, Grotte Vaticane, sepolcro di Bonifacio VIII
4. “Lo principe d’i novi Farisei”
4.1. I Gentili senza pace (Inf. XXVII, Purg. XIV)
Il primo versetto dell’esegesi della seconda tromba (Ap 8, 8; terza visione) è particolarmente dedicato ai “Gentili”, perché fra loro suonò il secondo angelo. Il male che seguì, e come il diavolo infiammasse e incitasse i Gentili contro i dottori e la loro dottrina, è così spiegato: “E fu messo nel mare come un gran monte ardente di fuoco”. Questo monte è il diavolo, adorato come Dio dai pagani negli idoli, che viene definito “gran monte” sia per il gran tumore della sua superbia, sia per la sua grande potenza naturale. Costui riarse del fuoco dell’ira e dell’invidia verso i santi dottori che predicavano contro l’idolatria per espellerla dal mondo quanto possibile, e per l’effetto del suo empio suggerire e insinuarsi “fu messo nel mare”, cioè nel flutto dei cuori dei Gentili, i quali erano come un grande mare inabitabile sia per i semplici fedeli, che si possono considerare quasi pecore e giumenti, sia per i perfetti e discreti, che sono come uomini. Il “mare” spesso nell’Apocalisse designa i Gentili, fluttuosi per gli errori, procellosi per guerre e rivolte, salsi e amari per costumi carnali e per turpe idolatria, profondi come una voragine per malizia e quasi senza fine per la moltitudine dei popoli. Gli effetti della seconda tromba sono specificati col dire: “E la terza parte del mare si fece sangue”, cioè quella parte dei Gentili che non volle credere in Cristo si fece persecutrice uccidendo i fedeli ed effondendo il loro sangue.
Un’esegesi quasi simmetrica a quella della seconda tromba si presenta per la seconda coppa (Ap 16, 3; quinta visione), che l’angelo versò nel mare, cioè sui pagani che non volevano credere ai predicatori e anzi li perseguitavano. Anche in questo caso i pagani sono designati dal mare fluttuoso di errori, nel quale non cresceva erba o albero della fede e non era luogo abitabile. La coppa, che sul piano temporale fu versata allorché prima con i martiri e poi con Costantino l’idolatria venne espulsa dal mondo e i pagani che non vollero convertirsi furono segregati come morti dalla vita civile e spirituale, spiritualmente designa il redarguire da parte dei santi martiri l’idolatria e l’ostinazione pagana. “E si fece sangue come quello di un morto”, cioè il mare del paganesimo si convertì in crudeltà mortifera ed effondente il sangue dei santi martiri. “E ogni anima vivente”, che cioè aveva prima una qualche disposizione alla vita della fede o qualche seme di essa, oppure ogni individuo che scelse di vivere per questo mondo, “morì nel mare”, ossia fu morto nel primo seme del bene a causa della miscredenza e della crudele persecuzione dei pagani e destinato alla morte eterna.
I temi della seconda tromba risuonano nell’episodio di Guido da Montefeltro. Già nella domanda fatta a Dante – “dimmi se Romagnuoli han pace o guerra” – il motivo della guerra si congiunge con quello del monte allorché Guido precisa la sua origine, i monti tra Urbino e il giogo appenninico da cui nasce il Tevere (Inf. XXVII, 28-30). La risposta di Dante sviluppa il tema del cuore dei Gentili fluttuoso per le guerre: “Romagna tua non è, e non fu mai, / sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni” (ibid., 37-38), dove persino il nome della terra allude nel suono al “mons magnus” messo nei cuori tempestosi. Nel seguito dell’episodio il tema del monte grande per superbia viene applicato a Bonifacio VIII, “il gran prete” che chiese a Guido di guarirlo “de la sua superba febbre” dandogli il consiglio fraudolento su come distruggere Palestrina (ibid., 70, 96-98). Il papa rimise così Guido, pentitosi in vecchiaia del suo operato volpino e fattosi francescano, nelle prime colpe: un motivo, quello del ritorno all’antica idolatria, presente sia nell’istruzione alla seconda chiesa (Ap 2, 10; non in tabella) come nell’esegesi della seconda guerra (Ap 12, 8) e nella similitudine del fiume sanguigno ad Ap 17, 6 sopra considerata.
Nel secondo girone del Purgatorio, Dante incontra altri due spiriti di Romagna, Guido del Duca e Rinieri da Calboli. Il primo dei due descrive a fosche tinte la valle dell’Arno, il cui nome è ben degno di perire, tanto essa è priva di qualsiasi virtù dal suo principio, dove il fiume nasce in Appennino – “ov’ è sì pregno / l’alpestro monte ond’ è tronco Peloro” – fino alla foce nel mare (Purg. XIV, 28-39). Il tema del “mons magnus … propter magnum superbie sue tumorem” è reso con il “pregno” dell’alpestro monte, che già Benvenuto, insieme ad altri commentatori, aveva spiegato come “tumorosus vel altus” per l’abbondanza di acque, senza però attribuirgli alcun significato spirituale. Si possono ricordare anche le parole del poeta a Oderisi da Gubbio, che purga la superbia nel girone precedente: “Tuo vero dir m’incora / bona umiltà, e gran tumor m’appiani” (Purg. XI, 118-119). Come nel mare dei Gentili, “inter quos non erat habitatio fidelium simplicium, quasi pecora et iumenta, et multo minus perfectorum et discretorum, qui sunt quasi homines”, così si son fatti a viver come bruti i conriparii del fiero fiume: “ond’ hanno sì mutata lor natura / li abitator de la misera valle, / che par che Circe li avesse in pastura” (Purg. XIV, 40-42).
Guido del Duca parla più avanti di sé stesso: “Fu il sangue mio d’invidia sì rïarso” (Purg. XIV, 82), che corrisponde in Ap 8, 8 all’ “exarsit igne … invidie” del diavolo-gran monte. “Di mia semente cotal paglia mieto”, continua il romagnolo con il motivo del seminato che è proprio della seconda coppa (Ap 16, 3), “o gente umana, perché poni ’l core / là ’v’ è mestier di consorte divieto?”, dove è presente un riferimento ai turbolenti cuori dei Gentili (Purg. XIV, 85-87). Guido passa poi a parlare della sua Romagna, il territorio compreso “tra ’l Po e ’l monte e la marina e ’l Reno” (il “monte” è sempre l’Appennino, il “giogo” da cui nascono Arno e Tevere). Afferma sconsolato che non solo il sangue, già pregiato e onorato, del casato di Rinieri da Calboli, suo compagno di pena per l’invidia passata, “è fatto brullo” (tema della seconda coppa, ad Ap 16, 3: “et factus est sanguis tamquam mortui”), privo com’è “del ben richesto al vero e al trastullo”, ma che tutta la regione è piena di velenosi e incoltivabili sterpi (Purg. XIV, 88-96). Il compianto sulle genti di Romagna, una volta buone e ora prive del valore di un tempo da nessuno ereditato, si avvicina a quanto ad Ap 16, 3 si dice di coloro che erano inizialmente ‘anime viventi’, che cioè avevano una qualche disposizione alla vita della fede o qualche seme di essa, oppure che scelsero di vivere per questo mondo, e che poi ‘morirono nel mare’, una volta morto in esse il primo seme del bene. La stessa distinzione fatta da Guido tra il bene richiesto “al vero” e quello “al trastullo”, che secondo gli antichi commentatori si richiama alla distinzione aristotelica tra il bene onesto (“bonum animi”) e quello utile e dilettevole (“bonum corporis”), sembra concordare con la distinzione nel testo di esegesi scritturale tra le anime viventi perché disposte alla fede e quelle che scelsero di vivere per il mondo, che nella trasformazione poetica sono l’amore e cortesia che invogliavano i cuori ora fatti tanto malvagi.
Si può notare, nel lamento di Guido del Duca sui casi di Romagna, accanto al nuovo valore assegnato ai ‘gentili’ (gente dal cuore tumultuoso, sediziosa e sempre in guerra: “o gente umana, perché poni ’l core / là ’v’ è mestier di consorte divieto?”) così come proposto ad Ap 8, 8 e in altri luoghi della Lectura, la presenza del significato tradizionale, caro al primo Dante, della parola ‘gentile’, cioè nobile di spirito, liberale: “quando in Faenza un Bernardin di Fosco, / verga gentil di picciola gramigna?” (Purg. XIV, 101-102). Una ‘gentilezza’ di vita (“Ugolin d’Azzo che vivette nosco // “Et omnis anima vivens” … mortificata est a primo seminario boni et fortius destinata ad mortem eternam”, ibid., 105; cfr. Ap 16, 3) che non solo si è perduta, ma che anzi è tornata allo stato brutale prima che fosse seminata la pianta: il verso “Oh Romagnuoli tornati in bastardi!” (ibid., 99) significa che essi sono ‘ritornati’ al silvestre stato precedente il tempo della vera ‘gentilezza’, di cui Guido del Duca ricorda “le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi / che ne ’nvogliava amore e cortesia” (ibid., 109-110). Sotto questo rispetto, Purg. XIV, 99 – “Oh Romagnuoli tornati in bastardi!” – è variazione, come lo sono le parole di Guido da Montefeltro a Inf. XXVII, 70-71 – “che mi rimise ne le prime colpe” -, del tema del ritorno all’antico paganesimo proprio della seconda guerra della Chiesa (Ap 12, 8; come avvenne con l’imperatore Giuliano l’Apostata: cfr. LSA, prologo, notabile X).
I tempestosi cuori dei ‘gentili’ si registrano ancora nel principio del lamento sulla condizione d’Italia (Purg. VI, 76-87): «Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere in gran tempesta … e ora in te non stanno sanza guerra / li vivi tuoi … Cerca, misera, intorno da le prode / le tue marine // “missus est in mare”, id est in fluctuosis cordibus gentilium … Per “mare” enim sepe in hoc libro designatur gentilitas, quia fuit erroribus fluctuans et bellis ac seditionibus procellosa … “Et omnis anima vivens” … ». E Sordello, “quell’anima gentil ” pronta a far festa al suo concittadino Virgilio “sol per lo dolce suon de la sua terra”, rappresenta, nella sua nobiltà di spirito, l’altro significato dell’essere ‘gentile’ [10].
La seconda delle sette guerre sostenute dalla Chiesa (descritte nella quarta visione) viene condotta dall’arcangelo Michele – del quale si sottolinea l’officio supremo -, duca delle schiere dei martiri assimilati agli angeli buoni che combattono contro quelli malvagi condotti dal drago (Ap 12, 7-12).
Al drago, sconfitto dalle schiere dell’arcangelo Michele, viene tolto il dominio e il potere: “E fu gettato in terra quel grande drago, il serpente antico, che è chiamato diavolo e satana e che seduce tutta la terra” (Ap 12, 9). Viene chiamato “serpente” per la malizia e l’errore con cui intossica il mondo, che seduce con dolosa astuzia. Viene detto “antico” perché, creato all’inizio del mondo, fin da principio si allontanò dalla verità e divenne omicida, come affermato in Giovanni 8, 44. Con parola greca viene definito “diavolo”, cioè “accusatore”; oppure, secondo altri, “colui che cade giù” (“deorsum fluens”), sia perché cadde giù dal celeste stato nel quale fu creato, sia perché cerca di precipitare tutti all’inferno accusandoli dinanzi al sommo giudice in modo che vengano condannati. In ebraico viene chiamato “satana”, cioè “avversario”, poiché sempre avversa gli eletti. “Seduce tutta la terra”, in quanto sedusse in Adamo tutto il genere umano, che trae quasi tutto a sé, tanto che, ad eccezione di Cristo e di sua madre, non vi è adulto che non venga sedotto a commettere qualche peccato, sia pure veniale. Il diavolo “fu gettato in terra”, ovvero nell’infimo grado, calpestato dai santi come si calca la terra. Oppure “in terra”, in quanto gli venne concesso di penetrare con più forza negli aderenti alle cose terrene, come entrò rapido nei porci allorché venne espulso dai due indemoniati ad opera di Cristo (Matteo 8, 28-34).
Dice Guido del Duca (Purg. XIV, 37-38) che nella valle dell’Arno la virtù viene da tutti fuggita “come biscia” (“serpens”) e “per nimica” (il diavolo ad Ap 12, 10 è detto pure “Dei et suorum omnium martirum inimicus”). Lungo il suo corso iniziale, nel Casentino, il fiume scorre “tra brutti porci, più degni di galle / che d’altro cibo fatto in uman uso” (vv. 43-45). Sempre nelle parole di Guido (v. 62), Fulcieri da Calboli, il feroce podestà di Firenze nel 1303, viene definito “antica belva” che uccide i lupi fiorentini (corrisponde all’ “antiquus … factus est homicida”). Fulcieri esce sanguinoso dalla “trista selva” fiorentina, lasciandola in tali condizioni che non basterebbero mille anni per farla tornare al pristino stato (vv. 64-66): anche il riferimento ai “mille anni”, che può apparire generico, fa parte del gruppo tematico che concerne il diavolo, del quale ad Ap 20, 3 (settima visione) si dice che venne gettato e chiuso nell’abisso in modo da non sedurre più fino al compimento dei mille anni. Guido piange quindi la decadenza della Romagna, piena di “venenosi sterpi” al punto di rendere tardivo ogni tentativo di coltivarla (vv. 94-96: il veleno è proprio del serpente; il coltivare, in senso equivoco con ‘culto’, è nel “colere” di Ap 12, 7, dove è descritta la seconda guerra che vede contrapposte la ‘coltura’ dei demoni e il ‘culto’ di Cristo). Sostiene Guido che i Pagani, signori di Faenza, faranno bene a non rifigliare “da che ’l demonio lor sen girà”, cioè dopo che sarà morto (nel 1302) l’ultimo di loro, Maghinardo, ma di essi non rimarrà più “puro … testimonio” (vv. 118-120): nella terzina sono presenti i temi dell’espulsione del demonio (Ap 12, 7/9) e della vittoria sul diavolo per opera della testimonianza della fede (Ap 12, 11: “vicerunt illum … propter verbum testimonii sui”), mentre il nome della famiglia romagnola concorda coi “pagani” che nella seconda guerra combattono a fianco dei demoni contro il culto di Cristo. Guido del Duca chiude il suo ragionare con la mente stretta dal desiderio di piangere più che di parlare, e licenzia Dante equivocando sul suo essere “Tosco” («“serpens” dicitur per venenum malitie et erroris quo mundum extoxicat »; vv. 124-126). Non diversamente si esprime alla fine del canto precedente Sapia senese, la quale chiede al poeta di rimetterla in buona fama presso i propri parenti, “se mai calchi la terra di Toscana”, che è variazione sul tema del diavolo gettato in terra e ‘calcato’ (Purg. XIII, 148-150). Il parlar “tosco” è sinonimo di inganno e tentazione per Marco Lombardo (Purg. XVI, 136-138) [11]. È da notare, nelle parole di Virgilio in fine di Purg. XIV (vv. 145-147), il motivo del trarre al peccato da parte dell’ “amo de l’antico avversaro” (Ap 12, 9).
Il tema del diavolo – «“proiectus est in terram” et cetera, id est in infimam deiectionem”» – è messo in bocca a Bonifacio VIII, “il gran prete” che domandò consiglio al francescano Guido da Montefeltro affinché gli insegnasse “sì come Penestrino in terra getti” (Inf. XXVII, 101-102). Ma al papa – “Lo principe d’i novi Farisei” – sono ironicamente appropriati i motivi di Michele “princeps angelorum” nella seconda guerra (Michele può essere l’arcangelo o anche un angelo degli ordini supremi che ne fa le veci). Mentre Michele combatte il diavolo e i pagani, Bonifacio fa la guerra ai cristiani senza guardare in sé “né sommo officio né ordini sacri” (Inf. XXVII, 85-91) [12]. Il diavolo, gettato a terra, scenderà ancora con grande ira a vendicarsi: poiché non lo può fare su Cristo e i santi che l’hanno vinto, intende vendicarsi almeno su quanti amano le cose terrene (Ap 12, 7). Così Minosse, il quale nel giudicare l’anima di Guido da Montefeltro si morde la coda “per gran rabbia”, non potendo punire il Vicario di Cristo che ha istigato il “consiglio frodolente” (Inf. XXVII, 124-126).
(Tab. VII)
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 8 (IIIa visio, IIa tuba)] “Et secundus angelus”, id est ordo doctorum secundi status, “tuba cecinit”, id est inter gentiles magnifice predicavit et docuit. Quid autem mali sit ex hoc per accidens subsecutum, et qualiter diabolus inflammavit et concitavit gentiles contra doctores et doctrinam eorum, monstratur cum subditur: “et tamquam mons magnus igne ardens missus est in mare”. Mons iste est diabolus, qui a gentilibus in idolis colebatur ut Deus, qui dicitur “mons magnus” tum propter magnum superbie sue tumorem, tum propter magnitudinem sue naturalis potentie, qui contra sanctos doctores, contra eius cultum et idolatriam predicantes et ipsam pro posse a toto orbe expellentes, exarsit igne ire et invidie contra ipsos, et per effectum impie suggestionis et successionis “missus est in mare”, id est in fluctuosis cordibus gentilium, quorum multitudo erat quasi mare magnum et inter quos non erat habitatio fidelium simplicium, quasi pecora et iumenta, et multo minus perfectorum et discretorum, qui sunt quasi homines. Per “mare” enim sepe in hoc libro designatur gentilitas, quia fuit erroribus fluctuans et bellis ac seditionibus procellosa et moribus carnalibus et idolatriis turpibus salsa et amara et malitiis profunda et voraginosa et multitudine plebium quasi infinita. Quid autem mali fecerit ostenditur cum subditur: “Et facta est tertia pars maris sanguis”, id est illa pars gentilium, que noluit in Christum credere, facta est persecutrix et interfectrix fidelium et effundens sanguinem eorum.[LSA, cap. XVI, Ap 16, 3 (Va visio, IIa phiala)] “Et secundus angelus effudit phialam suam in mare”, id est super paganos nolentes credere predicantibus ad eos missis, immo potius persequentes ipsos et doctrinam eorum. Pagani enim sunt velut mare erroribus fluctuans, in quo non crescebat herba vel arbor fidei et fidelium, nec ante Christum erat ibi habitatio homini fideli. Hec autem effusio est spiritaliter facta per sanctos martires, paganorum idolatriam et pertinaciam detestabiliter increpantes. “Et factus est sanguis tamquam mortui”, id est mare paganismi versum est in cr[ude]litatem mortiferam effundentem sanguinem sanctorum martirum. “Et omnis anima vivens”, id est prius aliquod seminarium seu aliquam dispositionem ad vitam fidei habens, vel “omnis” qui huic mundo vivere elegit, “mortua est in mari”, quia scilicet in infidelitate et crudeli persecutione paganorum mortificata est a primo seminario boni et fortius destinata ad mortem eternam.[LSA, cap. XII, Ap 12, 7-9.12 (IVa visio, IIum prelium)] Sequitur (Ap 12, 7): “Et factum est prelium magnum in celo”, id est in sancta ecclesia. “Michael et angeli eius preliabantur cum drachone, et dracho pugnabat et angeli eius”, scilicet contra exercitum Michaelis. […] sancti martires principaliter certabant ad expellendum de mundo culturam demonum et idolorum in quibus colebantur, et e contra pagani et demones principaliter certabant ad destruendum celestem et angelicum cultum Christi seu Dei unius et trini. […] An autem Michael, prout stat hic pro principe angelorum, significet hic et alibi unam solam personam unius spiritus angelici, vel aliquando propter conformitatem officii stet pro una aliquando pro alia, et an designet solos spiritus penultimi ordinis, scilicet archangelici, aut etiam quoscumque supremorum ordinum in quantum exercent vel regunt officia archangelorum seu principum militie celestis et preliorum eius, non clare constat ex sacro textu. Communis tamen opinio plurium fidelium tenet quod sit unus spiritus penultimi ordinis datus ecclesie in ducem sicut antea fuerat sinagoge, iuxta illud Danielis IX°, ubi Gabriel dicit Danieli: “Nemo est adiutor meus in operibus hiis, nisi Michael princeps [vester]” (cfr. Dn 10, 21), et capitulo XI°: “In tempore illo consurget Michael princeps magnus, qui stat pro filiis populi tui” (cfr. Dn 12, 1). Prelium autem hoc dicitur hic magnum tum quia, secundum Ricardum, fuit robustum et longum (nam circiter trecentis annis duravit), tum quia fuit universale in toto orbe, tum quia fuit pro maxima causa. Sequitur de triumpho martirum deiciente culturam demonum et idolorum et potestatem reducendi orbem ad illam eo modo quo prius, unde subdit (Ap 12, 8): “Et non prevaluerunt”, scilicet dracho et angeli eius sed, supple, devicti sunt. Unde subdit: “nec inventus est locus eorum amplius in celo”, id est in ecclesia vel in illa dominatione per quam ab idolatris estimabantur esse in celo tamquam dii celestes. “Et proiectus est” (Ap 12, 9), scilicet a predicta dominatione et potestate, “dracho ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur Diabolus et Sathanas”. “Serpens” dicitur per venenum malitie et erroris quo mundum extoxicat, et propter dolosam astutiam qua mundum seducit. “Antiquus” vero dicitur, tum quia a primo initio [mundi creatus est, tum quia ab initio] recessit a veritate et factus est homicida, prout dicitur Iohannis VIII° (Jo 8, 44). “Diabolus” vero dicitur grece, id est incriminator, vel secundum alios dicitur diabolus id est deorsum fluens, tum quia a celesti statu in quo fuit conditus cecidit deorsum, tum quia omnes nititur ad inferos precipitare, quia omnes pro posse accusat summo iudici ut dampnentur ab eo. Ebraice vero dicitur “Sathanas”, id est adversarius, quia semper adversatur electis et etiam omnibus. “Qui seducit universum orbem”, tum quia totum humanum genus in Adam seduxit, tum quia maiorem partem et fere totum seculum secum trahit, tum quia preter Christum et eius matrem non creditur esse aliquis adultus quem in aliquo peccato saltem veniali non seducat. Vel sensus est: “qui seducit”, id est qui prius seducebat. Et “proiectus est in terram” et cetera, id est in infimam deiectionem et calcandus a sanctis sicut terra calcatur ab omnibus. Vel “in terram”, id est in terrenos in quos tunc fortius est permissus intrare, sicut et rapide intravit in porcos quando per Christum expulsus fuit a duobus demoniacis, prout scribitur Matthei VIII° (Mt 8, 28-34). […] Deinde explicat augmentum mali quod ex prefata diaboli deiectione subsequuntur terrestres et tempestuosi, unde subdit: “Ve terre” (Ap 12, 12), id est terrenis et terrena amantibus, “et mari”, id est infidelibus vel quibuscumque tempestuosis per varia vitia fluctuantibus et per sevitiam amaris, “quia descendit diabolus ad vos”, scilicet per ampliorem potestatem vos temptandi sibi iuste permissam, quia scilicet tempore tante salutis et victorie per Christum et eius martires obtente, et manifesto exemplo et documento orbi toti ostense, aut nullatenus aut non sufficienter estis eos secuti. “Descendit” etiam “ad vos diabolus” plusquam ante, propter maiorem voluntatem et conatum vos gravius temptandi. Unde subditur: “habens iram magnam”, scilicet se ulciscendi de sua tanta deiectione facta a Christo et a sanctis, et quia non potest se ulcisci in eis vult saltem se ulcisci in nos. Habet etiam “iram magnam” ad hoc ut omne malum implendum, tamquam “sciens quod modicum tempus habet”, scilicet ad temptandum, id est quia scit tempus extremi iudicii cito venturum, et etiam quia scit magnam potestatem temptandi sibi interim super electos esse ablatam usque prope seculi finem, quo est iterum solvendus.[LSA, prologus, notabile X] Martiria vero, martires configurantia Christo passo et testimonium dantia Christo et fidei eius et virtutis exemplum relinquentia posteris, debuerunt esse multa et diuturna, tum propter maiorem gloriam Christi, tum propter maiorem confirmationem fidei, tum propter maiorem coronam maioremque societatem ipsorum martirum. Unde et a prima persecutione Neronis usque ad persecutionem Iuliani imperatoris et apostate et repulsam idolatriam renovantis fuerunt circiter trecenti anni. Et a passione Christi usque ad pacem christianis datam sub Constantino sunt quasi totidem anni. Qui numerus bene congruit statui martirum pro fide Trinitatis fructum martirii centenarium afferentium. |
|
Inf. XXVII, 28-30, 36-39, 70-71, 85-97, 100-102, 124-126:dimmi se Romagnuoli han pace o guerra;
|
Purg. XIV, 28-45, 61-66, 82-111, 118-120, 124-126, 145-147:E l’ombra che di ciò domandata era,
|
L’esegesi dell’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 4) mostra ancora come un medesimo passo della Lectura possa costituire il nucleo tematico di più momenti della Commedia a prima vista del tutto indipendenti. A Giovanni appare un cavallo rosso (l’esercito dei pagani rosso per il sangue sparso dai martiri). A chi vi sta seduto sopra (l’imperatore romano o il diavolo) è concesso di togliere la pace dalla terra, perseguitando non solo gente estranea e lontana ma anche i propri parenti e vicini. Le parole “terra”, “pace” e il verbo ‘togliere’ (“che mi fu tolta”, “come suole esser tolto”) sono fili che formano parte del tessuto sia nel discorso di Francesca (Inf. V, 97-102) come in quello di Catalano, uno dei due frati ‘godenti’ bolognesi nella bolgia degli ipocriti (Inf. XXIII, 103-108). Se identiche sono le parole, la loro collocazione è del tutto diversa nei due distinti episodi. Il significato originario, il “togliere la pace dalla terra” si mantiene in entrambi. A Francesca fu tolta la bella persona che fece innamorare Paolo, e quindi fu tolta la pace alla terra, Ravenna, che sembrava ristabilita con il matrimonio che aveva unito una da Polenta con un Malatesta, pace il cui tema viene espresso con il discendere verso il mare del Po. L’esegesi si riferisce ai Gentili, mai senza guerra, dai cuori fluttuanti come il mare. I due frati bolognesi Catalano dei Malavolti e Loderingo degli Andalò furono tolti (nel senso di presi, eletti) come podestà dalla terra fiorentina nel 1266 per conservare la sua pace, ma si comportarono in modo che gli effetti del loro operato sono ancor visibili presso il Gardingo, dove erano le case degli Uberti distrutte a seguito della rivolta popolare scoppiata dopo il loro governo e da essi preparata. Si può notare che i due passi presentano altre simmetrie (prese costui e insieme presi, ’l modo ancor m’offende e ch’ancor si pare). L’episodio di Paolo e Francesca, inoltre, a differenza di quello di Catalano e Loderingo, si inquadra principalmente nel secondo stato, quello dei martiri. Dall’apertura del secondo sigillo proviene il tema dell’uccisione dei propri parenti e “vicini” da parte dei persecutori (la Caina che “attende chi a vita ci spense”, Inf. V, 107).
Quest’ultimo tema si ritrova appropriato a Obizzo II d’Este il quale, ucciso dal figliastro, sta immerso nel Flegetonte sanguigno tra i violenti contro il prossimo (Inf. XII, 110-112; di conseguenza, “Alessandro” sarà Alessandro Magno, del quale Dante poteva leggere in Orosio III, xvi, 3: “omnes cognatos ac proximos suos interfecit”). Nello stesso canto, gli può essere accostato anche l’accenno ad Arianna, la sorella del Minotauro che ammaestrò Teseo su come portargli la morte (ibid., 19-20).
È interessante notare la variante vicino che il codice riccardiano 1005 (Rb nell’edizione del Petrocchi) recava a Inf. XXVII, 88, riferito a Bonifacio VIII, “lo principe d’i novi Farisei”, il quale nella lotta contro i Colonna muove guerra non contro Saraceni o Giudei, “ché ciascun suo nimico era cristiano”: variante che il Petrocchi ritiene originata dall’espressione “presso a Laterano”, ma che, essendo il contesto pregno di temi del secondo stato, potrebbe fare riferimento alla persecuzione operata non verso estranei, ma nei confronti di parenti e di vicini, come per il papa sono i propri correligionari. La variante è stata poi corretta a margine in “nimico”.
(Tab. VII bis)
4.2. L’agone del dubbio, ovvero il moderno martirio (Inf. V, XXVII)
Secondo il principio della concorrenza tra gli stati, affermato nel notabile X del prologo della Lectura super Apocalipsim, il sesto stato della Chiesa – quello in cui vivono Olivi e Dante e che è iniziato con Francesco d’Assisi – concorre con il secondo, per antonomasia lo stato dei martiri, non per connessione temporale (questo inizia infatti con la persecuzione di Nerone o con la lapidazione di santo Stefano o con la passione di Cristo), ma a motivo della quantità dei testimoni della fede. Il tipo di martirio è tuttavia diverso. I martiri del sesto stato soffrono nel dubbio, il loro è un “certamen dubitationis” che i primi testimoni della fede non provarono per l’evidenza dell’errore in cui incorrevano gli idolatri pagani. Nel sesto stato il martire non prova soltanto il tormento del corpo, viene anche spinto (“propulsabuntur martires”) dalla sottigliezza degli argomenti filosofici, dalle distorte testimonianze scritturali, dall’ipocrita simulazione di santità, dalla falsa immagine dell’autorità divina o papale, in quanto falsi pontefici insorgono, come Anna e Caifa insorsero contro Cristo. Per rendere più intenso il martirio, i carnefici stessi operano miracoli. Tutto ciò appartiene alla tribolazione del tempo dell’Anticristo, alla tentazione che induce in errore persino gli eletti, come testimoniato da Cristo nella grande pagina escatologica di Matteo 24: “dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi (cfr. Mt 24, 24)”. Scrive Gregorio Magno, commentando Giobbe 40, 12 – “stringe (nel senso di tendere) la sua coda come un cedro” -: “ora i nostri fedeli fanno miracoli nel patire perversioni, allora i seguaci di Behemot faranno miracoli anche nell’infliggerle. Pensiamo perciò quale sarà la tentazione della mente umana allorché il pio martire sottoporrà il corpo ai tormenti mentre davanti ai suoi occhi il carnefice opererà miracoli” [13].
Del tema del martirio inferto dal dubbio è pregno, in Inf. V, l’episodio di Francesca e Paolo, d’altronde principalmente ordito su temi del secondo stato [14]. I “dubbiosi disiri ” vengono conosciuti mentre i due amanti leggono “di Lancialotto come amor lo strinse”, quella lettura “per più fïate li occhi ci sospinse”. Vinti dalla passione, essi non arrivano a sostenere fino in fondo il loro “certamen dubitationis”. Se è vero che al secondo e al sesto stato spetta il martirio e al tempo stesso la dolcezza del conforto e della promessa (ad Ap 3, 11), i “dolci sospiri” dei due amanti sono stati da loro male interpretati, nel senso dell’amore carnale e non dell’ “amore acceso di virtù” di cui Virgilio avrebbe parlato a Dante sulla montagna del purgatorio (cfr. Purg. XVIII, 13-75; XXII, 10-12). Al momento della prova, i due vengono sospinti dalla lettura di un libro (“Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse”) verso un punto che li vince, non diversamente da come i nuovi martiri vengono sospinti dagli “intorta testimonia scripturarum”.
Ma il martirio non è stato inferto solo ai “due cognati” in vita, perché anche Dante sta dinanzi alle loro anime come un martire del sesto stato: prova pietà del loro male perverso, è tristo e pio fino alle lacrime dinanzi ai martìri, prova un’angoscia che chiude la mente. Perfino la domanda di Virgilio dopo le prime parole di Francesca – “Che pense? ” – sembra ricalcare l’invito di Gregorio Magno a riflettere sulla singolarità della tentazione: “… tunc autem Behemot huius satellites, etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit humane mentis illa temptatio, quando pius martir corpus tormentis subicit, et tamen ante eius oculos miracula tortor facit”.
Il “punto”, nel quale Lancillotto (secondo Dante, che inverte il rapporto) bacia Ginevra, corrisponde falsamente all’ardua visione dello splendore del volto di Cristo, che riluce come il sole in tutta la sua virtù e che nel sesto stato deve raggiare in tutta la sua chiarezza, imprimendo in chi guarda un senso di tremore. La decima delle dodici perfezioni di Cristo come sommo pastore, proposte in apertura della prima visione apocalittica, consiste nell’incomprensibile gloria che deriva a Cristo dalla chiarezza e dalla virtù, per cui si dice: “e la sua faccia riluce come il sole in tutta la sua virtù” (Ap 1, 16). Il sole riluce in tutta la sua virtù nel mezzogiorno, quando l’aere è sereno, fugata ogni nebbia o vapore grosso. Allora il viso corporeo di Cristo ha incomparabilmente più luce e vigore, e ciò designa l’ineffabile chiarezza e virtù della sua divinità e della sua mente. Lo splendore del volto indica l’aperta e fulgida conoscenza della Sacra Scrittura, che deve raggiare in modo più chiaro nel sesto stato, prefigurata dalla trasfigurazione sul monte avvenuta dopo sei giorni e designata dall’angelo che, al suono della sesta tromba, ha la faccia come il sole (Ap 10, 1).
Strettamente connessa alla decima è l’undecima perfezione, ossia l’imprimere negli inferiori, di fronte a tante sublimità, un sentimento di umiliazione, di tremore e di adorazione, per cui Giovanni dice: “e vedendolo”, cioè tanto e tale, “caddi ai suoi piedi come morto” (Ap 1, 17). Bisogna intendere che cadde col viso a terra in atto di adorazione, perché il cadere supino è segno di disperazione. Il cadere è causato sia dall’intollerabile eccesso dell’oggetto visto, sia dall’influsso dell’angelo o dell’assistente divino che incute terrore e provoca un sentimento di mutazione, sia dalla materiale fragilità del soggetto o dell’organo visivo. Proprio il senso di intimo mutare rende colui che vede esperto del fatto che si tratta di una visione ardua, divina e derivata da cause supreme. Il sentirsi annullato predispone a ricevere le visioni divine in modo più umile e timorato, e significa che la virtù e la perfezione dei santi provoca tremore e umiliazione negli inferiori. Significa anche che l’ascesa alla contemplazione divina avviene unicamente tramite l’oblio, la negazione, la mortificazione di sé stessi e la privazione di ogni cosa.
I temi della decima perfezione formano l’armatura del “riso” di Ginevra, il “punto” della lettura del libro “galeotto” che “vinse” Francesca e Paolo. Esso si annida nella “claritas” e nello “splendor faciei” di Cristo. Nel sesto stato, allorché lo splendore del volto di Cristo diviene più lucente, come il sole, si verifica quanto scritto nel Cantico dei Cantici (Cn 8, 2), lì dove la sposa desidera l’amato in modo da poterlo baciare e introdurre nella casa materna. L’amato viene considerato come un fratello che succhia il seno della stessa madre, e per questo la sesta chiesa, Filadelfia, viene interpretata come “amore fraterno” (Ap 3, 7, unico luogo della Lectura che contenga un riferimento al baciare). Il tremare di Paolo è quello proprio di colui che contempla un’ardua e sublime visione (Ap 1, 17), il baciare deriva dalla sesta chiesa (Ap 3, 7), il riso corrisponde alla “claritas” e allo “splendor faciei” (Ap 1, 16). Il cadere come morto è appropriato a Dante il quale, venendo meno per la pietà verso i “due cognati”, cade “come corpo morto”: «(…) ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” – Quando leggemmo il disïato riso / esser basciato da cotanto amante, / questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto tremante. … E caddi come corpo morto cade» (Inf. V, 133-136, 142). Il cadere di Dante non è però disperato (la “mente”, chiusa per la pietà e confusa di tristezza per il peccato, torna poi alla ragione), non come quello del padre di Guido Cavalcanti, che “supin ricadde e più non parve fora” di fronte all’indugiare della risposta di Dante alla domanda se il proprio figlio sia ancora in vita (Inf. X, 72).
Gli strumenti di questo moderno martirio psicologico, la cui sofferenza sta nel dubbio su quale sia la vera fede, possono essere vari. Può trattarsi di una falsa Scrittura, oppure di una falsa immagine di autorità proveniente da un papa: “propulsabuntur martires … per intorta testimonia scripturarum sanctarum … Propulsabit etiam eos per falsam imaginem divine et pontificalis auctoritatis”. Il primo caso è quello di Paolo e Francesca, il secondo è quello di Guido da Montefeltro.
“Allor mi pinser li argomenti gravi / la ’ve ’l tacer mi fu avviso ’l peggio” (Inf. XXVII, 106-107). Guido da Montefeltro viene ‘spinto’ da gravi argomenti a dare a Bonifacio VIII il consiglio fraudolento su come prendere Palestrina, ossia dal fatto di avere dinanzi l’immagine dell’autorità pontificia, nel notabile X del prologo della Lectura assimilata ad Anna e a Caifa, che lo assolve ancor prima di peccare. Nel suo cuore si insinua il dubbio su quale sia la vera via di salvezza: resistere in nome di “quel capestro / che solea fare i suoi cinti più macri” oppure cedere all’autorità papale? Come Francesca e Paolo nell’interpretare i “dubbiosi disiri” d’Amore, che essi intesero solo in senso carnale, così anch’egli viene meno nel momento della prova, nella quale avrebbe dovuto mantenere ferma la professione della regola evangelica, accettata col farsi “cordigliero”. E forse non è casuale che il nome della donna – Francesca -, reale nella sua storicità ma significante, sia cantato con versi che danno mani e piedi all’esposizione teologica del martirio proprio dei tempi moderni, che affligge l’animo con il dubbio ingannatore più che il corpo con i tormenti, e che dovrà essere sostenuto dagli eletti degli ultimi tempi, i segnati dell’esercito di Cristo, i quali per Olivi altri non sono che i Francescani. Nel sesto stato ha infatti luogo la grande battaglia nella quale l’Anticristo viene sconfitto, ma essa è preceduta da segni mendaci intesi a ingannare anche i più esperti. Filadelfia, la sesta chiesa interpretata come “amor fratris” e come “salvans hereditatem”, depositaria del seme evangelico, viene lodata perché non ha negato il nome di Cristo nell’angustia della persecuzione (Ap 3, 8). Non negare il nome di Cristo non è cosa grande se non in una forte persecuzione, allorché si è spinti e quasi costretti a negare. Non negare significa confessare, in quanto tacere in questo caso è come negare. Così Guido, il quale ritiene peggior partito il tacere e non nega quanto gli viene chiesto, ma al “gran prete” confessa non il nome di Cristo e la regola evangelica, bensì la frode (Inf. XXVII, 106-111). Neppure Francesco potrà impedire che il diavolo “löico” ne porti a Minosse l’anima dopo la morte (ibid., 112-129) [15].
Nel discorso beffardo che Bonifacio VIII, vero carnefice dei nuovi martiri della Chiesa, fa a Guido, con l’inciso “però son due le chiavi / che ’l mio antecessor non ebbe care” (Inf. XXVII, 104-105) viene illuminata “l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto” (Inf. III, 59-60). Il papa, domandando consiglio al Montefeltrano, lo inganna agendo in nome della potestà conferitagli da quelle chiavi che forse aveva consigliato lui stesso a Celestino di non avere care. Di fronte agli argomenti distorti del pontefice e alla falsa immagine della sua autorità – elementi che contrassegnano il martirio del sesto stato, e lo differenziano da quello subìto dagli antichi cristiani nel secondo -, il francescano Guido, dando il consiglio fraudolento, cede e apre al Caetani la porta di Palestrina, come il papa angelico, cedendo con il gran rifiuto, gli ha aperto la porta del pontificato. In entrambi i casi, i due potenziali eletti – il Montefeltrano e Celestino V – non hanno saputo vincere le tentazioni “in angustia persecutionis” e salvare il seme della fede nella regola evangelica, aprendo la strada a colui che non temette di “tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio” (Inf. XIX, 55-57).
Il tema del “certamen dubitationis” subisce molte variazioni nella Commedia [16]. È accompagnato in vario modo dai motivi compresenti nel notabile X del prologo della Lectura: il tormento, gli occhi, il pensare, lo stringere, l’essere spinti, la sottigliezza, gli argomenti scritturali, l’immagine torta, la meraviglia.
Il tormento dei superbi, rannicchiati a terra sotto il peso dei macigni, provoca una “tencione” negli occhi di Virgilio, incerto se paiano o meno persone (Purg. X, 115-117).
Il vecchio dubbio di Dante sulla giustificazione per la fede (con la conseguente questione della salvezza degli infedeli giusti) viene sciolto nel cielo di Giove dall’aquila, che s’assottiglia su quel mistero, con riferimento all’autorità della Scrittura, senza la quale “da dubitar sarebbe a maraviglia” (Par. XIX, 32-33; 82-84). Si meraviglia il poeta nel sentire che Traiano e Rifeo Troiano sono beati: il “dubbiar … con la forza del suo peso” gli “pinse” le parole, “tempo aspettar tacendo non patio” (Par. XX, 79-84). Ma non è un perverso patire. L’aquila, “benedetta imagine” e “sacrosanto segno”, non è depositaria degli “intorta testimonia scripturarum sanctarum” che hanno ‘spinto’ gli occhi dei due amanti, né si nasconde “per falsam imaginem divine et pontificalis auctoritatis” dalla quale Guido è stato ingannato.
San Bernardo scioglie il dubbio, che annoda ‘stringendo’ i sottili pensieri del poeta, sulla differente distribuzione dei bambini nei vari gradi della rosa celeste (Par. XXXII, 49-51).
Tace il tema del dubbio, ma contiene molti altri motivi tratti dal notabile X (l’appello al lettore affinché rifletta, la pietà del martire che patisce tormentato da una falsa immagine, da qualcosa di distorto), la descrizione del pianto di Dante, nuovo martire, di fronte agli indovini che col capo stravolto camminano all’indietro nella quarta bolgia: è pianto che Virgilio riprende come sciocco, perché non è possibile che una passionata pietà franga il giudizio divino (Inf. XX, 19-30; i versi sono da confrontare con l’atteggiamento del poeta di fronte ai “due cognati” in Inf. V).
(Tab. VIII)
[Ap 1, 16-17 (Ia visio)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
La quarta perfezione di Cristo sommo pastore consiste nella reverenda e preclara maturità del consiglio, designata dalla senile e gloriosa canizie del capo e dei crini, per cui si dice: “il suo capo e i suoi capelli erano candidi come lana bianca e come neve” (Ap 1, 14) [17]. Il capo costituisce la cima della mente e della sapienza, i capelli designano la moltitudine e l’ornato dei sottilissimi e spiritualissimi pensieri e affetti, oppure la pienezza dei doni dello Spirito Santo che adornano la cima della mente. L’accostamento dei crini e del consiglio (tra l’altro non consueto), è ben conosciuto dal diavolo preparato in logica che argomenta con successo, di fronte a san Francesco, il suo diritto a prendersi l’anima di Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 115-117). Guido, arrivato alla vecchiaia, si era pentito delle proprie opere volpine e si era cinto del cordone, ma poi, dando a Bonifacio VIII il consiglio fraudolento su come conquistare Palestrina, si era rimesso nelle prime colpe, e da quel momento i suoi crini non sono stati più segno di maturità e di gloria celeste, per cui il diavolo dice: “perché diede ’l consiglio frodolente, / dal quale in qua stato li sono a’ crini”. Crini e consiglio sono accostati nei versi in senso negativo, all’opposto di quanto viene detto di Cristo.
La senile maturità del consiglio è invece reverenda in Catone, “veglio … degno di tanta reverenza in vista”, di fronte al quale Virgilio rende reverenti le gambe e il capo di Dante, la cui barba è mista di pelo bianco somigliante ai capelli (Purg. I, 31-35, 49-51). Catone, per la senilità e il biancore (Purg. I, 31, 34-35), è accostabile a Caronte (Inf. III, 83, 87, 97): “un veglio solo … Lunga la barba e di pel bianco mista” – “un vecchio, bianco per antico pelo … Quinci fuor quete le lanose gote” (unico riferimento alla “lana” nel poema). Anche per il traghettatore d’Acheronte i temi corrispondono a parte della quarta prerogativa di Cristo sommo pastore, di cui vengono citate le due vie, corrispondenti al calore della lana e al freddo della neve, entrambe volte alla punizione: “i’ vegno per menarvi a l’altra riva, / ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo”.
Al torpido e smarrito vescovo della quinta chiesa d’Asia, Sardi, Cristo minaccia che il giudizio divino verrà da lui come un ladro, che arriva di nascosto all’improvviso a prendere e a uccidere, senza che egli sappia l’ora della venuta (Ap 3, 3). Dice infatti san Paolo ai Tessalonicesi che “il giorno del Signore verrà di notte come un ladro. E quando diranno: ‘pace e sicurezza’, allora verrà su di loro una repentina distruzione” (1 Th 5, 2-3). Il tema del venire come un ladro si trova in un passo simmetrico, proprio della sesta delle sette coppe che vengono versate nella quinta visione (Ap 16, 15), dove si parla di un giudizio improvviso e subitaneo, sottolineato dall’avverbio “ecce” e dal presente “venio” al posto del futuro ‘veniam’ per togliere ogni possibile stima dell’indugiare e per rendere più attenti, vigili e timorati. Inoltre si definisce beato colui che vigila e custodisce le sue vesti, cioè le virtù e le buone opere, per non andar nudo, cioè spogliato di esse, sì che tutti vedano le sue sconcezze, cioè il suo peccato e la pena piena di confusione inflitta nel giorno del giudizio [18].
A Inf. XXVII, 127-129, il tema del “fur” è nel “foco furo” che fascia Guido da Montefeltro, che va “sì vestito” perché gli altri lo vedano (“et videant” / “là dove vedi”): sono tutti motivi da Ap 16, 15. Due terzine prima (ibid., 121-123), l’espressione “mi prese”, riferita al diavolo “löico” che argomenta contro Francesco, può essere ricondotta al “comprehendat” della citazione paolina di Ap 3, 3. A questo punto, considerato l’inciso dal medesimo luogo – “ac erronee credit et optat se diu in prosperitate victurum et Dei iudicium diu esse tardandum” -, può essere interessante la variante “forse tu non credevi ”, anziché “non pensavi”, nelle parole del diavolo, come proposto dal codice parigino (Bibliothèque nationale de France, codice italiano 539), manoscritto considerato dal Petrocchi uno dei capisaldi del ‘gruppo del Cento’ (naturalmente la questione richiede verifiche ben più approfondite, ma il confronto con la Lectura dell’Olivi deve servire anche sotto questo aspetto).
La terzina di Par. XXVIII, 115-117 è riferita al “secondo ternaro” delle gerarchie angeliche (Dominazioni-Virtù-Potestà), il quale germoglia in una primavera sempiterna “che notturno Arïete non dispoglia”, verso che congiunge il tema della notte della citazione paolina in Ap 3, 3 con quello dell’essere spogliato delle virtù in Ap 16, 15. Poiché da un punto di vista astronomico l’Ariete è visibile di notte in autunno, la terzina rinvia ad altra assai più antica, quella che in Inf. III, 112-114 descrive il volontario gettarsi nella barca di Caronte del “mal seme d’Adamo”: “Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie”. È da notare l’accostamento del vedere, appropriato al ramo, con lo spogliarsi, motivi non presenti nella reminiscenza virgiliana – “Quam multa in silvis autumni frigore primo / Lapsa cadunt folia …” (Aen. VI, 309-310) -, e che sono invece nell’esegesi di Ap 16, 15.
All’opposto, nelle parole con cui Bonaventura tesse l’elogio di Domenico, sono “le novelle fronde / di che si vede Europa rivestire”, aperte da Zefiro, dove i temi dell’aprire e dell’essere nuovo sono tipici del sesto stato (Par. XII, 46-48).
(Tab. IX)
5. La corona di Francia: un nido di locuste (Purg. XX)
Al suono della quinta tromba, dal pozzo dell’abisso aperto escono le locuste, le quali designano in particolare la prava moltitudine dei chierici, dei monaci, dei giudici e dei curiali che pungono e crucciano. Costoro escono dal fumo del pozzo in quanto traggono occasione di compiere il male dal pravo esempio indotto dal venire meno del freno prima esistente. Come le locuste, saltano verso l’alto con le zampe posteriori poiché hanno come fine la vanagloria e ricadono a terra per la cupidigia. Oppure saltano con le zampe posteriori poiché, proponendosi di fare penitenza alla fine, sperano così di saltare alla gloria eterna, mentre con le zampe anteriori e con la bocca aderiscono alla terra e rodono quanto è verde. Hanno le ali non disposte a un volo alto e diuturno, ma basso e di breve durata. Sono leggeri, volatili e cupidi. Essendo la locusta, secondo la vecchia legge, un animale mondo, qui designa gli ipocriti simulatori dell’umiltà, della purezza e del volo della contemplazione, che rodono la vita altrui con la maldicenza e ne divorano i beni temporali agendo sia in nome dell’autorità ecclesiastica, sia con il pretesto di un’offerta fatta ai santi, o di un lucro giustificato sotto apparenti opere di pietà, o con frode simoniaca o con falsi e iniqui giudizi o con empie esazioni (Ap 9, 3).
Nel quinto girone della montagna, gli avari purganti giacciono a terra bocconi con le mani e i piedi legati. Dicono il Salmo 118, 25 “Adhaesit pavimento anima mea”, e l’aderire alla terra è proprio delle locuste (Purg. XIX, 70-75). Come le locuste tardano a pentirsi e non volano in alto, così Adriano V si convertì tardi scoprendo “la vita bugiarda” una volta diventato papa (1276), considerando che nella vita terrena non si poteva salire più in alto (ibid., 106-111; “salir” rinvia fonicamente a “saliunt”, cioè al corto saltare delle locuste).
Sempre tra gli avari, Ugo Capeto descrive le malefatte della sua dinastia. Profetizza il tempo “che tragge un altro Carlo fuor di Francia” (Carlo di Valois) da cui “sanz’arme n’esce” nel 1301 per venire in Italia, inviato poi da Bonifacio VIII a Firenze come paciere. Così le locuste – cui sono applicati i verbi exire e trahere, il primo riferito all’uscire dal fumo del pozzo dell’abisso (anche l’altro Carlo, lo Zoppo, “già uscì preso di nave”, cioè fu sconfitto e fatto prigioniero dagli Aragonesi nel 1284), il secondo al cattivo esempio che le induce a compiere il male – si presentano pie, socievoli e semplici a quanti tentano di trarre a sé ma che poi trafiggono nel fianco (Ap 9, 5-6). E Carlo di Valois, armato solo della lancia di Giuda, cioè della frode, punge e fa scoppiare la pancia a Firenze (Purg. XX, 70-75). Poiché le locuste non solo trafiggono nel fianco, ma anche nelle mani e nei piedi, il loro trafiggere le mani avviene per la violenza della rapina e per la frode (Ap 9, 5-6), qualità che Ugo attribuisce alla sua “mala pianta” dopo che questa ebbe ricevuto nel 1246 “la gran dota provenzale”: “Lì cominciò con forza e con menzogna / la sua rapina”, per cui prese la contea di Ponthieu (“Pontì”, che quasi interno calembour concorda con il ‘pungere’ e con la lancia con la quale Carlo di Valois “ponta” Firenze), la Normandia e la Guascogna (Purg. XX, 64-66). Sulla sua discendenza Ugo Capeto chiede sùbita vendetta a Colui che tutto giudica a nome di Douai, Lille, Gand, Bruges vessate da Filippo il Bello (ibid., 46-48), come i santi del quinto stato dai quali, all’apertura del quinto sigillo, “expetitur instanter et alte iusta vindicta”. Anche le parole di Ugo Capeto sul presunto assassinio dell’Aquinate perpetrato da Carlo d’Angiò, che “poi / ripinse al ciel Tommaso, per ammenda” (Purg. XX, 68-69), sono da connettere allo scorpionale stimolo delle pungenti e subdole locuste, che con pio zelo intendono sottrarre i fedeli dall’errore e ricondurli sulla via della salvezza.
I temi delle locuste ricorrono con frequenza nella bolgia dei barattieri (la quinta). Nell’ “arzanà de’ Viniziani” vengono riparate le navi che non possono navigare, come le locuste non sono capaci di alto volo (Inf. XXI, 7-10). La pece bolle levandosi e gonfiandosi tutta per poi ricadere compressa, come il levarsi e il ricadere dei piccoli animali (ibid., 19-21). Esempio delle locuste “leves et volatiles”, il diavolo nero che porta sull’omero “un de li anzïan di Santa Zita” ha “l’ali aperte” ed è “sovra i piè leggero” (ibid., 33; cfr., a Purg. XX, 78, “quanto più lieve simil danno conta”, riferito a Carlo di Valois e, al v. 93, “portar nel Tempio le cupide vele” da parte di Filippo il Bello). I diavoli ‘escono’ contro Virgilio (come i cani “a dosso al poverello”: Inf. XXI, 67-70) al modo con cui ‘esce’ la mala pianta capetingia dei Carli. Ciampolo, nella gara con Alichino, ferma le piante a terra e salta (atteggiamento proprio delle locuste) sciogliendosi dal controllo di Barbariccia (che recita la parte del prelato incapace di freno), mentre tutti gli altri diavoli sono ‘compunti’ della propria colpa, ossia sono punti nella coscienza dal rimorso per aver lasciato andare il Navarrese (Inf. XXII, 121-124). Non solo le locuste sono tardive nel pentirsi (Ap 9, 3), ma la loro puntura provoca il rimorso nella coscienza nei fedeli caduti in gravi peccati (Ap 9, 5). Alichino, che già nel nome indica l’incapacità di grandi voli (il “declinare” è uno dei motivi del quinto stato), si getta a capofitto verso la pece, ma le sue ali non possono aver la meglio sulla paura di Ciampolo e così torna in su come un falcone “crucciato e rotto” che ha invano cercato di ghermire un’anatra nascostasi sotto l’acqua (ibid., 125-132). L’essere “crucciato”, nella tematica delle locuste, designa l’ira di chi ha ricevuto un danno e un’offesa (Ap 9, 5). Il cruccio non è solo di Alichino, ma anche di Calcabrina il quale, adirato per l’inganno, si azzuffa con Alichino. I due finiscono col cadere entrambi nella pece bollente dove – altra ricorrenza del tema dell’incapacità di volare delle locuste – le ali invischiate non consentono loro di levarsi (ibid., 133-144). L’ira dei Malebranche per il danno causato dalla beffa è motivo di preoccupazione nel pensiero di Dante una volta lasciata la fiera compagnia dei diavoli: costoro verranno dietro più crudeli del cane alla lepre che sta per azzannare (Inf. XXIII, 13-18; la crudeltà è, ad Ap 9, 8, attributo dei denti delle locuste; cfr., a Purg. XX, 91 “Veggio il novo Pilato sì crudele”, riferito a Filippo il Bello). Il drammatico passaggio alla sesta bolgia è reso coi motivi del sesto stato [19]. La tematica delle locuste è però assunta in senso positivo nella prima terzina del Purgatorio: “Per correr miglior acque alza le vele / omai la navicella del mio ingegno, / che lascia dietro a sé mar sì crudele”.
(Tab. X)
Alla fine del quinto stato saranno pubblicamente impugnati e condannati la vita e lo Spirito di Cristo. Questa tribolazione, che Olivi assegna agli uomini spirituali, viene trasferita da Dante all’oltraggio recato da Filippo il Bello a Bonifacio VIII (Purg. XX, 85-93). Ugo Capeto profetizza quanto succederà ad Anagni (1303) e lo dice “perché men paia il mal futuro e ’l fatto”, come la gravità dei mali del quinto stato cresce continuamente, fino alla consumazione finale (Ap 9, 3 ss.; esegesi della quinta tromba). Questi mali sono predetti e descritti dall’Apostolo nella seconda lettera a Timoteo (2 Tm 3, 1-6), lì dove parla dei tempi perigliosi che incombono sugli ultimi giorni, allorché ci saranno uomini pieni di ogni vizio che penetrano nelle case e catturano le “muliercule” (Ap 9, 5-6). Così il fiordaliso entra ad Anagni e cattura Cristo nel suo vicario. Come si afferma nell’esegesi dell’istruzione alla chiesa di Efeso, il vescovo, “immagine di Cristo”, ne fa le veci in quanto pastore e sposo della Chiesa fecondata e santificata dallo Spirito di Cristo (Ap 2, 7). Non a caso Ugo Capeto dice le lodi della Vergine Maria, “di quell’ unica sposa de lo Spirito Santo” (Purg. XX, 97-98), la quale, nella quarta visione della donna vestita di sole (Ap 12, 1-2), è la Vergine e nello stesso tempo la Chiesa, madre di Cristo e del suo corpo mistico, partorito con grande dolore. E Ugo, partecipe di questo corpo mistico, chiama Maria “così nel pianto / come fa donna che in parturir sia” (Purg. XX, 19-21; cfr., nel girone successivo, a Purg. XXIII, 10-12: “Ed ecco piangere e cantar s’udìe / ‘Labïa mëa, Domine’ per modo / tal, che diletto e doglia parturìe”, che rinvia anche all’esegesi di Ap 10, 9).
Le parole del capostipite dei Capetingi tessono, con i fili tratti dalla Lectura, una rappresentazione del nuovo calvario di Cristo. Il nuovo pianto per la morte in croce è tema della sesta coppa (Ap 16, 16), dove l’ “Armagedon”, il luogo della battaglia contro l’Anticristo, viene assimilato all’uccisione in Megiddo del re Giosia, pianto e lamentato da Geremia e da tutta la Giudea, lamento che prefigura quello per la morte di Cristo. Le ombre dei purganti che giacciono nel girone degli avari e dei prodighi piangono e si lagnano pietosamente (Purg. XX, 17-18). Ugo ripete per tre terzine il suo ‘vedere’ il futuro, come tre sono i “veh”, le tribolazioni minacciate al quinto stato ad Ap 9, 12 (come sono tre i regnanti capetingi censurati: Carlo I d’Angiò, Carlo di Valois, Carlo II) [20]. La struttura ternaria del pianto e del lamento è pure presente nel triplice “veh” che i re della terra dicono sulla caduta di Babilonia (Ap 18, 10) [21], e non è estraneo ad altri punti della Commedia, come nella dolente anafora della scritta sulla porta dell’inferno, nelle parole porte da Francesca, nella triplice ripetizione de “il luogo mio” detta da san Pietro nel cielo delle stelle fisse dove la condanna dell’indegnità personale di Bonifacio VIII non è, come si vedrà, in contraddizione con il pianto di Ugo Capeto sul male fatto ad Anagni dai suoi discendenti.
Nella descrizione della nuova crocifissione, l’esser deriso, il fiele e i ladroni (ma non il loro esser “vivi”, cioè carnefici impuniti e non compagni di supplizio, che è aggiunta tutta dantesca) si trovano nel florilegio con il quale san Bonaventura, nel Lignum vitae, aveva ridotto l’intero Vangelo a dodici frutti, che i devoti trovavano scritti e dipinti in alcune immagini del crocifisso e che Olivi riporta ad Ap 22, 2.
Nel quinto stato il re delle locuste, accostato al cinghiale della selva che distrugge la vigna di Dio (Salmo 79, 9-14), viene assimilato in quanto Anticristo mistico a Caifa, il pontefice che condanna Cristo, e a Erode, il re che se ne prende gioco (Ap 9, 11). Le tre tribolazioni, alla fine del quinto stato, concorreranno insieme come Sadducei e Farisei, Pilato ed Erode convennero insieme contro Cristo (Ap 9, 12). Gli aggettivi attribuiti a Filippo il Bello, “novo Pilato”, si ritrovano fra le caratteristiche delle locuste, che escono dal pozzo dell’abisso al suono della quinta tromba: la crudeltà, corrispondente all’empia rapacità verso le cose temporali (Ap 9, 8); la cupidigia e il volare, che insieme rendono le “cupide vele” con cui mette le mani sul Tempio (Ap 9, 3).
(Tab. XI)
[LSA, cap. IX, Ap 9, 1-12: IIIa visio, Va tuba]
[Ap 9, 3 ss.; IIIa temptatio] “De fumo” autem predicti casus et apertionis “putei exierunt locuste” (Ap 9, 3), id est religiosi illorum sequaces ac leves et volatiles et cupidi et carnales et ypocritales et detractores, qui et contra omnes eis non faventes animosissime concitantur quasi equi currentes in bellum (Ap 9, 7), et etiam contra omnia multum spiritalia contra que zelum acrem assumunt. “Vox” autem “alarum” (Ap 9, 9), id est suarum sententiarum quas altissimas et prevolantes esse presumunt, est sicut vox rotarum et tumultuosi exercitus currentis in bellum contra omnem sententiam contrariam quantumcumque veram.
|
|
Purg. XX, 17-18, 85-93:e io attento a l’ombre, ch’i’ sentia
|
[Ap 16, 16; Va visio, VIa phiala] Vel forte scriptura sacra voluit hoc bellum assimilare illi bello in quo rex Iosias est in Magedon occisus, prout dicitur IIII° Regum XXIII° (4 Rg 23, 29) et II° Paralipomenon XXXV° (2 Par 35, 20-25), ubi et dicitur quod Ieremias cum tota Iudea et Iherusalem vehementissime planxit eum et fecit lamentationes super eum, cui quidem planctui assimilatur planctus mortis Christi a tribubus Israel convertendis fiendus, prout dicitur Zacharie XII° (Zac 12, 11-14). Et secundum hoc, [huic] nom[ini] Magedon, quod interpretatur temptatio, adiungitur ar, quod interpretatur suscitatio vel vigilie; vel her, quod interpretatur vigilans vel consurgens vel effusio, ut sic scriptura insinuet quod in magno prelio Antichristi et regum suorum re[nov]abitur magnus planctus crucis Christi et martirum eius, et consurget magna effusio temptationis in qua diabolus Antichristus cum suis attente pervigilabit.[Ap 22, 2; VIIa visio] In septimo autem sunt: Ihesus spretus ab omnibus, scilicet cum dicunt: “Non hunc, sed Barrabam” (Jo 18, 40), et cum dicunt: “Crucifige eum” (Jo 19, 15),Ihesus cruci clavatus,
|
[Ap 9, 11-12] Rex autem harum locustarum recte vocatur “Exterminans” (Ap 9, 11), ut insinuetur esse ille de quo in Psalmo dicitur: “Vineam de Egipto transtulisti”, id est ecclesiam de statu gentilitatis eduxisti, “et plantasti eam; ut quid destruxisti maceriam eius, et vindemiant eam omnes qui pretergrediuntur viam. Exterminavit eam aper de silva” et cetera (Ps 79, 9/13-14), quasi dicat: multi heretici quidem transeuntes et pretergredientes viam intulerunt ecclesie dampna que ad tempus poterant tolerari, quia etsi perdebatur fructus, ipsa tamen in statu suo integra permanebat. Sed ille qui dicitur “aper de silva et singularis ferus” intolerabiliter “exterminavit eam”, ita ut non videatur esse vinea Dei sed potius sinagoga diaboli. Iste autem aper sepe dicitur misticus Antichristus, assimilatus Caiphe pontifici Christum condempnanti et Herodi Christum illudenti. Sequens autem aper, magnus scilicet Antichristus, assimilatur Neroni pagano imperanti toti orbi et Simoni mago dicenti se Deum et filium Dei.
|
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 1-2 (IVa visio, IVum radicale)] Quartum vero, huic annexum, est ad Christum tam verum quam misticum in eius spiritali utero conceptum et in gloriam pariendum fortis cruciatio. Unde de eius adornatione subditur (Ap 12, 1): “Et signum magnum apparuit in celo”, id est in celesti statu Christi, scilicet “mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius coronam stellarum duodecim”. De parturitionis autem cruciatu subditur (Ap 12, 2): “Et in utero habens et clamat parturiens et cruciatur ut pariat”.
|
Purg. XX, 19-21:e per ventura udi’ “Dolce Maria!”
|
Nel 1846 il benedettino cassinese Luigi Tosti – il celebre autore della Storia della Lega Lombarda nel 1848 e del libello La Conciliazione tra il nuovo Stato italiano e la Chiesa di Leone XIII nel 1887 [22] – dedicò la Storia di Bonifazio VIII e de’ suoi tempi a Dante, nell’intento conciliatorista di deporre le chiavi di Pietro sulla Divina Commedia. La condanna dell’offesa recata in Anagni al vicario di Cristo e a tutta la Chiesa era chiaro segno del superamento dell’odio nutrito dal poeta nei confronti della persona del papa: “Tu eri italiano / Perciò innanzi a Bonifazio / Che credesti nemico / E disonestasti di un vitupero eterno / Come è eterna la poesia che lo fabbricava / Chinasti riverente la fronte / E lo adorasti Vicario di Cristo”. I versi di Purg. XX, 85-93 sono stati sempre molto dibattuti: indicano una debita reverentia per Bonifacio VIII? Come si conciliano con l’accusa senza appello di usurpatore del sacro soglio fatta a Par. XXVII, 22-24 per bocca di san Pietro? Dante ha per un momento cambiato posizione nei confronti del Caetani, oppure intese distinguere tra l’ufficio sacro e inviolabile e la persona indegna? [23]
In quanto simoniaco, Bonifacio interpreta la Scrittura e la regola evangelica in modo distorto, alla stregua degli antichi eretici; un’eresia che i nuovi dottori (Virgilio e Dante) confutano imponendo la corretta interpretazione nella vera lingua che fu prima nella casa di Abramo e poi di Pietro. Gli viene appropriata, per bocca di uno dei suoi predecessori, Niccolò III, l’espressione di Ap 12, 14 – “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” – che, coinvolgendo anche l’Orsini e il guascone Clemente V, designa la durata della tribolazione (tre anni e mezzo) sotto il regno dell’Anticristo (l’undicesimo re di Daniele 7, 24-25) (Inf. XIX). Vestito con gli ornamenti carnali della meretrice apocalittica, e come questa insaziabile, sfrontato ed ebbro, istiga nell’antico peccato quasi fosse un nuovo Giuliano l’Apostata ripristinatore del paganesimo; nuovo Michele, “princeps angelorum” nella guerra apocalittica, non combatte però il diavolo e i pagani, ma fa la guerra ai cristiani, cioè ai Colonna; vero carnefice dei nuovi martiri della Chiesa, tormentati dal dubbio sulle verità di fede, inganna un frate (che pure avrebbe dovuto essere esperto di arti volpine) presentandosi con una falsa immagine di autorità pontificia e arrogandosi prerogative di Cristo sommo pastore (la potestà delle chiavi, l’essere Colui che tutto antecede e consuma) (Inf. XXVII).
Questa l’immagine di Bonifacio come traspare dal confronto con la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi, immagine che il pubblico degli Spirituali avrebbe dovuto intendere tramite le parole-chiave che dai versi sollecitano la memoria verso la dottrina apocalittica dell’Olivi, ben oltre il senso letterale che già di per sé disonestava il Caetani, come scritto dal Tosti.
In Purg. XX viene sottolineata la tracotanza dei Capetingi anche nei confronti della Chiesa e del papa. Ma quale idea di Chiesa e del papa aveva Dante? Se chi leggeva andava con la memoria al passo paolino – “sunt qui penetrant domos et captivas ducunt mulierculas / veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, / e nel vicario suo Cristo esser catto” -, doveva pensare alla Chiesa come “muliercula”, cioè poverella. Non era l’idea temporale della Chiesa di Bonifacio VIII, fondata sulla “plenitudo potestatis” e sullo “ius clavium”, venuta a conflitto con la rapacità dei Capetingi; era la Chiesa sotto il segno di Maria “povera”, chiamata dalle anime purganti “così nel pianto / come fa donna che in parturir sia” (vv. 19-24), la “donna vestita di sole” di Ap 12, 1-2, che tiene la luna (le cose temporali) sotto i piedi e designa la Chiesa primitiva, “la sposa di Cristo allevata del sangue” di Pietro, Lino, Cleto, Sisto, Pio, Callisto, Urbano (cfr. Par. XXVII, 40-45). Bonifacio (non nominato nel canto) non è dunque un “martire”, né nella persona né nell’ufficio; Dante non muta posizione su di lui; il martirio è semmai quello della vera Chiesa che Cristo lasciò a san Pietro, ora depredata dalla “maladetta lupa”, la cupidigia che ha annullato i valori del Cristianesimo (Purg. XX, 10-15). La lupa si è ammogliata non solo con gli uomini di Chiesa, per i quali viene ricordata Maria, ma anche con i curiali, cioè i regnanti, e per essi si menziona il buon Fabrizio, il console vincitore di Pirro morto in povertà (vv. 25-27).
Che regno e sacerdozio siano accomunati dalla cupidigia, e dalla punizione che su di essi sta per sopravvenire, lo dimostra un’altra citazione paolina (seconda lettera ai Tessalonicesi 2, 3; ad Ap 13, 18) incastonata nell’apostrofe alla lupa di Purg. XX, 13-15. Secondo Olivi con le parole “nisi venerit discessio primum” l’Apostolo intende dire che l’apostasia, il ‘discedere’ dall’obbedienza del vero papa per seguire il falso papa non eletto canonicamente, scismatico ed errante contro la verità della povertà e della perfezione evangelica, dovrà venire prima del ritorno di Cristo nella parusia. Dante, nel verso “quando verrà per cui questa disceda?” appropria il ‘discedere’ alla lupa e il ‘venire’ al Veltro. Questa discessio, scrive Olivi (Ap 13, 18), si verificherà secondo alcuni con il grande terremoto con cui si apre il sesto sigillo (Ap 6, 12) in concomitanza con la caduta del regno di Francia. Purg. XX si chiude con il terremoto sentito “come cosa che cada” e che fa tremare la montagna (vv. 124-141). Stazio spiegherà, moralmente, che il terremoto si verifica allorché un’anima purgante si sente monda e libera nella sua volontà di salire al cielo (Purg. XXI, 58-72). Tra l’invettiva contro la lupa e il terremoto sta Ugo Capeto, il quale chiede vendetta a Dio sulla “mala pianta” di cui fu radice (Purg. XX, 46-48), come i santi del quinto stato dai quali, all’apertura del quinto sigillo, “expetitur instanter et alte iusta vindicta” (Ap 6, 9) e che si rivolge ancora a Dio chiedendogli quando potrà godere la gioia di vedere attuata la vendetta per ora nascosta nel suo segreto, chiusa cioè fino a quando, nel sesto stato, verrà il giudizio della nuova Babilonia (ibid., 94-96). Il terremoto che scuote la montagna, al di là dei motivi dati da Stazio, è anche allusione alla prossima caduta del regno di Francia.
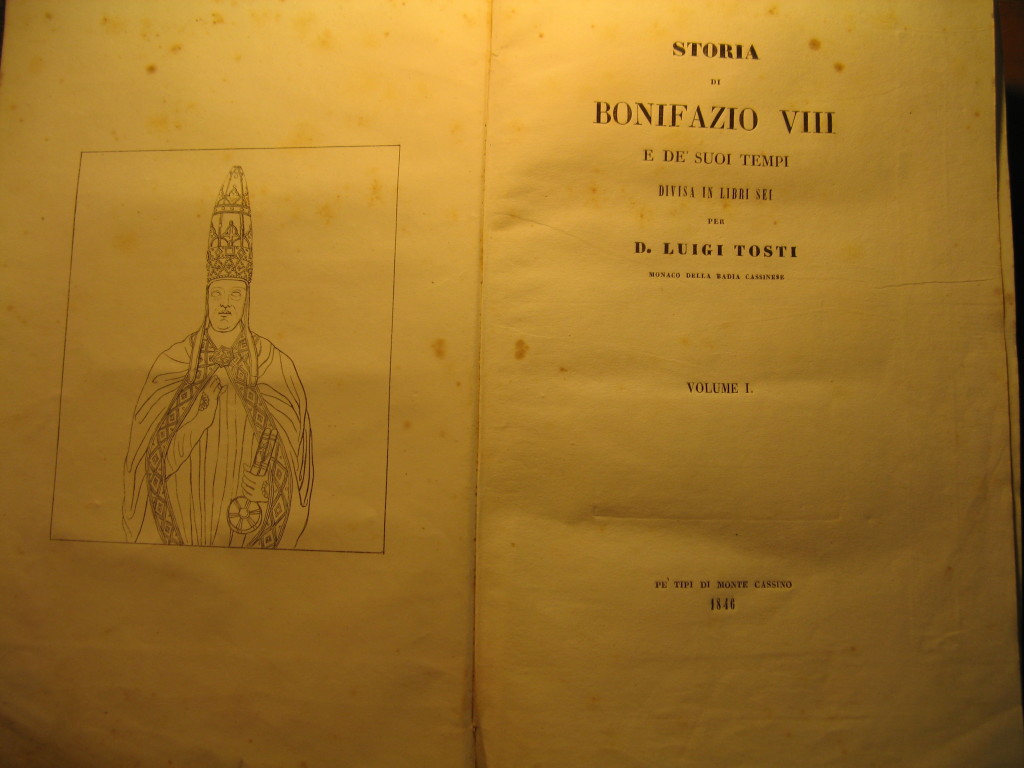
Luigi Tosti, dedica a Dante Alighieri della Storia di Bonifazio VIII e de’ suoi tempi (Monte Cassino, 1846)
6. La sede vacante (Par. XXVII)
Nel capitolo XI della Lectura si parla dei due testimoni dati da Dio, Enoch ed Elia, che verranno uccisi dalla bestia per poi risorgere dopo tre giorni e mezzo (corrispondenti a “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” di Ap 12, 14, ovvero ai tre anni e mezzo in cui regnerà l’Anticristo). Di essi si dice che “profetizzeranno vestiti di sacco”, cioè di cilici e di vesti povere e aspre, a significare l’austerità della loro vita religiosa (Ap 11, 3). Essi sono “due olivi” pingui di carità e ripieni dell’unzione divina e di soavità, e “due candelabri lucenti”, i quali spandono per tutta la Chiesa il lume della sapienza divina che portano in modo alto e preclaro, “che stanno nel cospetto del Signore”, cioè assistono sempre Dio sia per la singolare contemplazione che per il servigio di una pronta obbedienza e ossequio (Ap 11, 4). Secondo Gioacchino da Fiore, sia qui come in Zaccaria 4, 14 si dice di costoro “che stanno nel cospetto del Signore della terra” perché sono venuti per questo, e andranno davanti al volto di Cristo per annunziare la venuta di un tempo nel quale è necessario che il Figlio di Dio regni su tutta la terra, cosicché gli uomini siano illuminati come da candelabri luminosi e il cuore degli eletti venga unto dalla grazia e dalla dottrina spirituale come da lampade colme di olio santo. Con il “Signore della terra” può essere anche designato l’Anticristo, che allora dominerà da usurpatore la terra e i terreni, di fronte al quale i due resisteranno con costanza ammonendolo da parte di Dio, come fecero Mosè e Aronne di fronte al Faraone e Pietro e Paolo di fronte a Nerone.
Il tema dell’Anticristo che usurpa il dominio terreno si ritrova nel cielo ottavo, delle stelle fisse, allorché san Pietro pronuncia l’invettiva contro “quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, / il luogo mio, il luogo mio che vaca / ne la presenza del Figliuol di Dio” (Par. XXVII, 22-24). Si tratta di Bonifacio VIII, pontefice regnante nel 1300, e l’appellativo di usurpatore, nelle parole del principe degli apostoli che dichiara altresì essere vacante il suo seggio in terra, sembra alludere all’illegittimità dell’elezione del Caetani. Si può rispondere con Arsenio Frugoni, che le parole di Pietro non possono essere intese come denuncia di un’illegittimità canonica di Bonifacio, “ma bensì di un’indegnità totale di colui che ha tolto ‘a ’nganno / la bella donna’ e ne fa ‘strazio’ (Inf. XIX, 56-57), sicché per quell’alleato di Satana il Papato è di fatto vacante, anche se così non appare agli uomini, nel giudizio del Figlio di Dio” [24].
Dante non entra nel dibattito se la rinuncia di Celestino V sia stata canonicamente possibile (l’Olivi, è noto, la considerò tale in una celebre quaestio); il “gran rifiuto” che lo condanna fu quello di un eletto del sesto stato della Chiesa che, trovandosi nell’angustia della persecuzione dei nuovi martiri, lì dove era chiamato a testimoniare la regola evangelica dal suo alto stato, si sentì inadeguato. Ingannato, forse, da quello stesso Caetani che poi da papa avrebbe ingannato Guido da Montefeltro, altro eletto (perché si fece francescano in tarda età) decaduto nella prova del dubbio [25].
Al passo di Ap 11, 4, relativo ai due testimoni e al loro stare “in cospetto del Signore della terra” (che può essere il Figlio di Dio oppure l’Anticristo), rinvia pure lo stare di Francesco, assetato di martirio, “ne la presenza del Soldan superba” ove “predicò Cristo e li altri che ’l seguiro” (Par. XI, 100-102). Che il Sultano sia inteso come “Dominus terre” si ricava anche dalle parole di Virgilio relative a Semiramìs (“tenne la terra che ’l Soldan corregge”, Inf. V, 60) [26]. I due testimoni “verranno per questo”, cioè per stare in presenza di Cristo “Dominus terre” e per annunciare essere prossimo il tempo in cui il Figlio di Dio regnerà sull’universa terra: il tema entra nella narrazione che Bonaventura fa della vita di Domenico: “Spesse fïate fu tacito e desto / trovato in terra da la sua nutrice, / come dicesse: ‘Io son venuto a questo’ ” (Par. XII, 76-78). D’altronde ad Ap 11, 4 (passo in collazione con Ap 10, 1) conduce anche Par. XI, 35-36, dove si parla appunto dei due principi – Francesco e Domenico – ordinati dalla Provvidenza a guida della Chiesa, come nell’esegesi si dice (Ap 10, 1) che Dio ha ordinato uomini angelici che illuminano gli inferiori e (Ap 11, 4) che i due testimoni, Enoch ed Elia, sono due candelabri luminosi che stanno al cospetto di Dio, come due principi e consiglieri stanno e incedono uno a destra e uno a sinistra al cospetto di un gran re.
Il tema del vacare moralmente dinanzi a Dio è presente ad Ap 3, 1-2. Il vescovo di Sardi, la quinta delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione, viene rimproverato di avere fama di essere giusto e di vivere la vita della grazia, mentre invece è morto per colpa mortale: “nomen habes quod vivas et tamen mortuus es”. Viene invitato a vigilare e a confermare le sue opere che stanno per estinguersi, per cui Cristo gli dice: “non trovo le tue opere piene di fronte a Dio” cioè, spiega Olivi, anche se dinanzi agli uomini appaiono piene di virtù e di carità, vacano (nel senso di ‘sono vuote’) di fronte a Dio. Così per Boni facio, pontefice legittimo per i terreni ma non per Dio, singolarmente consonante nel nome con l’esegesi relativa al vescovo della quinta chiesa, “quia habebat nomen boni cum esset malus”. I versi pronunciati da san Pietro cuciono insieme i temi della quinta chiesa – l’essere le opere vacanti “coram Deo” – con quelli della sesta tromba da Ap 11, 4 – i due testimoni che stanno “in conspectu Domini terre” -, presente quest’ultimo con la duplice appropriazione all’usurpatore Anticristo (“Quelli ch’usurpa in terra”) e a Cristo (“ne la presenza del Figliuol di Dio”).
La Commedia è un viaggio nella storia umana, manifestazione dei segni di Dio, che attuano in terra la sua volontà provvidenziale: “divina voluntas per signa querenda est” (Monarchia II, ii, 8). Per questo san Pietro ‘concepisce’ il soccorso da un nuovo Scipione contro la Chiesa corrotta dei Caorsini e Guaschi, riaffermando i valori della Chiesa primitiva, della milizia che lo seguì, i cui cimiteri divennero “parti elette” di Roma e ora son fatti “cloaca del sangue e de la puzza” (Par. IX, 139-142; XXVII, 25-26, 40-63). Valori francescani applicati all’humana civilitas, “per una vera identità cristiana della società europea” [27], totalmente dissonanti dal disegno politico di Bonifacio VIII. Ma come fallì la teocrazia bonifaciana, la concezione del potere di “un homme qui a senti mourir en lui la foi du moyen âge” [28], così non si realizzò l’idea dantesca di una riforma religiosa e politica alla quale il suo “poema sacro” avrebbe dovuto cooperare, indirizzato intimamente a un pubblico di predicatori spirituali, che in esso avrebbero letto la metamorfosi e l’aggiornamento, secondo le esigenze del saeculum humanum, della concezione oliviana della storia espressa nella Lectura super Apocalipsim. Quel pubblico non si formò; gli Spirituali furono perseguitati e il loro libro-vessillo condannato nel 1326. Auerbach osservava che l’opera di Dante fu il punto di arrivo di uno sviluppo che si interruppe con lui: “Nessuno ha potuto continuare o completare la costruzione del mondo e della storia contenuta nella sua opera, perché quella costruzione crollò”. Venne a mancare il giudizio di Dio che attualizza, ordina e rende eterna la tragicità con cui Dante aveva inserito l’individuo nell’ordine universale: “Più tardi l’individuo è solo, e la sua tragedia finisce con la sua vita” [29]. Crollò, in quell’ ‘autunno del Medioevo’, anche la Lectura super Apocalipsim, perché oggetto di una persecuzione senza pari, e perché venne meno il senso di una storia della salvezza collettiva.
La situazione di Bonifacio VIII è parzialmente illuminata da altro luogo del poema. Si tratta della descrizione della cascata del Flegetonte che precipita dal settimo all’ottavo cerchio infernale. Il fiume di sangue è paragonato al Montone che all’inizio, nel suo alto corso, “prima dal Monte Viso ’nver’ levante, / da la sinistra costa d’Apennino” ha proprio cammino e proprio nome (Acquacheta; ad Ap 3, 4 il “proprium nomen” è il “proprium donum gratie” dato a ciascuno), nome che diventa “vacante” allorché il fiume, dopo la cascata di San Benedetto dell’Alpe, è sceso nella piana di Forlì e si chiama appunto Montone (Inf. XVI, 94-105; cfr. a Purg. V, 97 le parole di Buonconte da Montefeltro sullo sfociare in Arno dell’ “Archian rubesto”: “Là ’ve ’l vocabol suo diventa vano”). Questi versi di apparente indicazione geografica sono in realtà pregni di motivi spirituali. Il tema principale è la caduta rovinosa (la cascata) del fiume, corrispondente al precipitoso rovinare nella fase estrema del quinto stato condescensivo e rilassato. Così il fiume ha dapprima un nome di vita, “avante / che si divalli giù nel basso letto” (prima che ‘condiscenda’), e poi lo perde, come la chiesa di Sardi ha avuto un principio bello e poi l’ha perduto ritrovandosi con un nome vacante di fronte a Dio. Tutta la zona che precede la descrizione della cascata del Flegetonte – i sodomiti – è pervasa dai temi del quinto stato (da notare le ultime parole di ser Brunetto ad Inf. XV, 119-120: “Sieti raccomandato il mio Tesoro, / nel qual io vivo ancora”, cioè ho nome). Nel burrone in cui precipita il Flegetonte Virgilio getta la corda della quale Dante era cinto, e questo è “novo cenno” – che segna il passaggio al sesto stato -, per cui Gerione viene di sopra per portare Dante in volo nel fondo di “quell’alto burrato”, ubbidendo al comando di Virgilio che lo ha ‘fatto venire’, come Cristo promette alla sesta chiesa che le farà venire quelli della sinagoga di Satana, per sottoporli al suo magistero (Ap 3, 9) [30].
Se il ‘vacare’ della sede romana è un filo tratto dall’esegesi della quinta chiesa, la quale ebbe un principio bello poi corrottosi rendendo il proprio nome vacuo di fronte a Dio, l’intenzione di san Pietro non è di dire che Bonifacio VIII è stato eletto in modo illegittimo, ma che si è reso apostata da quell’alto stato (che pertanto “usurpa” occupandone il “luogo”), come l’apostata Anticristo il quale, precisa Olivi ad Ap 13, 11, non sarà educato ed edotto dal diavolo fin dall’infanzia o dal ventre materno ma, nuovo Lucifero, sarà apostata e cadrà di sua volontà dall’altissimo e giustissimo stato in cui era stato creato.
(Tab. XII)
[LSA, cap. III, Ap 3, 1-2/4 (Ia visio, Va ecclesia)] Talem ergo se proponit huic episcopo, quia habebat nomen boni cum esset malus, nec videbatur futurum iudicium formidare, et etiam quia Christus ostendit se nosse quosdam sanctos huius ecclesie occultos et paucos, tamquam omnibus spiritualiter presens et omnia potestative continens. […] Increpans ergo eam dicit: “Scio opera tua” (Ap 3, 1). Non ponitur hic “scio” pro ‘approbo’ sicut in precedentibus ponebatur, sed solum pro illa scientia qua infallibiliter scit omnia mala. “Quia nomen habes quod vivas”, id est famam habes in vulgo quod sis iustus et per vitam gratie vivus, “et tamen mortuus es”, scilicet per culpam mortalem. Vel si erat aperte malus, est sensus quod habebat nomen christiani, quod est nomen vite sancte, non tamen habebat rem eius sed potius oppositum, scilicet mortem culpe. […]
|
||
Inf. XV, 119-120:Sieti raccomandato il mio Tesoro,
|
Inf. V, 58-60:Ell’ è Semiramìs, di cui si legge
|
|
7. Il nuovo Giovanni (Par. XVII, XXVII)
«Segue: Poi la voce […] che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: “Va’, prendi il libro aperto dalla mano dell’angelo che sta ritto sul mare e sulla terra”. Allora mi avvicinai all’angelo e lo pregai di darmi il libro (Ap 10, 8-9). […] Segue: “Ed egli”, cioè l’angelo, “mi disse: Prendilo e divoralo; ti riempirà di amarezza il ventre”, cioè provocherà torsioni amare nel tuo ventre oppure una volta nel ventre provocherà esalazioni amare verso la bocca, “ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi il libro” e così via (Ap 10, 9-10). Nota che non dice “leggi” ma “divora”, né dice “vedi” ma “prendi” perché il fervidissimo e rapido affetto e gusto della devozione vuole masticare, assaporare, giungere all’intimità dei sensi spirituali e delle intelligenze del libro. Vuole anche che sia preso in mano, cioè che sia applicato e osservato nelle opere affinché compia nella pratica quanto viene insegnato nel libro. La contemplazione di questo libro è dolce alla bocca, cioè al gusto spirituale; riempie tuttavia di amarezza il ventre perché conduce all’amarezza della fatica e della passione. Per quanto infatti la chiara contemplazione delle future passioni sia soave per la mente, tuttavia nell’esperienza della fatica vi è gemito e afflizione di spirito; nulla di sconveniente quindi se, sotto diversi aspetti, sia insieme dolce e amara; come anche la passione di Cristo in quanto trionfale e per noi salubre ci è dolce, ma in quanto trafigge le nostre viscere per la compassione ci è amara. Segue: “Allora mi fu detto: devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue, re” (Ap 10, 11). Nella stessa sapienza del libro è espressamente affermata la necessità che il Vangelo sia predicato nuovamente in tutto il mondo, ai Giudei e ai Gentili, e che tutto il mondo alla fine sia convertito a Cristo. Ma che la predicazione e la conversione universale debba essere compiuta attraverso Giovanni lo si può sapere solo per una rivelazione spirituale, interpretando qui con Giovanni delle singole persone; se invece con Giovanni si intende un ordine evangelico e contemplativo, allora la stessa intelligenza del libro ci mostra che sarà esso a compiere la predicazione e la conversione universale. Si può anche dire che [Giovanni], nel momento stesso in cui per ispirazione e ordine di Dio riceve dall’angelo la particolare intelligenza del libro e la inviscera in sé stesso con singolare dolcezza e per questo preavverte con dolore le gravi passioni riservate in futuro a lui e alla Chiesa, comprende a sufficienza di essere destinato alla predicazione delle genti; ma, ciò nonostante, questo viene asserito più ampiamente dai sacri dottori perché non temano che ciò sia impedito dalla tentazione dell’Anticristo e dall’eccessiva moltitudine dei nemici. Si può anche affermare che questo è detto piuttosto precettivamente, ingiungendogli l’officio di predicare a tutti, per quanto infedeli o lontani (per cui dice: “Devi profetizzare ancora” e così via); per quanto si può anche dire che ciò è necessario rispetto all’infallibilità della prescienza divina e della predestinazione e rispetto alla finale necessità e utilità della conversione delle genti per mezzo della sua parola» [31].
Passo capitale quello che, ad Ap 10, 9-11, riguarda l’ingiunzione dell’angelo a Giovanni di predicare ancora a tutto il mondo dopo gli apostoli. Esso dovette dare a Dante la consapevolezza della propria missione nello scrivere una vera visione e permettergli la libertà di usare parole gravi anche nei confronti dei papi. Al passo rinvia il momento in cui Dante ascolta da Cacciaguida il suo futuro destino e le vicende dolorose dell’esilio, e gusta insieme l’amaro del suo futuro patire con il dolce della fama che gli è riservata. Questo essere dolce e amaro non è solo nel gusto di Dante che ascolta le parole dell’avo, ma pure negli effetti del libro, molesto nel primo gusto ma poi salutare. Come ai nuovi predicatori del sesto stato viene confermato dai sacri dottori il loro essere destinati alla predicazione universale in modo che non temano di venirne impediti dalla moltitudine dei nemici, così Cacciaguida invita Dante a non essere “timido amico” del vero e a manifestare senza timore tutta la sua visione, nonostante i molti che si troveranno ad avere “coscïenza fusca / o de la propria o de l’altrui vergogna” (Par. XVII, 124-142).
L’alternanza del dolce e dell’amaro percorre l’intero episodio: la vista del tempo che si prepara per il suo discendente viene a Cacciaguida dal “cospetto etterno”, cioè dalla prescienza divina, come “dolce armonia da organo” (Par. XVII, 43-45), ma nell’esperienza Dante dovrà provare “sì come sa di sale / lo pane altrui” (ibid., 58-59). L’inferno è “lo mondo sanza fine amaro”, per esso e per gli altri due regni il poeta ha appreso cose che, se ripetute, “a molti fia sapor di forte agrume” (ibid., 112-117). Alla fine delle parole di Cacciaguida, Dante “gustava” il suo pensiero “temprando col dolce l’acerbo” (Par. XVIII, 2-3). Nel caso della voce che “sarà molesta nel primo gusto”, ma “vital nodrimento / lascerà poi, quando sarà digesta” (Par. XVII, 130-132), l’esegesi oliviana arma quanto afferma Boezio sulle verità che mordono se gustate, per poi diventare dolci una volta ricevute dentro (De cons. phil., III, 1).
Varianti del tema sono “lo dolce assenzo d’i martìri” dei gironi del Purgatorio, al cui bere Nella ha condotto il marito Forese liberandolo con le sue preghiere dalla costa dove aspettano i negligenti nel pentimento (Purg. XXIII, 85-87); il legno dell’albero simbolico dell’Eden, dolce al gusto ma che fa poi torcere il ventre (Purg. XXXII, 43-45, con effetto contrario a quello del libro dato a Giovanni, che prima provoca contorsioni amare e poi risulta dolce; Adamo, a Par. XXXII, 121-123, “è ’l padre per lo cui ardito gusto / l’umana specie tanto amaro gusta”).
Il tema delle future gravi passioni cui sarà soggetta la Chiesa passa nelle “parole gravi” dette a Dante sulla sua “vita futura” nel corso del viaggio (Par. XVII, 22-23), nel gravare le spalle dell’esule da parte dei suoi compagni di parte bianca (ibid., 61-63), nelle parole di conforto di Beatrice, la quale sta “presso a colui ch’ogne torto (le “tortiones amare”) disgrava” (Par. XVIII, 4-6). È anche il tema che accompagna la descrizione di Giovanni che siede di lato a Pietro nella rosa celeste: “quei che vide tutti i tempi gravi, / pria che morisse, de la bella sposa / che s’acquistò con la lancia e coi clavi”, dove il riferimento alla lancia non può non far pensare all’Olivi, che contro l’opinione corrente sostenne essere stata la causa della morte di Cristo (Par. XXXII, 127-129; per Dante Cristo era ancora vivo allorché il colpo venne vibrato, come afferma lo stesso Tommaso d’Aquino a Par. XIII, 40-41: “e in quel che, forato da la lancia, / e prima e poscia tanto sodisfece”).
Sublimazione della tematica, nell’Empireo gli angeli – “moltitudine volante” che non “impediva la vista e lo splendore” – s’interpongono tra Dio e i beati (i petali della rosa) “sì come schiera d’ape che s’infiora / una fïata e una si ritorna / là dove suo laboro s’insapora”, vanno cioè, come il libro nei suoi effetti, dalla fatica al dolce gustare (Par. XXXI, 7-9, 19-21).
“Et dixit michi: Oportet te iterum prophetare in gentibus et populis et linguis et regibus multis”. Dante, alter Iohannes, evangelista degli ultimi tempi – già “sesto tra cotanto senno” in compagnia dei sommi poeti del Limbo -, riceve da Cacciaguida l’ingiunzione di predicare al mondo col rendere manifesto quanto gli è stato mostrato nel corso del viaggio e che egli ha notato nel suo poema sacro, nuova Apocalisse. L’ingiunzione verrà confermata da san Pietro nell’ottavo cielo, delle stelle fisse: “e tu, figliuol, che per lo mortal pondo / ancor giù tornerai, apri la bocca, / e non asconder quel ch’io non ascondo” (Par. XXVII, 64-66). Il passo di riferimento si trova ad Ap 22, 10, nel comando di divulgare la dottrina profetica in quanto utile e necessaria agli eletti, anche se nociva a molti per la loro malizia. Il versetto successivo (Ap 22, 11), dove si afferma che a chi si trova nelle brutture a causa della sua malizia è bene sia permesso di lordarsi ancor più, può essere all’origine delle brusche parole di Cacciaguida: “e lascia pur grattar dov’ è la rogna” (Par. XVII, 129). San Pietro, infine, nel rivolgersi a Dante usa quell’avverbio “ancor” che se è riferito all’essere il poeta un mortale che deve di nuovo tornare sulla terra, sembra bene alludere all’ “iterum” detto dall’angelo un tempo a Giovanni e ora agli spirituali del sesto stato della Chiesa (che si tratti di un ordine di contemplativi evangelici o di “singulares persone”) perché predichino ancora, dopo gli apostoli, a tutto il mondo quanto scritto nel libro loro aperto e consegnato, da essi divorato con dolore e con dolcezza.
(Tab. XIII)
Inf. XXVII, 7-12Come ’l bue cicilian che mugghiò prima
|
Purg. XXX, 40-54, 79-81Tosto che ne la vista mi percosse
|
[LSA, cap. X, Ap 10, 9-11 (IIIa visio, VIa tuba)] Sequitur (Ap 10, 9): “Et dixit michi”, scilicet angelus: “Accipe librum <et> devora illum, et faciet amaricar<i> ventrem tuum”, id est faciet tortiones amaras in ventre tuo, vel postquam erit in ventre faciet versus os exal<at>iones amaras, “sed in ore tuo erit dulce tamquam mel. (Ap 10, 10) Et accepi librum” et cetera. Nota quod non dicit ‘lege’ sed “devora”, nec dicit ‘vide’ sed “accipe”, quia <per> superfervidum et rapidum devotionis affectum et gustum vult libri spiritales sensus et intelligentias masticari et saporari et ad intima trahici. Vult etiam illum per manum accipi, id est in operibus poni et servari, ut scilicet opere impleat ea que in libro docentur. Huius autem libri contemplatio est dulcis ori, id est spiritali gustui, facit tamen amaricari ventrem quia ducit ad amaritudinem laboris et passionis. Quamvis enim preclara contemplatio futurarum passionum sit suavis menti, in experientia tamen laboris est gemitus et afflictio spiritus. Nichil etiam inconveniens si secundum diversos respectus sit simul dulcis et amarus, sicut et Christi passio in quantum triumphalis et nobis salubris est nobis dulcis, in quantum autem nostra viscera per compassionem transfigit est nobis amara.
|
|
Par. XVII, 22-23, 43-45, 58-63, 112-114dette mi fuor di mia vita futura
|
Par. XVII, 116-120, 127-132ho io appreso quel che s’io ridico,
|
[Ap 22, 10-11; finalis conclusio totius libri] Sextum est <iussio> de propalando doctrinam propheticam huius libri, tamquam scilicet utillimam et necessariam electis et tamquam certam et gloriosam et Christum et eius opera clarificantem et magnificantem. Unde subdit (Ap 22, 10): “Et dixit michi”, scilicet angelus: “Ne signaveris”, id est non occultes nec sub sigillo claudas, “verba prophetie huius libri”, subditque huius duplicem rationem.
|
|
Dante, alter Iohannes, si fregia anche delle prerogative dell’angelo che sale da oriente (“ascendens ab ortu solis”) all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 2). Tema così importante, che lo si ritrova già nei primi versi del poema [32]. Segna la salita di Dante al “dilettoso monte”, “quasi al cominciar de l’erta”, lì dove la lonza gli impedisce il cammino: l’ora è il “principio del mattino” (“in primo suo adventu”, “reascendit usque ad illud mane”); il sole sorge (“montava ’n sù” rende “ascendens”) nel segno primaverile dell’Ariete, costellazione che si riteneva occupasse anche al momento della creazione, “quando l’amor divino / mosse di prima quelle cose belle” (Inf. I, 37-40).
Secondo Gioacchino da Fiore, l’angelo designa un momento di gaudio e di quiete tra due tribolazioni, cioè tra la caduta di Babylon e il combattimento della bestia e dei re della terra contro colui che siede sul cavallo bianco (Ap 19, 19). San Pietro, dice l’abate calabrese citato da Olivi ad Ap 7, 2, ha trascorso una notte senza pescare, e ciò indica la prima tribolazione: Dante ha trascorso nella selva oscura una notte d’angoscia, “la notte ch’i’ passai con tanta pieta” (Inf. I, 21). Al mattino Pietro celebra il banchetto dopo la pesca miracolosa, e ciò indica il gaudio che segue la notte: arrivato al termine di “quella valle / che m’avea di paura il cor compunto”, il poeta quieta la sua paura nel vedere le spalle del colle “vestite già de’ raggi del pianeta / che mena dritto altrui per ogne calle” (ibid., 13-21); riposa un poco “il corpo lasso” prima di riprendere la via (ibid., 28); di fronte alla prima fiera è animato da buona speranza a motivo de “l’ora del tempo e la dolce stagione” (ibid., 41-43). Consumato il banchetto, Pietro sente Cristo che gli dice “seguimi”, cioè verso la croce (cfr. Giovanni 21, 3-19), e questo indica la seconda tribolazione, perché incomincia subito il combattimento della bestia e dei re della terra contro Cristo: Dante, impedito definitivamente dalla lupa nella salita del “dilettoso monte”, viene invitato da Virgilio, nel frattempo apparsogli nella “diserta piaggia”, a seguirlo “per loco etterno; / ove udirai le disperate strida, / vedrai li antichi spiriti dolenti, / ch’a la seconda morte ciascun grida” (ibid., 112-117), un viaggio che il poeta accetta e al quale si prepara per “sostener la guerra / sì del cammino e sì de la pietate, / che ritrarrà la mente che non erra”, cioè nella vera scrittura, come fu quella di “Livïo … che non erra” (Inf. II, 3-6, 8; cfr. Inf. XXVIII, 12).
Il motivo del seguire Cristo da parte di Pietro è rinfacciato dallo stesso Dante al simoniaco Niccolò III (Inf. XIX, 90-93). Dante sta di fronte al papa simoniaco come sta un dottore della Chiesa, che possiede la verità evangelica scritta e imposta da Cristo, di fronte a un eresiarca; parla a un pontefice romano in quanto depositario di quella “prima et vera lingua et confessio fidei” che avrebbe dovuto essere custodita “in domo Petri” (e Virgilio partecipa di quest’alto patrimonio nell’imporre al discepolo la retta risposta, come Cristo impose ai discepoli la regola evangelica).
Dante, nell’ascendere la montagna, porta sulla fronte i segni descritti dall’angelo portiere [33]. Questi segni sono piaghe, come quelle portate da Francesco, angelo del sesto sigillo “ascendens ab ortu solis”, negli ultimi suoi due anni (Par. XI, 106-108): «Et precipue gloriosissimis stigmatibus sibi a Christo impressis patet ipsum fore angelum apertionis sexti signaculi “habentem signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi, et etiam signum totalis transformationis et configurationis ipsius ad Christum et in Christum» (Ap 6, 12); «[…] e “Fa che lavi, / quando se’ dentro, queste piaghe” disse». (Purg. IX, 113-114). Di questi segni parla Virgilio a Stazio: «E ’l dottor mio: “Se tu riguardi a’ segni / che questi porta e che l’angel profila, / ben vedrai che coi buon convien ch’e’ regni. … l’anima sua, ch’è tua e mia serocchia, / venendo sù, non potea venir sola, / però ch’al nostro modo non adocchia”» (Purg. XXI, 22-30). Segni di configurazione della propria vita – “la conocchia / che Cloto impone a ciascuno e compila” (ibid., 26-27) – in quella di Cristo, del quale la Parca è ancella: “[…] eius singularis et exemplaris vita, quam apostolis imposuit et in se ipso exemplavit et in libris evangelicis sollempniter scribi fecit”.
(Tab. XIV)
8. Una ‘debita reverentia’ per le somme chiavi? (Inf. XIX, Purg. XIX).
Nella Lectura la riverenza di Giovanni verso l’angelo viene considerata in due punti distinti. Nel primo (Ap 19, 10), riferito al sesto stato (nella trattazione della festa nuziale che si tiene dopo la distruzione di Babylon), l’angelo vieta a Giovanni, che designa i discepoli spirituali che riveriscono in sommo grado i propri santi dottori e in particolare quelli che promettono cose alte e gloriose, di riverirlo e adorarlo non come una creatura adora Dio, ma cadendogli ai piedi come un servo onora il suo padrone creato con servile soggezione: “Allora caddi dinanzi ai suoi piedi per adorarlo”. L’angelo non tollera questo tipo di adorazione (anche se la tollerava nell’Antico Testamento) e ingiunge a Giovanni di non farlo: “ma egli mi disse: Non farlo! Sono conservo tuo”, cioè con te e come te sono servo del medesimo Dio e Signore. Affinché non si creda che dica questo con riferimento al solo Giovanni, a motivo della sua singolare eccellenza, e non anche a tutti gli uomini servi di Cristo, aggiunge: “e (sono conservo) di tutti i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù”, che cioè con perfetto cuore testimoniano che Gesù è Dio e Signore di tutti e salvatore e redentore degli uomini. L’angelo specifica chi si debba adorare: “Adora Dio”. Spiega quindi cosa sia la testimonianza di Gesù: “La testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia”, cioè la profezia o la predicazione spirituale di Cristo è testimonianza di lui, come dicesse: tutti quelli che servono Cristo predicando tramite il suo Spirito o confessando la sua fede sono servi di Cristo come lo sono io, e perciò siamo tra noi uguali. Oppure testimoniare Cristo significa credere alla sua spirituale profezia e dottrina, perché questa dà testimonianza a Gesù. L’angelo proibisce il modo di adorazione servile, proprio della vecchia legge, sia per la dignità che deriva al genere umano dall’essere l’umana natura di Cristo già esaltata nella sede di Dio, sia perché quel tipo di adorazione compete unicamente a Dio, sia perché nello stato di umiltà evangelica i santi prelati non permettono di essere onorati servilmente dai loro sottoposti, nei confronti dei quali non si pongono come padroni, ma come ministri e servi, secondo l’esempio e la parola di Cristo: “Chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo. Io sto in mezzo a voi come colui che serve” (Luca 22, 26-27). Così Pietro, principe degli apostoli e sommo pontefice della Chiesa, non permise che il centurione Cornelio, inginocchiatosi, lo adorasse servilmente, anzi lo fece levare dicendo: “Anch’io sono uomo come te” (Atti degli Apostoli 10, 26).
Un passo simmetrico è nella settima visione, dopo la dimostrazione della gloria della sposa e della nuova Gerusalemme (Ap 22, 8-9). In entrambi gli stati, il sesto e il settimo, quanto sarà più alta la contemplazione della gloria dello sposo e della sposa, tanto maggiore sarà l’umiliarsi non solo dinanzi a Dio ma anche dinanzi ai dottori spirituali che mostrano tanta gloria. Quanto maggiore sarà l’umiliarsi nei discepoli, tanto maggiore sarà anche nei maestri, cosicché gli angeli saranno letteralmente familiari e come compagni e conservi dei profeti, cioè dei dottori, e dei discepoli “che custodiscono le parole della profezia”, cioè della dottrina, “di questo libro”. Ivi viene sviluppato il tema della gara tra l’essere alto e umile – la “beata contentio evangelice humilitatis” -, per cui i maestri rifuggono dall’onore dato dai discepoli, i quali tuttavia non cessano di onorarli.
Il tema del riverire si ritrova in numerosi punti della Commedia. Ad Ap 19, 10 più di un commentatore ha ricondotto la proibizione di essere riverito fatta da papa Adriano V che purga l’avarizia (Purg. XIX, 127-138). Si può notare, in questo caso, la presenza nelle terzine di temi estranei al testo dell’Apocalisse, ma presenti nel commento dell’Olivi: l’inginocchiarsi (come il centurione Cornelio), la dignità (che Dante, erroneamente, intende quella terrena e non quella esaltata dal Cristo uomo), le parole “conservo sono / teco e con li altri ad una podestate” (il testo scritturale ha solo “conservus tuus sum”). Una variante è “la reverenza de le somme chiavi” che vieta al poeta di usare “parole ancor più gravi” contro il simoniaco Niccolò III (Inf. XIX, 100-103). Da notare che il riverire il papa (l’ufficio, non la persona), sentito e almeno in parte applicato come freno da Dante nella bolgia infernale (“Io non so s’i’ mi fui qui troppo folle, / ch’i’ pur rispuosi a lui a questo metro”, ibid., 88-89), è vietato proprio da un papa nel quinto girone del purgatorio, così come nell’Antico Testamento il riverire non è vietato, mentre lo è nel Nuovo. Altra variante è il divieto imposto da Virgilio a Stazio che tenta di abbracciargli i piedi, e in ciò l’antico poeta pagano assume la veste degli umili dottori del sesto stato, “qui tam alta et gloriosa promittunt et docent” (Purg. XXI, 130-132). Stazio risponde con il tema dell’ “amor fratris”, secondo l’interpretazione del nome della sesta chiesa, Filadelfia (ibid., 133-136).
Camminando sull’argine che lo protegge dal sabbione su cui piove fuoco, Dante tiene il capo chino, “com’ uom che reverente vada”, verso il suo maestro Brunetto Latini, che tuttavia pare primo nell’umiliarsi dicendo: “Però va oltre: i’ ti verrò a’ panni”, cioè procedendo più in basso col capo che sfiora la veste del poeta (Inf. XV, 40, 43-45). L’umiliarsi di Brunetto è tuttavia obbligato dalla sua pena che lo costringe in basso nel sabbione, mentre il discepolo, portato dai margini di pietra del Flegetonte, è elevato su di lui. Il tema della gara d’umiltà è già presente al momento dell’incontro e del riconoscimento del maestro da parte del discepolo: prima Brunetto, che sta più in basso, prende Dante “per lo lembo”, cioè per la veste, gridando la sua meraviglia, poi Dante china la mano verso la faccia di lui (ibid., 22-30). Al maestro che gli promette glorioso porto e tanto onore il poeta si dichiara pronto a ‘serbare’ la profezia fattagli (ibid., 88-90).
Virgilio non vieta, anzi impone a Dante il riverire di fronte al messo celeste che apre la porta della Città di Dite (Inf. IX, 86-87), dinanzi a Catone (Purg. I, 49-51) e all’angelo portiere del purgatorio (che tiene le chiavi in luogo di Pietro), che però ha il segno dell’umiltà nella veste color cenere o terra secca (Purg. IX, 106-111, 115-116) [34]. Passata la porta del purgatorio – vero e proprio accesso al sesto stato della Chiesa -, il primo angelo, quello dell’umiltà, è vestito dei temi della “beata contentio”: egli si appresta a compiere la propria funzione quando “l’ancella sesta” ha compiuto il suo “servigio del dì”, ossia quando è già passato mezzogiorno (e dunque l’angelo, come l’ora, è “conservus”; il meriggio è appunto l’ora del sesto stato), mentre Virgilio invita Dante a riverire la “creatura bella” (Purg. XII, 79ss.) [35].
La riverenza di fronte al nome della sua donna, “pur per Be e per ice”, “s’indonna” di tutto il poeta, che nel dubbio non ha sufficiente ardimento a chiedere (Par. VII, 13-15). È un riverire “sicut servus vehementer et cum servili subiectione honorat suum dominum creatum” -, ma che Beatrice, come l’angelo di Ap 19, 10, tollera per poco tempo (ibid., 16). Simile atteggiamento è già presente nell’Eden, dove al poeta avviene di non riuscire a tirare fuori la voce dinanzi a Beatrice e di cominciare a parlarle “sanza intero suono”, come capita “a color che troppo reverenti / dinanzi a suo maggior parlando sono”: la donna gli si rivolge per prima con umiltà, chiamandolo “frate” e invitandolo a domandare, poiché vuole che Dante si liberi da timore e da vergogna, “sì che non parli più com’ om che sogna” (Purg. XXXIII, 22-33). L’umiltà di Beatrice è accostabile anche al proporsi di Giovanni, autore del libro, come fratello anziché come maestro, pur avendone diritto, così da attirare i propri interlocutori e persuaderli con l’umiltà e la dolcezza della fraternità (Ap 1, 9).
Nel corso del viaggio, il personaggio-Dante si libera sempre più dal riverire, quasi in un passaggio dal servilismo del Vecchio Testamento alla libertà del Nuovo.
(Tab. XV)
* Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in “Archivum Franciscanum Historicum” 109 (2016), pp. 99-161. Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994.
[All quotations from the Lectura super Apocalipsim in the essays or articles published in this website have been drawn from the transcription, with notes and indexes, of ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, which has been available therein since 2009. The Biblical passages to which the exegesis refers are in Roman type in “ ”; for sources please refer to the online edition. The critical edition by W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) has not been considered due to the issues it poses, which are discussed in “Archivum Franciscanum Historicum” 109 (2016), pp. 99-162. The text referring to the Commedia has been drawn from Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, edited by G. PETROCCHI, Firenze 1994.]
_____________________________________________