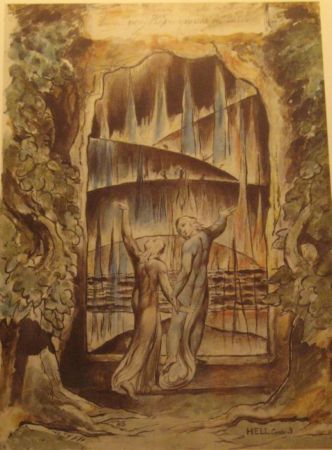III.
1. L’instabile arena del mare (Ap 12, 18). 2. I quattro lati dell’altare d’oro (Ap 9, 13). 3. I limiti invalicabili dell’Impero romano (Ap 9, 14). 4. Odiare la carità fraterna (Ap 16, 10-11). 5. Le corazze degli pseudoprofeti (Ap 9, 17).
INDICE GENERALE – AVVERTENZE
1. L’instabile arena del mare (Ap 12, 18)
Ad Ap 12, 18 (quarta visione, quinta guerra) si dice che il diavolo “stette fermo sull’arena del mare”, cioè sugli avanzi del vino purissimo dei quattro stati precedenti, corrottosi con l’eccezione di poche reliquie che nel quinto stato hanno conservato il seme della donna, osservando i comandamenti di Dio e dando testimonianza a Cristo (Ap 12, 18) [1]. L’ “arena” terrestre, polverosa, sterile, divisa in innumerevoli particelle indurite, instabile e disperdibile a ogni vento, penetrata e sbattuta dall’acqua del mare o putrefatta dal sole, viene interpretata, nel senso di Gioacchino da Fiore, come la moltitudine di coloro che non sono del tutto infedeli ma neppure aderenti alla pietà cristiana con tutta la purezza della fede. Si tratta delle genti (i cristiani di Alessandria e della Siria) [2] rimaste in aliqua sui parte nelle terre orientali conquistate dai Saraceni vicine al mare dei pagani, come l’arena è vicino al mare. A questa esegesi rinvia il “cattivo coro”, mischiato agli ignavi, degli angeli che furono per sé, né ribelli né fedeli a Dio e per questo cacciati dai cieli e non ricevuti dal profondo inferno (Inf. III, 37-39). Il motivo dell’ “arena” introduce a sua volta le terzine degli ignavi, nella descrizione del “tumulto, il qual s’aggira / … come la rena quando turbo spira” (ibid., 28-30).
Pietro Alighieri, nella terza redazione del suo commento (ca. 1358) riconduce gli angeli neutrali a Ugo di San Vittore: “Et ex hoc dicit hic auctor in persona Virgilii quod anime dictorum captivorum unite sunt cum illis angelis qui non fuerunt boni nec mali tenendo cum Deo vel cum Lucifero, quos Ugo de Sancto Victore dicit puniri etiam extra Infernum in loco et aere caliginoso (…)” [3]. Ma il Vittorino, se ritiene possibile un diverso grado di punizione degli angeli caduti, non parla di una specie ignava [4]. Altre fonti accreditate sono gli Stromata di Clemente di Alessandria [5], la Visio Pauli (sec. V, dove sono puniti gli ignavi, non gli angeli) [6], la Navigatio sancti Brendani [7], il Parzival di Wolfram von Eschenbach (ca. 1210-1220) [8] (in queste due ultime ci sono gli angeli neutrali, ma non sono puniti all’inferno). Gli angeli neutrali hanno un’origine letteraria e teologica insieme [9]. Si tratta di opere precedenti la Commedia, ma da ciò non si può dedurre una conoscenza certa di questa o dell’altra da parte di Dante.
È certo invece che questi angeli danno “e piedi e mano” all’esegesi apocalittica di Gioacchino da Fiore che, spostata in avanti di un secolo quanto alla sua applicazione (Gioacchino termina la sua Expositio nel 1200)[10], li fascia con un criptico significato di storia contemporanea, dopo il luttuoso evento della caduta di San Giovanni d’Acri nel 1291, ultimo baluardo della cristianità in Terrasanta. Si ricordino le parole di Guido da Montefeltro sui cristiani compromessi con gli infedeli: “Lo principe d’i novi Farisei, / avendo guerra presso a Laterano, / e non con Saracin né con Giudei, / ché ciascun suo nimico era cristiano, / e nessun era stato a vincer Acri / né mercatante in terra di Soldano”, espressione, quest’ultima, che ben s’accorda con le parole di Gioacchino da Fiore su quanti “utrum sint christiani aut sarraceni dubitatur” (Inf. XXVII, 85-90).
Si noti che il tema dell’arena percorre tutti i canti dedicati all’ “orribil sabbione” del terzo girone del settimo cerchio. Gli ultimi dannati sono gli usurai: “poco più oltre veggio in su la rena / gente seder propinqua al loco scemo”, cioè al burrone (Inf. XVII, 31-36). Sull’arena ma vicini a Malebolge, essi partecipano dell’instabilità degli ignavi; sono infatti violenti sui generis, contro la natura e l’arte (e quindi indirettamente contro Dio), ma pure quasi fraudolenti (Gerione, il simbolo della frode, nel salire dall’abisso arriva fin lì). Agli ignavi li accomuna il disprezzo che si esprime nel parlar poco: “Dicerolti molto breve … non ragioniam di lor, ma guarda e passa – Li tuoi ragionamenti sian là corti” (Inf. III, 45, 51; XVII, 40) [11].
Se gli angeli neutrali di Inf. III, 37-39 rinviano a un passo dell’Expositio di Gioacchino da Fiore, il resto dei versi dedicati agli ignavi si riferisce prevalentemente all’esegesi dell’istruzione data a Laodicea, l’ultima delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione (Ap 3, 14-22) [12]. In questa esegesi non ci sono citazioni di Gioacchino da Fiore, palesi o occulte. Il difetto maggiore del vescovo (o della chiesa) è la tepidezza, il non trovarsi né nel calore della carità che esulta in Dio né nel freddo dell’infedeltà triste per i propri peccati, per cui gli viene detto: “Magari tu fossi freddo o caldo!” (Ap 3, 15). Meglio (secondo Riccardo di San Vittore) sarebbe trovarsi freddi infedeli per ignoranza, ma con possibilità di convertirsi all’ardore della vera giustizia, piuttosto che tiepidi rinunciatari di una via di perfezione intrapresa e apostati da un alto stato. Olivi cita un passo delle Collationes di Cassiano [13] (360ca-435) a conferma di come sia più facile che un infedele o un secolare acquisti fervore spirituale che un monaco vi ritorni dopo averlo perduto. Verso questi “tiepidi”, detestati da Dio, gli uomini spirituali e i dottori debbono tralasciare di diffondere moniti o insegnamenti salutari cosicché, spregiata una terra sterile occupata da sterpi nocivi, spargano altrove il seme della parola salutare, in una nuova terra tra i pagani e i secolari, piuttosto che seminare sulle spine, secondo il comando del profeta Geremia (Jr 4, 3). L’ammonimento è rivolto a tutti coloro che hanno rinunciato a questo mondo e alla carnalità ma che poi, ritenendo di aver raggiunto il vertice della perfezione, sono lenti nel liberarsi dalle passioni e vengono così trovati in uno stato di tepidezza e rigettati dalla bocca di Dio. A differenza del freddo e del caldo, il tiepido provoca infatti nausea e vomito. I cibi freddi, recati alla bocca, si convertono in calore e diventano salutari e soavi, quelli viziati da tepidezza non solo non possono essere recati alle labbra, ma neppure guardati da lontano senza orrore. Così coloro che vengono ricevuti nelle viscere della carità, fattisi tiepidi, vengono vomitati poiché, pur potendo offrire un cibo salutare, sono diventati nauseabondi e detestabili. È più facile pertanto che un secolare o un pagano, acceso dall’ardore dello spirito, ascenda dal gelido stato di infedeltà alla fonte della vera purificazione, che vi riascenda un monaco nel quale sia scemato l’originario fervore e si ritenga ricco di beni spirituali e di nulla indigente, quando invece, fatto più deteriore del secolare o pagano, è misero, cieco, nudo e bisognoso di correzione.
I temi del tepore, del dispregio e del vomito sono propri degli ignavi, “a Dio spiacenti e a’ nemici sui”, sdegnati dalla misericordia e dalla giustizia divina, dei quali il dottore Virgilio, che applica i precetti dell’abate Daniele nelle Collationes di Cassiano, parla brevemente: “non ragioniam di lor, ma guarda e passa” (Inf. III, 50-51, 63; da considerare, al v. 31, la variante orror di error : ciò che è tiepido non può essere guardato senza orrore).
Alla chiesa di Laodicea e al suo vescovo viene rimproverata (Ap 3, 17) la presunzione di considerarsi senza difetti, nella ritenuta abbondanza di ricchezze che paiono renderla sufficiente a sé stessa. Essa si considera beata, e invece pecca di ignoranza dei propri difetti: è misera (la miseria si oppone alla beatitudine), miserabile (perché abbisogna di commiserazione), povera (perché difetta non solo del sufficiente, ma pure del necessario), cieca (perché difetta della prudenza e della previdenza con cui i ricchi, che reggono le città e consigliano i potenti, raccolgono, conservano e dispensano i beni materiali; così i ricchi di beni spirituali sono prudenti e conoscono i consigli divini), nuda (a differenza dei ricchi, che indossano vesti preziose e ornate). Sono i difetti comuni a un mendicante cieco, nudo, bisognoso, pieno di miserie e miserabile all’altrui sguardo.
La cecità, inoltre, è duplice: c’è quella che proviene dall’ignoranza che riconosce tuttavia umilmente sé stessa come tale, e quella che nell’ignoranza presume il contrario. Come la perfezione della conoscenza sta nel sapere di sapere, così la somma ignoranza sta nell’ignorare di essere ignorante e stolto.
Da questa esegesi, in cui né Riccardo di San Vittore né Gioacchino da Fiore, le due “auctoritates” dell’Olivi, assumono particolare rilievo, il tema del mendico e dei suoi difetti si insinua ancora tra gli ignavi. Al vescovo di Laodicea viene detto “quia tu es miser” (Ap 3, 17), e Virgilio dice degli ignavi: “… Questo misero modo / tegnon l’anime triste di coloro / che visser sanza ’nfamia e sanza lodo” (Inf. III, 34-36). Dell’uno si dice: «“et miserabilis” … quod vident te indigere Dei et ipsorum miseratione … “et cecus” … “et nudus”»; degli altri: “e la lor cieca vita è tanto bassa … misericordia e giustizia li sdegna … erano ignudi” (vv. 47, 50, 65). Contro la miseria, l’essere miserabile e povero, il vescovo di Laodicea viene invitato ad acquistare oro ignito e sottoposto a prova (Ap 3, 18), mentre gli ignavi sono “sciaurati” (vili, quasi fossero, per concordia nel suono delle parole, ‘senz’oro’: v. 64). Cristo stimola il vescovo della settima chiesa a imitare i santi esempi usando nel senso di ‘zelare per il bene’ un verbo – “emulari” – che ha però anche il significato di ‘invidiare’ (Ap 3, 19): così gli ignavi dalla cieca vita “ ’nvidïosi son d’ogne altra sorte” (v. 48) [14].
Una variazione dei motivi compare all’inizio di Inf. XXIV (vv. 1-30). Il turbamento di Virgilio di fronte al guasto ponte della sesta bolgia è reso con la similitudine del villanello che abbisogna del foraggio per il bestiame, “in quella parte del giovanetto anno / che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra” (tra gennaio e febbraio), e che sconfortato non sa il da farsi di fronte a quella che crede neve e invece è brina che presto si scioglie ai raggi del sole facendogli riacquistare la speranza di pascere le sue pecorelle. Al villanello sono appropriati temi presenti nel rimprovero al vescovo di Laodicea: l’essere ignorante (“che non sa che si faccia”), misero e povero (“a cui la roba manca”, “come ’l tapin”). Virgilio, invece, se è rimasto turbato d’ira per essersi fatto ingannare dai Malebranche bugiardi, dimostra di aver riacquistato tutta la sua sicurezza e di essere dotato di tutte le virtù contrarie alla “cecità” rimproverata al vescovo, nonostante l’ira gli abbia per poco offuscato l’occhio della mente: prende “consiglio” su come affrontare la via, si mostra previdente su quello che dovrà fare dopo (“E come quei ch’adopera ed estima, / che sempre par che ’nnanzi si proveggia”), indicando a Dante le schegge di roccia cui aggrapparsi e avvisandolo di provarle prima se siano salde in modo da potervisi reggere (da notare la variazione del “regunt” in “ti reggia”), mostra insomma di essere uno di quei “divites in spiritualibus … prudentes et scientes consilia summi Dei” [15].
I motivi del reggere, della prudenza, dell’essere sufficienti sono appropriati a Salomone, elogiato da Tommaso d’Aquino come re “sufficïente” e senza pari (Par. XIII, 94-96, 104-105). L’Aquinate invita anche alla prudenza nel giudicare sulla futura sorte delle anime, nella presunzione di vedere dentro al consiglio divino come credono “donna Berta e ser Martino” (i due nomi sono usati con un’accezione di disprezzo che corrisponde ai difetti rimproverati alla settima chiesa, ibid., 139-142). L’esser ciechi e mendichi è proprio degli invidiosi del secondo girone del Purgatorio (Purg. XIII, 61-62).
All’esegesi dell’istruzione data a Laodicea rinviano molti altri luoghi del poema. Il tema del tepore pernicioso ritorna ad esempio in un momento di grave pericolo, che insinua nell’animo il desiderio di rinunciare: il volo in groppa a Gerione verso Malebolge (Inf. XVII, 85-90). Allorché Virgilio lo invita a salire sul fiero animale, Dante prova tremando il senso di nausea e di vomito che il malato di “quartana” ha per i luoghi freddi (lo stesso sentimento proverà di fronte ai “gelati guazzi” di Cocito in Inf. XXXII, 70-72). La vergogna vince però la paura e il poeta non rinuncia ad andare avanti. Rispetto al commento scritturale, nei versi si conserva il tema della nausea mentre il freddo perde il suo valore positivo (di potersi trasformare in caldo) nei confronti del tiepido.
È Virgilio a invitare il gigante Anteo a non avere “schifo” di deporre lui e Dante al fondo dell’Inferno, “dove Cocito la freddura serra” (Inf. XXXI, 122-123). E in effetti il chinarsi di Anteo, senza “fare dimora” sul “fondo che divora / Lucifero con Giuda”, apparenta a suo modo il gigante a quei santi perfetti del quinto stato che condiscendono solo per la carità e l’utilità degli infermi senza per questo macchiarsi di impurità, nel caso senza contaminarsi coi traditori e gli apostati, dei quali colui che nella piana di Zama recò “già mille leon per preda” può ben avere “schifo”. Quei santi non verranno cancellati dal libro della vita, riceveranno anzi gloria e fama, secondo quanto esposto nell’esegesi della quinta vittoria, ed è la fama che brama Anteo (Ap 3, 5) [16].
Pur nel prevalere dell’asceta Cassiano citato da Olivi, c’è spazio anche per la trasformazione dell’esegesi di Riccardo di San Vittore dell’ “utinam frigidus esses”: risuona nell’apostrofe contro i traditori che stanno in Cocito, “mal creata plebe” (riflettere sulla propria creazione o principio appartiene anch’esso alla settima chiesa: Ap 3, 14), che meglio sarebbe stata in vita pecore o capre ignoranti e umili (Inf. XXXII, 13-15).
Lo stesso tema pervade la similitudine dei lussuriosi purganti nel settimo girone – “Poi, come grue ch’a le montagne Rife / volasser parte, e parte inver’ l’arene, / queste del gel, quelle del sole schife” (Purg. XXVI, 43-45) -, che cioè volino o al freddo o al caldo, quasi evitando comunque il tiepido (non esplicitato) come ingiunto al settimo vescovo. Le due schiere (lussuriosi secondo natura e contro), nel dipartirsi dopo essersi incontrate, “tornan, lagrimando, a’ primi canti” (vv. 46-48), cioè al principio, come deve fare la settima e ultima chiesa (Ap 3, 14); “lagrimando”, in quanto a questa è proposto il collirio pungente e lacrimativo, che fa riflettere sui propri difetti (Ap 3, 18). Dante, al quale è appropriato in senso negativo il tema della cecità: “Quinci sù vo per non esser più cieco” (v. 58), va “pensoso” di fronte a Guinizzelli (v. 100); Arnaut Daniel piange e va cantando, riflettendo afflitto sulla passata follia (vv. 142-143).
____________________________________________________________________________________________________________________
[1] Sul versetto precedente (Ap 12, 17) cfr. Il sesto sigillo, 2d.3 («Maria rimase giuso»).
[2] Si tratta, come Gioacchino precisa ad Ap 16, 19, di non pochi cristiani di Alessandria e di Siria e di altri luoghi,“qui tamen, si de moribus agitur, utrum sint christiani an sarraceni dubitatur” (Expositio, pars VI, distinctio I, f. 192va-b); cfr. G. L. POTESTÀ, Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Bari 2004, pp. 319-320.
[3] Cfr. il testo in I commenti danteschi dei secoli XIV, XV e XVI, a cura di P. PROCACCIOLI, Roma 1999 (Archivio Italiano).
[4] UGO DI SAN VITTORE, Summa Sententiarum, II, iv; PL 176, col. 84 B-C: “Et quia contra Creatorem suum in tantum superbivit, dejectus est in istum caliginosum aerem cum omnibus illis qui ei consenserunt; et hoc ad nostri probationem ut sint nobis adminiculum exercitationis. Non est eis concessum habitare in coelo, quae est clara patria; nec in terra, ne homines nimis infestarent; sed in aere caliginoso qui est carcer eis usque in diem judicii. Tunc enim detrudentur in barathrum inferni secundum illud: Ite, maledicti, in ignem aeternum qui praeparatus est diabolo et angelis ejus (Mt 25, 41). Et sicut majoris scientiae sunt vel minoris, ita habent majores vel minores praelationes; quia quidam uni provinciae, quidam uni homini, quidam uni vitio praesunt. Unde dicitur spiritus superbiae, spiritus luxuriae. De hoc autem dubitatio est utrum modo omnes in isto aere sint usque in diem judicii; an aliqui eorum in inferno inferiori sint, quod de auctoritate non multum certum habemus. Quidam tamen volunt dicere quod Lucifer qui plus caeteris peccavit, statim illuc demersus sit; et etiam quidam ex aliis”.
[5] CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromata, VII, 7; PG 9, coll. 466-467. È fonte sostenuta con decisione da B. NARDI, Dal “Convivio” alla “Commedia” (Sei saggi danteschi), Roma 1960 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi Storici, 35-39; ristampa anastatica, 1992), pp. 331-350: 338-339.
[6] TH. SILVERSTEIN – A. HILHORST, Apocalypse of Paul. A new critical edition of three long latin versions, Genève 1997 (Cahiers d’Orientalisme, XXI), 31, p. 136 [ms. parigino]: “Cum autem quieuit loqui mihi, duxit me foras extra ciuitatem per medias arbores et Acerosium lacum terre bonorum et statuit me super flumen lactis et mellis. Et post aec duxit me super Oceanum, qui portat fundamenta celi. Respondit angelus et dixit mihi: Intelliges quo incedas? Et dixi: Ita, domine. Et dixit mihi: Veni et sequere me et ostendam tibi animas impiorum et peccatorum, ut cognoscas quales sit locus. Et profectus sum cum angelo et tulit me per ocansu solis. Et uidi principium celi fundatum super flumine aque magno et interrogaui: Quis est iste fluuius aque? Et dixit mihi: Haec est Oceanus, qui circuit omnem terram. Et cum fuissem ad exteriora Oceani, aspexi et non erat lumen in illo loco, sed tenebre et tristicia et mesticia, et suspiraui. Et uidi illic fluuium ignis feruentem et ingressus multitudo uirorum et mulierum dimersus usque ad ienua et alios uiros usque ad umbiculum, alios enim usque ad labia, alios autem usque ad capillos. Et interrogaui angelum et dixi: Domine, qui sunt isti in flumine igneo? Et respondit angelus et dixit mihi: Neque calidi neque frigidi sunt, quia neque in numero iustorum inuenti sunt neque in numero impiorum. Isti enim inpenderunt tenpus uite suae in terris dies aliquos facientes in oracionibus dei, alios uero dies in peccatis et fornicacionibus usque ad mortem”. È fonte sostenuta da G. INGLESE, in Dante Alighieri, Commedia. Revisione del testo e commento. Inferno, Roma 2007, p. 63, nt. a Inf. III, 39.
[7] NAVIGATIO SANCTI BRENDANI ABBATIS. From Early Latin Manuscripts, ed. C. Selmer, University of Notre Dame Press 1959, cap. 11, 16-48, pp. 22-25: «Erat autem super illum fontem arbor mire latitudinis in girum, non minus altitudinis, cooperta auibus candidissimis. In tantum cooperuerunt illam ut folia et rami eius uix uiderentur. Cum hec uidisset uir Dei, cepit intra se cogitare et tractare quidnam esset aut que causa fuisset quod tanta multitudo auium potuisset esse in una collectione. Ac de hoc tantum sibi erat tedium ut effunderet lacrimas preuolutis genibus ac deprecaretur Deum, dicens: “Deus, cognitor incognitorum et revelator absconditorum omnium, tu scis angustiam cordis mei. Deprecor tuam majestatem ut mihi peccatori digneris per tuam magnam misericordiam reuelare tuum secretum, quod modo pre oculis meis uideo. Non de meritis meis aut dignitate sed de immensa clemencia tua presumo”. Cum hec dixisset intra se atque resedisset, ecce una de illis auibus uolabat de arbore, et sonabant ale eius sicut tintinnabula, contra nauim ubi uir Dei sedebat. Que sedit in summitate prore et cepit extendere alas quasi signo leticie et placido uultu aspicere sanctum patrem. Statimque agnouit uir Dei quia Deus recordatus esset deprecationem eius, et ait ad auem: “Si nuncius Dei es, narra mihi unde sint aues iste / aut pro qua re illarum collectio hic [sit]?” Que statim ait: “Nos sumus de illa magna ruina antiqui hostis, sed non peccando in eorum consensu fuimus. Sed ubi fuimus creati, per lapsum illius cum suis satellitibus contigit et nostra ruina. Deus autem noster iustus est et uerax. Per suum magnum iudicium misit nos in istum locum. Penas non sustinemus. Hic presenciam Dei possumus uidere, sed tantum alienauit nos a consorcio aliorum qui steterunt. Vagamur per diuersas partes aeris et firmamenti et terrarum, sicut alii spiritus qui mittuntur. Sed in sanctis diebus atque dominicis accipimus corpora talia qualia nunc uides et commoramur hic laudamusque nostrum creatorem. Tu autem cum tuis fratribus habes unum annum in tuo itinere. Adhuc restant sex. Ubi hodie celebrasti Pascha, ibi omni anno celebrabis, et postea inuenies que posuisti in corde tuo, id est terram repromissionis sanctorum”. Cum hec dixisset, leuauit se de prora illa auis et cepit uolare ad alias».
[8] WOLFRAM VON ESCHENBACH, Parzival, IX, 471, 15-25; XVI, 798, 11-22 (ed. a cura di L. Mancinelli. Traduzione e note di C. Gamba, Torino 1993). L’eremita Trevrizent parla a Parzival degli angeli neutrali, inviati da Dio in un primo tempo a vegliare sul Graal. Precisa di non sapere se, nella sua giustizia, li abbia in seguito assolti o dannati per sempre (avendo successivamente affidato la pietra agli eletti da lui scelti), salvo infine smentirsi affermando che questi spiriti sono dannati.
[9] È possibile che ad essi predisponga l’angelologia francescana (cfr. A. MELLONE, Angelo, in Enciclopedia Dantesca, I, Roma 19842, pp. 270-271), ma ciò non significa che Bonaventura o l’Olivi parlino di angeli neutrali. Quello che Olivi afferma nelle varie quaestiones sugli angeli [Quaestiones in secundum librum Sententiarum, ed. B. Jansen, I, Ad Claras Aquas prope Florentiam, 1922 (Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi, IV), qu. xlii-xliii, pp. 702-734: 710-711], è che gli angeli non peccarono nell’istante della loro creazione, tesi propria di altri teologi e da confrontare con le parole di Beatrice a Par. XXIX, 49-51.
[10] Cfr. G. L. POTESTÀ, Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore cit., pp. 286-287.
[11] Da notare la rima “latino / vicino” a Inf. XXII, 65, 67, dove il motivo della Chiesa “latina” rimasta nel quinto stato come reliquia dopo le devastazioni saracene in Oriente, “vicina” e quasi mescolata alle impurità, è appropriato in modo sarcastico ai barattieri del quinta bolgia (il numero corrisponde allo stato della storia della Chiesa, al quale principalmente rinviano i versi relativi a quella zona). All’esegesi di Ap 12, 18 rinviano anche parole-chiave in Inf. XXIV, 85, 90 («“Et stetit”, scilicet dracho, “super arenam maris” – Più non si vanti Libia con sua rena … né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe») e Purg. V, 15, 18 (“et semper instabilis et ab omni vento dispergibilis – per soffiar di venti … perché la foga l’un de l’altro insolla”).
[12] Qui vengono considerati soltanto alcuni aspetti; per un esame completo cfr. Il sesto sigillo, 7a, tab. XLIV.
[13] Cfr. CASSIANI Opera, Collationes XXIIII, edidit M. Petschenig. Editio altera supplementis aucta curante G. Kreuz, Wien 2004 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, XIII), Conlatio IIII, xviiii, 7, pp. 114-115 (= PL 49, col. 607 B-C). Sull’uso di questo autore da parte di Olivi cfr. A. A. DAVENPORT, Private Apocalypse: Spiritual Gnosis in Saint John Cassian and Peter John Olivi, in Ende und Vollendung. Eschatologische Perspektiven im Mittelalter, herausgegeben von J. A. Aertsen und M. Pickavé, Berlin-New York 2002 (Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln, 29), pp. 641-656.
[14] L’esegesi di Ap 3, 19 espone tutti i possibili significati del verbo emulari.
[LSA, cap. III, Ap 3, 19; Paris, BnF, ms. lat. 713, f. 55ra-b] Deinde ut ipsum efficacius inducat et trahat ad ista, ostendit se ex singulari amore ipsum corripere et alios, quos consimiliter corripit et emendat, in exemplum imitandum proponere sibi, unde subdit (Ap 3, 19): “Ego quos amo corrigo et castigo”, id est verbis reprehensionis obiurgo et penis castigo seu castifico et emendo. “Emulare ergo”, scilicet illos bonos et eorum sancta exempla, quos ego amo et castigo. Emulari sumitur aliquando pro invidere, ut ad Romanos [XIII°] (Rm 13, 13): “Non in contentione et emulatione”; aliquando autem pro zelotipe indignari, ut Ezechielis VIII° (Ez 8, 3): “Erat statutum idolum zeli ad provocandum emulationem”; aliquando pro ex magno amore zelari seu ex magno zelo optare bonum alteri, ut IIa ad Corinthios XI° (2 Cor 11, 2): “Emulor enim vos Dei emulatione”, et ad Romanos X° (Rm 10, 2): “Emulationem” quidem “Dei habent”; aliquando vero sumitur pro zelatorie imitari, ut Proverbiorum III° (Pro 3, 31): “Ne emuleris hominem iniustum”, [et] ad Galatas IIII° (Gal 4, 18): “Bonum”, scilicet hominem, “emulamini in bono semper”, et sic sumitur hic. “Et penitentiam age”, quasi dicat, secundum Ricardum: «si suasio premissa non potest te de tuo tepore excitare, animadverte diligenter me verbis arguere et flagellis castigare illos quos amo, ipsosque mea verba et flagella libenter accipere, et ab illis exemplum sume ipsosque imitando in bono emulare». Vel sensus est: “Emulare ergo”, id est ad exemplum mei et zelo amoris mei et tue salutis irascere et indignare contra tua vitia, “et” ad castigandum ea “penitentiam age”.
Invidiare, nel senso positivo di imitare i buoni esempi, è nel linguaggio di Bonaventura al termine della lode di Domenico: “Ad inveggiar cotanto paladino / mi mosse l’infiammata cortesia / di fra Tommaso e ’l discreto latino; / e mosse meco questa compagnia” (Par. XII, 142-145; negativo il senso di “inveggia” a Purg. VI, 20). “Paladino” sarebbe così da riferire non a Domenico, ma a Tommaso d’Aquino, del quale Bonaventura ha ‘emulato’ l’elogio di Francesco.
[15] Nella similitudine del villanello entrano anche i temi della quarta perfezione di Cristo come sommo pastore trattata nel primo capitolo (Ap 1, 14), i cui capelli sono bianchi come la lana e come la neve. La lana lenisce col calore, è molle, temperata e soave nel candore; la neve è fredda, congelata, rigida e intensa nel candore non sostenibile alla vista. Così la sapienza di Cristo, umore che impingua e purga le colpe, è da una parte calda per la pietà e condescensiva in modo contemperato alle nostre facoltà; è dall’altra astratta, rigida e intensa. Non a caso la similitudine del villanello cade “in quella parte del giovanetto anno / che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra”: il passaggio dalla neve alla sua bianca sorella brina segna il passaggio dal rigido inverno, gelato e chiuso, al condiscendere temperato e pietoso verso la necessità di cibo delle pecorelle. I ‘crini’ di Cristo designano anche il maturo consiglio, per cui il temprare i crini da parte del sole è speculare alla formazione di un provvido consigliarsi da parte di Virgilio.
[16] Cfr. Il sesto sigillo, 2d. 1, tab. XVII.
Tab. 1.1
[LSA, cap. XII, Ap 12, 17.18 – 13, 1 (IVa visio, Vum prelium)] (Ap 12, 17) Utrique enim signanter vocantur reliqui seu reliquie, quia sicut bibita superiori et puriori et maiori parte vini vasis magni restant pauce reliquie cum fecibus quibus sunt propinque et quasi commixte, sic de plenitudine purissimi vini doctorum et anachoritarum tertii et quarti temporis remanserunt reliquie circa tempora Sarracenorum; ac deinde pluribus ecclesiis per Sarracenos vastatis et occupatis, Grecisque a romana ecclesia separatis, remansit in quinto tempore sola latina ecclesia tamquam reliquie prioris ecclesie per totum orbem diffuse. De utrisque ergo reliquiis simul agit, tum quia in utrisque remissio habundavit respectu perfectionis priorum, tum quia bestia sarracenica contra utrosque pugnavit quamvis primo contra primos. […]
|
Inf. XXII, 64-67Lo duca dunque: “Or dì: de li altri rii
|
Tab. 1.2
[LSA, cap. III, Ap 3, 15 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Increpans ergo eum, subdit (Ap 3, 15): “Scio opera tua”, id est scientia iudiciali et improbativa, “quia neque calidus es”, scilicet per caritatem, “neque frigidus”, per infidelitatem vel per omnimodam vite secularitatem, quasi dicat: solam fidem et quandam exterioris religionis speciem absque igne caritatis habes.
|
|
Inf. III, 31-51, 61-63E io ch’avea d’error la testa cinta, orror
|
Inf. XVII, 85-87, 106-112, 115Qual è colui che sì presso ha ’l riprezzo
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 17-19 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Deinde hanc eius presumptionem improbat et falsificat per sex defectus intente sue presumptioni oppositos sueque presumptioni annexos.
|
|
Inf. III, 34-36, 46-51, 64-66Ed elli a me: “Questo misero modo
|
Inf. XXIV, 1-30In quella parte del giovanetto anno
|
2. I quattro lati dell’altare d’oro (Ap 9, 13-14)
Al suono della sesta tromba, nella terza visione apocalittica, scrive Giovanni: “E udii una voce dai quattro lati dell’altare d’oro che si trova dinanzi agli occhi di Dio” (Ap 9, 13). Questa voce una, secondo Riccardo di San Vittore, è la voce concorde dell’universale dottrina; i quattro lati dell’altare d’oro designano i predicatori che levano in alto e portano Cristo col predicare i quattro Vangeli alle quattro parti del mondo. Cristo è detto altare, perché su di lui vengono offerti i nostri sacrifici (cfr. Ap 8, 3-5); sta dinanzi agli occhi di Dio perché il Padre si compiacque nel Figlio (cfr. Mt 3, 17; 17, 5; Mr 1, 11; Lc 3, 22). Accanto a questa interpretazione Olivi giustappone quella, tragica, di Gioacchino da Fiore. I quattro lati dell’altare sono i quattro evangelisti dai cui Vangeli una comune voce è udita, dicente che Cristo sarà consegnato a tradimento in mano dei peccatori alla fine del quinto giorno (giovedì) che precede la Parasceve ebraica; che sarà crocifisso, morrà e sarà seppellito nel sesto giorno (venerdì, cioè nella Parasceve). La voce intende dire che al momento del suono della sesta tromba i figli delle tenebre verranno sciolti perché sia compiuta la parola di Cristo: “Quando vedrete che Gerusalemme è circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vicina” (Luca 21, 20).
I quattro lati dell’altare sono pure, secondo Olivi, le quattro virtù di Cristo che chiamano perché i figli delle tenebre siano sciolti, cosicché vengano a punire Babylon che tanti crimini ha commesso contro Cristo alla fine del quinto stato. Lo grida la verità di Cristo da essa conculcata e che invece è degna di essere esaltata, la giustizia di Cristo che esige vendetta con la punizione corrispondente alle colpe, la misericordia di Cristo verso gli eletti troppo oppressi, che devono essere liberati, e la vita e la gloria di Cristo che conviene e giova siano dichiarate a tutto il mondo e da questo adorate e partecipate, il che non può avvenire se prima non siano stati espulsi dalla Chiesa le turpitudini e quanti insozzano.
I motivi dei quattro lati dell’altare da cui esce una comune voce, di Cristo tradito e consegnato nelle mani dei nemici nel quinto giorno che precede la Parasceve, della sua crocifissione nel sesto giorno, del chiamare contro le scelleratezze della nuova Babilonia, percorrono come cellule musicali il racconto del conte Ugolino (Inf. XXXIII, 43-58, 67-74, 85-89), dove la poesia li appropria variandoli: il padre scorge “per quattro visi il mio aspetto stesso”; vede cadere tre dei suoi quattro figli, posti “a tal croce”, tra il quinto e il sesto giorno di prigionia; li chiama per due giorni dopo morti, ha voce di aver tradito Pisa consegnando i castelli ai nemici. Ciò che nell’esegesi è concentrato solo su Cristo, nei versi è diffuso: è Pisa ad essere “tradita … de le castella” (per voce comune che accusa Ugolino; “fore traditum … d’aver tradita”: unico caso, nel poema, del participio passato di tradire); ma alla croce essa ha posto i quattro figli del conte (che rode l’arcivescovo Ruggieri, a sua volta traditore), per cui s’è fatta “novella Tebe”, figura della “nova Babilon” e della nuova crocifissione di Cristo. Il poeta invoca perciò che la città, “vituperio de le genti / del bel paese là dove ’l sì suona”, venga punita con il muoversi della Capraia e della Gorgona a chiudere la foce dell’Arno sì da farne annegare gli abitanti, invettiva che contiene il tema del muoversi delle isole e del conseguente sterminio dei popoli che segna il terremoto con cui si apre il sesto sigillo (Ap 6, 14; 16, 20). Il suonare del “sì ” nel “bel paese” trova riscontro nell’amen – “vere sic sit et fiat” – con cui i seniori e gli animali lodano Dio (Ap 7, 11-12). I tempi che scandiscono la fine del conte e dei suoi figli nella Muda sono gli stessi della passione di Cristo. Ma l’ottavo giorno, la domenica di resurrezione, designato dall’ottava beatitudine – “Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam” (Mt 5, 10) -, o dallo stadio paolino (l’ottava parte del miglio romano) in cui tutti corrono ma uno solo vince il premio e che è misura dei lati della Gerusalemme celeste (1 Cor 9, 24, cfr. Ap 21, 16), non è stato tale per il conte: “vid’ io cascar li tre ad uno ad uno / tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’ io mi diedi, / già cieco, a brancolar sovra ciascuno, / e due dì li chiamai, poi che fur morti. / Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno”.
La Scrittura è “pelago”, il mare vitreo simile a cristallo che sta dinanzi alla sede divina (Ap 4, 6). La Scrittura resta dinanzi alla Chiesa in modo che gli eletti possano in essa vedere l’aspetto del proprio volto e conoscano quali essi siano, e anche possano comprendere le cose invisibili di Dio come in un chiaro specchio e per mezzo di esso. Guardare sé nella Scrittura per conoscere la propria immagine appartiene al conte Ugolino, dopo che ha sentito inchiodare l’uscio dell’orribile torre: «ond’ io guardai / nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto … e Anselmuccio mio / disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?” … e io scorsi / per quattro visi il mio aspetto stesso» (Inf. XXXIII, 47-48, 50-51, 56-57). Fra i vari significati attribuiti al “mare di vetro”, si addicono al conte l’amaro e infinito patire di Cristo e, per contrasto, la tolleranza del martirio, la contrizione penitenziale. Come egli non sa sopportare le tribolazioni, ed è impaziente e si dispera mordendosi le mani per il dolore, così il guardare nei figli – che sono quattro come i Vangeli – non gli rende la vista delle cose spirituali.
Un altro attributo della Scrittura è di essere assimilata al collirio. Il tema è introdotto ad Ap 3, 18, nel corso dell’istruzione data alla chiesa di Laodicea, la settima delle chiese d’Asia. Il collirio, che all’inizio punge gli occhi in modo amaro e provoca le lacrime e le fa uscire, rendendo però alla fine chiara la vista, designa l’amara compunzione dei propri peccati. Così la Scrittura è come il collirio, perché il precetto del Signore è lucente e illumina gli occhi. Ugolino guarda nel viso dei suoi figli che piangono, ma lui non piange né lacrima.
Nell’Eden, Beatrice rimprovera Dante invitandolo a guardarla: “Guardaci ben!” (Purg. XXX, 73). Il poeta guarda nel Lete, “chiaro fonte” le cui acque senza “mistura alcuna” sono limpide e nulla nascondono (Purg. XXVIII, 28-30), ma vedendo la sua immagine prova tanta vergogna da distogliere gli occhi verso l’erba (Purg. XXX, 76-78). Di fronte al rimprovero della donna, che gli pare superba come la madre al figlio “perché d’amaro / sente il sapor de la pietade acerba”, Dante resta “sanza lagrime e sospiri”, gelato attorno al cuore come la neve congelata e addensata dai venti di Schiavonia che soffiano fra i rami degli alberi sul giogo d’Appennino. Il dolce canto degli angeli, che temperano l’amaro delle parole di Beatrice, scioglie però quel gelo come neve al caldo vento del sud e lo trasforma in sospiri e lacrime che sgorgano con fatica dalla bocca e dagli occhi (ibid., 79-99).
All’inizio del periodo di purgazione, “le guance lagrimose” di Dante, annebbiate dal “sucidume” infernale, vengono lavate da Virgilio con la rugiada sul “molle limo” ai piedi della montagna, secondo l’indicazione di Catone (Purg. I, 94-99, 121-129).
Se Dante guarda in Beatrice e piange dinanzi a lei, la sua donna è discesa a visitare “l’uscio d’i morti”, dove ha rivolto lacrimando gli occhi lucenti a Virgilio per renderlo ancor più presto al muovere per la salute dell’amico (Inf. II, 115-117; Purg. XXVII, 136-137; XXX, 139-141). Piange, Beatrice, non solo perché donna e amante, come voleva Boccaccio [1]. La “gentilissima” designa la Sacra Scrittura, precetto di Dio che rende lucidi gli occhi, purga, chiarisce e illumina con umiltà l’alta tragedia.
[1] G. BOCCACCIO, Il Comento alla Divina Commedia e gli altri scritti intorno a Dante, a cura di D. Guerri, I, Bari 1918 (Scrittori d’Italia, G. Boccaccio, Opere volgari, XII), pp. 224-225: “E in questo lagrimare ancora più d’affezion si dimostra, dimostrandosi ancora un atto d’amante, e massimamente di donna, le quali, come hanno pregato d’alcuna cosa la quale disiderino, incontanente lagrimano, mostrando in quello il disiderio suo essere ardentissimo”.
Tab. 2.1
3. I limiti invalicabili dell’Impero romano (Ap 9, 14)
La voce proveniente dai quattro lati dell’altare d’oro (Ap 9, 13) dice al sesto angelo tubicinante di sciogliere i quattro angeli legati nel grande fiume Eufrate (Ap 9, 14). Riccardo di San Vittore interpreta questo fiume come il battesimo, il cui merito non ha permesso all’esercito delle genti infedeli di distruggere la cristianità. Secondo Gioacchino da Fiore, il grande fiume è invece l’Impero romano, per la cui possente resistenza non fu permesso alle genti di passare i confini posti da Dio. Quando il sesto angelo verserà la sua coppa sul fiume Eufrate (Ap 16, 12), le acque si prosciugheranno, ossia verrà meno la difesa della milizia cristiana e latina e si aprirà la via alla distruzione di Babilonia.
La funzione di ritenere i nemici della cristianità, che Gioacchino da Fiore assegna all’Impero romano, è nei versi assegnata da Ulisse a Ercole: “Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi / quando venimmo a quella foce stretta / dov’ Ercule segnò li suoi riguardi / acciò che l’uom più oltre non si metta” (Inf. XXVI, 106-109). L’esegesi di Ap 9, 14 va collazionata con quella di Ap 20, 3 (settima visione), dove l’angelo che possiede la chiave dell’abisso ha il potere di chiudere in esso il diavolo, e anzi di “segnare” la chiusura con un sigillo inviolabile. Agostino (De civitate Dei, XX, 7) vede in questa chiusura la volontà di Dio di non rendere noti coloro che il diavolo non potrà sedurre e gli altri nei quali gli sarà invece concesso di mettersi. Olivi aggiunge che la legge di Cristo e l’esemplare vita sua e dei suoi seguaci legano il diavolo affinché non seduca costoro e sono il limite non oltrepassabile. Anche la santità della grazia dei sacramenti di Cristo è come un segno che incute timore e impedisce che il diavolo acceda a coloro che da essi sono segnati. Il passo tratto da Ap 20, 3 ha nella Lectura come contesto il rapporto tra l’essere il diavolo legato per mille anni e il suo potere di tentare, sciolto, i predestinati, una questione che Olivi risolve con ampie citazioni dal De civitate Dei (a questa esegesi rinviano alcune parole-chiave in Purg. I, 46, 77, 89: “le leggi d’abisso … men non lega … per quella legge).
Ercole, in quanto rappresentante dell’Impero romano ancora prima della sua formazione storica, assume un valore provvidenziale. Ulisse non poteva varcare i limiti da lui posti per “la divina elezione del romano imperio”, per cui “Enea venne di Troia in Italia, che fu origine de la cittade romana, sì come testimoniano le scritture”, e Roma nacque nel medesimo tempo in cui nacque David, dalla cui progenie (dalla radice di Iesse) sarebbe discesa Maria, “la baldezza e l’onore dell’umana generazione”, come scritto in Convivio IV, v, 5-6. Un’elezione divina avvenuta nell’Empireo (Inf. II, 20-21), in “quella Roma onde Cristo è romano” (Purg. XXXII, 102), contro la quale nulla può l’ardore di Ulisse. Il fattore che trattiene le genti infedeli, nell’esegesi scritturale, è ad Ap 9, 14 l’Impero romano e ad Ap 20, 3 la “Christi lex et eius et suorum sanctorum exemplaris vita … quia sanctitas gratie sacramentorum Christi est signum terrens et prohibens diabolum ab hiis qui sunt gratia Christi et eius sacramentis signati”. L’Aquila è “sacrosanto segno” (Par. VI, 32), per essa si manifestano i segni di Dio nella storia umana, che attuano in terra la sua volontà, una con quella del cielo e con quella di Roma stessa: “divina voluntas per signa querenda est” (Monarchia II, ii, 8).
“Acciò che l’uom più oltre non si metta”. Ulisse avrebbe dovuto considerare di seguire virtù e conoscenza in senso relativo, per quanto possibile in questa vita, e invece le desiderò assolutamente. L’esperienza dei costumi umani, dei vizi e delle virtù, della quale Orazio rende modello il greco, avrebbe dovuto essergli sufficiente, mantenendolo nel campo dell’Etica, cioè dell’intelligenza morale propria dell’uomo razionale, esaltato nel terzo stato. Campo riservato agli Antichi dalla prescienza divina, che in esso ebbero la propria parte di libro aperto e “però moralità lasciaro al mondo” (Purg. XVIII, 67-69). Ulisse volle invece sperimentare con i sensi il “mondo sanza gente”, andando oltre l’Etica verso la montagna dell’anagogia (il ‘sovrasenso’). La terra proibita alla ragione umana non era solo una terra senza abitanti, l’ “extra notum nobis orbem” di cui scrive Seneca (Epist. LXXXVIII, 6); era figura della terra che sarebbe stata data alle Genti, luogo della loro conversione a Cristo, che si sarebbe compiuta solo nel sesto stato della Chiesa. L’ultimo viaggio dell’eroe greco fu un andare sensibilmente al sesto stato, verso un lido allora noto unicamente a Dio, andata che solo un uomo evangelico avrebbe potuto compiere, nel novum saeculum segnato dal secondo avvento di Cristo nello Spirito. Su quel “lito diserto”, all’arrivo di Dante, sta Catone. Custode della legge, garante della libera volontà, di un tesoro che con il suicidio fece vittima come in un voto di alto valore, il “santo petto” di Catone sta ai piedi della montagna che designa il tempo, non ancora concluso, della “plenitudo gentium” paolina.
Prima che Ercole ponesse le sue mete alla ragione umana, un segno invalicabile era già stato posto da Dio stesso ad Adamo, come ammesso dal progenitore, il quale spiega a Dante che non il gustare il frutto proibito causò la cacciata dall’Eden, “ma solamente il trapassar del segno”, non cioè il peccato di gola, ma quello di superbia (Par. XXVI, 115-117). L’andare oltre il segno, nel caso di Ulisse, è proposto in modo assai più chiuso che nel caso di Adamo, ma qualcosa li unisce, nel comune presumere di sapere. Non è casuale, come mai nulla è nel poema sacro, se l’incontro con entrambi corrisponda nel medesimo numero di canto e che, nel canto successivo a quello relativo ad Adamo, il ricordo di Ulisse si ripresenti allorché, prima di ascendere al Primo Mobile, Dante ne vede dall’alto “il varco folle” (Par. XXVII, 82-83). Adamo condannò sé e tutta la sua prole “per non soffrire a la virtù che vole / freno a suo prode” (Par. VII, 25-27; un’assenza di freno che per Eva fu assenza di “velo”, Purg. XXIX, 25-27; si noti, ancora, la simmetria numerica dei versi); Ulisse si perdette per sé, per non aver frenato il suo ingegno.
Il passo della sesta tromba (Ap 9, 14), con il tema del trattenere, trova vari riscontri. Nella rosa dell’Empireo, san Bernardo spiega che, dopo la Redenzione, coloro che muoiono senza battesimo sono ‘ritenuti’ (il ritenere traduce l’ “alligare”) nel Limbo (Par. XXXII, 82-84). Stazio racconta di aver ricevuto il battesimo prima di scrivere l’episodio in cui i Greci giungono ai fiumi di Tebe (Purg. XXII, 88-89). A prima vista non sembrerebbe esserci alcuna relazione con l’esegesi (salvo il riferimento congiunto al fiume e al battesimo; da notare che Tebe è figura classica della Babilonia ebraica e della Babylon moderna: cfr. Inf. XXXIII, 89), se più avanti i tre poeti, sulla soglia del sesto girone della montagna, non trovassero la strada sbarrata da un albero i cui rami digradano all’ingiù, “perché persona sù non vada”, limite stabilito da Dio per punire i golosi (Purg. XXII, 130-135). Tra i golosi rinsecchiti nella pelle (come le acque dell’Eufrate al versamento della sesta coppa), Bonagiunta da Lucca, una volta che Dante gli ha esposto il proprio manifesto poetico, dichiara di essere finalmente in grado di vedere “il nodo / che ’l Notaro e Guittone e me ritenne / di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo”, impedendo di varcare il limite superato invece dalle “nove rime” (Purg. XXIV, 55-57). Superare il confine appartiene al sesto stato, al periodo della vita cristiforme, del rendersi simili a Cristo, del seguirlo fedelmente, che non è poi altro, nelle parole di Bonagiunta, se non l’andare dietro stretti al “dittator” che spira dentro. Che l’incontro con Bonagiunta sia il culmine del sesto stato lo si ricava dall’essere tutto l’episodio dell’incontro con Stazio e l’intero girone dei golosi tessuti con i motivi dello stato più caro ad Olivi, che iniziano dove finiscono quelli del quinto, appropriati al precedente girone degli avari e prodighi, che si conclude con un terremoto, trasposizione di quello con cui si apre il sesto sigillo.
Il passaggio dalla quinta alla sesta bolgia è vietato ai Malebranche che vorrebbero prendere Dante e Virgilio, perché posti dall’alta provvidenza come “ministri de la fossa quinta” (Inf. XXIII, 55-57). In questo caso il limite di cui si dice ad Ap 9, 14 coincide con quello trattato ad Ap 20, 3, dove si proibisce al diavolo di tentare i predestinati.
Il messo celeste che apre la porta della Città di Dite – altro sesto momento – discende come vento impetuoso “che fier la selva e sanz’ alcun rattento / li rami schianta, abbatte e porta fori” (Inf. IX, 67-70), attraversa “con le piante asciutte” lo Stige dalle acque prosciugate come quelle dell’Eufrate per far via agli eserciti che distruggeranno la nuova Babilonia (ibid., 80-81), apre infine con una verghetta la porta “che non v’ebbe alcun ritegno” (ibid., 89-90; cfr. la pioggia che nulla ritiene nel suo rovinare dai fossati verso l’Arno a Purg. V, 121-123).
Con la sua “orazion picciola”, Ulisse rese i suoi compagni “sì aguti / … al cammino, / che a pena poscia li avrei ritenuti” (Inf. XXVI, 121-123), anticipando un momento che sarebbe dovuto avvenire dopo la Redenzione, nel sesto stato della Chiesa di Cristo, al suono della sesta tromba e al versamento della sesta coppa.
Olivi vede nel grande fiume Eufrate, che funge da meta non valicabile, il potere papale, cui obbediscono le plebi numerose, che impedisce il passaggio e l’assalto degli avversari dello stato evangelico. Lo scioglimento dei quattro angeli legati nel fiume significa pertanto che viene a cessare il favore del papa verso lo stato evangelico, impersonato dall’Ordine francescano. Questa interpretazione passa nel cielo di Venere, dove Folchetto da Marsiglia presenta la luce più fulgida, quella di Raab, la meretrice di Gerico la quale, ricevendo nella sua casa gli esploratori inviati da Giosuè, favorì la vittoria di questi in Terra Santa, nei luoghi che oggi non sono nel cuore del papa (Par. IX, 124-126). Il termine “favor”, che nel testo teologico è collegato alla persona del papa, nella terzina viene appropriato a Raab, restando sempre il riferimento polemico alla scarsa memoria (e dunque allo scarso favore) del pontefice verso i casi di Terra Santa. Il vescovo di Tolosa, sviluppando il tema della cessazione del favore papale verso lo stato evangelico, procede quindi a deplorare che, per brama di ricchezza (del fiorino, “il maladetto fiore” prodotto e sparso da Firenze, “pianta” di Lucifero), il pastore si sia trasformato in lupo e il Vangelo e i padri della Chiesa siano abbandonati a solo vantaggio dello studio delle Decretali, alle quali attendono il papa e i cardinali: “non vanno i lor pensieri a Nazarette, / là dove Gabrïello aperse l’ali” (ibid., 127-138).
Tab. 3.1
4. Odiare la carità fraterna (Ap 16, 10-11)
Bello in principio, dotato di tutti i doni dello Spirito, pacifico, di lunga durata (cinquecento anni a partire da Carlo Magno o da suo padre Pipino), limitato alla sede romana a causa delle devastazioni operate in Oriente dai Saraceni, il quinto stato degenera poi in rilassatezza: alla fine la Chiesa appare corrotta quasi fosse una nuova Babilonia (cfr. prologo, Notabile VII: “circa finem quinti temporis a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta”). La chiesa, delle sette d’Asia, che per eccellenza possiede tutte le perfezioni stellari è la quinta, quella di Sardi, assimilata alla sede romana (Ap 3, 1). Va tuttavia precisato che Roma in quanto meretrice si identifica con la moltitudine dei reprobi, i quali con le loro inique opere impugnano e blasfemano la Chiesa dei giusti peregrina sulla terra. Questa meretrice non deve pertanto essere cercata in un solo luogo ma, come per tutta l’area dell’impero romano è diffuso il grano degli eletti, così per la sua intera latitudine è dispersa la paglia dei reprobi. È l’interpretazione morale e spirituale dei “patres catholici”, che fa salve le prerogative carismatiche della sede romana, data da Gioacchino da Fiore citato da Olivi ad Ap 17, 1.
Il quinto angelo, cioè l’ordine dei santi che zelano nel quinto stato, “versò la sua coppa sulla sede della bestia e il regno di questa si fece tenebroso” (Ap 16, 10; quinta visione). La sede della bestia, cioè della moltitudine bestiale, prevale in numero e potere e quasi assorbe la Chiesa di Cristo con la quale si trova mischiata “localiter et nominaliter”, tanto da essere chiamata Chiesa dei fedeli come quella che è veramente per grazia la sede e la Chiesa di Cristo. Su tale sede dagli enormi e abominevoli vizi gli zelanti del quinto tempo non cessano di versare la coppa del rimprovero, in modo che il suo regno appaia a tutti con evidenza, si voglia o meno, “tenebroso”, cioè dissipato e reso abominevole da sozza ed enorme lussuria, avarizia, simonia, superbia, commercio doloso, astuzia e da quasi ogni malizia, per cui di seguito viene chiamata Babilonia, la meretrice che tiene in mano la coppa aurea piena di abominio (Ap 17, 4).
LSA, cap. XVI, Ap 16, 10 (Va visio, Va phiala) “Et quintus angelus” (Ap 16, 10), id est ordo sanctorum zelatorum quinti temporis, “effudit phialam suam super sedem bestie, et factum est regnum eius tenebrosum”. Nota quod sicut post quattuor animalia, quattuor primos status sanctorum designantia, sublimata est generalis sedes romane ecclesie, ceteris patriarchalibus seu ecclesiis orientalibus a Christo et ab eius vera fide reiectis, sic in eodem quinto tempore, post quattuor bestias a Daniele visas et quattuor primis ordinibus sanctorum contrarias (cfr. Dn 7, 2-8), sublimata est ‘sedes bestie’, id est bestialis caterve, ita ut numero et potestate prevaleat et fere absorbeat sedem Christi, cui localiter et nominaliter est commixta, unde et sic appellatur ecclesia fidelium sicut et illa que vere est per gratiam sedes et ecclesia Christi. Super huiusmodi vero malitiam non cessant zelatores sancti huius quinti temporis effundere phialam detestationis et celebris increpationis, ita quod “regnum” eius velit nolit evidenter apparet omnibus et etiam ipsismet “tenebrosum”, id est feda et enormi luxuria et avaritia et symonia et superbia et dolosa negotiatione et astutia et fere omni malitia dissipatum et abhominandum, unde et infra vocatur Babilon meretrix “habens in manu sua poculum aureum plenum abhominatione” (Ap 17, 1.4-5).
In particolare, la sede della bestia designa il clero carnale, che nel quinto tempo regna e presiede su tutta la Chiesa e in cui la vita bestiale regna e siede in modo trascendente e singolare come nella sua principale sede ed assai più che nelle plebi laiche ad esso soggette. Secondo Gioacchino da Fiore – che nell’esegesi oliviana della quinta coppa registra due citazioni contro una sola di Riccardo di san Vittore -, costoro ambiscono a regnare al di sopra dei loro confratelli come il diavolo regna al di sopra dei figli della superbia e, poiché all’abito sembrano essere dello stesso livello di coloro che su di essi effondono le coppe dell’ira divina, tanto più sdegnano di essere rimproverati dai propri uguali o dagli inferiori. Il loro regno si fa tenebroso perché l’ambizione acceca i loro occhi, in quanto l’odio che nutrono nei confronti di quanti li rimproverano sottrae ad essi del tutto il lume della vista.
Poiché, impediti dagli spirituali, non possono ottenere quello che vogliono, per il dolore nel cuore e per impazienza prorompono in detrazione di quanti li rimproverano. Per questo segue: “e si mangiarono le proprie lingue per il dolore”. Per “lingue”, secondo Gioacchino da Fiore, si intendono coloro che posseggono il fuoco dello zelo divino e l’ardore di parlare contro le ingiurie fatte a Dio, e tali lingue vengono morse dalle detrazioni fatte senza timore dai rimproverati. Secondo Riccardo di San Vittore, mordersi la lingua significa interrompere il discorso per livore d’invidia e per detrazione, oppure distruggere e corrodere dentro di sé ogni quieto sapore di gioia. “E bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei dolori e delle piaghe” (Ap 16, 11), cioè per il livore dell’invidia e per le piaghe inflitte per la confusione recata dai rimproveri dei santi. Bestemmiano Dio in quanto odiano e maledicono la grazia e la verità divina e il divino zelo dei santi. “E non si pentirono delle loro azioni”, cioè si ostinano nel loro operare malvagio invece di fare penitenza.
Come sempre nella metamorfosi dantesca, gli elementi che nella teologia della storia dell’Olivi sono concentrati sulla Chiesa vengono nel poema rifratti sull’intero creato e in particolare sul mondo umano, che si agita sull’ “aiuola che ci fa tanto feroci”.
L’espressione “quia quoad speciem habitus videntur esse unius ordinis cum eis” (riferita ai chierici che all’abito sembrano essere dello stesso livello di coloro che su di essi effondono le coppe dell’ira divina) viene traslata, in tutt’altro contesto (per quanto tessuto principalmente con i temi del quinto stato) nel richiamo dei tre fiorentini sodomiti: “Sòstati tu ch’a l’abito ne sembri / essere alcun di nostra terra prava” (Inf. XVI, 8-9; cfr. “abitüati” a Purg. XXIX, 146).
La trattazione della quinta coppa è suscettibile di alcune collazioni, con passi anch’essi riferiti al quinto stato. Il “rodere” è proprio dei denti delle locuste che escono dal pozzo dell’abisso al suono della quinta tromba, considerati ad Ap 9, 8 (quinta proprietà), e si tratta del corrodere crudelmente la vita e la fama degli altri. Dell’odio, vizio predominante nella vita bestiale del quinto tempo, si tratta anche nell’esegesi del capitolo XV, il quale fa da introduzione alla quinta visione, che è quella delle coppe (ad Ap 15, 1). Una citazione di Gioacchino da Fiore afferma che dopo le prime quattro virtù, corrispondenti ai quattro animali che stanno intorno alla sede divina (Ap 4, 6-8) – fede, pazienza, umiltà e speranza -, succede lo zelo igneo della carità proprio dello Spirito Santo e della sua sede sostenuta dai quattro animali. Così nei reprobi, ai quattro vizi contrari – infedeltà, impazienza, superbia, disperazione – subentra l’odio della fraterna carità, che è peccato contro lo Spirito Santo.
Questi temi – l’odio, corrodere la fama altrui, mangiare coi denti, vivere bestiale, il dolore del cuore, l’impazienza, la disperazione, l’accecamento – sono altrettanti fili del panno di cui è vestito il conte Ugolino. Coi denti rode il misero teschio dell’arcivescovo Ruggieri, come Tideo “si rose / le tempie a Menalippo per disdegno”, ed è un roderne la fama: “Ma se le mie parole esser dien seme / che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo” (Inf. XXXII, 127-132; XXXIII, 7-8). Per “sì bestial segno” mostra odio su colui che si mangia, ma ha anche il cuore oppresso da disperato dolore (Inf. XXXII, 133-134; XXXIII, 4-6). Mostra impazienza di fronte all’impassibilità senza pianto del poeta, che considera crudele (XXXIII, 40-42). Non solo si mangia il suo nemico, “come ’l pan per fame si manduca”, ma si morde per il dolore ambo le mani tanto che i figli pensano che lo faccia “per voglia di manicar”, lì dove le mani sostituiscono nella poesia il mordersi la lingua della prosa scritturale (Inf. XXXII, 127; XXXIII, 58-60). Brancola cieco sopra i figli morti (Inf. XXXIII, 72-73). Dopo il racconto, “con li occhi torti / riprese ’l teschio misero co’ denti” in modo ancor più ostinato di prima (vv. 76-77), variazione sul «“Et non egerunt penitentiam ex operibus suis”, scilicet malis, immo, supple, amplius obstinati sunt in illis peragendis» da Ap 16, 11. I denti, “che furo a l’osso, come d’un can, forti” (v. 78): nell’esegesi di Ap 22, 15 i cani sono i detrattori della vita altrui, come i malvagi su cui viene versata la quinta coppa. Si può notare che forse anche l’espressione “ma se le mie parole esser dien seme” (v. 7) suggerisce una caratteristica delle locuste, che “disseminant verba sua” (è la “vox alarum” trattata ad Ap 9, 9). Il sembrare Dante fiorentino all’ascolto della lingua pare rinviare allo stesso inciso da cui proviene il richiamo dei tre fiorentini sodomiti (vv. 11-12).
All’impazienza del conte ben si addice quella provocata dal versamento della quinta coppa:
Potest etiam effusio huius phiale exponi de pluribus corporalibus bellis et exterminiis temporalis regni ecclesie in hoc quinto tempore factis, ex quo multi per impatientiam se corroserunt et Deum blasphemaverunt.
In Purg. VI, 82-84 a rodersi l’un l’altro sono i cittadini della “serva Italia”, chiusi da uno stesso muro e da uno stesso fossato, e invece sempre divisi da fazioni che si combattono. Il muro e il fossato sono motivi della Gerusalemme celeste, della “civitas” interpretata come “civium unitas” (Ap 21, 2 .12.18). I temi sono trattati nella settima visione.
Dello stesso tenore sono le parole di Brunetto Latini: “Faccian le bestie fiesolane strame / di lor medesme” (Inf. XV, 73-74), in un contesto (si tratta di una zona nella quale prevalgono i temi del quinto stato) dove l’aver fame del poeta da parte delle fazioni fiorentine si presta ad una variazione del versetto “et commanducaverunt linguas suas pre dolore”, cioè si rodano tra loro e non tocchino Dante, “sementa santa”.
Mordersi la lingua per livore d’invidia e per detrazione si addice ai Malebranche, i dieci demoni che, prima di andare in compagnia di Virgilio e Dante a sorvegliare i barattieri immersi nella pece, “avea ciascun la lingua stretta / coi denti, verso lor duca, per cenno”, cui Barbariccia risponde “con sì diversa cennamella” (Inf. XXI, 136-139; XXII, 10).
All’inizio del capitolo XIII (quarta visione), la bestia che sale dal mare ha sette teste e dieci corna (Ap 13, 1). Su questo luogo Gioacchino da Fiore (richiamato da Olivi anche ad Ap 12, 3) afferma che le teste di questa bestia differiscono dalle teste del drago come le chiese metropolitane, che sono capo alle altre, si distinguono dai propri vescovi, i quali sono comunque anch’essi capi e quasi teste di Cristo di cui fanno le veci, e con ciò intende che quei popoli che furono i principali nel perseguitare Cristo e la Chiesa sono, come capi degli altri, propriamente teste della bestia e della massa bestiale. Il riferimento ai “capita capitum”, cioè a delle teste che stanno sopra altre teste loro sottoposte, e queste teste bestiali che sovrastano le altre sono gli arcivescovi preposti alle chiese metropolitane, è impersonato nei versi dalla posizione sovrapposta del conte Ugolino nel rodere coi denti l’arcivescovo Ruggieri, “sì che l’un capo a l’altro era cappello” (Inf. XXXII, 126), posizione rovesciata rispetto all’esegesi poiché è l’arcivescovo a star sotto, ma che mostra ugualmente, “per sì bestial segno”, due bestie una delle quali soggiace e l’altra soggioga.
Tab. 4.1
Tab. 4.2
[LSA, cap. XII, Ap 12, 3 (IVa visio)] Secundum autem Ioachim, septem capita drachonis sunt allegorice septem reges, qui secundum septem status ecclesie debebant esse prima et principalia capita septem certaminum contra Christum et eius ecclesiam fiendorum. Sicut enim episcopalis ecclesia dicitur esse caput subiectarum ecclesiarum, episcopus vero dicitur esse caput illius ecclesie, sic illi populi per quos facte sunt generales seu principales persecutiones ecclesie sunt capita bestie de quibus in capitulo sequenti agetur (cfr. Ap 13, 1). Reges vero, qui eisdem populis prefuerunt, dicuntur capita drachonis et quasi capita capitum; corpus vero drachonis est innumera reproborum multitudo*.* Expositio, pars IV, distinctio I, f. 156rb-va. |
[LSA, cap. XIII, Ap 13, 1 (IVa visio)] Et ideo subdit: “habentem capita septem”. Ioachim, prout superius recitavi, dicit quod capita huius bestie differunt a capitibus drachonis sicut metropolitane ecclesie, que sunt capita aliarum, differunt a suis episcopis, qui utique sunt capita ipsarum et quasi capita Christi cuius vicem gerunt. Et secundum hoc, vult quod illi populi, qui fuerunt principales et quasi capita aliorum ad persequendum Christum et ecclesiam, sint proprie capita bestie et bestialis caterve.Inf. XXXII, 124-126; XXXIII, 13-14Noi eravam partiti già da ello,
|
5. Le corazze degli pseudoprofeti (Ap 9, 17)