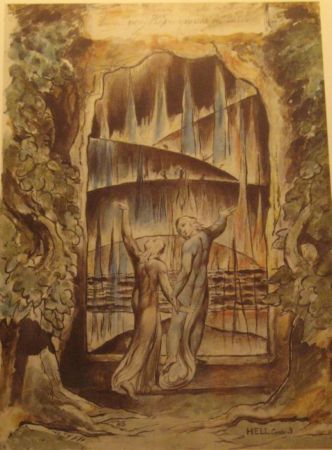INTRODUZIONE
Vieux prophètes du Moyen-Âge,
qui nous promettez l’Évangile éternel:
venez à notre aide!
Jules Michelet [1]
“Rabano è qui, e lucemi dallato / il calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato”. Sulle parole di san Bonaventura pronunciate nel cielo del Sole, dove si mostrano gli spiriti sapienti (Par. XII, 139-141), scriveva Arsenio Frugoni:
Che la qualifica di ‘profeta’ possa avere giustificazione in una conoscenza diretta o indiretta da parte di Dante di opere, autentiche o credute tali, di Gioacchino, non si può affermare, perché manca nell’opera di Dante una qualsiasi indicazione di opere di Gioacchino; né ci è dato di trovare un solo riscontro testuale preciso, ché sempre ci si può richiamare a una fonte comune, scritturale o patristica, o riferire ad affermazioni diffuse nel mondo ‛spirituale’ [2].
Era definitivamente chiusa la via di un rapporto diretto di Dante con l’opera dell’abate calabrese, dopo che la pubblicazione del Liber Figurarum, attribuito a Gioacchino, da parte di Leone Tondelli [3] aveva suscitato tante speranze presto deluse dal confronto fra i testi.
Restava l’altra via, quella di un rapporto di Dante con il “gioachimismo”, cioè con le opere nate nell’ambito dei movimenti ispirati in qualche modo a Gioacchino.
Nel suo saggio del 1965 su Dante e l ’“Ecclesia Spiritualis”, Manselli partiva proprio da tale questione chiedendosi come fosse possibile negare il rapporto che unisce la religiosità dantesca, la sua critica alla gerarchia ecclesiastica, con uno dei più tormentati filoni della religiosità duecentesca. La risposta è che se Dante non conobbe le opere di Gioacchino, ebbe però presente l’idea dell’Ecclesia Spiritualis così come si era sviluppata tra gli Spirituali francescani, e ne condivise alcuni degli elementi fondamentali. In questo senso Pietro di Giovanni Olivi, il maggiore esponente del movimento spirituale, non può considerarsi una fonte di Dante ma, attraverso la Lectura super Apocalipsim, una voce dell’Ecclesia Spiritualis [4].
Manselli era l’ultimo dei grandi maestri che avevano segnato il campo nel secolo XX. Alois Dempf, in Sacrum Imperium (1929), aveva accostato la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi (completata poco prima della morte, a Narbonne, nel 1298) alla Commedia di Dante (iniziata intorno al 1307) come due “Apocalissi gioachimite”. Con la differenza che Dante, posto fra due secoli, guardava come Giano sia a una guida spirituale sia a un imperatore filosofo [5].
Con grande equilibrio, nel 1932 Herbert Grundmann aveva inquadrato il problema del rapporto tra Dante e Gioacchino da Fiore nella spiegazione del perché l’abate calabrese si manifesti nel cielo del Sole accanto a Bonaventura che lo presenta [6].
Nel 1934, Ernst Benz aveva sottolineato nella sua Ecclesia Spiritualis la consonanza dell’elogio di san Francesco pronunciato da san Tommaso nel cielo del Sole con le attese escatologiche degli Spirituali francescani, come Dante avrebbe potuto leggere nella Lectura super Apocalipsim dell’Olivi e ascoltare dalle parole stesse del frate, che insegnò a Santa Croce fra il 1287 e il 1289 [7].
Due anni dopo, nel 1936, Ernesto Buonaiuti aveva trovato in Olivi lo “schema ideale” nel quale Dante “ha potuto inquadrare il suo amore per Beatrice” [8].
Con recisa negazione intervennero Michele Barbi e Bruno Nardi. Per il primo, che andava scrivendo sulle “eresie dantesche” di Dempf, la Commedia era certo una profezia e una rivelazione, ma a Dante poteva bastare il testo della Scrittura, senza la sua esegesi [9]. Il secondo denunciava come innaturale questo voler far coincidere le idee di Dante con quelle dei gioachimiti:
Nelle loro aspirazioni c’era qualcosa del romanticismo anarchico che di quando in quando vediamo tornare ad affermarsi, nel corso della storia, come reazione ad una vita politico-sociale agitata, turbolenta, tirannica. Dante aveva studiato troppo il suo Aristotele e il suo Virgilio per svalutare fino a questo punto la vita terrena. Ed aveva troppo lottato, troppo amato, troppo sofferto, per dimenticare anche nella luce dei cieli “l’aiuola che ci fa tanto feroci” e in essa Firenze [10].
[…] accanto alla Bibbia, per Dante, ci sono gli scritti d’Aristotele e c’è l’Eneide. Nel terzo stato di Gioacchino, invece, l’Impero è assente; e con l’Impero sono assenti la filosofia aristotelica e l’umanesimo virgiliano che riempiono di sé tutta la Divina Commedia. […] Non manca certo in Dante l’ardore religioso e lo slancio dei grandi mistici. […] Ma si guasterebbe il miracoloso equilibrio della Divina Commedia, se se ne accentuasse l’aspetto di visione profetica, qual essa certamente è, fino a ignorarne o anche semplicemente a svalutarne l’umanesimo filosofico, dimenticando che il poema dantesco è nato da una felicissima “contaminatio” dell’Eneide con la Bibbia [11].
In tutti questi casi, di affermazione o diniego, il confronto tra Dante e gli Spirituali era un mettere in parallelo le idee, coincidenti o divergenti, di rinnovamento della Chiesa. Nel 1984, Marjorie Reeves, al II Congresso internazionale di studi gioachimiti al quale partecipò anche Raoul Manselli, propose di connettere il numero con cui Beatrice indica il messo di Dio – “cinquecento”, “diece” e “cinque”, cifre corrispondenti alle lettere latine D, X, V: DVX, invertendo l’ordine delle lettere (Purg. XXXIII, 43-45) –, con la profezia del novus dux contenuta nel quarto libro della Concordia di Gioacchino da Fiore [12]. Passo che però è citato nella Lectura super Apocalipsim dell’Olivi ad Ap 7, 2. Il confronto con quella che è stata definita l’ultima storia della salvezza collettiva del Medioevo cristiano [13] non era più rinviabile.
I risultati della ricerca sin qui condotta, e pubblicata su questo sito, convergono tutti su un punto fondamentale: tra il poeta e il frate non ci fu solo una consonanza di idee. Olivi non fu per Dante solo una ‘voce’ come intendeva Manselli; l’insegnamento del Francescano, in vita e dopo la morte, si concretizzò in testi esegetici che il Fiorentino liberamente elaborò e trasformò in poesia aderendo alla teologia della storia espressa in particolare nella Lectura super Apocalipsim da cui trasse elementi semantici e concetti teologici in essi racchiusi, destinati alla Chiesa, per trasferirli sulle vicende dell’ “aiuola che ci fa tanto feroci”. Non fu un tentativo mistico, come sarebbe avvenuto al principio del secolo XX con Solov’ëv, il primo Blok e gli altri simbolisti russi del gruppo degli “Argonauti”, ispirati dalla teologia nella ricerca del soprannaturale, dell’Eterno Femminino; la teologia della storia dell’Olivi – la più discussa del tempo nella sua novità – servì a Dante per dare ad Aristotele e agli Antichi la cittadinanza “di quella Roma onde Cristo è romano”. Non fu la poesia “ancilla theologiae”, bensì fu il “saeculum humanum”, per usare il titolo di un celebre libro di Hanno Helbling (Napoli 1958), ad appropriarsi delle sacre prerogative.
Dante si sentì investito di una missione, attraverso la poesia, di predicazione e di conversione universale. Nuovo Giovanni esiliato e visionario autore di una nuova Apocalisse, nel narrare la sua vera visione fu profeta perché diede alle particolari vicende e personaggi di questo mondo valore universale. Così fu Isaia il quale, parlando di Babilonia e del suo re, dilata il discorso rivolgendolo contro tutto il mondo simile a Babilonia e contro Lucifero re di tutti i superbi e i malvagi quasi fosse re della grande Babilonia (Is 14, 12). Così Ezechiele, parlando contro Tiro, si diffonde su tutto il mondo e sul supremo cherubino che sta nel mezzo delle pietre infuocate (Ez 28, 14-16). Così Cristo, che attribuisce tutti i mali provenienti da ogni generazione di reprobi alla particolare malvagia generazione dei reprobi Giudei del suo tempo, sulla quale ricade tutto il sangue versato dal tempo di Abele il giusto (Matteo 23, 35-36). Così l’autore dell’Apocalisse, che toccando della bestia che sale dal mare (la bestia saracena: Ap 13, 1-10) si dilata a tutta la massa dei reprobi che dalla creazione alla fine del mondo combatte contro la Chiesa degli eletti e ha sette teste corrispondenti alle sette età. Così Dante può dire della fama di Firenze che “si spande” per tutto l’inferno (Inf. XXVI, 1-3), o che la città “è pianta” di Lucifero (Par. IX, 127-128). Fu profeta ‘laico’, nel senso che rese sacro il “viver bene” dell’“omo in terra”, con le sue esigenze – lingua, ragione, regime politico – e le sue passioni. Il realismo dantesco fa sì che “l’altro mondo è reso sensibile e leggibile con le forme del nostro mondo” [14] ma, armonizzando “e cielo e terra”, nel “poema sacro” le forme del nostro mondo sono inserite in un processo storico che manifesta i segni della volontà divina. Questa storia universale della salvezza è contenuta nella Lectura super Apocalipsim dell’Olivi.
Le norme che regolano il rapporto intertestuale fra Commedia e Lectura sono state più volte indicate: rispondenze semantiche in rose di parole-chiave entro spazi testuali ristretti, con accostamenti non banali o scontati; parole-chiave, riferibili alla medesima pagina esegetica, che si riscontrano in più punti del poema; collazione di più passi della Lectura (il cui testo si può scomporre e riaggregare sulla base di elementi settenari), secondo un procedimento analogico tipico delle distinctiones ad uso dei predicatori; elaborazione di una struttura semantica interna al poema, “topograficamente” articolata secondo i sette stati della storia della Chiesa, cioè secondo le categorie in base alle quali Olivi espone l’Apocalisse.
È stato anche sempre sottolineato che l’adesione non significa acquiescenza. Dante aggiorna l’Olivi appropriando i concetti teologici presenti nella Lectura all’Impero, alla filosofia aristotelica e all’umanesimo virgiliano che, come rilevava Nardi nella critica al Tondelli, riempiono di sé tutta la Commedia.
Poema polisemico, secondo quanto l’autore afferma nell’Epistola a Cangrande (Ep. XIII, 20), la Commedia è un universo di segni. Il senso letterale contiene parole che sono chiavi di accesso a un altro testo, la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi. Si tratta di un procedimento di arte della memoria: le parole-chiave operano sul lettore come imagines agentes che lo sollecitano verso un’opera di ampia dottrina, che già conosce, ma che rilegge mentalmente parafrasata in volgare, profondamente aggiornata secondo gli intenti propri del poeta, in versi che le prestano “e piedi e mano” e la dotano di exempla contemporanei e noti. Nel senso letterale del “poema sacro”, riservato a tutti, sono incardinati gli altri sensi interpretativi: allegorico, morale, anagogico (che Dante, nell’Epistola a Cangrande, definisce collettivamente “mistici” o “allegorici”). Dante mirava non solo a un pubblico di laici, ma anche di predicatori e riformatori della Chiesa. Questo pubblico di chierici non si formò, perché gli Spirituali (non un gruppo organizzato, ma di sensibilità comune), che dovevano conoscere la Lectura oliviana, furono perseguitati e il loro libro-vessillo, censurato nel 1318-1319 e condannato nel 1326, fu votato alla clandestinità e quasi alla sparizione. Ma la Commedia e la Lectura, testualmente tanto unite, furono anche gli ultimi testimoni, nel Medioevo cristiano, dell’inserimento dell’individuo nell’ordine universale secondo i giudizi di Dio, di una storia della salvezza collettiva, prima che l’individuo restasse solo.
Incurante della “solita censura ideologica e inquisizionale” operata dal “pietismo dantistico imperante” allo scopo di sottrarre Dante all’eterodossia, di cui scriveva Giorgio Brugnoli a proposito della possibilità che il poeta avesse aderito alle tesi dell’Olivi condannate dal Concilio di Vienne (1311-1312) [15], indifferente ai timori dei guardiani del laicismo integrale su un possibile ‘farsi frate’ dell’autore della Monarchia, tetragona ai consapevoli silenzi accademici che l’hanno accompagnata per vent’anni [16], la ricerca rovescia la vecchia regoletta del loicare, che Nardi adduceva a proposito delle presunte fonti dantesche [17]: “a posse ad esse non datur illatio”. Non inventa ipotesi ma mostra testi, non forzandoli né dolcemente sollecitandoli. Sono i testi, nel loro esse, ad argomentare e a provare.
Il rapporto fra Commedia e Lectura getta nuova luce sull’intera opera dantesca – dalle “nove rime” alla Vita Nova al Convivio alla Monarchia -; potrà forse in futuro precisare meglio cronologie insicure e accertare “possibili” biografie di Dante. Egregi studi sui rapporti del poeta con il gioachimismo [18] e con i Francescani [19] potranno essere rivisti alla luce della nuova ricerca. Tutto ruota attorno al momento in cui Dante ebbe in mano la Lectura dell’Olivi. Fu probabilmente Ubertino da Casale colui che diede a Dante il “libro” affinché ne facesse cosa nuova in versi. Dopo la morte dell’Olivi la Lectura si diffuse subito in Italia; nel 1305 (marzo-settembre) Ubertino da Casale l’aveva con sé a La Verna mentre scriveva l’Arbor vitae; nel 1306 (6 ottobre) Dante è in Lunigiana come procuratore di pace con il vescovo di Luni per conto dei Malaspina; nel 1307 è forse in Casentino, da dove invia a Moroello la canzone Montanina; nello stesso anno Ubertino, diventato cappellano del cardinale Napoleone Orsini [20], opera per il ritorno a Firenze degli esiliati, azione che fallisce dopo il mancato scontro a Gargonza tra i Neri e le truppe del Cardinale, ospite dei conti Guidi. Dunque negli stessi mesi, e in luoghi contigui se non coincidenti, Dante e Ubertino lavoravano per la pace, e si può ben immaginare quanto l’attività del frate stesse a cuore al poeta. Fu quella l’ultima possibilità che Dante ebbe di rientrare a Firenze prima dell’inizio della stesura della Commedia. Fu un anno decisivo, il 1307, come scrisse Giorgio Petrocchi, allorché “un totale commovimento etico-religioso, quale ben oltre la visione allegorica della Vita Nuova, irrompe nelle prime terzine dell’Inferno” e “il mondo del profetismo gioachimita e celestiniano del Duecento crea nuovi temi e interrogativi all’animo del poeta” [21].
In ogni caso, parlare di “profetismo” dantesco senza conoscere la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi significa rimanere sul piano del confronto di idee, legittimo ma privo di quelle basi storiche che solo può fornire lo scavo dei testi, e dunque opinabile e insicuro. Togliere la Lectura dalla ‘biblioteca’ di Dante, o non valutare compiutamente il gran peso che vi recò, equivale a concepire quella di Agostino senza le Historiae di Orosio, di Cervantes senza i romanzi cavallereschi, di Proust senza Ruskin e Bergson, di Italo Calvino senza Kipling e Conrad.
In questa nuova situazione, il rapporto Dante-Gioacchino da Fiore appare in modo più chiaro, liberato dai legittimi dubbi derivanti dalla dimostrata mancanza di conoscenza diretta. Di Gioacchino Dante utilizzò nel poema solo quanto citato dall’Olivi e solo in quel contesto che non era, in senso stretto, gioachimita.
Quasi una basilica a due navate, la Lectura è una synkresis tra due grandi esegeti dell’Apocalisse, che si temperano a vicenda: Riccardo di San Vittore (morto nel 1173), preoccupato dell’interpretazione letterale del testo, quale irrinunciabile fondamento dell’allegoria; Gioacchino da Fiore (che termina la sua Expositio nel 1200) [22], più attento all’interpretazione spirituale lì dove serva a interpretare i fatti storici contemporanei, e anche quelli passati in quanto prefigurazione degli eventi successivi. Sui due emerge la voce modesta e sapiente del francescano, tutta centrata su Cristo e sui suoi tre avventi, il secondo dei quali – novum saeculum – si verifica nei tempi moderni (il sesto stato della Chiesa), vicini ma non coincidenti con l’ultimo avvento, quello della parusia.
Complessivamente i due auctores sono in equilibrio: 161 citazioni esplicite di Riccardo (di cui 157 dal commento all’Apocalisse); 167 di Gioacchino (di cui 129 dall’Expositio e 38 dalla Concordia, ma le citazioni implicite sono assai più numerose rispetto a quelle del Vittorino) [23], a cui bisogna aggiungere due citazioni di rilievo dagli scritti pseudo gioachimiti (ad Ap 13, 18, sul redivivo seme di Federico II; ad Ap 20, 1-5, dove è fatto diffuso riferimento al De semine Scripturarum).
Gioacchino da Fiore non è per l’Olivi “un autore fra gli altri, che egli cita, discute, accetta o rifiuta come uno qualsiasi dei teologi o degli esegeti che via via utilizza nella sua opera”, come intende Raoul Manselli [24]. Ciò è vero sui singoli punti, ma Gioacchino è in primo luogo il profeta del sesto stato (che con il settimo corrisponde alla terza età dell’abate), e questo comporta in primo luogo l’accettazione della sua impostazione storica.
Con Riccardo di San Vittore il Francescano dissente su punti fondamentali, che riguardano proprio il sesto stato. I 144.000 segnati all’apertura del sesto sigillo da tutte le dodici tribù d’Israele (Ap 7, 3-8) sono, secondo il Vittorino, i santi dell’Antico Testamento, il cui numero è preciso, a differenza della “turba magna, quam dinumerare nemo poterat” che segue (Ap 7, 9), con la quale sono invece designati i santi del Nuovo Testamento. Olivi rovescia questa interpretazione: i segnati sono gli eletti destinati all’ultima fase, cioè al sesto stato della Chiesa, come quanto mancava alla costruzione del tempio fu fatto negli ultimi sei anni. La gran turba, che viene dopo, segue i segnati come i fanti nella milizia seguono i cavalieri e i capitani.
Ancora, Riccardo afferma che l’angelo del sesto sigillo (Ap 7, 2; ciò vale anche per l’angelo dalla faccia solare di Ap 10, 1) è Cristo. Tale asserzione priva di ogni sviluppo storico la figura apocalittica. Se certamente Cristo è la prima causa di ogni bene, ha tuttavia ordinato sotto di sé uomini angelici che illuminano gli inferiori, come avvenuto anche per i sette angeli che suonano la tromba (Ap 10, 1).
In entrambi i casi, l’esegesi di Olivi è sostenuta da citazioni di Gioacchino, tutte di particolare pregnanza, soprattutto quella che fa riferimento alla duplice tribolazione di Pietro, con cui si apre la parte relativa ad Ap 7, 2. Ma il frate non arriva ad identificare l’angelo del sesto sigillo con un pontefice romano, l’“universalis pontifex nove Iherusalem” prefigurato nella salita al tempio di Zorobabele. Per lui è Francesco, seminatore della nuova pianta evangelica, fondatore cioè di un Ordine che convertirà molti pescando nel gran mare dei laici, che ascende partendo dalla “civitas solis”, cioè da Roma, “quia sui ascensus in Deum fundamentum et initium cepit a sede romana”. Non dunque una sola singola persona, un papa come pensava Gioacchino [25], ma più persone suscitate dallo Spirito, i discepoli di Francesco che potranno ancora ripercorrere quell’ascesa.
La struttura del pensiero di Gioacchino rimane e, ciò che è più importante, viene esposta in modo sintetico con una chiarezza, sconosciuta all’abate calabrese, che sembra quasi predisposta a una volgarizzazione. Accanto a una rilevante presenza, anche implicita (in particolare nel prologo e nella prima visione), di Gioacchino, si registrano tuttavia profonde differenze.
Soprattutto, l’età dello Spirito (il sesto e il settimo stato), che per Gioacchino è segnata dal giubilo salmodiante, è per Olivi tempo di prove e di battaglie, solo successivamente quietate [26]; su questo punto Gregorio Magno è autore determinante nella descrizione del martirio non corporale ma psicologico dei tempi finali, allorché il martire affronta un “certamen dubitationis” ingannato da una falsa Scrittura e da una falsa autorità pontificale [27].
Né per il francescano l’età dello Spirito è appropriazione a una persona della Trinità, ma manifestazione compiuta dello Spirito di Cristo, interno dettatore che subentra alla voce esteriore della sua umanità (per altro non completamente abbandonata):
[LSA, cap. IX, Ap 9, 20] Christus etiam et eius Spiritus non ignoravit rationem et causam propter quam idolatria fuit post tempora martirum exsufflanda, iuxta quod per psalmistam et prophetas fuerat multipliciter prophetatum. … [cap. XXII, Ap 22, 17] Septimo loquitur ut invitator omnium ad prefatam gloriam, et hoc tam per se quam per ecclesiam et eius doctores, unde subdit: “Et sponsus”, id est, secundum Ricardum, Christus (quidam tamen habent “Spiritus”, et quidam correctores dicunt quod sic habent antiqui et Greci, ut sic Christus tam per se quam per Spiritum suum et eius internam inspirationem ostendat se invitare), “et sponsa”, id est generalis ecclesia tam beata quam peregrinans vel contemplativa ecclesia, “dicunt: veni”, scilicet ad nuptias.
Passi come quelli presenti nell’esegesi di Ap 3, 7 e 9, 20, il cui impianto gioachimita è innegabile, non debbono trarre in inganno, perché hanno come centro Cristo e come sfera la Chiesa che gira, cioè si sviluppa in luminosità, per poi tornare al suo principio: “Ma naturalmente non si tratta di un ciclo dell’eterno ritorno: nel tornare in fine al suo principio la storia della Chiesa apre sempre orizzonti nuovi, non ripete il passato ma fruttifica, chiarisce, porta a compimento il processo inaugurato dal primo avvento di Cristo” [28]. Alla base c’è la visione cristocentrica esposta nella prima ratio del notabile VII del prologo, dove i tre stati generali del mondo si riferiscono prima “ad Christum prefigurandum et promittendum et parturiendum”, poi a Cristo “ut Dei et hominis filius mundum redimens et renovans”, e infine alla “singularis participatio et sollempnizatio sue sanctissime vite et caritatis”.
Si può dunque affermare che “[…] lo schema gioachimita delle tre età e dunque la funzione liminare dello Spirito Santo nella storia della salvezza sono senz’altro presenti nella Lectura super Apocalipsim; ma in essa il modello originale appare sottoposto a una radicale rilettura in chiave cristologica e francescana che ne modifica profondamente il contenuto; Francesco ripropone Cristo, e lo Spirito, che lo conduce e lo colma, è lo Spirito di Cristo, l’orizzonte dell’opera dello Spirito è sempre e comunque la Chiesa. Vi è certo un progresso, nella storia della Chiesa, nella conoscenza della Scrittura e nella comprensione della verità e tale progresso può essere ascritto e appropriato allo Spirito; ma la verità, chiarita e illustrata, è la verità di Cristo e della sua Chiesa. In definitiva, a ben vedere, lo Spirito non inaugura dunque un’epoca nuova ma porta a compimento e a pienezza il tempo della Chiesa nel Nuovo Testamento” [29]. Per cui, se Olivi assume lo schema gioachimita non sostituisce un’epoca nuova, appropriata allo Spirito, alle precedenti, ma delinea un’età di rinnovamento che porti alla loro piena “consummatio”: «Thus the age of the Holy Spirit will fulfill the Christian dispensation, not replace it […] In this context, finis seems to mean not “conclusion” but “fulfillment”» [30].
È nota la posizione dell’Olivi in merito a Gioacchino da Fiore, nel pensiero del quale distingue tra verità e opinioni:
[LSA, cap. IX, Ap 9, 1-11; IIIa visio Va tuba] Super quo et consimilibus advertendum quod ipse plura dicit non assertorie sed opinative. Sicut enim ex naturali lumine intellectus nostri quedam scimus indubitabiliter ut prima principia, quedam vero ut conclusiones ex ipsis necessario deductas, quedam vero nescimus sed solum opinamur per probabiles rationes, et in hoc tertio sepe fallimur et possumus falli, nec tamen ex hoc lumen nobis concreatum est falsum nec pro tanto fallimur pro quanto opiniones nostras scimus non esse scientias infallibiles, sic lumen per gratuitam revelationem datum quedam scit ut prima principia et indubitabilia revelata, quedam vero ut conclusiones ex ipsis necessario deductas, quedam vero ex utrisque solum probabiliter et coniecturaliter opinatur, et sic videtur fuisse intelligentia scripturarum et concordie novi et veteris testamenti per revelationem abbati Ioachim, ut ipsemet asserit, data. |
[LSA, cap. IX, Ap 9, 13; IIIa visio VIa tuba] Hec autem commemoravi quia videntur necessaria ad intelligentiam huius partis, et etiam ut sciatur quod Ioachim dicit in hiis multa non assertorie sed solum opinative. |
[LSA, cap. XII, Ap 12, 6; IVa visio] Quod autem ultra hoc Ioachim opinative dixit futuram persecutionem Antichristi esse complendam in primis quadraginta annis huius centenarii, aut etiam in tribus annis et dimidio prime partis eorum, unde et super illo verbo infra XIII° (Ap 13, 4): “Quis similis bestie, et quis poterit pugnare cum illa?”, dicit: «Heu, quot arbitror natos esse in mundo, qui tante huius calamitatis angustias non evadent!», non mireris si cum magna luce sibi data, quasi in aurora tertii status, habuit permixtas tenebras in notitiam futurorum, et maxime cum nocturne tenebre quinti temporis suo tempore inundarent. Quod autem non assertorie sed opinative talia dixerit, patet ex pluribus superius a me tactis super quinta et sexta tuba. |
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 10; VIa visio] Vides ne quod, tamquam dubitans circa ista, nunc in uno loco opinative dicit unum et in alio loco aliud, nec mirum, quia neutrum horum potest clare et indubitabiliter probari ex textu. |
Formalmente, è la stessa posizione di Tommaso d’Aquino (Super Sent., lib. 4, d. 43, q. 1, a. 3, qc. 2):
Ad tertium dicendum, quod quamvis status novi testamenti in generali sit praefiguratus per statum veteris testamenti, non tamen oportet quod singula respondeant singulis, praecipue cum in Christo omnes figurae veteris testamenti fuerint completae; et ideo Augustinus, 18 de Civ. Dei, respondet quibusdam, qui volebant accipere numerum persecutionum quae Ecclesia passa est et passura secundum numerum plagarum Aegypti, dicens: ego per illas res gestas in Aegypto istas persecutiones prophetice significatas esse non arbitror; quamvis ab eis qui hoc putant, exquisite et ingeniose illa singula his singulis comparata videantur, non prophetico spiritu, sed conjectura mentis humanae, quae aliquando ad verum pervenit, aliquando fallitur. Et similiter videtur esse de dictis abbatis Joachim, qui per tales conjecturas de futuris aliqua vera praedixit, et in aliquibus deceptus fuit.
Gioacchino, secondo Olivi, è colui che ha visto in spirito, senza fallire, il sesto stato, con il quale è iniziata la terza età generale del mondo. Può essere assimilato a Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, al quale venne rivelato il prossimo avvento di Cristo:
[LSA, cap. VI, Ap 6, 12; IIa visio, apertio VIi sigilli] […] est adhuc notandum a quo tempore debeat sumi initium huius sexte apertionis. Videtur enim quibusdam quod ab initio ordinis et regule sancti patris prefati; aliis vero quod a sollempni revelatione tertii status generalis continentis sextum et septimum statum ecclesie facta abbati Ioachim, et forte quibusdam aliis sibi contemporaneis […] Sicut enim Luchas inchoat Christi evangelium a sacerdotio Zacharie, cui facta est prophetica revelatio de Christo statim venturo et de Iohanne eius immediato precursore […] sic hec sexta apertio sumpsit quoddam prophetale initium a revelatione abbatis et consimilium […].
Sui singoli punti, le divergenze sono però numerose. Le posizioni sono completamente diverse, ad esempio, su una questione importante come i termini iniziali e finali dei sette periodi di guerra della Chiesa nella quarta visione: a partire dalla terza guerra (Ap 12, 13), l’Olivi procede in modo completamente autonomo. Così i due esegeti sono assai distanti nell’identificare il secondo dei due testimoni che, insieme ad Elia, verrà ucciso dalla bestia e poi risorgerà dopo tre giorni e mezzo: per Gioacchino si tratta di Mosè, per Olivi di Enoc (Ap 11, 3; è la stessa posizione di Bonaventura). Ancora, l’atrio che ad Ap 11, 2 si dice debba essere calcato dalle genti non designa per il francescano i Greci, ma i pravi chierici e religiosi della Chiesa latina. Nell’enumerare le sette teste del drago (Ap 12, 3), o le sette teste della bestia che sale dal mare (Ap 13, 1), o i sette re di Ap 17, 9-10, Olivi riporta l’opinione di Gioacchino, che le appropria storicamente a re e a popoli, ma poi, considerata anche la posizione prevalentemente morale di Riccardo di San Vittore, esprime il proprio parere in tutto o in parte diverso. A differenza di Gioacchino, Olivi non costringe in un tempo troppo breve (i tre anni e mezzo letteralmente intesi) né la distruzione di Babylon (ad Ap 11, 2) né la durata del terzo stato generale del mondo, che non può essere abbreviato in modo risibile e sproporzionato per un periodo che è appunto generale (prologo, notabile XII).
Oltre a Gioacchino da Fiore, a Riccardo di San Vittore e a Gregorio Magno, fonti importanti per la Lectura oliviana sono Agostino (per la questione del millenarismo ad Ap 20, 2) e lo pseudo Dionigi (soprattutto ad Ap 21, 9.18.21, dove Olivi, nell’esegesi della Gerusalemme celeste, paragona la differenziata gloria dei beati alle differenti gerarchie angeliche, che secondo Dionigi non possono essere da noi apprese in modo univoco, ma solo attraverso similitudini note e familiari; la gerarchia fra i beati, come fra gli angeli, fa sì che i diversi gradi siano tratti e tirino al tempo stesso verso la visione di Dio, nella quale i beati entrano come per specchi o vetri sempre più chiari o trasparenti).
Accostato a Riccardo di San Vittore o ad altri autori decisivi, incastonato nell’esegesi dell’Olivi, Gioacchino da Fiore, nel rapporto fra Commedia e Lectura super Apocalipsim, è presente nel “poema sacro” in modo diffuso, perché le numerose sue citazioni nella Lectura sono inserite nella generale metamorfosi di questa. Si procederà dunque progressivamente all’esame delle singole citazioni. Alcuni punti sono stati già trattati; se ne dà brevemente conto qui di seguito.
Si registrano pagine di autonoma rilevanza: Ap 7, 2 per le tribolazioni descritte nel primo canto dell’Inferno; 10, 1 (il “magnus predicator”) per il risveglio nell’Eden (Purg. XXXII); 17, 1, con l’immagine della Roma dei giusti peregrinante per l’intero Impero insieme a quella dei malvagi appropriata a Romeo, ministro di Provenza e pellegrino (Par. VI); 19, 17-18 per la “gustativa et palpativa experientia” del trasumanar nell’ascesa al cielo (Par. I).
In altre pagine Gioacchino da Fiore è solo una citazione fra altre nel contesto dell’esegesi oliviana: così di nuovo Ap 7, 2 nell’elogio di Francesco, angelo del sesto sigillo (Par. XI); la “signatio” (7, 3-4); 10, 3 (i sette tuoni); l’ingiunzione a Giovanni di predicare ancora, dopo gli apostoli, a tutto il mondo (10, 8).
Ampio spazio è riservato a Gioacchino nell’esegesi del quarto stato, alla quale rinviano celebri figure e luoghi del poema: la lupa, Omero, il passaggio dei petrosi margini del Flegetonte, solo per citarne alcuni (cfr. anche 12, 14).
Le opinioni gioachimite citate ad Ap 13, 18 subiscono una profonda trasformazione in Farinata.
Si possono accostare Virgilio e Gioacchino da Fiore, “di spirito profetico dotati ”, perché i limiti dell’abate calabrese, come sottolineati da Olivi, si riverberano nelle incertezze del poeta pagano.
Cosa rimane del rapporto tra Dante e Gioacchino da Fiore? In primo luogo, l’adesione a una storia della salvezza collettiva, descritta nel libro dell’Apocalisse come esposto dall’Olivi. In secondo luogo, una moltitudine di frammenti di testi di Gioacchino, citati nella Lectura super Apocalipsim, ai quali la poesia presta “e piedi e mano” vestendoli di un senso letterale la cui semantica doveva sollecitare la memoria del lettore accorto verso quelle citazioni che lui e il poeta sapevano appartenere all’abate calabrese. In terzo luogo, la fede in una nuova età, il novum saeculum che tanto s’aspetta dopo quello augusteo. C’è una perfetta concordanza spirituale, e anche letterale, fra quanto Olivi afferma della renovatio recata dal sesto e settimo stato della storia della Chiesa (l’età dello Spirito) e la quarta egloga virgiliana. Un’età nella quale ogni contraddizione o contrasto terreno si appiana (“Tunc enim omnis litigatio et contradictio inter vetus et novum omnino silebit, prout notat apertio septima”: LSA, cap. VIII, Ap 8, 1).
Notava Grundmann come la costante ricerca di una superiore concordia in terra fra opposte fazioni cittadine, fra posizioni speculative o teologiche avverse, fra impero e papato, i “due soli” in conflitto, consentì a Dante di collocare, fra gli spiriti sapienti che si manifestano nel cielo del Sole, Gioacchino da Fiore accanto a Bonaventura in simmetria con Sigieri di Brabante presentato da Tommaso d’Aquino. Con ciò si mostrò spirito veramente ‘cattolico’ [31]. Il rapporto con la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi non è estraneo alla ricerca di questa universale concordia. Con l’esegesi dell’ultimo libro canonico, esposta in una teologia della storia che comprende per settenari tutta la Scrittura, la quale a sua volta è forma, esempio e fine di ogni scienza, concorda infatti ogni conoscenza dell’autore, ogni esperienza, ogni soluzione indipendente data a questioni dottrinali, quasi la storia della salvezza marcata dai segni della volontà divina attribuisse a ciascuna il posto che le spetta. Non vi è solo concordia dell’Eneide con la Bibbia, come intendeva Nardi, ma dell’Eneide con l’Apocalisse e dunque con l’ “alta provedenza”.
Il volgare della Commedia, che tanto riceve dall’umile latino dell’esegesi e alla sua dottrina rinvia facendovi concordare ogni conoscenza, è vera clavis universalis del sapere. È la lingua del nuovo Giovanni, non più solo illustre ma di tutti; con essa gli stili possono essere liberamente variati, come lo sono nell’esegesi i quattro sensi scritturali; l’allegoria non è più finzione ma figura, cioè storia significante della prescienza e provvidenza divina. Nel secondo avvento di Cristo nei suoi discepoli spirituali, il volgare è diventato una nuova “lingua gratiae” come fu l’ebraico, la lingua parlata dal Redentore nel suo avvento nella carne [32].
—————————————————————————————————————————————-
Tab. introd.1 (Nota)
[LSA, cap. X, Ap 10, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] […] Ioachim dicit hic: «Quicumque erit iste predicator veritatis, “fortis” esse describitur, quia robustus erit in fide; et “de celo” descendet, id est de vita contemplativa ad activam; et “amictus” erit “nube”, quia indutus erit scriptura prophetarum; et “irim in capite”, quia Spiritum Sanctum et misticum seu spiritalem intellectum scripturarum habebit in mente. Sicut enim archus celestis apparet iunctus nubibus celi, sic scripturis prophetarum iungendus est misticus intellectus ad adversarios convincendos». Et subdit: «Ego autem angelum istum secundum litteram aut Enoch fore puto aut Heliam. Verum, prout hoc Deus melius novit, unum dico pro certo, quod hic angelus significat personaliter magnum aliquem predicatorem, quamvis spiritaliter ad multos viros spiritales tunc temporis futuros competenter valeat intorqueri. Sane facies angeli similis est soli, quia in hoc sexto tempore oportet Dei contemplationem in modum solis splendescere et perduci ad notitiam eorum qui designantur in Petro et Iacobo et Iohanne, id est Latinorum et Grecorum et Hebreorum, primo quidem Latinorum, deinde Grecorum, tertio Hebreorum, ut fiant novissimi qui erant primi et e contrario». Hec Ioachim. * […]
|
Purg. XXXII, 70-78Però trascorro a quando mi svegliai,
|
[Nota alla Tab. introd.1]
Ad Ap 10, 1, trattando dell’angelo che ha la faccia come il sole (terza visione, sesta tromba), Olivi cita l’Expositio in Apocalipsim di Gioacchino da Fiore. È un passo che Ubertino da Casale ha poi riportato nell’Arbor vitae e che il Kraus ritenne connesso con il Veltro [33]: “Penso che quest’angelo, secondo la lettera, sia Enoch o Elia, come Dio meglio sa; ma affermo con certezza che esso indica personalmente un grande predicatore, per quanto spiritualmente possa essere volto a indicare molti futuri uomini spirituali di quel tempo. La faccia dell’angelo è simile al sole perché in questo sesto stato è necessario che la contemplazione di Dio splenda come il sole per condurre alla verità coloro che sono designati in Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè i Latini, i Greci e gli Ebrei, prima i Latini, poi i Greci e infine gli Ebrei, perché siano ultimi coloro che furono primi e viceversa”.
Questa citazione conduce a Purg. XXXII, 70ss., allorché Dante si risveglia nell’Eden dal sonno, come Pietro, Giovanni e Iacopo si risvegliarono dopo essere stati condotti ad assistere alla trasfigurazione. Si ritrovano nei versi di Dante alcune parole della prosa esegetica: “splendescere”, “perduci” e i nomi dei tre apostoli. Si deve tenere in considerazione anche il passo del capitolo primo (simmetrico a quanto viene detto dell’angelo del capitolo X, ivi richiamato) relativo alla decima perfezione di Cristo sommo pastore (Ap 1, 16), dove “la faccia come il sole” designa appunto l’aperta e fulgida notizia delle Scritture che avviene nel mezzogiorno del sesto stato, come la trasfigurazione avvenne dopo sei giorni.
Si deve intendere che il risveglio del poeta designa la compiuta illuminazione di quelle genti che nel sesto stato verranno condotte a Cristo, prima le reliquie dei Gentili (Latini e Greci) e poi gli Ebrei. All’ora di mezzogiorno del sesto giorno di viaggio si chiude la seconda cantica (Purg. XXXIII, 103-105), con il poeta “rifatto sì come piante novelle / rinovellate di novella fronda” (ibid., 143-144). Il sesto stato è rinnovamento della vita di Cristo e della nuova pianta seminata da Francesco nel suo Ordine, nel senso che, dopo un inizio profetico con Gioacchino da Fiore, che con la terza età dello Spirito vide in anticipo il sesto stato, si ha un secondo inizio in Francesco (nella sua conversione, avvenuta nel 1206) e un terzo nell’Ordine perfettamente disposto e maturato a predicare contro l’Anticristo, un quarto infine nell’effettiva caduta di Babylon (cfr. l’esegesi di Ap 6, 12). Così il rinnovarsi della pianta prima dispogliata, una volta che il grifone vi ha legato il carro (Purg. XXXII, 52-60), è prefigurazione del Dante rinnovato, “puro e disposto a salire a le stelle”.
Da notare che all’angelo dal volto solare di Ap 10, 1 rinviano sia i versi relativi al Veltro (Inf. I, 100-105) come quelli riferiti a Cangrande (Par. XVII, 76-84).
—————————————————————————————————————————————-
Tab. introd.2 (Nota)
[Nota alla Tab. introd.2]
Che i Saraceni, mai nominati, siano ben presenti in Inf. III, lo dimostrano espressioni come “cattivo coro”, “setta d’i cattivi” (vv. 37, 62). I ‘cattivi’ sono i prigionieri fatti dai Saraceni, secondo l’esegesi dell’apertura del quarto sigillo (Ap 6, 8), in cui il cavallo pallido (la morte) designa Maometto e la sua setta, secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore seguita da Olivi. Da quando i Saraceni hanno iniziato a devastare la Chiesa non si è mai letto o ascoltato di miracoli fatti dai fedeli uccisi o resi schiavi, né che fosse stato dato il verbo della predicazione per convertire a Cristo gli infedeli e vivificarli o per confermare nella vita della fede i fedeli, ché anzi la maggior parte dei finiti in cattività è convolata alla setta mortifera. Tra i Saraceni non accade – e ciò da più di seicento anni – quanto era avvenuto con i pagani e gli eretici, fra i quali si moltiplicavano i fedeli e molti venivano convertiti alla fede.
Ecuba è “trista, misera e cattiva”, una troiana furia paragonata ai rabbiosi falsatori di persona (Inf. XXX, 16). Il primo difetto che rende chiuso il quarto sigillo (ad Ap 5, 1) è il superbo essere indomito della nostra libertà: nella quarta apertura la morte che siede sul cavallo pallido, cioè sulla carne già morta e impallidita (i Saraceni), domò e infranse la superba libertà delle chiese orientali che non vollero sottoporsi alla sede e alla fede di Pietro. E certo, afferma Olivi, nulla è più adatto ad infrangere la superbia del nostro potere quanto l’assidua considerazione ed esperienza della fragilità umana e della morte. Per spuntare la superbia umana è infatti detto nell’Ecclesiastico: “A che insuperbisci, terra e cenere?” (Ecli 10, 9) e: “In tutte le tue opere ricordati della tua fine, e non cadrai mai nel peccato” (Ecli 7, 40). I temi della superbia domata e della considerazione della morte sono appropriati, nella descrizione dell’ultima bolgia, appunto ai Troiani – la cui “altezza … che tutto ardiva” (motivo dell’ardua e alta vita degli anacoreti del quarto stato, distrutta in oriente dai Saraceni), fu volta in basso dalla fortuna, – e a Ecuba, che “forsennata latrò sì come cane” dopo che si fu accorta dei propri figli morti (Inf. XXX, 13-21). Variazioni dei motivi (la superbia domata, l’esperienza della morte) si registrano in Capaneo (Inf. XIV, 63-64; da notare, al v. 90, l’ “ammorta” appropriato al Flegetonte, i cui vapori estinguono le falde della pioggia infuocata, salvando i “duri margini” sui quali passano i due poeti), in Fialte (Inf. XXXI, 91-93), in Omberto Aldobrandesco (Purg. XI, 52-54), nelle parole di Beatrice e Pier Damiani a Par. XXI, 4-12, 61-63.
La superbia distrutta è nel ricordo di Montaperti, espresso da Oderisi da Gubbio a proposito di Provenzan Salvani, che era signore di Siena “quando fu distrutta / la rabbia fiorentina, che superba / fu a quel tempo sì com’ ora è putta” (Purg. XI, 112-114). L’orgoglio è propriamente fiorentino. Con Filippo Argenti: “Quei fu al mondo persona orgogliosa … ’l fiorentino spirito bizzarro” (Inf. VIII, 46-48, 61-63). Nella risposta di Dante ai tre concittadini sodomiti: “la gente nuova e i sùbiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni”, Inf. XVI, 73-75). Costituisce un vizio proprio del quarto tempo, allorché – come si afferma nel Notabile XII del Prologo con citazione dal quinto libro della Concordia di Gioacchino da Fiore – l’ordine degli anacoreti contemplativi “visus est floruisse ad horam” ma poi passò dalla perfezione al gloriarsi e di qui all’esaltazione e infine alla rovina.
Questi motivi si ritrovano nel discorso di Cacciaguida in Par. XVI, che utilizza (vv. 97-99) il tema del discendere, proprio del quinto stato, dall’alto e arduo stato precedente (cfr. il Notabile V del Prologo), applicandolo a “li alti Fiorentini” (alti come gli anacoreti, secondo l’interpretazione delle “stelle” data ad Ap 8, 12, nell’esegesi della quarta tromba), da lui conosciuti nel tempo in cui “le palle de l’oro / fiorian Fiorenza in tutt’ i suoi gran fatti” (vv. 109-111), e poi “disfatti / per lor superbia”.
Nell’elencare le schiatte degli “antichi ” fiorentini volte in basso dalla Fortuna, Cacciaguida usa l’immagine delle maree causate dal volgere del cielo della luna, che “cuopre e discuopre i liti sanza posa” (Par. XVI, 82-84), sollecitando la memoria del lettore verso le instabili generazioni dell’Antico Testamento di cui parla Gioacchino da Fiore nella citazione, ad Ap 12, 6, del secondo libro della Concordia.
__________________________________________________________________________________________________________________
Tab. introd.3 (Nota)
Par. X, 130-132Vedi oltre fiammeggiar l’ardente spiro
|
Inf. XXVI, 90-93, 118 …………………………Quando
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 14 (IVa visio, III-IVum prelium)] Nota etiam quod, secundum Ioachim, libro V° Concordie, sicut de opere quarte diei, scilicet de sole et luna et stellis, dicitur quod “sint in signa et tempora et dies et annos” (Gn 1, 14), sic in quarta visione huius libri, in qua describitur mulier in celo existens et adornata sole et luna et stellis, proponitur fuisse in “signum magnum” et distinguitur tempus eius in “tempus et tempora”, signanterque hoc reperitur ubi agitur de quarto statu ecclesie. Consimiliter enim sub quarto signaculo veteris testamenti fuit Helias et Heliseus et filii prophetarum quasi sol et luna et stelle, ubi et idem numerus ponitur, scilicet tres anni et dimidius absconsionis Helie a facie Iesabel (3 Rg 17-19) et subtractionis pluvie a gente peccatrice *. Et subdit: «quare hic misterialis numerus potius est scriptus sub quarto tempore quam sub alio, nisi quia quartum tempus est tribus temporibus precedentibus totidemque sequentibus veluti ex equo coniunctum, ita ut utrique participare videatur? Nempe et ecclesia ipsa virginum, que in muliere significatur, est mater et nutrix fidelium, quia Virgo portavit Christum in utero, Virgo peperit et lactavit?** Tales etiam viri et mulieres in signa fuere, quia sicut stelle celi in signa sunt navigantibus, ita et vita iustorum est in exemplum fidelium data, ut sciant quo ire debeant omnes qui considerant eos»***. Hec Ioachim.* Concordia, V 1, c. 12; Patschovsky 3, pp. 556, 12-18, 22-25; 557, 1-3.** Ibid., p. 557, 15-21.*** Ibid., p. 556, 19-22. |
|
Inf. XXII, 10-12, 19-24né già con sì diversa cennamella
|
Purg. III, 100-102, 112-117Così ’l maestro; e quella gente degna
|
[Nota alla Tab. introd.3]
Secondo Gioacchino da Fiore (quinto libro della Concordia, citato ad Ap 12, 14), come nel Genesi le opere del quarto giorno – il sole, la luna e le stelle – vengono chiamate “segni e tempi e giorni e anni” (Gn 1, 14), così nella quarta visione dell’Apocalisse la donna che sta nel cielo ed è adornata dal sole, dalla luna e dalle stelle viene detta “grande segno” (Ap 12, 1) e il suo tempo, che è il quarto della Chiesa, viene distinto in “tempo, tempi e la metà di un tempo” (Ap 12, 14) [34]. Il medesimo tema compare nel quarto sigillo dell’Antico Testamento, nel quale Elia, Eliseo e i figli dei profeti furono come il sole, la luna e le stelle ed Elia venne nascosto lontano da Gezabele per tre anni e mezzo, periodo nel quale la pioggia della predicazione venne sottratta alla gente peccatrice (3 Rg 18, 1; Lc 4, 25; Jc 5, 17). Gioacchino si domanda per quale motivo questo numero mistico compaia sempre nel quarto tempo, e risponde che il quarto è il mediano di sette tempi, connesso ai tre tempi precedenti e agli altrettanti che seguono e di tutti partecipante. La donna – la Vergine che portò Cristo nel ventre, che lo partorì e lo allattò – sta a significare la Chiesa delle vergini, madre e nutrice dei fedeli, formata da uomini e donne dalla giusta vita che, come le stelle del cielo segnano il cammino ai naviganti, sono segni ed esempi agli altri, in modo che sappiano dove andare coloro che li considerano.
Pier Damiani, nel settimo cielo di Saturno (Par. XXI), si rivolge a Dante in tre riprese, corrispondenti a tre domande del poeta: la prima volta ai versi 61-72, per spiegare perché in quel cielo non si oda, come negli altri, il dolce canto e per chiarire cosa l’abbia spinto a scendere i gradini della scala santa per porsi vicino a lui; la seconda volta ai versi 79-102, per spiegare l’imperscrutabilità dei disegni provvidenziali; la terza volta – “il terzo sermo” – ricomincia ai versi 106-111 e continua ai versi 112-135. Questa divisione dei versi comporta che il ‘primo sermo’ occupi 12 versi (“un tempo”), il secondo 24 versi (“due tempi”, il doppio del primo) e l’inizio del “terzo sermo” 6 versi (“metà di un tempo”), per complessivi 42 versi, che corrispondono alle generazioni gioachimite. La restante parte del “terzo sermo” (vv. 112-135) occupa 24 versi che, aggiunti ai 6 del suo cominciare, fanno 30 (il numero che moltiplicato per 42 dà 1260). Parlando de “lo abisso de l’etterno statuto … che da ogne creata vista è scisso”, Pier Damiani raccomanda al poeta di riferire al mondo mortale quanto gli viene detto, “sì che non presumma / a tanto segno più mover li piedi”, espressione che traduce il “signum magnum” della quarta visione apocalittica e del quarto tempo della Chiesa diviso in “(un) tempo, (due) tempi e la metà di un tempo” (vv. 97-99). Nel cielo di Saturno si mostrano gli spiriti dei contemplativi e numerosi sono i temi provenienti dal quarto stato. Il cielo di Saturno, settimo in progressione, è anche il quarto a partire dal cielo del Sole, la prima delle “alte rote” a non venire toccata dal cono d’ombra proveniente dalla terra (cfr. Topografia spirituale della “Commedia”).
Le anime degli scomunicati riconciliati con Dio in fin di vita, che errano ai piedi della montagna trenta volte il tempo vissuto nella scomunica, fanno “insegna” coi dossi delle mani a Dante e a Virgilio in modo che tornino indietro procedendo innanzi a loro: sono la trasposizione degli uomini e delle donne dalla giusta vita di cui parla Gioacchino che, come le stelle del cielo, segnano il cammino ai naviganti (Purg. III, 100-102; cfr. VI, 60; XI, 42 e la similitudine dei delfini a Inf. XXII, 19-24). Il tema della Chiesa madre e nutrice dei fedeli è appropriato a Costanza, la “bella figlia” di Manfredi “genitrice / de l’onor di Cicilia e d’Aragona”, alla quale il re svevo prega il poeta di andare, una volta ritornato al mondo, per spiegare il suo vero stato, che è di salvezza, nonostante la condanna della Chiesa (Purg. III, 114-117). Nell’espressione “bella figlia” è contenuto anche il tema della bellezza, che nell’esegesi del quinto stato definisce la Chiesa, la quale è come una regina ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei vari doni e nelle varie grazie delle diverse membra [35].
La precedente illuminazione di Virgilio – “de la divina fiamma / onde sono allumati più di mille” – ha operato su Stazio, al cui ardore poetico furono seme le faville dell’Eneide, “la qual mamma / fummi, e fummi nutrice, poetando” (Purg. XXI, 94-99). Stazio fascia Virgilio con parte del panno della Vergine madre e nutrice da Ap 12, 14 come, nel canto successivo, Virgilio farà con Omero, “quel Greco / che le Muse lattar più ch’altri mai” (Purg. XXII, 100-105).
La donna – la Vergine che portò Cristo nel ventre, che lo partorì e lo allattò – sta a significare la Chiesa delle vergini, madre e nutrice dei fedeli, formata da uomini e donne dalla giusta vita che, come le stelle del cielo segnano il cammino ai naviganti, sono segni ed esempi agli altri, in modo che sappiano dove andare coloro che li considerano (considerare equivale a contemplare, come dice Tommaso d’Aquino di Riccardo di San Vittore, “che a considerar fu più che viro”, Par. X, 131-132).
Nella citazione di Gioacchino, è proprio di Ulisse il ‘considerare’ dei naviganti, l’essere stato ‘sottratto’ da Circe “più d’un anno là presso a Gaeta, / prima che sì Enëa la nomasse”, prima cioè che Enea desse a quel luogo il nome della sua nutrice, che ripete pertanto, prefigurandolo, il tema della Chiesa nutrice dei fedeli (Inf. XXVI, 90-93). La ‘sottrazione’ di Ulisse (unico caso del verbo ‘sottrarre’ nel poema), che corrisponde alla sottrazione della salutare pioggia della predicazione (cfr. il potere dato ai due testimoni, Enoch ed Elia, ad Ap 11, 6), concorda con l’immagine del greco dottore esperto dei vizi umani [36].
__________________________________________________________________________________________________________________
Tab. introd.4 (Nota)
[LSA, cap. XII, Ap 12, 17 (IVa visio, Vum prelium)] Dicit ergo: “Et iratus est draco in mulierem”. […] “Et abiit facere bellum cum reliquis de semine eius, qui custodiunt mandata Dei et habent testimonium Ihesu”, id est fidelem confessionem Christi per quam testimonium perhibent de Christo. Duo ponit necessaria ad salutem, scilicet observantiam mandatorum et fidem Christi exteriori professione et confessione expressam. Ioachim dicit quod semen mulieris est Christus raptus ad tronum cum martiribus suis, et istud semen precesserat; aliud autem remanserat designatum in Iohanne evangelista, scilicet ordo monachorum quarti temporis meridianam plagam incolentium. Et ideo vocat eos reliquos seu residuos de semine mulieris*.
|
|
Inf. X, 40-42, 46-48, 94-95, 118-120Com’ io al piè de la sua tomba fui,
|
Inf. XV, 73-85“Faccian le bestie fiesolane strame
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Si vero queratur plenior ratio sui casus vel translationis predicte, potest colligi ex tribus. Primum est inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et primitate, quam scilicet habuit non solum ex hoc quod prima in Christum credidit, nec solum ex hoc quod fideles ex gentibus ipsam honorabant et sequebantur ut magistram et primam, tamquam per eam illuminati in Christo et tracti ad Christum, sed etiam ex gloria suorum patriarcharum et prophetarum et divine legis ac cultus legalis longo tempore in ipsa sola fundati.[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7 (IIIa visio, Ia tuba)] Vel per hoc designatur quod temptationem que simul habet magnam speciem boni et veri, et auctoritatem et testimonium maiorum et antiquiorum et in sapientia famosiorum, et sequelam maioris et quasi totalis partis populi, nullus potest vincere nisi sit in fide et caritate firmus ut terra vel arbor et non fragilis et instabilis et cito arefactibilis sicut fenum. Talis autem fuit temptatio iudaica contra Christum. |
[LSA, cap. III, Ap 3, 12 (Ia visio, VIa victoria)] Columpna autem, sic stans, est longa et a fundo usque ad tectum erecta et solida ac sufficienter densa, et rotunda communiter vel quadrata, et firmiter fixa templique sustentativa et decorativa. Sic autem stat in Dei ecclesia vel religione vir evangelicus Christo totus configuratus, sic etiam suo modo stat in celesti curia. […] In huius[modi] autem mente tria inscribuntur […] Item, secundum quosdam, inscribitur sibi nomen Dei Patris quando sue paternitatis imago sic illi imprimitur ut merito possit dici abba seu pater spiritualis religionis et prolis. […] Nomen vero Christi sibi inscribitur, cum meretur dici christianus et etiam christus Domini, secundum illud Psalmi (Ps 104, 15): “Nolite tangere christos meos”. |
Purg. XX, 13-15, 43-51, 127-128O ciel, nel cui girar par che si creda
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (Vum sigillum)] In quinta autem (apertione), contra torporem accidie et otii quinti temporis, quod est sentina luxurie et omnis iniquitatis, clamant sancti martires eorum sanguinem, id est penales labores et dolores usque ad mortem, vindicari in illos. […] In quinta autem apertione, contra carnales eiusdem quinti temporis contemptores macerationum et martiriorum Christi et sanctorum precedentium, expetitur instanter et alte iusta vindicta (cfr. Ap 6, 10). Contra etiam ignominiam, est non solum spiritalis sed etiam temporalis pax et gloria sanctorum quinti status, designata per hoc quod ibi dicitur sanctis ut interim quiescant et in sui ornatum recipiant stolam albam (cfr. Ap 6, 11).
|
[Ap 13, 18] Prefatum autem cleri et regni Francie casum et aliquem alium illi annexum vel previum dicunt designari per terremotum in initio apertionis sexti sigilli tactum, quamvis etiam preter hoc designet spiritalem subversionem et excecationem fere totius ecclesie tunc fiendam. Quid autem horum erit vel non erit, dispensationi divine censeo relinquendum. Addunt etiam predicti quod tunc in parte implebitur illud Apostoli [IIa] ad Thessalonicenses II° (2 Th 2, 3), scilicet “nisi venerit discessio primum”. |
|
Inf. VI, 60-63ma dimmi, se tu sai, a che verranno
|
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 19; VIa visio] Ex hiis autem sequetur divisio que subditur: “Et facta est civitas magna in tres partes”. […] Potest etiam per hoc designari quecumque intestina discordia et divisio tunc temporis futura in ipsa. Nam et Zacharie XIII° (Zc 13, 7-9) dicitur evangelica religio consimiliter dividenda tunc temporis in tres partes, cum dicitur: “Et convertam manum meam ad parvulos, et erunt in omni terra: partes due in ea dispergentur et deficient, et ducam tertiam partem per ignem et probabo eos sicut probatur aurum. Ipse invocabit nomen meum, et dicam: Populus meus es” et cetera, quamvis hoc in parte in primitiva ecclesia sub apostolis sit impletum.Inf. X, 48sì che per due fïate li dispersi |
[Nota alla Tab. introd.4]
Al termine dell’esegesi del capitolo XIII dell’Apocalisse, che tratta della grande guerra mossa nel sesto stato dalla bestia, della quale viene spiegato anche il mistero del numero del nome – il DCLXVI -, Olivi riporta l’opinione di alcuni, i quali, sulla base degli scritti che allora si ritenevano di Gioacchino da Fiore e di quanto sarebbe stato rivelato in segreto da san Francesco a frate Leone suo confessore e ad altri compagni, ritengono che Federico II e il suo seme sia la testa della bestia che sembrava uccisa e che rivive di Ap 13, 3 (“Et vidi unum de capitibus suis quasi occisum in mortem, et plaga mortis eius curata est”). Secondo costoro, al tempo dell’Anticristo mistico (che precede quello aperto), in questo discendente di Federico non solo rivivrà l’Impero romano, ma egli conquisterà pure il regno di Francia e gli saranno alleati gli altri cinque re cristiani. Farà eleggere papa un falso religioso nemico della regola francescana, che contro questa escogiterà dolose dispense, promuovendo vescovi a lui consenzienti ed espellendo i chierici e i precedenti vescovi che erano stati avversi al seme di Federico e specialmente a quell’imperatore, a lui e al suo stato (Ap 13, 18).
In questa pagina si misura la portata della metamorfosi della Lectura nella Commedia, perché l’operato del falso papa che caccia coloro qui semini Frederici et specialiter illi imperatori et sibi et suo statui fuerant adversati risuona in bocca al ghibellino Farinata, uditi i nomi de “li maggior” di Dante: Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte (Inf. X, 46-47; la forma “furo avversi” ricorre solo in questo luogo).
Farinata incarna la vecchia Sinagoga e i suoi capi, sdegnosa perché forte di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’ (cioè degli avi) e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo: fu questa la tentazione giudaica contro Cristo, come spiegato nell’esegesi della prima tromba (Ap 8, 7). Ben si addice al ghibellino, che domanda “quasi sdegnoso” chi furono “li maggior” del proprio interlocutore, e che alla risposta alza in alto le ciglia dichiarando di averli per due volte cacciati in quanto a lui avversi, l’immagine dei pontefici e dei prìncipi della vecchia legge i quali, superbi per l’altezza del magistero e della fama conseguita presso tutto il popolo e del favore di questo, non si sottomettono alla correzione di Cristo, che anzi sdegnano e disprezzano per l’abiezione.
Alla chiesa di Gerusalemme, subentrata nel primato alla Sinagoga con la nuova fede, viene assimilata Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione apocalittica. Nel suo eccessivo e superbo mantenere le cerimonie della vecchia legge giudaica, la chiesa “ex circumcisione” fu troppo zelante contro la fede di Cristo e venne meno all’originario fervore di carità. Così fece Farinata nei confronti di Firenze, “nobil patrïa” assimilata alla Chiesa di Cristo, come egli stesso riconosce dicendo: “a la qual forse fui troppo molesto”.
La chiesa di Efeso si distinse per l’ “inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et primitate”, per cui viene minacciata di traslazione del primato, come avvenne per la Sinagoga (Ap 2, 5). Così Farinata: “Fieramente furo avversi … a miei primi ”. Alla Sinagoga dell’Antico Testamento corrisponde, nel Nuovo, Babylon, la Chiesa corrotta della fine del quinto stato, come a Cristo corrisponde la Chiesa del sesto stato, quella che Dante rappresenta, che sarà, una volta liberatosi dal vecchio con cui ancora concorre, “novum saeculum”, per cui essa si ricongiungerà circolarmente, quasi fosse una sfera, ai suoi inizi. In tal modo al ghibellino sono appropriati temi propri della sesta e grande guerra combattuta dalla Chiesa. Vicende private ed episodi locali, del microcosmo toscano, trovano collocazione in una storia universale, quale è quella della Chiesa insita nell’Apocalisse secondo Olivi.
Il verso successivo, “sì che per due fïate li dispersi” (Inf. X, 48), rinvia ad Ap 16, 19, dove si introduce il tema della divisione della grande città in tre parti, provocata da discordie intestine (“la città partita” di Ciacco, assalita da tanta discordia, di Inf. VI, 60-63; “’l giglio … per divisїon fatto vermiglio” evocato da Cacciaguida a Par. XVI, 152-154), designate dal terremoto descritto nel secondo preambolo della sesta visione che, in quanto segno premonitore della caduta della nuova Babilonia che avviene nel sesto tempo della Chiesa, designa l’accecamento della chiesa carnale, la quale sotto l’Anticristo mistico si muove contro lo spirito evangelico di Cristo. Un passo del profeta Zaccaria (Zc 13, 7-9), applicato alla divisione in tre parti della religione evangelica, precisa che due parti verranno disperse, mentre la terza, popolo di Dio, verrà condotta e provata attraverso il fuoco. Si può intendere che, dispersi i maggiori di Dante nel 1248 e nel 1260, la terza parte, Dante stesso, non lo sarà (cfr. quanto gli dice Cacciaguida a Par. XVII, 68-69: “sì ch’a te fia bello / averti fatta parte per te stesso”).
Questo Farinata, tessuto nel suo parlare con il panno, pregno di scritti pseudogioachimiti, del falso papa imposto dall’Anticristo mistico-Federico II, ma che dice delle fazioni di Firenze come fossero divisioni della religione evangelica, giace mell’arca “con più di mille” epicurei, “che l’anima col corpo morta fanno”. Fra costoro c’è “’l secondo Federico”, nominato ma che non si drizza dal suo sepolcro (Inf. X, 118-119). Nell’episodio, il rivivere del seme di Federico sembra tacere, ma al ghibellino il poeta augura il riposo della sua discendenza (ibid., 94). “Deh, se riposi mai vostra semenza”: è augurio di pace delle fazioni, per cui gli sbanditi Uberti possano ritornare a Firenze. Dante pronuncia queste parole dopo un profondo mutamento interiore intervenuto in Farinata. Alla risposta del poeta, che la causa dell’esilio dei suoi è la memoria del sangue sparso a Montaperti, il ghibellino, fino allora immutabile nell’aspetto e immobile nella figura, sospirando muove il capo. È il momento in cui la sofferenza trasforma la statua in uomo e gli apre il libro della memoria, per cui ricorda il suo muovere contro Firenze con gli altri non senza ragione, quasi ministro della giustizia divina, e la sua solitaria difesa a viso aperto della città contro tutti, che per un attimo lo fa assurgere ai segnati di Cristo, ai quali nel sesto stato è data la costante e magnanima libertà di difendere pubblicamente la fede. Tanto alti significati, che qui non è possibile compiutamente aprire, fanno dell’episodio il più profondo ed ermetico del poema.
Il tema del seme imperiale che rivive è invece messo in bocca a Brunetto Latini, per il quale “le bestie fiesolane” (i fiorentini) non dovranno toccare Dante, pianta in cui riviva la sementa santa / di que’ Roman che vi rimaser quando / fu fatto il nido di malizia tanta, che parteciparono cioè alla fondazione di Firenze (Inf. XV, 76-78; unico caso nel poema del verbo ‘rivivere’, proprio congiunto al seme come ad Ap 13, 18). Anche il ‘rimanere’ del seme ha un valore, come spiegato ad Ap 12, 17, al momento della guerra del quinto stato. La quinta guerra [37] viene condotta dal drago contro le rimanenze (le reliquie) del seme della donna, rappresentate da coloro che custodiscono i precetti divini e danno testimonianza di Cristo. Secondo Gioacchino da Fiore, il seme della donna è Cristo rapito in cielo e questo è seme che precede; quello che ‘rimane’ viene designato con l’evangelista Giovanni, cioè con i contemplativi propri del quarto stato. Olivi ritiene tuttavia che il testo sacro, nella quarta visione, dopo aver trattato le guerre sostenute in primo luogo da Cristo, in secondo dai martiri e in terzo e quarto dalla Chiesa prima dispersa e poi riunita da Costantino e dotata delle ali dei dottori e degli anacoreti per volare nel deserto dei Gentili e in quello della vita contemplativa, si riferisca ora in parte ad eventi successivi allo stato degli anacoreti, e precisamente a quanti fra essi rimasero sopravvivendo alle distruzioni operate dai Saraceni e, comunque, alle reliquie lasciate al quinto stato (che inizia con Carlo Magno e dura circa cinquecento anni). In entrambi i casi si parla di ‘reliquie’ poiché, come in un vaso di vino purissimo, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e più pura, rimangono solo poche reliquie vicine alle impurità e quasi con esse mescolate, così della pienezza e purezza del vino dei dottori e degli anacoreti del terzo e del quarto stato rimasero prima solo le reliquie, al momento della devastazione saracena; poi, nel quinto stato, occupate molte chiese dai Saraceni e separatisi i Greci dalla fede romana, rimase solo la Chiesa latina come reliquia della Chiesa che prima era diffusa in tutto l’orbe. Dante è pertanto ‘reliquia’ del seme che rimane – assimilato alla Chiesa romana – accanto e commisto al letame delle bestie fiesolane. È da notare che, nelle parole di Brunetto, il “romanus populus … ille sanctus, pius et gloriosus” (Monarchia, II, v, 5), di cui Dante è seme rimasto, è ammantato dalla veste che nell’esegesi scritturale spetta alla Chiesa di Roma, la sola ‘rimasta’ di una Chiesa prima diffusa su tutto l’orbe, della quale il seme degli antichi Romani è dunque prefigurazione. Il tema del purissimo seme della donna che rimane, da Ap 12, 17, è anche singolarmente consonante con quanto affermato in Convivio IV, v, 5-6: “E però [che] anche l’albergo dove ’l celestiale rege intrare dovea, convenia essere mondissimo e purissimo, ordinata fu una progenie santissima … Per che assai è manifesto la divina elezione del romano imperio, per lo nascimento della santa cittade, che fu contemporaneo alla radice della progenie di Maria”.
L’espressione di Brunetto – “e non tocchin la pianta, / s’alcuna surge ancora in lor letame” (Inf. XV, 73-75) – trasforma un tema della sesta vittoria (Ap 3, 12), allorché il nuovo nome di Cristo viene iscritto intendendo ‘cristiano’ come ‘unto del Signore’, nel senso del salmo 104, 15: “Non toccate i miei consacrati”. Chi consegue la sesta vittoria – ed è uomo evangelico che sta fisso in Cristo come una colonna nel tempio – ha iscritto nella mente il nome di Dio padre, immagine paterna che si imprime come quella di un padre spirituale nella prole, di un abate nella propria religione. Nella mente di Dante è “fitta … la cara e buona imagine paterna” di Brunetto Latini che gli insegnava “come l’uom s’etterna”, immagine che ora l’ “accora” (Inf. XV, 82-85). Anche nell’inferno esistono momenti di apertura all’imitazione di Cristo, per quanto solo nel ricordo della vita passata che la poesia registra.
Olivi (ad Ap 13, 18) rimette alla volontà divina l’avverarsi dell’opinione che l’Anticristo mistico nasca dal seme di Federico II [38]. Ricorda tuttavia che i sostenitori di questa tesi affermano pure che la ‘caduta’ del regno di Francia avverrà in coincidenza con il terremoto che segna l’apertura del sesto sigillo, e che allora si verificherà quanto dice l’Apostolo ai Tessalonicesi sul fatto che l’apostasia, il discedere dall’obbedienza del vero papa per seguire il falso papa non eletto canonicamente, scismatico ed errante contro la verità della povertà e della perfezione evangelica, dovrà venire prima del ritorno di Cristo nella parusia (2 Th 2, 3). Dell’espressione paolina – “nisi venerit discessio primum” – è pregno il verso di invettiva contro la lupa – “quando verrà per cui questa disceda?” -, nel quale il ‘discedere’ è appropriato alla lupa e il ‘venire’ al Veltro. L’invettiva è collocata all’inizio di Purg. XX (vv. 13-15), canto che si chiude con il terremoto sentito “come cosa che cada” e che fa tremare la montagna (vv. 124-141). Stazio spiegherà che il terremoto si verifica allorché un’anima purgante si sente monda e libera nella sua volontà di salire al cielo (Purg. XXI, 58-72). Tra l’invettiva contro la lupa e il terremoto è descritto l’incontro con Ugo Capeto, il quale chiede vendetta a Dio sulla “mala pianta” di cui fu radice. Il terremoto – che assume testualmente, comunque, le caratteristiche dell’apertura del sesto sigillo –, al di là dei motivi dati da Stazio (anch’essi propri del sesto stato) [39], è allusione alla prossima caduta del regno di Francia.
All’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9) i santi, rattristati fino alla disperazione per i mali che invadono la Chiesa, chiedono a gran voce che venga fatta subito vendetta contro i carnali del quinto tempo che dispregiano Cristo e i suoi. Con grande desiderio gridano a Dio: “Fino a quando, Signore, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?”. Nel “fino a quando” sta la loro insofferenza ad attendere ancora una vendetta rinviata per seicento anni e che la giustizia divina non può ulteriormente procrastinare. Poiché santo, Dio non può non odiare l’iniquità, e in quanto vero non può non mettere in pratica i mali minacciati e i beni promessi. Tuttavia ai santi del quinto stato viene detto di quietarsi e di aspettare le cose grandi che avverranno all’apertura del sesto sigillo, allorché saranno rivelati segreti fino allora chiusi e si rinnoveranno i gloriosi martìri in modo che il numero degli eletti sia completato. Il tema del santo desiderio di vendetta che chiama contro i malvagi e che non soffre altra attesa, risuona in più punti del poema. Compare ben tre volte tra gli avari e i prodighi del Purgatorio, in una zona che principalmente si riferisce al quinto stato. La prima volta è il poeta a maledire l’antica lupa e a domandare al cielo il momento dell’arrivo del Veltro (Purg. XX, 10-15). La seconda volta è Ugo Capeto a chiedere sùbita vendetta a colui che tutto giudica a nome di Douai, Lille, Gand, Bruges vessate da Filippo il Bello (ibid., 46-48), come i santi del quinto stato dai quali “expetitur instanter et alte iusta vindicta”. Ancora Ugo Capeto si rivolge a Dio chiedendogli quando potrà godere la gioia di vedere attuata la vendetta per ora nascosta nel suo segreto, chiusa cioè fino a quando, nel sesto stato, verrà il giudizio di Babylon (ibid., 94-96). Terminato l’episodio di Ugo Capeto, un terremoto scuote la montagna: si tratta di un’allusione al terremoto con cui si apre il sesto sigillo (ibid., 124-141).
L’esame dei testi rivela un metodo per il quale la poesia trasforma in senso positivo, di prossimo rinnovamento, quanto nell’esegesi dell’Apocalisse viene appropriato a figure o a situazioni negative. Così per la discendenza di Federico II, che Olivi, sulla base di scritti ritenuti di Gioacchino da Fiore, connette con l’Anticristo mistico, e che invece per Dante è “sementa santa”. Così nella descrizione delle luci degli spiriti giusti, che nel cielo di Giove risorgono formando la figura di un’aquila, viene utilizzata l’esegesi della bestia la cui testa sembrava uccisa e che invece risorge (Ap 13, 3).

Zahari Zograf (1810-1853), scene dall’Apocalisse. Monastero di Rila (Bulgaria)
1. L’angelo dalla parola ornata. 2. L’Ordine finale. 3. Evangelium aeternum
1. L’angelo dalla parola ornata (Ap 11, 1; 14, 14)
■ A Giovanni (Ap 11, 1; terza visione, sesta tromba) viene dato il “calamus”, cioè una canna simile a una verga, che designa il potere e la discrezione di reggere la Chiesa. Come con il “calamus” gli architetti sogliono misurare gli edifici e i mercanti i panni, così con esso i rettori della Chiesa posseggono la regolare e giusta misura in base alla quale sanno ciò che debbono governare e ciò che debbono lasciare. Questo “calamus” non assomiglia a una vuota e fragile canna o asticciola, ma piuttosto a una dritta e solida verga. Designa infatti l’autorità nel governare propria dei pontefici e dei maestri, la virtù e la giustizia capace di correggere, drizzare e dirigere rettamente la Chiesa. Secondo Gioacchino da Fiore, il “calamus” designa la lingua erudita di cui si dice nel Salmo: “La mia lingua è stilo di scriba” (Ps 44, 2). Come infatti con l’austerità della verga si piegano le bestie indomite, così con la disciplina della lingua vengono corretti i duri cuori degli uomini.
Si ritrova questa limitata parte di esegesi, variamente utilizzata, in più punti del poema, che ad essa rinviano. Il “calamus” designa l’autorità nel governare propria dei pontefici: il drizzare ben si applica al “benedetto Agapito, che fue / sommo pastore”, il papa (535-536) che avrebbe convinto Giustiniano ad abbandonare l’eresia monofisita (Par. VI, 13-21; da notare la corrispondenza numerica fra terzine).
Gli elementi semantici – parole-chiave che conducono dal senso letterale dei versi alla dottrina contenuta nell’altro testo prestando una lingua moderna ed esempi contemporanei – fasciano con i loro significati non solo la Chiesa, quali sue prerogative, ma pervadono l’intero mondo umano con le sue esigenze. Due di queste, la lingua e il regime del Monarca, si mostrano intimamente congiunte, per cui si può affermare che l’assenza dell’Imperatore dall’Italia è di nocumento anche alla lingua [1]. “Il valore della parola presuppone l’identificazione, addirittura pseudoetimologica, fra la rectorica e l’arte di ‘reggere’ le comunità” [2], tanto che Brunetto Latini, concludendo il Tresor con la trattazione della politica, la fa seguire a quella della retorica, e afferma (III, 75, 8): “[…] il affiert a seingnor que il parole miauz que les autres, por ce que tot li mondes tient a plus saige celui qui plus saigement dit […]”. Così la “pontificalis vel magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei” è pervenuta in mano anche all’ “alto Arrigo, ch’a drizzare Italia / verrà in prima ch’ella sia disposta” (Par. XXX, 137-138).
Il “calamus” equivale agli sproni e al freno con cui l’Imperatore dovrebbe correggere l’Italia, “costei ch’è fatta indomita e selvaggia”, dopo che la Chiesa (la “gente” che dovrebbe “esser devota”) si è impadronita della cavalcatura (Purg. VI, 91-99). “Indomita” è hapax nel poema.
Il “calamus” – si è detto – è la “lingua erudita”, secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore. La lingua di Virgilio è di un reggitore: il poeta latino è colui che possiede la scienza della discrezione, in virtù della quale conosce luoghi e tempi per ammettere ed escludere i malvagi dannati, che fa a lui venire, che ‘adizza’ a parlare e ai quali dà licenza di andar via. La sua “parola ornata” o “parlare onesto” (così dice Beatrice in Inf. II, 67, 113), con cui nel mondo scrisse “li alti versi”, corrisponde alla “lingua erudita-calamo” data a Giovanni (Ap 11, 1): è la sola che possa piegare gli “schivi” Greci; essa frena la lingua del discepolo (Inf. XXVI, 70-75), congeda in lombardo la fiamma che fascia Ulisse, fa drizzare la voce del “latino” Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 1-3, 19-21) [3].
La regolare e giusta misura, espressa dal “calamus” dato a Giovanni per reggere la Chiesa, mancò a Stazio nel troppo spendere, “e questa dismisura / migliaia di lunari hanno punita”. Si salvò ‘drizzando’, cioè torcendo alla giusta misura, la propria “cura”, cioè il proprio affanno a spendere, grazie alla lettura di quel punto dell’Eneide (III, 56-57) in cui Virgilio, di fronte all’assassinio di Polidoro perpetrato da Polimnestore, esclama “crucciato quasi a l’umana natura: / ‘Per che non reggi tu, o sacra fame / de l’oro, l’appetito de’ mortali?’” (Purg. XXII, 34-42). È noto che la citazione virgiliana è stata interpretata in due modi opposti: ‘Per che (cioè a quali malvagità) non spingi (o trascini, secondo il Petrocchi) tu, o esecranda fame dell’oro, l’appetito dei mortali?’, oppure ‘Perché non guidi tu, o santa fame dell’oro, l’appetito dei mortali?’. Proprio il panno dell’esegesi consente di scegliere la seconda soluzione: in esso infatti il “calamus” che frena, costringe e drizza designa la “discretio … regendi … per regularem ipsius calami rectitudinem et mensuram”. Si tratta pertanto di ‘reggere’, cioè di guidare misuratamente nell’appetire le ricchezze, misura che appunto Stazio non ha avuto peccando di prodigalità.
Virgilio, a Purg. XIV, 143-144 (a proposito delle voci su Caino e Aglauro, esempi di invidia punita), parla del “duro camo”, cioè del freno “che dovria l’uom tener dentro a sua meta”, con il quale viene percosso da Dio, che “tutto discerne”. “Camo” (freno, morso) deriva da “camus”, e come tale è nel Salmo 31, 9: “in camo et freno maxillas eorum constringe”, citato a Monarchia III, xv, 9. Ma il “calamus” dato a Giovanni, di cui ad Ap 11, 1, è in realtà un “camus”, ed è accompagnato da motivi non contenuti nel Salmo 31, 9: la durezza, il discernere di colui che regge, l’uomo. È questo esempio di citazione polisemica, cioè di più significati (“polisemos” è il termine con cui Dante definisce la Commedia nell’Epistola XIII, 20). Ciò avviene in più luoghi del poema, dove le citazioni scritturali, palesi o coperte, sono incastonate in quelle della Lectura super Apocalipsim, che le circoscrivono e le armano con diverse maglie semantiche [4].
Al “calamus” dei reggenti è assimilata la “doga” di Purg. XII, 105, cioè la misura del sale un tempo sicura e poi falsificata nella Firenze ironicamente chiamata “la ben guidata”.
Infine, i temi da Ap 11, 1 sono nel parlare di san Bernardo: la misura del panno del “buon sartore” nel fare “la gonna”, il ‘drizzare’ gli occhi a Dio (Par. XXXII, 139-144). Il “tempo” che “assonna”, cioè il tempo della visione, sta per finire, così come pure sta per terminare il “panno” su cui è stata cucita la “gonna”.
In tutt’altro contesto (Purg. XX, 54-56), “panni” e “freno del governo del regno” sono nel parlare di Ugo Capeto.
Per il principio della collazione analogica di più passi della Lectura, freno, oltre che ad Ap 11, 1, rinvia anche all’esegesi di Ap 9, 1-2 (terza visione, quinta tromba); panni ad Ap 3, 3-4 (prima visione, quinta chiesa).
Tab. I.1
Inf. IX, 88-90Ahi quanto mi parea pien di disdegno!
|
|
[LSA, cap. XI, Ap 11, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] “Et datus est michi calamus” (Ap 11, 1). Hic ordini prefato datur potestas et discretio regendi ecclesiam illius temporis. Datio enim potestatis significatur [per] donationem calami, quo artifices domorum solent mensurare edificia sua. Discretio vero regendi sibi dari designatur, tum per regularem ipsius calami rectitudinem et mensuram, tum per hoc quod docetur quos debeat mensurare, id est regere, et quos relinquere. Dicit autem: “Et datus est michi”, supple a Deo, “calamus similis virge”, quasi dicat: non similis vacue et fragili canne seu arundini, sed potius recte et solide virge. Et certe tali communiter mensurantur panni et edificia. Per hanc autem designatur pontificalis vel magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei.
|
|
Par. VI, 16-18ma ’l benedetto Agapito, che fue
|
Par. XXX, 133-138E ’n quel gran seggio a che tu li occhi tieni
|
[Ap 9, 1-2; IIIa visio, Va tuba] “Et data est [illi] clavis putei abissi, et aperuit puteum abissi” (Ap 9, 1-2), id est data est eis potestas aperiendi ipsum. Puteus abissi habet infernalem flammam et fumositatem obscuram et profunditatem voraginosam et quasi immensam et societatem demoniacam. Aperire ergo puteum abissi in populo quinti status fuit perverso exemplo et malo regimine solvere frenum carnalis concupiscentie et avaritie et terrene astutie et malitie et secularis lacivie ac demoniace seu pompose superbie, quod quidem frenum erat prius in ecclesia tam per Dei et suorum preceptorum ac iudiciorum timorem quam per sanctorum prelatorum disciplinam rigidam et severam ad se et suos subditos fortiter infrenandos, et etiam per sancte societatis exemplum et zelum nequeuntem in se vel in sociis tolerare enormitates et effrenationes predictas. |
|
[LSA, cap. XI, Ap 11, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] “Et datus est michi calamus” (Ap 11, 1). Hic ordini prefato datur potestas et discretio regendi ecclesiam illius temporis. Datio enim potestatis significatur [per] donationem calami, quo artifices domorum solent mensurare edificia sua. Discretio vero regendi sibi dari designatur, tum per regularem ipsius calami rectitudinem et mensuram, tum per hoc quod docetur quos debeat mensurare, id est regere, et quos relinquere. Dicit autem: “Et datus est michi”, supple a Deo, “calamus similis virge”, quasi dicat: non similis vacue et fragili canne seu arundini, sed potius recte et solide virge. Et certe tali communiter mensurantur panni et edificia. Per hanc autem designatur pontificalis vel magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei.
|
|
Inf. XXVII, 16-21 (6-7)Ma poscia ch’ebber colto lor vïaggio
|
Par. VI, 16-18 (6)ma ’l benedetto Agapito, che fue
|
Purg. XIV, 142-151 (48-50)
Già era l’aura d’ogne parte queta; Ps 31, 9
|
Par. XXXII, 139-144 (47-48)Ma perché ’l tempo fugge che t’assonna,
|
■ La canna simile a una verga, che designa il potere e la discrezione nel reggere la Chiesa, viene interpretata anche come la “lingua erudita”, che serve a correggere i duri cuori degli uomini, come con la verga si piegano le bestie indomite (Ap 11, 1). Questa “lingua erudita” è altresì propria dell’angelo che ad Ap 14, 14 siede sopra una nube candida con in capo la corona d’oro e in mano la falce acuta: secondo Gioacchino da Fiore, l’immagine designa un ordine di giusti ai quali è dato di imitare in modo perfetto il Figlio dell’uomo e di possedere l’eloquio per diffondere il Vangelo del regno e per raccogliere nel campo del Signore l’ultima messe. La nube candida indica che la “conversatio” dell’angelo, cioè la sua vita religiosa, non è gravata da oscurità ma è lucida e spirituale.
La “lingua erudita”, di cui si parla ad Ap 11, 1 (il “calamus similis virge”, dato a Giovanni, che corregge e piega i duri cuori degli uomini: terza visione, sesta tromba) e ad Ap 14, 14 (quarta visione, settima guerra), è anche honesta. Se si confronta infatti Ap 11, 1 con Ap 1, 13, dove si tratta della terza perfezione di Cristo sommo pastore (prima visione), si può notare che all’autorità pontificale si addice tanto il “calamus similis virge”, cioè l’eloquio, quanto la “honestatis sanctitudo”.
Se si confronta ancora Ap 14, 14 con Ap 3, 18 (prima visione, esegesi della settima chiesa, Laodicea), si vede che la “conversatio non … ponderosa et obscura sed lucida et spiritalis”, propria di quanti hanno la “lingua erudita” (Ap 14, 14) è “conversatio honesta” e consiste nell’ “ornatus” esteriore delle buone opere (Ap 3, 18; il “parlare onesto” e la “parola ornata” di Virgilio, come affermato da Beatrice a Inf. II, 67, 113).
Il potere di correzione, che ad Ap 11, 1 si dice dato al pontefice, al maestro o comunque a chi governa, è quello proprio della nona perfezione di Cristo sommo pastore (Ap 1, 16), per cui la giustizia retta e severa si esprime nella parola viva, nel “sermo vivus” che penetra efficace come una spada a doppio taglio, secondo quanto affermato nella Lettera agli Ebrei 4, 12.
La collazione di tutti questi passi, collegati tra loro da parole-chiave (“pontificalis” per Ap 11, 1 e 1, 13; “conversatio” per Ap 14, 14 e 3, 18; “corrigere / correctio” per Ap 11, 1 e 1, 16) e vertenti anche sul tema dell’eloquio, fornisce il panno per tessere le parole con cui Farinata si rivolge a Dante: “O Tosco che per la città del foco / vivo ten vai così parlando onesto” (Inf. X, 22-23).
Certamente è presente, nel parlare ornato e onesto, una “concezione classico-umanistica della poesia (di lunghissima durata), i cui valori principali sono il decoro formale, l’efficacia etica, la fama” [5]. Ma i significati ciceroniani dell’ “oratio erudita” contrapposta all’ “oratio popularis”, degli illuminati “erudita saecula” che Dante contrapporrebbe alle “etati grosse”, sono congiunti con ben altro valore. La “lingua eudita”, nella citazione dall’Expositio in Apocalypsim di Gioacchino da Fiore riportata da Olivi ad Ap 14, 14, è la lingua della conversione finale e universale “ad evangelizandum evangelium regni et colligendam in aream Domini ultimam messionem”. Essa è propria di quanti, designati dall’angelo che sta su una nube candida (per purezza spirituale), appartengono a un ordine di giusti imitatori del Figlio dell’uomo.
Virgilio che guida, mosso dalla “donna del ciel”, e Beatrice incarnano entrambi due distinte prerogative di Cristo. Corrispondono il primo all’insegnamento di Cristo in quanto uomo e in quanto “lux simplicis intelligentie”, o verbale sapienza del Padre; la seconda ai suggerimenti, per gusto interiore d’amore, dello Spirito di Cristo, ai quali prepara la voce esteriore del Figlio dell’uomo. Beatrice rappresenta il gusto e il sentimento dell’amore, appropriato allo Spirito Santo. Mossa da amore, fa muovere Virgilio alla salvezza del suo amico: “Or movi, e con la tua parola ornata … l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata. … amor mi mosse, che mi fa parlare” (Inf. II, 67-72: il Paraclito è ‘consolatore’; cfr. qui di seguito). Virgilio e Beatrice operano entrambi, come Cristo, per mezzo della “locutio”, cioè della favella; il primo con la “parola ornata”, la seconda con il parlare dettato da amore che suggerisce all’altro ciò che debba fare.
Tab. I.2
|
1, 13
|
11, 1 |
14, 14
|
| pontificalis sanctitudo ————————> |
honestas
|
pontificalis vel magistralis seu gubernatoria | lingua erudita ————————————> | corrigere ————- 1, 16 correctio | sermo vivus |
lingua erudita | conversatio ——– 3, 18 conversatio honesta | exterior ornatus |
↓
[LSA, cap. XI, Ap 11, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] “Et datus est michi calamus” (Ap 11, 1). Hic ordini prefato datur potestas et discretio regendi ecclesiam illius temporis. Datio enim potestatis significatur [per] donationem calami, quo artifices domorum solent mensurare edificia sua. Discretio vero regendi sibi dari designatur, tum per regularem ipsius calami rectitudinem et mensuram, tum per hoc quod docetur quos debeat mensurare, id est regere, et quos relinquere. Dicit autem: “Et datus est michi”, supple a Deo, “calamus similis virge”, quasi dicat: non similis vacue et fragili canne seu arundini, sed potius recte et solide virge. Et certe tali communiter mensurantur panni et edificia. Per hanc autem designatur pontificalis vel magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei.
|
[LSA, Ap 14, 14 (IVa visio, VIIum prelium)] “Et vidi et ecce nubem candidam et super nubem sedentem similem Filio hominis, habentem in capite suo coronam auream et in manu sua falcem acutam” (Ap 14, 14).
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 13 (radix Ie visionis)] Tertia (perfectio summo pastori condecens) est sacerdotalis et pontificalis ordinis et integre castitatis et honestatis sanctitudo, unde subdit: “vestitum podere”. Poderis enim erat vestis sacerdotalis et linea pertingens usque ad pedes, propter quod dicta est poderis, id est pedalis: pos enim grece, id est pes latine. Poderis enim, secundum aliquos, erat tunica iacinctina pertingens usque ad pedes, in cuius fimbriis erant tintinabula aurea, et de hac videtur dici illud Sapientie XVI[II]° (Sap 18, 24): “In veste poderis, quam habebat, totus erat orbis terrarum, et parentum magnalia in quattuor ordinibus lapidum erant sculpta”. |
[LSA, cap. III, Ap 3, 18 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Nota autem quod supra premisit cecum ante nudum, hic vero premittit expulsionem nuditatis per vestes curationi oculorum et visus per collirium, quia cum perditione interne caritatis primo perditur interior lux et visus, antequam perdatur exterior ornatus bonorum operum et conversationis honeste. In reparatione vero non pertingitur ad plenam compunctionem et illuminationem visus interni usquequo, reiectis pravis operibus, assumitur aliquis ornatus bonorum operum seu exterioris status penitentie; initium tamen compunctionis et illuminationis precedit hunc ornatum. |
Inf. I, 67-69Rispuosemi: “Non omo, omo già fui,
|
Inf. II, 67-69, 112-114Or movi, e con la tua parola ornata
|
■ Ad Ap 12, 5 (quarta visione, prima guerra) si dice che la donna, dinanzi alla quale stava il drago pronto a divorarne il parto, “partorì un figlio maschio”, maschio non solo per sesso ma anche per valore di virile virtù, “che avrebbe governato tutte le genti con lo scettro di ferro”, cioè con inflessibile e insuperabile giustizia e potenza; figlio che fu poi “rapito” al trono di Dio.
Il tema del figlio maschio che governerà le genti con lo scettro di ferro (Ap 12, 5) si connette con quanto detto all’inizio del capitolo XI sul significato del “calamus” dato a Giovanni per misurare il tempio. La canna simile a una verga, che designa il potere e la discrezione nel reggere la Chiesa, viene interpretata anche come la “lingua erudita”, che serve a correggere i duri cuori degli uomini, come con la verga si piegano le bestie indomite (Ap 11, 1). Questa “lingua erudita” è altresì propria dell’angelo che ad Ap 14, 14 siede sopra una nube candida con in capo la corona d’oro e in mano la falce acuta: secondo Gioacchino da Fiore, l’immagine designa un ordine di giusti ai quali è dato di imitare in modo perfetto il Figlio dell’uomo e di possedere l’eloquio per diffondere il Vangelo del regno e per raccogliere nel campo del Signore l’ultima messe. La nube candida indica che la “conversatio” dell’angelo, cioè la sua vita religiosa, non è gravata da oscurità ma è lucida e spirituale.
Sono questi i fili spirituali intrecciati nella terzina relativa alla “luce de la gran Costanza” d’Altavilla, sposa del figlio di Federico Barbarossa, Enrico VI, “secondo vento di Soave”, dal quale “generò ’l terzo e l’ultima possanza”, ossia Federico II, ultimo imperatore dei Romani (Par. III, 118-120).
Costanza è come la donna che ha partorito un figlio destinato a governare con giustizia e potenza “in virga ferrea”, che non è solo lo scettro del potere, ma anche quello della lingua. Come affermato nel De vulgari eloquentia I, xii, 4, Federico II e il suo “benegenitus” Manfredi, “illustres heroes”, avevano fatto in modo che quanti erano nobili di cuore e dotati di doni divini aderissero loro e, poiché la sede del trono regale era la Sicilia, tutto ciò che gli Italiani di animo eccellente producevano a quel tempo vedeva dapprima la luce in quella reggia e di conseguenza quanto è stato finora prodotto in volgare viene chiamato siciliano, “nec posteri nostri permutare valebunt”.
È stato notato da alcuni commentatori (Pietro di Dante, Buti) come l’espressione “vento di Soave”, riferita ad Enrico VI, secondo imperatore della casa di Svevia, alluda all’instabilità delle dignità mondane: “esprime potenza impetuosa e superba”, aggiunge il Sapegno. Questa interpretazione sembra confermata dalla Lectura nell’esegesi dell’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 13) dove, per spiegare la caduta delle stelle dal cielo, cioè dei religiosi apostati e scismatici dal proprio alto stato, si ricorre all’immagine dell’immaturità dei fichi, privi della “soave” carità interna e grossi per superbia, per cui verranno portati via dall’albero della santa religione dal “vento” della vanità e della tentazione.
Il tema della mascolinità nel corpo e nella virtù, del reggere con forza insuperabile e con giustizia inflessibile, è applicato in modo disgiunto e con diversa intensità a Pietro III d’Aragona e a Carlo d’Angiò, che purgano la propria negligenza nella valletta dei principi. Del re, “quel che par sì membruto” e che, mentre canta, si accorda con Carlo I d’Angiò – “con colui dal maschio naso” -, è detto che “d’ogne valor portò cinta la corda” (Purg. VII, 112-114), superando nella virtù l’angioino, come dimostra il maggior diritto a vantarsi del marito da parte di Costanza, moglie di Pietro III, rispetto a Beatrice e a Margherita, mogli di Carlo (ibid., 127-129). Un rapimento per virtù è il movimento con cui Beatrice spinge Dante dal cielo di Saturno a quello Stellato (Par. XXII, 100-105).
Tab. I.3
[LSA, cap. XI, Ap 11, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] “Et datus est michi calamus” (Ap 11, 1). Hic ordini prefato datur potestas et discretio regendi ecclesiam illius temporis. Datio enim potestatis significatur [per] donationem calami, quo artifices domorum solent mensurare edificia sua. Discretio vero regendi sibi dari designatur, tum per regularem ipsius calami rectitudinem et mensuram, tum per hoc quod docetur quos debeat mensurare, id est regere, et quos relinquere. Dicit autem: “Et datus est michi”, supple a Deo, “calamus similis virge”, quasi dicat: non similis vacue et fragili canne seu arundini, sed potius recte et solide virge. Et certe tali communiter mensurantur panni et edificia. Per hanc autem designatur pontificalis vel magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei.
|
[LSA, Ap 14, 14 (IVa visio, VIIum prelium)] “Et vidi et ecce nubem candidam et super nubem sedentem similem Filio hominis, habentem in capite suo coronam auream et in manu sua falcem acutam” (Ap 14, 14).
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 5 (IVa visio, Ium prelium)] Sequitur: “Et peperit filium masculum” (Ap 12, 5), masculum quidem non solum sexu corporis sed etiam strenuitate virilis virtutis, “qui recturus erat omnes gentes in virga ferrea”, id est in inflexibili et insuperabili iustitia et potentia. “Et raptus est”, scilicet per resurrectionem et ascensionem, “filius eius ad Deum et ad tronum eius”. Christus secundum deitatem non fuit raptus vel mutatus, sed solum secundum humanitatem, nec per resurrectionem et ascensionem fuit eius humanitas rapta seu elevata, nisi solum in quantum erat passibilis. Nam in initio incarnationis fuit ad unionem personalem Dei et ad mentis substantialem gloriam plenissime elevata. Dicit autem “raptus” ad innuendum supernaturalem vim et repentinam ac prepotentem actionem, per quam de inferis exivit et a morte resurrexit et ascendit ad celos.
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 13 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Quantum etiam ad tertium initium sexte apertionis, fiet utique grandis terremotus subvertens fidem plurium contra evangelice regule veritatem et contra spiritum vite eius, et ideo tunc “sol” plenius fiet “niger”, et “luna” crudelis ut “sanguis” tam in electos quam in se invicem per seditiones et bella. Unde suscitationem spiritus preibunt in ecclesia quedam bella subvertentia insulas et montes (cfr. Ap 6, 14), id est urbes et regna. Preibunt etiam vel comitabuntur aliqua scismata in clero et religione subvertentia aliquorum status et collegia, unde plures “stelle” cadent per apostasiam de suo statu celesti seu regulari, etiam plures de evangelico statu, qui pre ceteris videbantur stelle. Cuius ratio est quia non erant “ficus” mature per devote caritatis suavitatem, nec parve per humilitatem, sed grosse per inflantem superbiam et immature per interne virtutis defectum, et ideo “a vento” vanitatis et illius temptationis impellentur et corruent a ficulnea sancti status, propter que omnia plures non solum boni, sed etiam mali fortiter perterrebuntur non solum a visu et perpessione tantorum malorum, sed etiam suspicione et expectatione longe maiorum (cfr. Ap 6, 13). Tunc etiam plures signabuntur ad militiam spiritalem, quamvis sint pauci respectu multitudinis reproborum. |
■ La seconda proprietà di Cristo sommo pastore (nella parte ‘radicale’ della prima visione) è la conformità con la natura umana, ovvero l’umiltà e l’umanità condiscendente verso quanti gli sono soggetti, per cui viene definito “simile al Figlio dell’uomo” (Ap 1, 13). Dal fatto che non si dica “Figlio dell’uomo” ma “simile al Figlio dell’uomo”, Riccardo di San Vittore deduce trattarsi di un angelo apparso a Giovanni, che gli mostrava le cose con persona simile a quella di Cristo e in modo tanto più autorevole per il fatto di assomigliare al Salvatore. Si può anche sostenere – continua Olivi – che la forma in cui Cristo apparve era molto simile a quella conosciuta da Giovanni e dagli altri apostoli prima della morte e dopo la resurrezione. Sebbene infatti nella gloria fosse stata cancellata ogni traccia di mortalità, di passione e di infermità, nondimeno Cristo ritenne per il resto la somiglianza con l’aspetto precedentemente avuto nella vita mortale. L’interpretazione di Riccardo si addice al fatto che la visione fu spirituale e non corporea, per cui Giovanni non vide con l’occhio corporeo un corpo esteriore realmente esistente, ma vide mediante le specie formate nella memoria e presenti al suo vedere spirituale al quale era elevato.
Il tema della conformità con la natura umana è presente nell’apparizione di Virgilio “nel gran diserto”. A Dante che gli chiede se sia “od ombra od omo certo” Virgilio risponde: “Non omo, omo già fui”, dove l’insistenza sulla locuzione “omo”, ripetuta per tre volte in due versi, indica che l’ombra è conforme alla natura umana e mantiene la somiglianza con la forma assunta nella precedente vita mortale (Inf. I, 64-67). Se si collaziona Ap 1, 13 con Ap 22, 16, l’espressione di Cristo “fui homo mortalis”, per cui si definisce “stella splendida”, illuminatrice dei santi, e “matutina”, che promette, predica e mostra la luce futura dell’eterno giorno (il sole della sua divinità), sembra coincidere con l’ “omo già fui” detto dal poeta pagano che, se pure può paragonarsi a Cristo solo per questo, è anch’egli “stella matutina” perché il suo parlare, prospettando a Dante il viaggio nell’oltretomba, è promessa di tanto bene (Inf. II, 126). Se l’angelo che appare a Giovanni è autorevole in quanto si presenta somigliante al Salvatore, Virgilio è l’ “autore” di Dante (Inf. I, 85), e questi a lui si dà per la sua salute (Purg. XXX, 51).
Virgilio non ritiene solamente l’aspetto umano, ma anche la sua “parola ornata”, il “parlare onesto” per cui Beatrice fiduciosa lo fa andare al soccorso dell’amico nella “diserta piaggia” (Inf. II, 67, 113-114). In altro punto del testo apocalittico Giovanni descrive la visione di un angelo simile nell’aspetto al Figlio dell’uomo: si tratta dell’angelo che sta seduto su una nube bianca con sul capo una corona d’oro e in mano una falce affilata (Ap 14, 14). Questo angelo, secondo Gioacchino da Fiore citato da Olivi, designa un ordine di giusti a cui è dato di imitare Cristo in modo perfetto e che possiede una “lingua erudita” per diffondere il Vangelo del regno di Dio e per raccogliere sulla terra l’ultima messe. A differenza dell’angelo che esce dal tempio, cioè dagli arcani del cielo dove sta nascosto (Ap 14, 17), appare manifesto perché coloro che sono destinati all’erudizione delle plebi sono dati di fronte agli occhi in modo che esse possano ricevere gli ammonimenti salutari e i pii esempi di comportamento. Così Virgilio, che viene offerto dinanzi agli occhi di Dante per la sua salute (Inf. I, 61-63).
All’umanità di Cristo è associata la fragilità che deriva dall’essere soggetto a morte, passione, infermità, abiezione (cfr. l’esegesi ad Ap 1, 5 e 5, 12-13, luogo, quest’ultimo, dove l’apparire infermo e abietto di Cristo è una delle cause per cui i sigilli sono chiusi). La fragilità di Cristo viene meno nella gloria; resta in Virgilio, “chi per lungo silenzio parea fioco” (Inf. I, 63). Il motivo dell’essere fragili e disprezzabili a causa della mortalità è presente anche in altri punti della Lectura. All’apertura del quarto sigillo (Ap 5, 1; 6, 8), la fragilità dell’uomo è connessa con il pallore della morte. Ad Ap 11, 7-11 i due testimoni vengono vinti e uccisi dall’Anticristo e i loro corpi giacciono insepolti nella piazza della grande città, da tutti disprezzati: ma si tratta di vittoria secondo l’apparenza umana, perché dopo tre giorni e mezzo i due risorgono. Così l’esser “fioco” di Virgilio, per il lungo silenzio dovuto alla morte, è solo apparente agli occhi corporei di Dante, non ancora sollevato a una visione spirituale (cfr. Inf. XXIV, 64-66).
Come sempre nella stesura del poema, la stessa parte di “panno” teologico è servita, variando i temi, a fare la “gonna” dei versi, che con ars memorativa ad esso rinviano. Il ritenere ancora l’aspetto della vita precedente (Ap 1, 13) è tema proprio di Giasone, “quel grande che vene, / e per dolor non par lagrime spanda”, fatto impassibile alla fragilità umana come l’angelo simile al Figlio dell’uomo di Ap 14, 14. Il tema raggiunge piena intensità nell’espressione “quanto aspetto reale ancor ritene!” (Inf. XVIII, 83-85). Anche Giasone, come Virgilio, ebbe le “parole ornate”, che però utilizzò per ingannare Isifile (ibid., 91-93).
Una visione spirituale, che non avviene mediante gli occhi corporei, è l’apparizione di Beatrice nell’Eden. Dante non vede la donna velata, di cui scorge però delle specie già conosciute, i colori bianco e rosso portati nelle vesti dalla donna in vita e descritti nella Vita Nova. Il suo spirito, che per tanto tempo non l’aveva vista presente, sente “sanza de li occhi aver più conoscenza” la potenza dell’antico amore per occulta virtù che muove da lei (Purg. XXX, 34-39) [6].
Questo diffondere le prerogative del Figlio dell’uomo, nel bene e nel male, su più soggetti a lui “simili” come l’angelo di Ap 14, 14, rende massima dignità all’Impero. A conclusione della Monarchia (III, xv, 18), Dante parla della reverenza che Cesare deve a Pietro come quella del figlio primogenito verso il padre. La controversa espressione – “ut romanus Princeps in aliquo romano Pontifici non subiaceat” (ibid., 17) -, alla quale è speculare il parlare di Giustiniano in Par. VI, 84 – “per lo regno mortal ch’a lui soggiace” -, non denota soggezione politica dell’uno all’altro, ma tensione della parte mortale verso ciò che è immortale, “mentre che ’l nostro immortale col mortale è mischiato” (Convivio, II, viii, 15). Anche Cristo fu soggetto al Padre per la sua mortale umanità, ma non per questo gli fu meno consustanziale ed eguale. Gli angeli lo trascendono rispetto alla sua carne passibile, secondo il Salmo 8, 6 – “Tu l’hai fatto poco minore che li angeli” – che Dante applica all’uomo, medio tra ciò che è corruttibile e ciò che è incorruttibile, operante in modo quasi divino (cfr. Convivio, IV, xix, 7; Monarchia, I, iv, 2; III, xv, 3-5). Qui sta il paradosso, non la contraddizione: nel momento in cui l’Impero diventa consorte in cielo della Chiesa, discendente dalla medesima fonte, partecipa a pieno titolo non solo dei doni e delle prerogative dello Spirito ma anche dei misteri della Trinità e dell’Incarnazione, cioè dell’eterna generazione del Verbo e del suo farsi carne. Il Figlio che deve reverenza al Padre non è un figlio qualunque, è il Figlio dell’uomo al quale il romano Principe è assimilato [7]. Fra umano e divino vi è concordia, pur in apparente contraddizione: così avviene nel Primo Mobile, il luogo dove il tempo ha le sue radici, fra i cerchi corporali e quelli angelici, fra l’esempio e l’esemplare che “non vanno d’un modo” (Par. XXVIII, 55-57) [8]. Cristo è “lignum vitae” fra le due rive, umana e divina, del fiume luminoso (lo Spirito che deriva dall’intera Trinità) che scorre nel mezzo della Gerusalemme celeste (Ap 22, 1-2).
Nei celebri versi di Purg. XVI, 106-114, relativi ai “due soli” di Roma, il periodo storico rimpianto da Marco Lombardo, in cui il “pasturale” (il potere spirituale) non aveva spento e congiunto a sé la “spada” (il potere temporale), corrisponde alla concorrenza nel tempo di due stati distinti, il terzo (i dottori, che razionalmente confutano le eresie con la spada e danno le leggi) e il quarto (gli anacoreti, dalla santa e divina vita fondata sull’affetto), nel periodo in cui (da Costantino a Giustiniano) entrambi erano due stati di sapienza solare e concorrevano per due diverse strade a infiammare il meriggio dell’universo, prima che nel quinto stato i beni temporali invadessero la Chiesa trasformandola quasi in una nuova Babilonia. Quell’improprio congiungere da parte del potere spirituale è eresia assimilabile a quella di Ario, che divise il Figlio dal Padre ritenendolo non consustanziale, a livello di creatura, o, ancor meglio, a quella di Sabellio, che unificò il Padre e il Figlio nella stessa persona.
Tab. I.4
■ La diffusione di singoli aspetti perfettivi di Cristo sulla natura e sugli uomini è proprio, in varia misura, di tutto il gruppo delle dodici prerogative di sommo pastore (Ap 1, 13-17), nonché delle precedenti appartenenti all’apparente fragilità del Cristo uomo (Ap 1, 5-7). Si tratta di passi nei quali non si registrano citazioni di Gioacchino da Fiore. Virgilio, che incarna molte qualità del Figlio dell’uomo, anzi gli è “simile” (Ap 1, 13), si fregia altresì della santità del manto sacerdotale (Ap 1, 13), elemento che non manca all’indovina ‘Manto’, fondatrice della sua città e dannata nella quarta bolgia.
La terza perfezione di Cristo sommo pastore consiste nell’appartenenza all’ordine sacerdotale e pontificale, cui si addicono santità, integrità, castità e onestà, per designare la quale si afferma: “vestito con un abito lungo fino ai piedi” (Ap 1, 13). La veste è la “poderis” di lino, propria dei sacerdoti, lunga fino ai piedi (“poderis” è vocabolo di origine greca che equivale a “pedalis”). È assimilata al manto dell’efod da cui era avvolto Aronne, la “tunica superhumeralis” sovrapposta al pettorale del giudizio (il “rationale” con incisi i nomi degli Israeliti), di color giacinto, sulle cui frange erano sonagli aurei (“tintinabula”, Esodo 28, 31-35). Di questo manto si dice nella Sapienza (Sap 18, 24): “Sulla sua veste lunga fino ai piedi vi era tutto il mondo e la grandezza dei parenti era scolpita su quattro ordini di pietre preziose”. All’ordine sacerdotale appartiene anche quanto soggiunge l’autore dell’Apocalisse: “e cinto alle mammelle con una zona aurea”. L’essere succinto alle reni designa il restringere la concupiscenza carnale. L’essere precinto alle mammelle indica la restrizione di ogni impuro pensiero e affetto del cuore: l’intelletto e la volontà sono infatti le due mammelle della mente che propinano il latte della sapienza e dell’amore. Cingersi con una zona di pelle, cioè con una fascia di cuoio di animali morti, designa il mantenere la castità per il timore della morte o della pena. Cingersi con una zona aurea significa serbarsi casti per puro e solido ardore di carità.
Il tema del manto avvolge la figura di Virgilio dal “parlare onesto” (Inf. II, 113). Mantova, patria del poeta latino, concorda con “manto” nel suono e anche nel significare i “parentum magnalia”, la grandezza dei padri. Così Virgilio si presenta a Dante dicendo: “e li parenti miei furon lombardi, / mantoani per patrïa ambedui”. (Inf. I, 68-69). La prova che Mantova non sia un puro nome geografico sta nel fatto che lo stesso tema riveste la fondatrice della città, Manto, la quale nella bolgia degli indovini mantiene nella pena un che di sacerdotale, per quanto stravolto dal tenere il capo volto all’indietro, con il ricoprire le mammelle con le trecce sciolte (Inf. XX, 52-55; le trecce corrispondono ai capelli propri della quarta perfezione di Cristo): ciò designa, con senso limitato, la restrizione di ogni impuro pensiero e affetto del cuore. Il “Mantoano” Sordello è “anima lombarda … onesta” (Purg. VI, 61-63, 74-75). Ai “parentum magnalia” sembra rinviare anche la menzione di Bartolomeo della Scala, il “gran Lombardo / che ’n su la scala porta il santo uccello” (Par. XVII, 70-72).
Il tema del manto connesso con il riferimento alla famiglia appartiene anche a Niccolò III, che fu “vestito del gran manto” papale e vero “figliuol de l’orsa” (Inf. XIX, 69-70). Adriano V parla del peso, da lui sperimentato, del “gran manto” subito dopo aver detto del titolo comitale della sua famiglia (Purg. XIX, 100-105). In apertura di Par. XVI, la nobiltà del sangue viene paragonata a un manto che presto si raccorcia se non si aggiunge altra stoffa derivante dai meriti personali.
I motivi sacerdotali della terza perfezione di Cristo come sommo pastore (Ap 1, 13), combinati con quelli provenienti dalle altre perfezioni, rivestono anche Catone (cfr. qui di seguito).
Il tema del cingersi si ritrova nella corda con la quale, prima di scioglierla su ordine di Virgilio, Dante pensava di prendere la lonza, cioè la concupiscenza carnale (Inf. XVI, 106-108). Fra i giganti, Nembrot sembra anch’egli fasciato, ma con tono sarcastico, dai motivi connessi con il manto sacerdotale: ha come perizoma la sponda del pozzo e la parte del corpo scoperta è alta “trenta gran palmi” a partire dalla clavicola, “dov’ omo affibbia ’l manto”; tiene al collo un corno legato con una “soga” che gli “doga”, cioè gli fregia, il “gran petto” (Inf. XXXI, 61-66, 70-75). Fialte è cinto da una catena che gli tiene “soccinto” dinanzi il braccio sinistro e dietro il braccio destro (ibid., 85-88). Alla stessa esegesi rinviano, con appropriazione in malam partem delle prerogative di Cristo, Inf. XXIII, 67 (“manto”); XXIV, 31 (“vestito”), 34 (“precinto”) e, in collazione con Ap 15, 6, XXXII, 43 (“strignete i petti”), 49 (“cinse”).
Nella Firenze che “si stava in pace, sobria e pudica”, Cacciaguida vide Bellincion Berti “andar cinto di cuoio e d’osso” e i Nerli e i Vecchietti “esser contenti a la pelle scoperta”, cioè senza panno di sopra (Par. XV, 112-113, 115-116).
Nel cielo del Sole, la prima corona di spiriti sapienti circonda Beatrice e Dante come la luna (“la figlia di Latona”, che designa la castità) si cinge di un alone luminoso (la “zona”) quando l’atmosfera è satura di vapori in modo da trattenere la luce (Par. X, 67-69; cfr. XXIX, 1-6).
L’Empireo, “precinto” al Primo Mobile, che a sua volta comprende gli altri cieli, è “luce e amor”, che corrispondono all’intelletto e alla volontà, le due mammelle della mente: esso è cinto da Dio, che solo intende il suo operare (Par. XXVII, 112-114; cfr. i serafini, descritti a XXVIII, 22-27). Il Primo Mobile è anche “lo real manto di tutti i volumi del mondo” (Par. XXIII, 112-113).
Tab. I.5
___________________________________________________________________________________________________________________
Tab. I.6 (Nota)
[Nota alla Tab. I.6]
● La quarta perfezione di Cristo sommo pastore consiste nella reverenda e preclara maturità del consiglio, che è designata dalla senile e gloriosa canizie del capo e dei crini, per cui si dice: “il suo capo e i suoi capelli erano candidi come lana bianca e come neve” (Ap 1, 14). Il capo costituisce la cima della mente e della sapienza; i capelli designano la moltitudine e l’ornato dei sottilissimi e spiritualissimi pensieri e affetti, oppure la pienezza dei doni dello Spirito Santo che adornano la cima della mente.
I capelli di Cristo sono bianchi come lana e come neve. La lana lenisce col calore, è molle, temperata e soave nel candore; la neve è fredda, congelata, rigida e intensa nel candore non sostenibile alla vista, ma è anche umore che purga e impingua la terra. Così la sapienza di Cristo è da una parte calda per la pietà e condescensiva in modo contemperato alle nostre facoltà; è dall’altra astratta, rigida e intensa, ma anche purgativa delle colpe e impinguativa della nostra eredità.
L’esegesi della quarta perfezione si distingue pertanto in due parti, la prima strettamente connessa con i capelli, la seconda mostra invece una duplice proprietà nella sapienza di Cristo.
La duplice prerogativa della sapienza di Cristo ha diversi significati portati da parole: nix, frigiditas, algor, rigor, rigida, abstracta, candor intensior nostroque visui intolerabilior, per indicare il lato che si potrebbe chiamare duro della sapienza divina; lana, calor, mollities, condescensiva, contemperativa, pietate calefactiva, candor contemperantior, per designarne invece il lato pietoso e temperato. Inoltre il lato duro, indicato dalla neve, non si mostra solo freddo e rigido, ma anche purgativo e impinguativo, per cui la sapienza divina è sordium purgativa nostreque hereditatis impinguativa.
Beatrice (Purg. XXX, 70-81), nel suo apparire a Dante nel Paradiso terrestre, si presenta dapprima come “proterva”, cioè altera e rigida. Come una madre al figlio rimproverato “par superba … perché d’amaro / sente il sapor de la pietade acerba”, così la donna riprende (vv. 73-75) le prime parole di rimprovero (vv. 55-57) – “continüò come colui che dice / e ’l più caldo parlar dietro reserva”. Beatrice mostra il lato astratto della sapienza di Cristo, ma nello stesso tempo di lei si anticipa il lato pietoso: il “più caldo parlar” può essere riferito sia alle seconde parole, più dure delle prime, ma anche a quelle, assai più temperate ed espresse con pietà non acerba, che pronuncerà in seguito, dopo il pentimento di Dante. Il contrasto fra il gelido rigore e il caldo pietoso e temperato percorre infatti i versi che seguono.
Beatrice tace, e gli angeli cantano “In te, Domine, speravi ”, cioè il salmo XXX, ma solo i primi nove versetti, perché dopo “pedes meos” David chiede misericordia a Dio nelle proprie tribolazioni, cosa che sarebbe fuor di luogo per Dante (ibid., 82-84). Gli angeli sono “dolci tempre” (ibid., 94), “sustanze pie” (ibid., 101): ad essi è appropriato il lato pietoso della sapienza di Cristo.
Alle parole proterve e superbe della donna il cuore del poeta si congela come la neve tra gli alberi d’Appennino quando è “soffiata e stretta da li venti schiavi”, cioè del nord-est, e tale resta fino all’ascolto del canto pietoso degli angeli che paiono partecipare del suo dramma e dire a Beatrice: “Donna, perché sì lo stempre?”, cioè perché gli togli vigore con le tue parole non temperate? Poi, come la neve si liquefa allo spirare del caldo vento meridionale che proviene dall’Africa (“la terra che perde ombra”), così il gelo stretto attorno al cuore del poeta si scioglie in “lacrime e sospiri”, “spirito e acqua”, “e con angoscia / de la bocca e de li occhi uscì del petto” (ibid., 85-99). Anche Dante dunque partecipa dei due lati, rigido e aperto, della sapienza di Cristo.
È da notare la compresenza di alcune parole nella ristretta parte di esegesi e nel ristretto numero di versi: la neve e il congelarsi, il caldo, la pietà, il contemperare. Il significato originario non cambia, anche se quanto nell’esposizione scritturale è concentrato solo su Cristo è in poesia diffuso su tre soggetti, Beatrice, gli angeli e Dante. Bisogna anche dire che se la neve e il gelo sono accostati già nel parlare comune, e nell’ambito di questo sono altresì contrapponibili al caldo e al temperato, non appartiene del tutto al comune sentire acquisito nel linguaggio accostare la pietà al caldo e al temperare in contrapposizione al gelo.
Sarebbe ancora da notare che i piedi e il liquefarsi (vv. 84, 88) sono parole che compaiono nella sesta prerogativa di Cristo come sommo pastore, che concerne la vita attiva e l’operare, per cui si dice: “e i suoi piedi simili all’oricalco, come nel crogiolo ardente” (Ap 1, 15). L’oricalco (l’ottone) è assai simile all’oro, nel crogiolo si liquefa, è nitido, fiammeggiante, scintillante: così in Cristo gli atti corporei, esterni e inferiori procedevano e procedono fiammeggianti per la carità verso Dio e verso di noi, scintillanti in modo esemplare, provati durante la vita terrena nel crogiolo delle tentazioni e assai simili all’oro della sua interna e suprema carità.
Lo sgorgare lacrime e sospiri appartiene invece alla settima prerogativa, per cui si dice: “e la sua voce come la voce di molte acque” (Ap 1, 15) [9], cioè come la voce di piogge inondanti e come l’impeto di fiumi e il mugghiare del mare. Questa voce di molte acque viene interpretata (in un luogo parallelo, ad Ap 14, 2) come suono di un’acqua che irriga, impingua, rinfresca con le lacrime e con sospiri ruggenti. La sapienza di Cristo, designata dalla neve, è rigida ed astratta, ma anche “sordium purgativa”.
● Il duplice aspetto della sapienza di Cristo non si ritrova solo nei versi sopra citati. “Freddi e molli” sono i canali de “li ruscelletti che d’i verdi colli / del Casentin discendon giuso in Arno”, che “la rigida giustizia” divina fa sì che siano sempre dinanzi agli occhi di maestro Adamo, il falsario di Romena, per accrescergli l’arsura della sete dell’idropico datagli per pena (Inf. XXX, 64-72). Il bucolico paesaggio virgiliano – “hic gelidi fontes, hic mollia prata” (Buc. X, 42) – è qui armato dai motivi propri della sapienza divina, che si presenta, anche nella pena, insieme neve e lana, fredda e ‘condiscendente’ (il tema è nei ruscelletti che “discendono”; da notare l’aggettivo “rigida”, presente nei versi e nell’esegesi teologica).
●La prima parte dell’esegesi di Ap 1, 14 è relativa ai capelli, o crini, che nella loro senilità designano la “reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas”. Un accostamento, quello dei crini e del consiglio (tra l’altro non consueto), che è ben conosciuto dal diavolo preparato in logica che argomenta con successo, di fronte a san Francesco, il suo diritto a prendersi l’anima di Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 115-117). Guido, arrivato alla vecchiaia, si era pentito delle proprie opere volpine e si era cinto del cordone, ma poi, dando a Bonifacio VIII il consiglio fraudolento su come conquistare Palestrina, si era rimesso nelle prime colpe, e da quel momento i suoi crini non sono stati più segno di maturità e di gloria celeste, per cui il diavolo dice: “dal quale in qua stato li sono a’ crini”. Crini e consiglio sono accostati nei versi in senso negativo, all’opposto di quanto viene detto di Cristo.
● I motivi sacerdotali delle perfezioni di Cristo come sommo pastore rivestono Catone, il Gentile degno di significare Dio più di qualsiasi altro uomo terreno (Convivio, IV, xxviii, 15). La santità (terza perfezione: Ap 1, 13) è propria delle quattro stelle (le virtù cardinali, le “quattro luci sante”), “non viste mai fuor ch’a la prima gente”, che adornano la sua faccia di luce come se avesse davanti il sole (Purg. I, 23-24, 37-39; il tema della “facies eius sicut sol” costituisce la decima perfezione ad Ap 1, 16). È “veglio onesto” (Purg. II, 119; terza perfezione) e muove le “oneste piume” (la barba, Purg. I, 42). La sua barba (ibid., 34-36) è mista di pelo bianco (quarta perfezione, i capelli candidi come la neve: Ap 1, 14), somigliante (seconda perfezione, somiglianza con il Figlio dell’uomo: Ap 1, 13) ai capelli (quarta perfezione) che cadono sul petto in doppia lista (il precinto delle mammelle, cioè dell’intelletto e della volontà). La senile maturità del consiglio designata dai capelli (quarta perfezione) è reverenda, per cui è “veglio … degno di tanta reverenza in vista”, di fronte al quale Virgilio rende reverenti le gambe e il capo di Dante (ibid., 31-32, 49-51). Il suo “santo petto” (ibid., 80) designa, come si desume da Ap 2, 4, il retto consiglio, che corrisponde alla domanda del veglio se per Virgilio e Dante sia mutato il consiglio divino che impedisce ai dannati di fuggire la prigione eterna (ibid., 47-48). La castità (terza perfezione) è negli occhi della moglie Marzia (ibid., 78-79). Invia i due poeti verso il “molle limo” sull’orlo più basso della montagna del Purgatorio: ivi crescono giunchi che non induriscono al percuotere delle onde, simbolo dell’umiltà che è principio di purgazione (ibid., 100-105; cfr. i “piè molli” a Purg. XXI, 36). Ivi (Purg. I, 94-99) Dante deve essere lavato nel viso d’ “ogne sucidume” e cinto (terza perfezione; ibid., 94-99, 133). È da notare che la sapienza di Cristo è molle e condescensiva (come i giunchi), e anche “sordium purgativa” (quarta perfezione).
● Catone, per la senilità e il biancore (Purg. I, 31, 34), è accostabile a Caronte (Inf. III, 83, 97): “un veglio solo … Lunga la barba e di pel bianco mista” – “un vecchio, bianco per antico pelo … Quinci fuor quete le lanose gote” (unico riferimento alla lana nel poema, assente in Virgilio; cfr. Aen. VI, 299-300: “cui plurima mento / canities inculta iacet”). Anche per il traghettatore d’Acheronte i temi corrispondono in parte alla quarta prerogativa di Cristo sommo pastore, di cui vengono citate le due vie, corrispondenti al calore della lana e al freddo della neve, entrambe volte alla punizione: “i’ vegno per menarvi a l’altra riva / ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo” (Inf. III, 86-87). L’aggettivo “antico” appartiene, nell’esegesi della sesta coppa versata dall’angelo sul grande fiume Eufrate (Ap 16, 12), all’antica Babilonia per la quale quel fiume scorreva contribuendo non poco alla sua difesa. Secondo Gioacchino da Fiore, esso designa Roma o la milizia mondana dell’impero cristiano, per cui ad Ap 17, 15 viene detto che “le acque sopra le quali siede la meretrice sono i popoli e le genti”. Di qui il verso “vidi genti a la riva d’un gran fiume” (Inf. III, 71). Di Babilonia si dice ad Ap 18, 2: “Ed è fatta nido di demoni e covo di ogni spirito immondo e di ogni uccello sozzo e odioso”. I demoni sono detti “spiriti” per la natura sottile; “uccelli” per agilità, velocità e superbia; “immondi” per le macchie dei vizi; “odiosi” per la grande malizia, empietà ed arroganza. Babilonia sarà la loro abitazione e il loro covo, poiché come nella colpa terrena, nel consentire ad essi e nell’imitarli, fu ad essi soggetta e associata e fu quasi la loro casa, così sarà nella pena eterna. Giovanni in questo caso mantiene l’immagine di Isaia: “Babilonia, gloriosa città tra i regni, sarà come Sodoma sconvolta da Dio; le sue case si riempiranno di serpenti, vi faranno dimora gli struzzi e esseri pelosi vi danzeranno” (Is 13, 19.21). Di qui il “pelo” di Caronte.
La quinta perfezione di Cristo come sommo pastore è il fervido, splendente e perspicace zelo della contemplazione che osserva intorno ogni atto, intenzione o cenno delle chiese, per cui si dice: “e i suoi occhi fiammeggianti come fuoco” (Ap 1, 14). Un passo simmetrico è ad Ap 19, 12. Se si collazionano i passi relativi alla quinta perfezione con quanto ad Ap 9, 9 si dice, nell’esegesi della quinta tromba, sullo zelo acre delle locuste le cui ali suonano come ruote ed eserciti tumultuosi che corrono in guerra contro ogni sentenza contraria, si ritrovano altri fili con cui è tessuta la figura di Caronte, “che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote” (lo zelo è il motivo-chiave che unisce i tre passi). Dante ha presente il virgiliano “stant lumina flamma” (Aen. VI, 300), ma modifica l’immobilità dello sguardo con il movimento circolare degli occhi, reso dalle “rote” fiammeggianti, che raccoglie tutte le anime con cenni. Un altro passo che può aver recato motivi a Inf. III, 99 è ad Ap 14, 11, dove la fiamma infernale è detta ardente e sempre in vivacissimo moto (cfr., a Inf. IV, 123, “Cesare armato con li occhi grifagni”). La “bragia” degli occhi si trova ad Ap 4, 8, nel fuoco della carità proprio dei cherubini, lampade ardenti secondo Ezechiele (Ez 1, 13), riferito alle sei ali piene di occhi circospetti di ciascuno dei quattro esseri viventi che vanno intorno alla sede divina difendendola dalle insidie come un leone (cfr. l’atteggiamento di Sordello a Purg. VI, 61-66).
L’avvento di Caronte è segnato, come quello di Virgilio, da temi che nell’esegesi sono propri di Cristo. La sua apparizione riprende il tema, da Ap 1, 7 e 2, 12, dell’avvento di Cristo giudice, che viene proposto al lettore in modo sensibile e terribile: «Ecce venit cum nubibus … “veniam tibi”, id est contra te, “cito” / Ed ecco verso noi venir per nave» (Inf. III, 82; cfr., a Inf. IV, 82-87, l’arrivo di Omero con la “spada”, che come il “remo” di Caronte corrisponde al “gladium” di Ap 2, 12, cioè alla parola viva dello spirito di Cristo, che determina, giudica e condanna).
Alcuni motivi suggeriti ad Ap 11, 18 (settima tromba) sono presenti nei versi che descrivono la “trista riviera d’Acheronte”. La divisione dei buoni dai malvagi è nell’invito di Caronte a Dante: “pàrtiti da cotesti che son morti” (Inf. III, 89). L’ira nell’espressione di Virgilio: “quelli che muoion ne l’ira di Dio …” (ibid., 122). L’esser pravo e il “guai!” nelle parole crude del nocchiero: “Guai a voi, anime prave!” (ibid., 84; cfr. l’espressione “terra prava” a Inf. XVI, 9 e Par. IX, 25).
__________________________________________________________________________________________________________________
Tab. I.7 (Nota)
[Nota alla Tab. I.7]
Verso la fine del quinto stato tre gravissime tentazioni pervadono la Chiesa: la rilassatezza del clero, dei monaci e dei laici; la pestifera eresia manichea (catara), valdese e patarina; l’impugnazione dello spirito di Cristo fatta da religiosi ipocriti e fraudolenti in modo subdolo così da indurre in errore anche gli eletti. Le tre tentazioni vengono considerate insieme nella trattazione della quinta tromba.
La causa della rilassatezza è il cadere di vescovi e abati nella cupidigia e nell’ambizione, essi che prima apparivano come stelle in cielo. Perciò si dice: “vidi una stella caduta dal cielo sulla terra”, cioè nella terrestre avarizia e lussuria. Alla stella “fu data la chiave del pozzo dell’abisso e aprì il pozzo dell’abisso” (Ap 9, 1-2). Il pozzo dell’abisso è la fiamma infernale oscura e fumosa, la voragine profonda e quasi senza fondo e la compagnia dei demoni. Aprire il pozzo dell’abisso significa che il cattivo esempio e il malgoverno dei prelati scioglie il freno posto ai vizi, che prima nella Chiesa era rappresentato dai precetti divini, dal timore dei giudizi, dalla rigida e severa disciplina dei prelati nei confronti dei sudditi, dall’esempio della santa compagnia e dallo zelo insofferente di enormità o sfrenatezze. Poiché il male commesso dai prelati viene preso a esempio dai sottoposti che li seguono come capi e guide, il gregge dei sudditi, sempre incline al male, vedendo i prelati precipitare a poco a poco nei vizi, in assenza di correzione o punizione da parte dei superiori negligenti e anzi favorevoli ad aprire il pozzo dei cuori, scivola anch’esso e infine precipita.
“E salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace” (Ap 9, 2). Il grave e grosso fumo che esce dal pozzo punge e confonde gli occhi di chi guarda e diffama e oscura presso fedeli e infedeli la solare chiarezza della fede, della Chiesa e della religione che conduce al culto di Cristo vero sole, come l’aere perspicuo permette alla nostra facoltà visiva di raggiungere il sole e ai raggi del sole di pervenire all’occhio. Così molti prelati, secolari e regolari, che prima apparivano quasi come il sole, e molti spirituali, che prima erano quasi come l’aere puro illuminato dal sole, si corrompono e si fanno neri per il fumo causato da tanta rilassatezza.
Se si collazionano tutti i temi relativi all’apertura del pozzo dell’abisso una volta sciolto il freno, e al fumo che ne esce, propri delle tre tentazioni del quinto stato (Ap 9, 1-2), si possono identificare una serie di fili con cui è tessuto parte dell’ordito di Purg. XV-XVI. In questo caso gli iracondi purganti nella terza cornice della montagna non appartengono a una zona nella quale prevalgono i temi del quinto stato (sono quelli del terzo a essere preminenti; cfr. Topografia spirituale della “Commedia” ), tuttavia il tema del fumo ha una parte importante, sia perché anticipa la quinta zona degli avari e dei prodighi, dopo la quarta relativamente breve degli accidiosi, sia perché nell’Inferno il fumo è tema proprio sia degli iracondi come degli accidiosi, che portarono dentro “accidïoso fummo”, insieme fitti nel limo della palude Stigia (Inf. VII, 123), e pertanto viene nel Purgatorio posto a introduzione di tre successivi gironi.
Per la seconda tentazione (relativa all’eresia manichea, cioè catara e patarina, radicata nella contea di Tolosa e in Italia) viene riportata l’esegesi di Gioacchino da Fiore, per il quale la stella che cadde dal cielo fu qualche chierico ripieno di scienza delle lettere, che dal “padre di menzogna” prese la chiave della scienza del dogma erroneo e il potere di investigare le profondità della sapienza falsa e superstiziosa.
Nella terza tentazione, la più grave perché impugna la vita e lo spirito di Cristo e apre la via alla “setta” del grande Anticristo, secondo Olivi la stella designa il cadere di alcuni alti e dotti religiosi moderni nella cupidigia delle cose terrene e nelle scienze filosofiche curiose e mondane e in molti punti erronee e pericolose. Costoro hanno ricevuto l’ingegno e la chiave per aprire ed esporre la dottrina di Aristotele e di Averroè suo commentatore e per escogitare profondi e abissali dogmi che oscurano il sole della sapienza cristiana e della vita evangelica e l’aere puro della vita religiosa a questa ispirata. Costoro avversano l’ “usus pauper”, cioè proporzionato all’altissima povertà secondo le debite circostanze, e sostengono che esso non fa parte della sostanza della perfezione evangelica, di cui è invece proprio avere in comune quanto è sufficiente o almeno quanto è necessario. Molti chierici hanno inserito nei loro trattati questi dogmi filosofici o piuttosto pagani e sostenuto a Parigi che solo la filosofia mondana è vera e sufficiente al governo degli uomini. Hanno pure affermato che Dio ha operato e opera tutto per necessità ab aeterno, senza poter fare mai cosa nuova; sostengono con Averroè che in tutti gli uomini esiste un solo intelletto possibile e arrivano a negare quasi del tutto la libertà umana.
Il fumo oscuro come la notte, che avvolge gli iracondi, si fa incontro verso Dante e Virgilio “a poco a poco” (i prelati rovinano gradatamente) togliendo “li occhi”, cioè non consentendo di vedere, e “l’aere puro”; fa al viso “sì grosso velo … che l’occhio stare aperto non sofferse” (Purg. XV, 142-145; XVI, 4-7, 25, 35, 142). Nel colloquio con Marco Lombardo, l’essere il mondo “di malizia gravido e coverto” deriva dalla “gravitas mali” provocata dal fumo che esce dal pozzo. È presente il tema del rapporto tra necessità e libero arbitrio, che Dante applica alla questione, che gli è cara, del rapporto tra gli influssi astrali e la volontà degli uomini (Purg. XVI, 58-84). Il tema del freno e della guida appare nell’ingannarsi de “l’anima semplicetta che sa nulla”, la quale corre dietro ai piccoli beni che le paiono grandi “se guida o fren non torce suo amore” (ibid., 85-93). Di qui la convenienza a porre il freno della legge e la guida del monarca che conduca l’umanità alla meta prefissa (ibid., 94-96). Il tema del precipitare dei prelati trascinando dietro a sé i propri sudditi per negligenza e complicità nel peccato è ancora nell’argomentare di Marco: nessuno pone mano alle leggi esistenti essendo vacante l’Impero, e il pontefice, pastore che procede innanzi al gregge, si indirizza solo ai beni materiali imitato dalla gente che non cerca altro (ibid., 97-102; il cattivo esempio può venire anche dai casati: cfr. quanto a Purg. XIX, 142-145 dice Adriano V della sua nipote Alagia, la moglie di Moroello Malaspina).
Sull’essere la filosofia mondana sufficiente al governo degli uomini, come sostenuto da alcuni religiosi a Parigi, c’è la risposta data da Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole. Il “doctor angelicus” esalta la sapienza di Salomone, la luce più bella del quarto cielo; per essa egli “chiese senno / acciò che re sufficïente fosse”, non per futili motivi di filosofia mondana. Salomone fece pertanto un “uso povero”, cioè prudente e proporzionato, della sapienza (Par. XIII, 94-102; non in tabella) [10]. Da notare che una delle questioni, giudicate dall’Aquinate come superflue, è se da una premessa necessaria e da una contingente si possa dedurre una conclusione necessaria, il che è assurdo secondo la logica aristotelica: essa sembra un’eco delle parole di Marco Lombardo: “Voi che vivete ogne cagion recate / pur suso al cielo, pur come se tutto / movesse seco di necessitate” (Purg. XVI, 67-69).
Quanto alla decisa condanna da parte dell’Olivi di Aristotele e di Averroè, considerati un pericolo per il pensiero cristiano, è stato più volte affermato, nel corso dell’esposizione di questa ricerca, che il “maestro di color che sanno” e il suo grande commentatore sono da Dante incorporati nella stessa teologia della storia concepita dal francescano e quindi conciliati con il pensiero cristiano. Non solo vengono onorati come giusti che non conobbero Cristo fra gli “spiriti magni” del Limbo, ma sono anch’essi inseriti in un processo provvidenziale che non riguarda solo la Chiesa ma l’intero mondo degli uomini, in attesa di una nuova conversione universale.
Un altro modello di “usus pauper” è la montagna del Purgatorio. Alla domanda di Virgilio sulle cause del terremoto e del grido che l’ha sconvolta allorché i due poeti hanno lasciato Ugo Capeto, Stazio risponde che “ la religïone de la montagna” fa in modo che tutto ciò che avviene non sia “sanza ordine” o “fuor d’usanza”. La montagna, al di là della porta, è libera da tutte le alterazioni terrestri e in essa si può far sentire solo l’efficacia causale “di quel che ’l ciel da sé in sé riceve … e non d’altro …” (Purg. XXI, 40-45). Il terremoto stesso corrisponde a quello che accompagna l’apertura del sesto sigillo.
Nella foresta dell’Eden tre soli passi separano Dante da Matelda, che sta al di là del fiumicello; eppure l’Ellesponto, molto più largo del Lete, non fu oggetto di maggiore odio da parte di Leandro, quando il mareggiare gli impediva di raggiungere di notte l’amata Ero (Purg. XXVIII, 70-75). Il riferimento a Serse, “ancora freno a tutti orgogli umani”, in quanto passò l’Ellesponto per portare guerra ai Greci e lo riattraversò sconfitto, non è solo reminiscenza storica tratta dall’Ormista (II, x, 8-11) che s’innesta sulle Heroides di Ovidio (18-19), perché il fiumicello che separa il poeta dalla bella donna è il freno che non viene aperto o sciolto. Come dirà più avanti Beatrice, non si può passare il Lete senza pentimento delle proprie colpe (Purg. XXX, 142-145). L’uso di questo tema conferma Matelda, bella donna che fa rimembrare un ‘prima’ perduto, come depositaria della disciplina propria dei prelati dell’inizio del quinto stato, il cui bel principio designa l’età dell’oro sognata in Parnaso dagli antichi poeti.
All’esegesi di Ap 9, 1-2 rinviano altri luoghi della Commedia: l’oscura bolgia dei barattieri dove Ciampòlo, saltando nella pece bollente, si scioglie dalla poco severa sorveglianza del “preposto” Barbariccia, come i sudditi dal freno dei rilassati prelati che dovrebbero governarli (Inf. XXI, 4-6; XXII, 121-123); la tempesta di pioggia scatenata dal diavolo sul corpo senza vita di Buonconte da Montefeltro, insepolto sull’ “Archian rubesto” dopo la battaglia di Campaldino, per vendicarsi della salvezza dell’anima “per una lagrimetta che ’l mi toglie” (Purg. V, 109-129: il diavolo assume il ruolo del prelato che, oscurando l’aere [cfr. anche l’esegesi di Ap 16, 17], permette che il freno sia sciolto, ma il suo operato conduce a rovina solo il corpo, non l’anima).
Il “freno”, cioè le redini del “governo”, di cui all’esegesi di Ap 9, 1-2, è strettamente connesso con il già trattato “calamus” di Ap 11, 1. Ugo Capeto afferma: “Figliuol fu’ io d’un beccaio di Parigi: / quando li regi antichi venner meno / tutti, fuor ch’un renduto in panni bigi, / trova’mi stretto ne le mani il freno / del governo del regno …” (Purg. XX, 52-56). Per comprendere il significato di “tutti, fuor ch’un renduto in panni bigi” bisogna esaminare l’esegesi di Ap 3, 3-4, come esposta nella tabella che segue (cfr. nota).
_________________________________________________________________________________________________________________
Tab. I.8 (Nota)
[Nota alla Tab. I.8]
Nella tabella viene presa in considerazione l’esegesi di Ap 3, 3-4, parte dell’istruzione data alla chiesa di Sardi, la quinta delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione [11].
Se il vescovo della chiesa di Sardi, accusato di essere negligente, intorpidito e ozioso, non vigilerà correggendosi, il giudizio divino verrà da lui come un ladro, che arriva di nascosto all’improvviso, senza che egli sappia l’ora della venuta (Ap 3, 3). È giusto infatti che chi non conosce sé stesso a causa della negligenza e del torpore non conosca l’ora del proprio giudizio e sterminio. Costui non vede la luce a motivo delle sue tenebre; erroneamente crede e desidera di poter vivere a lungo nella prosperità ritenendo che il giudizio divino possa essere a lungo ritardato, e con speranza presuntuosa spera di venire infine salvato. Ma l’Apostolo dice ai Tessalonicesi che “il giorno del Signore verrà di notte come un ladro. E quando diranno: ‘pace e sicurezza’, allora verrà su di loro una repentina distruzione” (1 Th 5, 2-3). Ma ai santi non verrà come un ladro, per cui san Paolo aggiunge: “Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro: voi tutti infatti siete figli della luce e del giorno. Pertanto, non dormiamo come gli altri, ma vigiliamo e restiamo sobri. Quelli che dormono, infatti, dormono di notte” (ibid., 5, 4-7). È questa una prefigurazione dell’occulto avvento e giudizio di Cristo alla fine del quinto stato e all’inizio del sesto, che verrà spiegato all’apertura del sesto sigillo.
Il tema del venire come un ladro si trova in un passo simmetrico, proprio della sesta delle sette coppe che vengono versate nella quinta visione (Ap 16, 15), dove si parla di un giudizio improvviso e subitaneo, sottolineato dall’avverbio “ecce” e dal presente “venio” al posto del futuro ‘veniam’ per togliere ogni possibile stima dell’indugiare e per rendere più attenti, vigili e timorati. Inoltre si definisce beato colui che vigila e custodisce le sue vesti, cioè le virtù e le buone opere, per non andar nudo, cioè spogliato di esse, sì che tutti vedano le sue sconcezze, cioè il suo peccato e la pena piena di confusione inflitta nel giorno del giudizio.
Da questi difetti vengono escluse poche persone buone, i cui nomi sono noti a Cristo per la loro santità, per cui si dice: “Ma hai pochi nomi in Sardi” (Ap 3, 4). Il dono della grazia che ciascuno ha ricevuto come proprio dà a ogni uomo un nome per il quale egli è conosciuto. La carità divina, in quanto comune a tutti i buoni, dà un comune nome ai santi, che sono così chiamati cittadini di Gerusalemme.
I due passi (Ap 3, 3 e 16, 15), che sono loci paralleli, se collazionati offrono una serie di parole-temi. Comune è il “fur”, il “vigilare”, il sopravvenire improvviso. Peculiari di Ap 3, 3 sono l’inconsapevolezza (“et horam nescies qua veniam ad te”), il “tardare”, la speranza presuntuosa di potersi salvare alla fine e, nel passo paolino, il sentirsi sicuri e la distinzione tra coloro che sono nelle tenebre perché dormono la notte e i figli della luce e del giorno. Peculiari di Ap 16, 15 sono l’avverbio “ecce”, l’impossibilità di stimare l’indugio (“ut per hoc estimationem de sua mora nobis tollat”), il timore, il non vedersi spogliato delle vesti, cioè delle virtù e delle buone opere.
A questi temi si può aggiungere, in quanto richiamato dall’Olivi ad Ap 3, 3, ciò che avviene all’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12-17): il sentir sopravvenire il giudizio divino provoca la fuga ai “monti” e alle “pietre”, interpretati come i santi sublimi e fermi nella fede.
È da notare che su Ap 3, 3 e 16, 15 Olivi non si discosta dall’esegesi di Riccardo di San Vittore [12], salvo che per due punti: l’inserimento del passo paolino dalla prima lettera ai Tessalonicesi e il collegamento del sopravvenire di Cristo in quanto “fur” con quello che avverrà in apertura del sesto sigillo.
Una delle apparizioni del tema che si potrebbe definire ‘del ladro’ è in Inf. XXI, 22-45, nel momento in cui Dante, fisso a guardare la “pegola spessa” che bolle nella bolgia dei barattieri, simile a quella che si vede nell’ “arzanà de’ Viniziani”, viene richiamato da Virgilio. Il poeta si volge come colui che “tarda” nel fermarsi a vedere ciò che è opportuno fuggire e che un sùbito timore priva di gagliardia per cui non indugia il partire, guardando però al tempo stesso un diavolo nero venire correndo su per lo scoglio. Il diavolo porta in spalla un peccatore – “ecco un de li anzïan di Santa Zita!” – e dal ponte dice agli altri Malebranche di metterlo sotto la pece intanto che lui torna a Lucca, terra ben fornita di barattieri. Buttato l’ “anzian” di sotto, ritorna indietro con tanta fretta come mai fece mastino nell’inseguire un ladro. Dal confronto dei versi con i passi tratti da Ap 3, 3 e 16, 15 si può notare che il tardare rinvia ad Ap 3, 3 (dove designa la presunzione di chi ritiene che il giudizio divino tardi; il “Guarda, guarda!” di Virgilio è richiamo dal torpore proprio di chi si ritiene troppo sicuro), mentre la “paura sùbita” e il non indugiare sollecitano la memoria del lettore accorto (che cioè già conosce la Lectura oliviana) verso Ap 16, 15 (“et subito faciet hec iudicia … ut per hoc estimationem de sua mora nobis tollat et ad adventum suum nos attentiores et evigilantiores et timoratiores reddat”). Entrambi i passi sono congiunti dalla parola “fur”, che nel testo di esegesi scritturale compare come soggetto attivo del giudizio (è Cristo giudice che viene all’improvviso come un ladro), mentre in poesia viene appropriato all’oggetto del giudizio, cioè ai barattieri lucchesi che il diavolo si precipita ad andare a prendere. Il ‘fuggire’ come atto da non ritardare è un tema del sesto stato e più precisamente dell’apertura del sesto sigillo, ad Ap 6, 12-17; lo si ritroverà nella fuga dai Malebranche, nel passaggio dalla quinta alla sesta bolgia. La sarcastica frase del diavolo su Lucca – “ogn’ uom v’è barattier, fuor che Bonturo” – sembra tradurre l’eccezione fatta nella chiesa di Sardi di pochi buoni non “coinquinati”, che segue immediatamente ad Ap 3, 4. Per quanto collocate in un contesto diverso e appropriate a soggetti differenti, le parole mantengono una parte dei significati originari. Resta nel complesso il tema principale del sopravvenire improvviso del giudizio divino, nel caso impersonato dal diavolo nero che di tale giustizia è ministro.
Una variazione di questi motivi si trova nella selva dei suicidi. Dapprima Pier della Vigna spiega che dopo la resurrezione i suicidi andranno anch’essi nella valle di Giosafat per riprendervi i propri corpi (le “nostre spoglie”) senza però rivestirsene, perché questi saranno trascinati per la selva e appesi ciascuno al pruno che incarcera l’anima. Nei versi è ripetuto il motivo di Ap 16, 15: «“Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus» (Inf. XIII, 103-105). Il corpo non è in questo caso “la carne glorïosa e santa” che “fia rivestita” (cfr. Par. XIV, 43-44), bensì ‘spoglia’, cioè carne spogliata di virtù, “ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie”.
Mentre i due poeti attendono ancora al tronco di Pier della Vigna per udire altro, vengono sorpresi da un rumore e vedono venir fuggendo due dannati, il senese Lano e Iacopo da Santo Andrea, inseguiti da nere cagne (anche qui il fuggire è motivo tratto dal sesto sigillo, come pure il sentir venire sopra di sé qualcosa di imminente, nel caso “’l porco e la caccia”). Uno dei due scialacquatori, Iacopo, “cui pareva tardar troppo” nella corsa, si rivolge all’altro rinfacciandogli di non aver avuto gambe tanto svelte nell’agguato della Pieve al Toppo (1278), dove trovò la morte (Inf. XIII, 109-121). Il tardare è ad Ap 3, 3, l’avverbio “ecco” ad Ap 16, 15.
Si potrebbe dire che perfino l’espressione “Lano, sì non furo accorte / le gambe tue a le giostre dal Toppo!” concorda nel verbo con fur, quasi ad accentuare una subitanea rapidità, propria del ladro, che è mancata al momento del bisogno. Non paia, questa, affermazione astrusa, perché il confronto tra Lectura e Commedia registra nei versi non pochi esempi di parole che nel suono coincidono con altre dell’esegesi teologica pur avendo significato letterale diverso.
Nei versi che descrivono l’intervento di Catone a disperdere le anime da poco giunte alla riva del Purgatorio, tutte fisse e attente con Dante e Virgilio ad ascoltare l’amoroso canto di Casella che intona dolcemente “Amor che ne la mente mi ragiona”, si registrano numerosi motivi del gruppo del “fur”, nel silenzio del tema principale (Purg. II, 118-133). Alla negligenza si contrappone il rimprovero del “veglio onesto” (“veglio” equivoca tra ‘vecchio’ e ‘vigilante’), e si tratta di motivi che rinviano ad Ap 3, 3.
L’invito ad andare a purgarsi – “Correte al monte a spogliarvi lo scoglio / ch’esser non lascia a voi Dio manifesto” – contiene il motivo del «“Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus» ad Ap 16, 15. ‘Spogliarsi lo scoglio’ del peccato è un rivestirsi di virtù. È da notare che nel canto precedente Virgilio ricorda a Catone il suo suicidio in Utica, “ove lasciasti / la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara” (Purg. I, 74-75): non è casuale che il versetto precedente, Ap 16, 14, parli del “dies magnus Dei omnipotentis”, cioè del giudizio di cui poi si dice che verrà subitamente come un ladro. È ancora da notare come il corpo, detto ‘spoglia’ nel caso dei suicidi puniti nella selva infernale, sia chiamato “vesta” nel caso di Catone, che vigilò e custodì le virtù e le buone opere. Lo stesso motivo compare nel coro dei quattro figli del conte Ugolino: “tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia” (Inf. XXXIII, 62-63). Essi offrono in sacrificio al padre una carne peritura e hanno fame di cibo spirituale, come Catone di libertà [13].
Le anime che il gridare di Catone fa fuggire verso la montagna sono paragonate ai colombi che abbandonano il cibo “se cosa appare ond’ elli abbian paura”. Anche nella similitudine (Purg. II, 124-133) sono presenti motivi del gruppo: “subitamente” corrisponde a “et subito faciet hec iudicia”, “abbian paura” a “timoratiores reddat”, mentre il fuggire delle anime “com’ om che va, né sa dove rïesca” è da ricondurre al non sapere l’ora del giudizio ad Ap 3, 3. Il fuggire atterriti ai monti è inoltre un tema di Ap 6, 15, l’apertura del sesto sigillo cui è assimilato il venire di Cristo come un ladro proposto alla chiesa di Sardi.
Nel complesso dei versi si mantengono i concetti teologici di un sopravvenire improvviso che suscita la paura del giudizio (da notare la presenza dell’avverbio “ecco”, da Ap 16, 15), della necessità di vigilare contro ogni negligenza e torpore, del custodire le proprie vesti, cioè le virtù e le buone opere. Tace, come si è già notato, il tema principale, quello del “fur”.
Nel colloquio con Sordello, Virgilio usa il motivo del vestirsi di virtù e di buone opere da Ap 16, 15 (Purg. VII, 7-8, 25-27). Egli ha perduto la visione di Dio “non per far, ma per non fare”, cioè “per non aver fé” in quel Dio “che fu tardi per me conosciuto”. Da notare il tardare, ad Ap 3, 3; il “non fare” corrisponde ai «“vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera», e per questo il poeta pagano aggiunge: “quivi sto io con quei che le tre sante / virtù non si vestiro, e sanza vizio / conobber l’altre e seguir tutte quante” (vv. 34-36). Virgilio distingue tra le virtù cardinali, di cui si rivestì, e quelle teologali, di cui non poté rivestirsi. Qui il tardare non è peccato, perché solo la prescienza divina poteva stabilire il tempo della Redenzione; designa un fatto ineluttabile e doloroso. Delle quattro parole fondamentali del gruppo da Ap 16, 15 (“vestimenta”, “virtutes”, “bona opera”, “spoliatus”) solo l’ultima, quella negativa, non viene pronunciata da Virgilio.
Più avanti nel canto, Sordello guida i due poeti alla valletta dei principi, dove il tema della negligenza e del tardare (da Ap 3, 3) sono generali, ma in particolare appropriati a Rodolfo d’Asburgo (re d’Italia dal 1273 al 1291), “che potea / sanar le piaghe c’hanno Italia morta, / sì che tardi per altri si ricrea” (Purg. VII, 91-96).
Nel secondo balzo del cosiddetto Antipurgatorio, tra i morti per violenza e negligenti nel pentimento sino all’ultima ora, Iacopo del Cassero ripete il motivo paolino di quanti dicono “pax et securitas”, ammettendo di essere stato ucciso dai sicari del marchese Azzo d’Este a Oriago, presso Padova (1298), proprio nel luogo, “in grembo a li Antenori”, dove credeva di essere più sicuro (Purg. V, 73-76). Pace e sicurezza di cui, dice ironicamente il poeta, può vantarsi Firenze: “tu ricca, tu con pace e tu con senno!” (Purg. VI, 137).
Il tardare è proprio del cielo della Luna, che delle sfere celesti è quella che si muove più lentamente. In essa si manifestano i beati che hanno negletto i voti (Par. III, 51, 55-57). Piccarda varia ancora i temi. Fu infatti clarissa, secondo la regola per cui “nel vostro mondo giù si veste e vela, / perché fino al morir si vegghi e dorma / con quello sposo ch’ogne voto accetta / che caritate a suo piacer conforma” (ibid., 97-102). Il vestirsi, da Ap 16, 15, è speculare al vegliare da Ap 3, 3; il dormire (motivo anch’esso presente, in senso negativo, ad Ap 3, 3) corrisponde al ‘velare’.
“Fu tarda” la conversione alle cose celesti di Adriano V, che purga l’avarizia nel quinto girone della montagna (Purg. XIX, 106); il successore di Pietro (il Fieschi regnò per soli trentotto giorni nel 1276) aggiunge il tema dell’eccezione di pochi buoni della chiesa di Sardi (Ap 3, 4) allorché menziona la sua “buona” nipote Alagia, la moglie di Moroello Malaspina (ibid., 142-145). Le parole “e questa sola di là m’è rimasa” contengono il tema del rimanere del purissimo seme, proprio della quinta guerra (Ap 12, 17) [14]. All’inciso «excipit quosdam illius ecclesie … Caritas autem Dei, in quantum communis omnibus bonis, dat commune nomen sanctis ut vocentur cives Iherusalem. “Qui non coinquinaverunt”, scilicet sordibus vitiorum et precipue carnalium, “vestimenta sua”, id est virtutes suas quibus quasi vestibus ornantur et vestiuntur” …», nel rimprovero fatto al vescovo di Sardi, che era suonato beffardo nel giudizio del diavolo su Lucca – “ogn’ uom v’è barattier, fuor che Bonturo” -, rinviano anche le parole di Ugo Capeto: “Figliuol fu’ io d’un beccaio di Parigi: / quando li regi antichi venner meno / tutti, fuor ch’un renduto in panni bigi, / trova’mi stretto ne le mani il freno / del governo del regno …” (Purg. XX, 52-56). Tutto l’episodio dell’incontro con Ugo Capeto si inserisce topograficamente nel quinto stato della storia della Chiesa. Pochi si salvano: il capostipite della “mala pianta” capetingia e l’ultimo, non nominato, dei “regi antichi”, fattosi monaco.
___________________________________________________________________________________________________________________
Tab. I.9 (Nota)
[Nota alla Tab. I.9]
Il capitolo XXII dell’Apocalisse si apre con la visione del nobilissimo fiume che scorre nel mezzo della città celeste. È lo stesso Spirito Santo, ovvero la gloria che da Dio affluisce sui beati: fiume di acqua viva, o di vita eterna, da cui deriva tutta la sostanza della Trinità. Fiume di splendore e luce per sapienza, che ha due rive o due parti (destra e sinistra, superiore e inferiore), designanti le due nature, divina e umana, di Cristo-lignum vite che dà perpetui frutti. Il lignum vite, l’albero che sta nel mezzo, con le sue foglie getta un’ombra sacramentale, di verità superiori, su entrambe le rive, l’umana e la divina, perché non solo il cielo, ma anche la terra è ripiena della gloria di Dio [15].
L’esegesi di Ap 22, 1-2 offre una ricchezza tematica riaffiorante in numerosi luoghi della Commedia. Può inoltre essere considerata in collazione con altri passi del testo sacro, come Ap 21, 11 (la forma della città, ‘idea’ dello splendore divino) e Ap 21, 18.21 [16].
Se riferita al fiume, essa conduce ai due fiumi dell’Eden (il Lete e l’Eunoè) che si dipartono da un’unica fontana, e al fiume di luce dell’Empireo. In sintesi, qui si noterà come il tessuto dell’Eden sia in parte segnato dai temi del fiume celeste, scomposti e assegnati a più immagini. In parte perché innumerevoli sono i segni che rinviano agli altri raggruppamenti tematici, e qui se ne isola un solo tipo. Si noti la rima diriva / ravviva, per l’Eunoè (Purg. XXXIII, 127, 129); ma viva è anche “la divina foresta”, in rima con riva intesa come margine in corrispondenza dell’ultimo gradino della scala (Purg. XXVIII, 2, 4), quasi anticipazione della ripa verdeggiante e ombrata del Lete. L’operare degli uccelli sotto le foglie piegate “a la parte / u’ la prim’ ombra gitta il santo monte”, ibid., 10-18, ha un valore sacramentale: “Per folia enim designantur verba divina, tum quia veritate virescunt, tum quia fructum bonorum operum sub se tenent et protegunt”. Il Lete, “rio, / che ’nver’ sinistra con sue picciole onde / piegava l’erba che ’n sua ripa uscìo” (ibid., 25-27), la cui acqua toglie la memoria del peccato, costituisce la riva sinistra del fiume celeste, mentre l’Eunoè, il cui gusto “a tutti altri sapori … è di sopra” (ibid., 133), corrisponde all’altra riva, destra e superiore. Entrambi i fiumi nascono da un’unica sorgente, “al fin d’un’ombra smorta, / qual sotto foglie verdi e rami nigri / sovra suoi freddi rivi l’alpe porta” (Purg. XXXIII, 109-111). I signacula rinviano tutti alla medesima parte di esegesi, ma sono assegnati alcuni a un fiume altri all’altro, altri a entrambi: la ripa e l’essere “fiume sacro” al Lete, il derivare e l’essere l’acqua viva all’Eunoè; è comune l’ombra delle foglie. Dalle singole parti così parzialmente contrassegnate, come per sineddoche, l’esperto lettore può ricostruire il tutto, cioè la dottrina che proviene dall’esegesi del testo sacro. Certo questo ‘tutto’ egli già lo conosce in latino, ma è cosa diversa ritrovarselo in volgare, figurato in tante immagini.
Non sono solo i due fiumi dell’Eden ad essere fasciati dalla sacra pagina e dalla sua esposizione. Perfino Beatrice vi partecipa. Anche la donna ha due bellezze, gli occhi e la bocca. Alla prima si perviene con le virtù cardinali (le quali accompagnano lì Dante), ma si guarda nel suo profondo solo con le virtù teologali e per preghiera di queste, congiunta con la grazia gratuitamente data, si ottiene la seconda bellezza. Nel suo svelarsi, Beatrice è “isplendor di viva luce etterna” che sta fra cielo e terra, “là dove armonizzando il ciel t’adombra”. Per lei non si parla di ‘fiume’ o di ‘acqua’, ma assume alcune fondamentali prerogative di Cristo centro della Gerusalemme celeste, della sua irrigazione e dunque della storia umana (Purg. XXXI, 139-145). La donna ha anche nelle sue vesti una zona superiore (il velo candido, “sopra” il quale è “cinta d’uliva”) e una inferiore (“sotto verde manto”), cioè la veste rossa, indelebile memoria dell’umana Beatrice descritta con “vestimenta sanguigne” nella Vita Nova (1. 4/15; 28. 1 [ed. G. Gorni, Torino 1996]; Purg. XXX, 31-33). Il suo disvelarsi è una vera e propria messa in versi della parola “apocalisse”, rivelazione per grazia dell’arcano [17]. L’ombra del velo verrà completamente tolta nella gloria di Cristo allorché, nel sesto e nel settimo stato, la luce della luna sarà, come quella del sole, splendente della luce di sette giorni, secondo Isaia 30, 26 che è incipit della Lectura super Apocalipsim [18].
I due fiumi dell’Eden sono figura in terra dell’unico luminoso fiume dell’Empireo: “fulvido di fulgore, intra due rive / dipinte di mirabil primavera”, dal quale escono “faville vive”, è “onda / che si deriva” da Dio; ma il fiume, le faville (“li topazi / ch’entrano ed escono”) e il verdeggiante “rider de l’erbe” sono “umbriferi prefazi”, cioè ombra sacramentale “di lor vero”, adombranti il primo una forma circolare e non lineare, le seconde gli angeli, il terzo i beati (Par. XXX, 61ss.). Non è detto, ma è facile deduzione dal confronto con gli elementi semantici che segnano l’esegesi scritturale e i versi, che il fiume di luce, come linearmente appare al poeta che non ha “viste ancor tanto superbe”, designi nelle sue due rive la doppia natura di Cristo, umana e divina, volta verso la terra e il cielo. Ma sono entrambe rive di un unico fiume di “luce intellettüal, piena d’amore” (lo Spirito Santo: Dante ne beve l’acqua con gli occhi), per cui dalla Trinità deriva ai beati, ad essi comunicata, tutta la sostanza della grazia e della gloria.
All’estremo infernale dell’Empireo sta Cocito, nella cui Tolomea si registra uno stare dell’anima (superiore e ‘viva’) e del corpo (inferiore e terreno) distorto rispetto a quello di Cristo centro fra le due rive: ivi infatti i traditori degli ospiti stanno dannati con l’anima ancor prima della morte corporale, essendo il corpo governato da un demonio che lo fa apparire “vivo ancor di sopra” (Inf. XXXIII, 154-157).
Ma l’archetipo figurale del nobilissimo fiume di luce dell’Empireo è il “bel fiumicello” che ‘difende’ il “nobile castello” del Limbo (Inf. IV, 106-108); con gli “spiriti magni” che vi albergano, costituisce il primo nucleo dell’edificio santo che tanto si svilupperà attraverso i sette stati della storia, antica e nuova.
In questa esegesi del fiume di una città immateriale, perché tale è la Gerusalemme celeste, Dante poteva specchiare quanto la sua mente aveva elaborato sulle due beatitudini, poste come fini all’uomo dalla Provvidenza: la beatitudine di questa vita (raffigurata nel paradiso terrestre), alla quale si perviene sotto il regime dell’Imperatore, attraverso la filosofia e la pratica delle virtù morali e intellettuali; la beatitudine della vita eterna (consistente nella visione di Dio), alla quale si perviene tramite le virtù teologali e sotto la guida del romano pontefice (cfr. Monarchia, III, xv, 7-10). Entrambe le beatitudini, come le loro guide, discendono senza intermediari dall’unico Fonte dell’universale autorità (ibid., xv, 15). Corrispondono alle due rive, umana e divina, dell’unico fiume della grazia e della gloria, all’umanità e alla divinità di Cristo. Beatrice, figura di Cristo, è nell’Eden cerniera: gli occhi partecipano sia dell’una come dell’altra, la bocca svelata adombra la visione di Dio.
Nel “poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra” (Par. XXV, 1-2; cfr., ad Ap 10, 5-7, l’angelo che giura che al suono della settima tromba il tempo cesserà), per il quale la Grazia deriva da entrambe le rive dell’unico fiume celeste, l’esegesi di Ap 22, 1-2 torna con insistenza, e in modo insospettabile. Ad esempio, voto religioso e impero sono nel Paradiso trattati rispettivamente nei primi due cieli, entrambi, nelle “sacre bende” (di cui dice Piccarda) o nelle “sacre penne” (di cui parla l’aquila imperiale, il “sacrosanto segno” [cfr. Ap 1, 20; 17, 7] per bocca di Giustiniano), “ombra” sacramentale di verità superiori che discendono dal fiume luminoso dell’Empireo, che ha due rive, una divina e l’altra umana (cfr. Par. III, 114; VI, 7). C’è una ragione precisa del tanto spazio dato alla questione dell’alienabilità dei voti. Alcuni fondamentali attributi del voto evangelico, così come delineati dall’Olivi, appaiono infatti applicabili anche alla Monarchia: la stabilità, l’immutabilità, l’indissolubilità, il divieto assoluto di alienazione. Così lo stato di altissima povertà, a causa dell’immutabilità del voto, produce su chi lo professa gli stessi effetti della giurisdizione del Monarca: il non poter desiderare di più, la rimozione della cupidigia, la carità, la pace [19].
Si direbbe che la stessa poesia derivi la sua linfa da quel fiume di grazia e di gloria (Ap 22, 1-2). Essa, nel descrivere il “regno santo”, è umbratile figurazione di verità superiori; si corona delle lauree foglie del “diletto legno” del “buono Appollo” utilizzando ambedue i gioghi di Parnaso, quello abitato dalle Muse e quello sede di Apollo, come su ambedue le rive, umana e divina, stanno le foglie di Cristo-lignum vite con il loro sacro ombreggiare (Par. I, 16-18, 22-27; cfr. XIII, 19-21).
2. L’Ordine finale
Vengono qui esposte in forma sintetica, con l’ausilio di autorevoli citazioni, le posizioni di Gioacchino da Fiore, Bonaventura e Olivi in relazione all’Ordine che si instaurerà nel terzo status : definizione, rapporto con gli Ordini precedenti, finalità. Seguono i riferimenti all’esegesi olivana contenuti nella Commedia.
Gioacchino da Fiore
● Novus ordo dell’ecclesia contemplativa; Concordia, V 1, c. 14, Patschovsky 3, pp. 569, 2-9, 570, 1-7: “Futurum est enim, ut ordo unus convalescat in terra, similis Joseph et Salomonis … ut compleatur in eo promissio illa psalmi dicentis: Et dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum (Ps 71, 8) … Hic est populus ille sanctus, ordo scilicet iustorum circa finem futurus, de quo in typo Salomonis dictum est … Ego ero illi in patrem et ipse erit michi in filium (2 Reg 7, 14)”; V 2, c. 10, Patschovsky 3, p. 744, 9-12: “Beatus est autem, aut erit, ordo ille, quem dominus diliget super omnes, utpote qui visione pacis fruiturus est et dominaturus a mari usque ad mare …” [1].
● Nel sesto tempo (sesta tromba), i due testimoni di Ap 11, 3-12 – Mosè (ordo dei chierici), Elia (ordo dei monaci) – sono da considerare “come i resti dei due ordines al cospetto dell’Anticristo, così come Mosè e Aronne stettero davanti al Faraone, e Pietro e Giovanni davanti a Nerone” [2].
● “Se la celebrazione dei cistercensi e di Bernardo è alta, resta peraltro il dubbio se saranno loro i protagonisti degli eventi futuri sino alla consumazione finale: Gioacchino accenna infatti alla necessità che ad essi succedano altri, senza chiarire affatto in che rapporto siano questi ultimi con coloro che li precedono. Si intravede dal testo che nell’avvicendarsi dei tempi finali dovranno succedersi monaci dotati di carismi particolari. Coloro che nella sesta tribolazione si opporranno all’undicesimo re saranno predicatori. Quanto ai protagonisti del tempo successivo, saranno interamente dediti alla contemplazione (non a caso la Scrittura loro propria corrisponderà nello spirito al vangelo di Giovanni)” [3].
● Non è chiaro se la domus religionis (Concordia, V, 1 c. 17; Patschovsky 3, pp. 581-586) sia un’istituzione del terzo stato o della fase di passaggio dal secondo al terzo stato: «Come osservava già Grundmann, l’abate aveva in mente non “un ordine monastico con monasteri del tutto identici, bensì un’organizzazione complessiva unitaria di comunità disparate”». La sesta delle sette mansiones spetta ai laici “che, come gli animali della terra nel sesto giorno, possono prendere moglie in vista della procreazione” [4].
Bonaventura
● “L’affermazione fondamentale concernente il nuovo ed ultimo ordine è in Bonaventura la stessa che in Gioacchino: sarà un ordine di ‘contemplatio’. Questa ‘contemplatio’ è però anche un nuovo modo di vedere la Scrittura, destinata a realizzarsi completamente e veramente soltanto ora, così da poter parlare di una rivelazione nuova, generale, consistente in una nuova intelligenza dell’antica Scrittura. […] I tipi principali sono in questo caso Beniamino-Paolo e Giovanni. […]” [5].
Gli Spirituali facevano coincidere l’ordo con i Francescani; Bonaventura lo distingue: l’ordine cherubico (Francescani e Domenicani); l’ordine serafico (Francesco): “[…] il Santo è palesemente dell’opinione che l’ordine escatologico deve essere un ordine di Francesco che in lui venererà e vedrà il suo vero inizio e che lo stesso Francesco appartiene interamente all’ ‘ordo seraphicus’ e non all’ ‘ordo cherubicus’. Ciò significa che l’ordine francescano attuale non è ancora il vero ordine di San Francesco. Nella propria persona Francesco anticipa in definitiva una forma di esistenza escatologica che quale forma di vita universale appartiene ancora al futuro. In questa realistica distinzione tra Francesco e il francescanesimo, che non è dunque solo una scoperta della liberale Forschung su Francesco ma venne invece già formulata dal grande Generale francescano del secolo XIII, non si ha solo la risposta di Bonaventura agli Spirituali; in essa troviamo anche – come Gilson, in altro contesto e con diverso accento, ha già dimostrato – la chiave del comportamento di Bonaventura come Generale ed inoltre dell’atteggiamento di vita suo proprio come francescano. Egli può rifiutare il ‘sine glossa’ – che pure conosce dal testamento di lui come la vera volontà di Francesco – sia per l’esercizio della sua funzione che per la sua personale forma di vita, sapendo che per tutto ciò l’ora storica non è ancora scoccata. Fino a quando durerà il sesto giorno, i tempi non saranno ancora maturi per quella radicalità dell’esistenza cristiana che Francesco, per missione divina, aveva potuto realizzare in anticipo nella sua persona. Senza la coscienza di un’infedeltà nei riguardi del santo fondatore, Bonaventura potè e dovette, di conseguenza, creare per il suo ordine quei limiti istituzionali che sapeva non esser mai stati voluti da Francesco” [6].
Olivi
● Nella LSA introduce il concetto di sviluppo (uomo-pianta): il novus ordo sono i Francescani giunti a maturità.
L’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12) avviene in quattro diversi momenti temporali:
1) un inizio profetico, con Gioacchino da Fiore (e altri a lui contemporanei), al quale fu rivelato in spirito il sesto stato, cioè la terza età: corrisponde al Vangelo di Luca, che inizia dal sacerdozio di Zaccaria, al quale fu rivelato l’avvento di Cristo e del suo precursore Giovanni Battista;
2) un inizio generazionale – “sue generationis et plantationis initium” – con il rinnovamento della regola evangelica fatto da Francesco: corrisponde al Vangelo di Matteo, che inizia dall’umana generazione di Cristo;
3) un inizio di nuova fioritura della pianta dovuta al risvegliarsi dello Spirito di Cristo e di Francesco in alcuni predicatori, nel momento in cui la regola francescana viene impugnata e condannata da Babylon, la Chiesa carnale – “a suscitatione spiritus seu quorundam ad spiritum Christi et Francisci … a predicatione vero spiritualium suscitandorum et a nova Babilone reprobandorum sumet initium refloritionis seu repullulationis”: corrisponde al Vangelo di Marco, che inizia dalla predicazione di Cristo e Giovanni Battista;
4) l’ultimo inzio dalla distruzione di Babylon, allorché non ci sarà più concurrentia fra quinto e sesto stato e questo si distinguerà con chiarezza: corrisponde al Vangelo di Giovanni, che inizia dall’eternità del Verbo e dalla sua eterna generazione.
Olivi, ad Ap 6, 12, spiega perché Francesco, la cui conversione segnò il secondo inizio dell’apertura del sesto sigillo, non sarà con i suoi nel terzo e nel quarto inizio. Assimila i seguaci di Francesco alla persona umana di Cristo: come questa si sviluppò fino all’età virile, così dovrà essere per i primi; l’ordo evangelicus piantato da Francesco avrà bisogno (a differenza di Cristo che stette poco tempo nel mondo) di due o tre generazioni per svilupparsi prima di subire una condanna simile a quella di Cristo.
[LSA, cap. VI, Ap 6, 12 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Secunda ratio est quia persone Christi correspondet in sexta apertione unus ordo plurium personarum sic secundum suam proportionem augendus, sicut Christus secundum suum corpus fuit usque ad perfectam etatem viriliter auctus. […] Quarta est quia, prout super evangelia ostendi, Christus parvo tempore debuit inter nos vivere et pauciori predicare, nec suis discipulis altum spiritum debuit dare usque post eius mortem et resurrectionem, ac per consequens nec ecclesiam suam sollempniter instituere per eosdem, nec ipse per se eguit multo tempore roborari ad sustinendum condempnationem a summis pontificibus Iudeorum et ab omnibus consentientibus eis. Nisi autem ordo evangelicus, per Franciscum renovatus, esset in multis et saltem sub duabus vel tribus generationibus propagatus et sollempnizatus, non esset nec ipse nec populus ab eo ducendus sufficienter dispositus ad tam autenticam condempnationem condempnationi Christi consimilem subeundam. […]
Simile impostazione ispira le rationes date ad Ap 7, 3 per spiegare perché il conflitto fra gli Spirituali e i nuovi Babilonesi debba precedere la distruzione temporale di Babylon.
Olivi fa dunque coincidere il novus ordo con i Minori [7] pervenuti a maturità, rinnovati come piante novelle per opera di alcuni ‘Spirituali’ – “a suscitatione spiritus seu quorundam ad spiritum Christi et Francisci … a predicatione vero spiritualium suscitandorum et a nova Babilone reprobandorum sumet initium refloritionis seu repullulationis” -, cioè di una parte limitata dell’Ordine. Mentre Bonaventura distingue Francesco (l’ordine futuro) dal francescanesimo attuale, escludendo di fatto gli Spirituali dalla storia prossima, Olivi incorpora gli Spirituali nel processo storico dell’Ordine come suscitatori di un vicino rinnovamento (due o tre generazioni, cioè al massimo novant’anni dalla conversione di Francesco). Più che un novus ordo, Olivi pensa a un ordo renovatus.
D’altronde Olivi, fin dalla quaestio de altissima paupertate, aveva applicato il concetto di sviluppo alla Chiesa stessa, assimilata in questo al mondo naturale, rispondendo all’obiezione, che sarebbe stata fatta più volte dai suoi censori, di un possibile declassamento dello “status Apostolorum” rispetto alla pienezza, in vita e in sapienza di Cristo, del sesto stato.
Secondo Bonaventura il novus ordo dovrà pervenire a una corrispondenza con Francesco stimmatizzato attraverso le tribolazioni, come fosse Cristo apparso sofferente nel suo corpo mistico: “Iste ordo non florebit, nisi Christus appareat et patiatur in corpore suo mystico – Et dicebat, quod illa apparitio Seraph beato Francisco, quae fuit expressiva et impressa, ostendebat, quod iste ordo illi respondere debeat, sed tamen pervenire ad hoc per tribulationes. Et in illa apparitione magna mysteria erant”.
Secondo Olivi l’angelo del sesto sigillo (Ap 7, 2) non si identifica solo con Francesco – come inteso da Bonaventura – ma anche con il “cetus discipulorum eius in tertio et quarto initio sexte apertionis futurus et consimiliter ab ortu solis ascensurus”, assistito (come alcuni ritengono) da Francesco risorto nel momento delle maggiori prove, al modo con cui Cristo risorto apparve ai discepoli per istruirli sul futuro governo della Chiesa. L’angelo del sesto sigillo ascende fra due tribolazioni, come spiegato nell’ampia citazione di Gioacchino da Fiore ripresa nell’esegesi oliviana di Ap 7, 2.
● Quale il rapporto del novus ordo con gli altri Ordini? La questione non è chiarita né da Bonaventura né da Olivi.
La possibilità che ci siano diversi offici (predicazione contro i vizi dei cristiani, contemplativi, predicazione agli infedeli) nell’unica professione evangelica è affermata da Olivi in principio del capitolo X, al momento di definire se l’angelo dalla faccia solare (Ap 10, 1) sia da distinguere o meno dall’angelo della sesta tromba (Ap 9, 13):
[LSA, cap. X, Ap 10, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] Sicut enim Petrus, quamquam esset universalis pastor omnium fuit specialiter ab initio deputatus apostolatui circumcisionis, Paulus vero predicationi gentium, prout ipse dicit ad Galatas II° (Gal 2, 7-8); sicut etiam Deus in ecclesia “quosdam dedit apostolos, secundo prophetas, tertio doctores”, prout dicitur Ia ad Corinthios XII° (1 Cor 12, 28), sic et in sexto statu quidam plus predicabunt contra vitia monstrando exterminium Babilonis tamquam de proximo imminens et deinde tamquam iam factum, sic quidam alii plus insistent contemplative sapientie et illuminationi discipulorum contemplativorum ad speciale regimen ecclesie applicandorum et ad predicationem infidelium mittendorum. Primi autem designantur per angelum sexte tube, secundi per angelum istum faciei solaris, tertii per Iohannem accipientem ab eo librum apertum et predicaturum populis et gentibus et mensurantem templum (Ap 10, 8-11; 11, 1ss.), per quam mensurationem designatur specialis gubernatio ecclesie Christi, sicut per tubam et eius tubicinationem designatur exhortatio et incitatio ad prelium contra vitia et errores et contra principes et exercitus vitiis et erroribus plenos.
Ancora, ad Ap 11, 3, trattando dei due testimoni (Elia ed Enoc), non esclude la possibilità che designino più ordini evangelici concorrenti, come già da cent’anni ve ne sono due (con allusione ai Francescani e ai Domenicani).
[LSA, cap. XI, Ap 11, 3 (IIIa visio, VIa tuba)] Nec oportet istos duos ordines testium esse diverse professionis seu religionis, sicut nec Petrus et Iohannes fuerunt, immo uterque fuit eiusdem professionis apostolice et evangelice, nec tamen per hoc nego quin ordines diversarum professionum in hoc concurrant sicut et iam fere per centum annos simul cucurrerunt duo.
I due testimoni vengono da Bonaventura e Olivi identificati con Elia ed Enoch, contrariamente a Gioacchino da Fiore che vi scorgeva Elia e Mosè. Olivi tuttavia non esclude che, “ex misterio ternarii”, oltre a Enoch (lex naturae) e a Elia (lex scripta) ci possa essere un altro testimone (“cetus sanctorum evangelicorum illius temporis, aut aliquis unus ex eis”: lex gratiae).
[LSA, cap. XI, Ap 11, 3] Unde ex misterio ternarii non potest probari quod Moyses sit venturus pro tertio teste, et maxime quia cetus sanctorum evangelicorum illius temporis, aut aliquis unus ex eis, poterit servire de tertio, ut sic sit ibi Enoch de statu legis nature, Helias vero de statu legis mosaice, reliqui vero sint ibi de statu legis gratie.
Dunque l’ordine finale, che pure ha la sua pianta in Francesco e nella sua Regola veramente evangelica, potrà mostrarsi diversamente articolato. Accanto alla preminenza francescana, in Olivi sembra presente quella visione complementare degli ordini che “in uno studii proposito et voto concurrent”, già propria alla metà del secolo del Super Hieremiam [8]. D’altronde lo stesso francescano afferma di aver sentito, novizio nel convento di Béziers, Raimondo Barravi predicare quanto udito a Parigi da san Domenico, il quale constatata personalmente ad Assisi la vita senza possessi dei Minori, ne avrebbe seguito l’esempio per i suoi [9]. Bonaventura aveva scritto di “religiones pauperculae” suscitate dallo Spirito [10].
Il problema è che Ap 10, 1 e 11, 3-12 sono riferiti alla sesta tromba, dunque al sesto stato. Sarà così anche nel settimo e ultimo stato? Questo può valere per Bonaventura, che non sembra distinguere chiaramente la settima età dalla sesta – “Et secundum hoc distinguuntur sex aetates; septima autem currit secundum omnes cum sexta [Collationes in Hexaëmeron, XVI, 2, in Sancti Bonaventurae Sermones Theologici, Roma 1994 (Sancti Bonaventurae Opera, VII/1), p. 290] -, ma non per Olivi, per il quale il settimo stato, sia pur concorrendo a lungo col sesto, ha una propria autonomia, come detto nel notabile I del prologo della LSA: “Septimus autem uno modo inchoat ab interfectione illius Antichristi qui dicet se Deum et messiam Iudeorum, alio vero modo inchoat in initio extremi et generalis iudicii omnium reproborum et electorum”.
● Gioacchino da Fiore e Bonaventura ritengono che l’ordine finale sia formato da contemplativi. Olivi si distingue perché i contemplativi sono anche reggitori. Una doppia corona, regia o pontificale, spetta all’ordine evangelico e contemplativo di quanti, alla fine dei tempi, più si saranno fatti simili a Cristo. Essi sono designati dall’angelo di Ap 14, 14, simile nell’aspetto al Figlio dell’uomo, seduto su una nube bianca con sul capo una corona d’oro e in mano una falce affilata. Questo angelo, secondo Gioacchino da Fiore citato da Olivi, designa un ordine di giusti a cui è dato di imitare Cristo in modo perfetto e che possiede una “lingua erudita” per diffondere il Vangelo del regno di Dio e per raccogliere sulla terra l’ultima messe.
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 14 (IVa visio, VIIum prelium)] “Et vidi et ecce nubem candidam et super nubem sedentem similem Filio hominis, habentem in capite suo coronam auream et in manu sua falcem acutam” (Ap 14, 14). Ioachim dicit: «Arbitramur in isto signari quendam ordinem iustorum, cui datum est perfecte imitari vitam Filii hominis et habere eruditam linguam ad evangelizandum evangelium regni et colligendam in aream Domini ultimam messionem, qui stat super nubem candidam quia conversatio eius non est ponderosa et obscura sed lucida et spiritalis». […] dicitque quod […] intelligendus est aliquis ordo futurus perfectorum virorum servantium vitam Christi et apostolorum […]. Si autem e contra obicias quod angelus in extremo iudicio metens malos et bonos incongrue diceretur “similis Filio hominis” et “habens coronam auream”, quasi rex omnium, ex quo magis videtur quod designet ibi Christum, qui in nube seu nubibus venturus est ad iudicium, prout dicitur supra capitulo I° (cfr. Ap 1, 7), potest dici quod principaliter designat hic evangelicum ordinem sanctorum Christo et eius vite similium et regiam seu pontificalem coronam seu auctoritatem circa finem seculi habiturorum cum potestate et officio colligendi finalem messem electorum. Unde et eorum ordo designatus est supra, capitulo X°, per angelum amictum nube in cuius capite erat iris quasi corona (cfr. Ap 10, 1).
A Giovanni (Ap 11, 1) viene dato il “calamus”, cioè una canna simile a una verga, che designa il potere e la discrezione di reggere la Chiesa. Come con il “calamus” gli architetti sogliono misurare gli edifici e i mercanti i panni, così con esso i rettori della Chiesa posseggono la regolare e giusta misura in base alla quale sanno ciò che debbono governare e ciò che debbono lasciare. Questo “calamus” non assomiglia a una vuota e fragile canna o asticciola, ma piuttosto a una dritta e solida verga. Designa infatti l’autorità nel governare propria dei pontefici e dei maestri, la virtù e la giustizia capace di correggere, drizzare e dirigere rettamente la Chiesa. Secondo Gioacchino da Fiore, il “calamus” designa la “lingua erudita” di cui si dice nel Salmo: “La mia lingua è stilo di scriba” (Ps 44, 2). Come infatti con l’austerità della verga si piegano le bestie indomite, così con la disciplina della lingua vengono corretti i duri cuori degli uomini. Si tratta della stessa “lingua erudita” di cui si fregia l’angelo di Ap 14, 14, che designa l’ordine finale di contemplativi e di governanti.
[LSA, cap. XI, Ap 11, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] “Et datus est michi calamus” (Ap 11, 1). Hic ordini prefato datur potestas et discretio regendi ecclesiam illius temporis. Datio enim potestatis significatur [per] donationem calami, quo artifices domorum solent mensurare edificia sua. Discretio vero regendi sibi dari designatur, tum per regularem ipsius calami rectitudinem et mensuram, tum per hoc quod docetur quos debeat mensurare, id est regere, et quos relinquere. Dicit autem: “Et datus est michi”, supple a Deo, “calamus similis virge”, quasi dicat: non similis vacue et fragili canne seu arundini, sed potius recte et solide virge. Et certe tali communiter mensurantur panni et edificia. Per hanc autem designatur pontificalis vel magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei. Secundum Ioachim, calamus iste signat linguam eruditam, dicente Psalmo (Ps 44, 2): “Lingua mea calamus scribe”, qui est similis virge, quia sicut austeritate virge coarcentur iumenta indomita, ita lingue disciplina dura corda hominum corriguntur.
I futuri reggitori del mondo sono designati dai compagni dell’Agnello che stanno sul monte Sion (Ap 14, 1-5). Il quale è interpretato come “specula”, cioè come luogo di altissima contemplazione; è però anche il luogo più consono per il governo dell’orbe convertito. Ciò avverrà in un futuro prossimo, forse anche prima della morte dell’Anticristo:
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 5 (IVa visio, VIum prelium)] Nota quod cum superius dixit istos cum Christo stare “super montem Sion”, forte ultra sensum ibi tactum voluit insinuare quod post mortem Antichristi, et forte etiam ante mortem, erit sublimissimus cultus Christi ad litteram in monte Sion. Nec mirum si locus nostre redemptionis super omnia loca terre tunc temporis exaltetur, et maxime quia ad conversionem totius orbis et ad gubernationem totius iam conversi ille locus erit congruentior summis rectoribus orbis, tamquam centrale medium terre habitabilis.
La quarta vittoria (Ap 2, 26-28) è conseguita dagli anacoreti, alti per contemplazione come il sole e le stelle, ma anche operosi senza requie a forti cose nella vita attiva. Alla quarta chiesa d’Asia (Tiàtira), che in questo consegue la suprema perfezione dei due ultimi stati, il sesto e il settimo (dunque anche dell’ordine finale), viene detto che quanti vinceranno seguendo e custodendo fino alla fine i precetti e i consigli di Cristo otterranno la virtù, ossia la potestà di reggere le genti in modo retto e inflessibile, spezzandone i vizi quasi con uno scettro di ferro, e la conoscenza, ossia la pienezza della sapienza celeste atta a governare la Chiesa. Si tratta dunque di contemplativi, ma anche di reggitori.
[LSA, cap. II, Ap 2, 26-28 (IVa victoria)] Quarta est victoriosus effectus, quando scilicet omnes vires corporis et mentis assidue et totaliter perfectis virtutum operibus dedicantur, nec ex longa continuatione operis remittuntur sed potius intenduntur et roborantur et ad fortia opera superexcrescunt, qualis fuit in exercitiis perfectorum anachoritarum, quibus competit premium de quo quarte ecclesie dicitur: “Qui vicerit et custodierit usque in finem opera mea”, id est qualia ego feci et precepi vel consului, “dabo illi potestatem super gentes et reg[et] [eas] in virga ferrea, et tamquam vas figuli confri[n]gentur, sicut ego accepi a Patre meo, et dabo illi stellam matutinam” (Ap 2, 26-28).
Secundum quosdam hic promittitur quarto ordini perfectio sexti et septimi status, quia ordo quartus est in fine seculi consumandus et visurus confractionem statue Nabucodonosor et superaturus gentes et regna et Christi cultui subiugaturus. Est etiam accepturus claram intelligentiam scripturarum et future diei eterne quasi stellam matutinam, que gratiose solem pronuntiat et precurrit.
Generaliter tamen hic significatur quod quicumque sunt sic operosi sunt digni super principatum ecclesie sublimari et accipere virtutem rectam et inflexibilem et insuperabilem, quasi virgam ferream ad faciliter confringendum terrestria vitia gentium, et accipere plenitudinem sapientie celestis ad regendum ecclesiam et ad celestia contemplanda. Unde Luche XIX° (Lc 19, 17) illi, qui per unam mnam acquisivit decem mnas, dicit Christus: “Eris potestatem habens super decem civitates”, et iterum infra dicit: “Auferte ab illo”, id est a servo otioso, “mnam et date illi qui habet decem mnas, quia omni habenti dabitur et habundavit” (Lc 19, 24-26). Per mnam autem illius otiosi, secundum sanctos, intelligitur donum scientie. Designatur etiam per hoc quod in a[na]choriticis sic operosis est virtus terrificativa et contritiva gentium terrestrium, et quod per exemplum operis lucent omnibus velut stella matutina, et quod in celis habebunt gloriosam potestatem et lucem huic correspondentem.
● Ad Ap 10, 11 Olivi afferma che Giovanni, al quale viene ingiunto di predicare ancora a tutto il mondo – “Oportet te iterum prophetare in gentibus et populis et linguis et regibus multis” -, designa sia delle “singulares persone” sia un “ordo”, e la distinzione è sottolineata dalla doppia congiunzione (“prout … prout”) e dal fatto che per i singoli è necessaria una rivelazione spirituale della missione ingiunta, mentre per l’ordine basta l’intelligenza del libro. Un terzo testimone accanto a Elia e a Enoch potrebbe essere anche un solo membro del “cetus sanctorum evangelicorum”. Bonaventura sosteneva che la sua comparazione degli ordini secondo maggiore o minore perfezione era stata fatta “secundum status, non secundum personas; quia una persona laica aliquando perfectior est quam religiosa”.
Dante
I due testimoni
Elia ed Enoch sono, nel capitolo undecimo dell’Apocalisse (Ap 11, 3-13), i due testimoni dati per compiere la loro missione di profeti, al termine della quale vengono uccisi in apparenza dalla bestia che sale dall’abisso per resuscitare dopo tre giorni e mezzo ed ascendere al cielo sotto lo sguardo dei nemici, mentre un grande terremoto distrugge un decimo della città, fa perire settemila persone e costringe gli altri a dare gloria a Dio.
Contro Gioacchino da Fiore, che identifica i testimoni con Elia e Mosè, i quali apparvero con Cristo sul monte della trasfigurazione, Olivi si schiera accanto ad Agostino, Gregorio Magno, Riccardo di San Vittore e Bonaventura, secondo i quali i due sono Elia ed Enoch. Di Enoch è scritto, nel Genesi (5, 22-24) e nella Lettera agli Ebrei (11, 5), che venne trasportato via, in modo da non vedere la morte. Di Mosè si sa invece che morì, e non è logico che ora risorga per morire di nuovo per mano della bestia, mentre si può dire che Enoch sia stato riservato per qualche compito solenne per la fede e per la Chiesa, assolto il quale possa poi morire. Accanto a Cristo trasfigurato sul monte apparve, accanto a Elia, Mosè perché i discepoli di Cristo erano nati dalla stirpe di Israele, e dunque a essi era più adatto, in quanto legislatore di somma autorità. Al tempo dell’Anticristo, al momento della conversione di tutto il mondo, accanto a Elia, adatto agli Ebrei perché della stirpe di Israele, nato sotto la legge mosaica, uomo evangelico il cui avvento è stato promesso dai profeti, dovrà comparire Enoch il quale, per essere stato contemporaneo di Adamo primo padre e padre di tutti i popoli nati da Noè dopo il diluvio, e per essere nato sotto la legge naturale, sarà molto più adatto per i Gentili da convertire, oltre che per gli stessi Ebrei. Gioacchino argomenta ancora che tra i segni in potere dei due testimoni ci sono il convertire l’acqua in sangue e il percuotere la terra con ogni sorta di piaga (Ap 11, 5-6), che sono attributi propri di Mosè, ma Olivi ribatte che ciò non toglie possano essere propri anche di Enoch. Gioacchino infine propone in subordine che i testimoni siano in realtà tre – Elia, Mosè e Enoch -, ma Olivi sottolinea che se in altri luoghi scritturali prevale il mistero trinitario, in questo caso, come in molti altri, la lettera conferma trattarsi di un mistero fondato sul numero due.
Elia ed Enoch hanno caratteristiche differenti. Così risulta dalla collazione di Ap 11, 3 (i due testimoni) con Ap 14, 14.17 (i due angeli con la falce, il primo simile al Figlio dell’uomo, l’altro uscente dal tempio che è in cielo). Elia è più dedito al governo e ai patimenti, come san Pietro; Enoch, come san Giovanni, alla contemplazione e alla pace. Il primo è ardente e feroce nello zelo contro i reprobi, il secondo più mite e soave nel raccogliere la messe degli eletti. Uno è occulto eremita che negli arcani del cielo imita la vita degli angeli e, allorché se ne distacca, scuote i cuori con il timore. L’altro rappresenta l’ordine di coloro che imitano la vita di Cristo ed è dato alle genti in modo manifesto per la loro utilità ed erudizione. Uno è fuoco ardente nell’amore e nello zelo divino, l’altro pioggia che riga la superficie terrestre nella perfezione della carità fraterna. Lo sdoppiamento ripete quanto detto a proposito dell’angelo del capitolo decimo, che ha la faccia come il sole. A questi due testimoni Olivi aggiunge comunque un terzo elemento, l’ordine dei santi evangelici, rappresentati da Giovanni che riceve il libro e viene destinato a predicare ai popoli e alle genti e a misurare il tempio, ossia a governare la Chiesa (Ap 10, 11; 11, 1-2). Così Enoch designa la legge naturale, Elia quella mosaica e Giovanni il tempo della grazia.
Come avviene con l’angelo del sesto sigillo e con l’angelo che ha la faccia come il sole, anche nel caso dei due testimoni i temi, nella trasformazione poetica, non vengono concentrati su un unico personaggio, ma variamente diffusi e appropriati. Se Elia, uomo evangelico ardente e feroce nel segare i reprobi vendemmiando, si avvicina al Veltro che caccerà la lupa e la rimetterà nell’inferno, Dante, che assume su di sé il compito di Giovanni e dell’ordine evangelico, di predicare di nuovo ai popoli e alle genti (Ap 10, 11), ha almeno due prerogative proprie di Enoch, l’altro testimone. Come di costui è scritto, nel Genesi (5, 24) e nella Lettera agli Ebrei (11, 5), che venne trasportato via in modo da non vedere la morte, perché riservato ad alto officio alla fine dei tempi, così del poeta dice Virgilio a Catone: “Questi non vide mai l’ultima sera” (Purg. I, 58), essendogli stata riservata un’onorata impresa alla fine dei tempi. Enoch fu contemporaneo di Adamo, e Dante nel cielo delle stelle fisse incontra “l’anima prima / che la prima virtù creasse mai” (Par. XXVI, 80-142).
Dei due testimoni si dice (Ap 11, 3) che «“prophetabunt amicti saccis”, id est vestibus cilicinis vel asperis et pauperculis», a significare l’austerità della vita religiosa. Essi sono (Ap 11, 4) “due olive”, pingui di carità e ripieni dell’unzione divina e di soavità, “et duo candelabra lucentia” spandenti per tutta la Chiesa il lume della sapienza divina che portano in modo alto e preclaro, “in conspectu Domini terre stantes”, cioè assistono sempre Dio sia per la singolare contemplazione che per il servigio di una pronta obbedienza e ossequio. Secondo Gioacchino da Fiore, sia qui come in Zaccaria 4, 14 si dice di costoro che ‘stanno nel cospetto del Signore della terra’ perché sono venuti per questo, e andranno davanti al volto di Cristo per annunziare la venuta di un tempo nel quale è necessario che il Figlio di Dio regni su tutta la terra, cosicché gli uomini siano illuminati come da candelabri luminosi e il cuore degli eletti venga unto dalla grazia e dalla dottrina spirituale come da lampade colme di olio santo. Con il “Signore della terra” può essere anche designato l’Anticristo, che allora dominerà da usurpatore la terra e i terreni, di fronte al quale i due resisteranno con costanza ammonendolo da parte di Dio, come fecero Mosè e Aronne di fronte al Faraone e Pietro e Paolo di fronte a Nerone. Inoltre vengono detti stare nel cospetto del Signore come due candelabri luminosi o due luci stanno davanti a un signore o dinanzi all’altare di Dio uno a destra e l’altro a sinistra, o come due prìncipi e consiglieri che stanno e incedono uno a destra e uno a sinistra al cospetto di un gran re.
Il loro insegnamento sarà così alto e umile da non poter piacere ai carnali, i quali non potranno gustarlo e, conseguentemente, neppure intenderlo. Con la loro dottrina e vita accenderanno gli avversari di invidia e di indignazione, cosicché non potranno apprezzarle e amarle, ma piuttosto disprezzarle e impugnarle. La loro virtù sarà efficace contro gli avversari, in quanto potranno operare segni e prodigi (Ap 11, 5-6).
Olivi osserva (Ap 10, 1) che alcuni (Riccardo di San Vittore) dicono che l’angelo dal volto solare (di cui si tratta nel capitolo X) deve essere Cristo perché solo a lui spetta aprire il libro, come è detto al capitolo quinto (Ap 5, 2-3). Non si nega, afferma il francescano, che sia lui il principale rivelatore del libro, in particolare in quanto è Dio che illumina interiormente le menti; nondimeno ordinò sotto di sé degli spiriti e degli uomini angelici per illuminare, come suoi ministri, gli esseri inferiori. Al modo con cui i sette angeli che suonano la tromba vanno interpretati come gli uomini angelici e i dottori e anche come gli spiriti angelici che presiedono ad essi, sebbene sia Cristo principalmente a insegnare tutte quelle cose significate col suono della tromba, così si deve intendere a proposito dell’angelo con la faccia come il sole.
Il testo di Olivi conduce a Par. XI, 35-36, dove si parla dei due prìncipi – Francesco e Domenico – ordinati dalla Provvidenza a guida della Chiesa. È da notare che se si collaziona il testo del capitolo X (Ap 10, 1) con quello del capitolo XI dove i due testimoni, Enoch ed Elia, sono definiti due candelabri luminosi che stanno al cospetto di Dio, come due prìncipi e consiglieri che stanno e incedono uno a destra e uno a sinistra al cospetto di un gran re (Ap 11, 4), si ritrovano complessivamente, tradotte dal latino in volgare, alcune parole contenute nei versi danteschi. Però il medesimo passo del capitolo X si accosta pure ad Inf. VII, 77-78, dove si dice che la Fortuna è “general ministra e duce” ordinata “a li splendor mondani”.
Se si collaziona ulteriormente con Ap 4, 4 (nella parte proemiale della seconda visione), cioè con il passo relativo ai ventiquattro seniori che circondano la sede divina come prìncipi, dodici da sinistra e dodici da destra, ordinati come muro e come servitori alla difesa della Chiesa, si ottengono altri accostamenti: la difesa della Chiesa da parte dei due campioni nelle parole di san Bonaventura (Par. XII, 106-107), il circuire la vigna proprio di Domenico (ibid., 86-87); l’essere ordinate le virtù cardinali, ninfe nell’Eden, come ancelle a Beatrice, che nel caso rappresenta la Chiesa (Purg. XXXI, 106-108); Iride (tema sia della sede, ad Ap 4, 3, come dell’angelo solare di Ap 10, 1) ancella di Giunone (Par. XII, 10-12); l’apprestarsi (l’ ‘aggirarsi’, come i seniori stanno “in circuitu”) dei diavoli alla difesa entro le mura della Città di Dite (Inf. VIII, 123).
Ventiquattro sono pure gli spiriti sapienti che circondano nel cielo del Sole, con due corone concentriche, Dante e Beatrice. I seniori che circondano la sede divina ad Ap 4, 4 sono, secondo Gioacchino da Fiore, i dodici apostoli per i quali i Gentili entrarono in Cristo e i dodici futuri evangelici per i quali Israele e l’intero orbe si convertiranno a Cristo.
Al passo di Ap 11, 4, relativo ai due testimoni e al loro stare “in cospetto del Signore della terra” (che può essere il Figlio di Dio oppure l’Anticristo), rinvia pure lo stare di Francesco, assetato di martirio, “ne la presenza del Soldan superba” ove “predicò Cristo e li altri che ’l seguiro” (Par. XI, 100-102). Che il Sultano sia inteso come “Dominus terre” si ricava anche dalle parole di Virgilio relative a Semiramìs (“tenne la terra che ’l Soldan corregge”, Inf. V, 60) [11]. I due testimoni “verranno per questo”, cioè per stare in presenza di Cristo “Dominus terre” e per annunciare essere prossimo il tempo in cui il Figlio di Dio regnerà sull’universa terra: il tema entra nella narrazione che Bonaventura fa della vita di Domenico: “Spesse fïate fu tacito e desto / trovato in terra da la sua nutrice, / come dicesse: ‘Io son venuto a questo’” (Par. XII, 76-78).
Da un “panno” strettamente francescano è dunque fatta la “gonna” per più soggetti. All’austerità della vita religiosa dei due testimoni rinviano il “vil ciliccio” che copre gli invidiosi purganti a Purg. XIII, 58, nonché “le rime aspre e chiocce” di Inf. XXXII, 1. Circa l’efficacia della loro virtù, Olivi pone la questione se essi faranno alla lettera segni e miracoli – come il non far piovere in qualche parte del mondo, o il bruciare i nemici con il fuoco che esce dalla bocca, o il percuotere la terra con ogni piaga e peste (Ap 11, 5-6) -, seguendo il modo della vendetta corporale propria dei santi dell’Antico Testamento, o se piuttosto non sia verosimile che essi seguiranno la mansuetudine evangelica tenuta da Cristo e dagli apostoli. La risposta è che essi saranno nel pieno potere di fare segni e miracoli, ma che opereranno solo quanto sarà conveniente e necessario. La questione ricorda la domanda sulla misericordia di Arrigo VII contenuta nella lettera ai Signori d’Italia – “Sed an non miserebitur cuiquam?” -, perché la maestà di Cesare sgorga dal fonte della pietà, anche se Cesare certo non plauderà alle audacie dei malvagi ma perseguiterà i recidivi fino alla loro distruzione come avvenne con Pompeo (Ep. V, 7-10). La compresenza delle parole conduce invece nel poema a un momento di vendetta corporale, cioè a Dante che, passeggiando sul ghiaccio di Cocito tra le teste dei traditori, percuote forte con il piede il volto di Bocca degli Abati, ‘pestandolo’ (deriva, per concordia fonica, dal percuotere con la piaga della ‘peste’) e accrescendo in tal modo la vendetta verso il traditore di Montaperti (Inf. XXXII, 76-81).
Infanzia e maturità dell’Ordine evangelico
Trattando dell’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12), che ha quattro diversi inizi temporali, Olivi pone la questione del perché Francesco, angelo del sesto sigillo, non fu presente personalmente nel terzo (nel momento della nuova predicazione degli Spirituali) e nel quarto inizio (la distruzione di Babylon) della sua apertura, così come Cristo visse con i suoi apostoli nell’inizio della nuova legge al tempo della sua predicazione e crocifissione, corrispondente al terzo inizio. Così anche Pietro e Paolo furono martirizzati al tempo di Nerone e di Simon Mago e in cui la Giudea venne devastata da Vespasiano inviato da Nerone, momento corrispondente al quarto inizio, nel quale la chiesa carnale verrà percossa e appariranno l’undecimo corno della bestia (nella visione di Daniele, 7, 24), nuovo Nerone, e il grande Anticristo da tale corno esaltato come lo fu Simon Mago da Nerone. Dal tempo di Francesco (la cui conversione si colloca nel 1206) al terzo inizio (il momento in cui il suo Ordine consegue la piena maturità) trascorre infatti tutto il tredicesimo secolo.
Delle otto rationes fornite, di particolare interesse è la quarta. Cristo fu nel mondo poco tempo e infuse il suo alto spirito nei discepoli, istituendo la Chiesa, solo dopo la propria morte e resurrezione. Non ebbe bisogno di molto tempo per dotarsi della forza necessaria a sostenere la condanna da parte dei Giudei. L’Ordine evangelico rinnovato da Francesco, e il popolo da esso condotto, non poteva invece essere disposto a subire una condanna simile a quella di Cristo prima di essersi propagato e reso solenne in più generazioni (almeno due o tre) [12].
“Il mondo m’ebbe / giù poco tempo; e se più fosse stato, / molto sarà di mal, che non sarebbe”, inizia a dire Carlo Martello, morto nel 1295 (Par. VIII, 49-51; i versi 58-78 sono una vera e propria messa in poesia dell’esegesi dell’apertura del sesto sigillo). La conformità con Cristo, nella brevità della vita, si palesa ancora nel tema, proprio della chiesa di Filadelfia (Ap 3, 7), dell’essere diletti da Cristo. Come negli attivi anacoreti del quarto stato rifulse l’amore verso Cristo, così nei contemplativi del sesto rifulge il loro essere diletti da Cristo, non diversamente da quel che si dice di Pietro, che amò Cristo, e di Giovanni, che fu prediletto da Cristo. In tal modo prerogativa del sesto è di essere disposto a ricevere e a patire, e in ciò si differenzia dagli stati precedenti, disposti a fare e a dare. È questo tema che travasa nell’amore verso il poeta – “dilectus a Christo”, per quanto fosse stato anch’egli attivo (“Assai m’amasti”) – che l’angioino avrebbe portato fino ai frutti se fosse vissuto più a lungo (ibid., 55-57). Così si può dire di Stazio, il quale ha amato Virgilio, ed è stato poi da questi amato (dopo che Giovenale, arrivato nel Limbo, gli ha reso noto l’affetto: Purg. XXII, 13-18), o di Forese che molto amò la sua Nella, diletta da Dio (Purg. XXIII, 91-93).
Il tema della necessità di un lasso di tempo perché l’Ordine evangelico e il suo popolo siano disposti a ricevere l’alto spirito di Cristo è nelle parole con cui Beatrice nell’Empireo mostra a Dante il gran seggio “de l’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia / verrà in prima ch’ella sia disposta” (Par. XXX, 133-138). Il ‘drizzare’ proviene dall’esegesi di Ap 11, 1, dove il “calamus” simile a una verga, che viene dato a Giovanni per misurare il Tempio, designa l’autorità nel governare propria dei pontefici e dei maestri, la virtù e la giustizia capace di correggere, drizzare e dirigere rettamente la Chiesa di Dio.
Ancora, come si afferma nell’ottava ratio al quesito, negli inizi del rinnovamento della vita evangelica vennero seminati errori spirituali contro di essa, i quali necessitano di tempo per emettere spine perfette e per gettare fuori tutto il veleno. Come Erode uccise i bambini per uccidere Cristo, così nell’infanzia dell’Ordine francescano il nuovo Erode costituito dai dottori carnali condannò lo stato della mendicità evangelica uccidendo molti buoni e teneri concetti. In attesa del secondo Erode, è necessario istruire gli eletti contro gli errori e le insidie, perché queste, nella tentazione ventura, feriscano di meno.
Beatrice, rimproverando Dante nell’Eden per essersi fatto subito attrarre dopo la sua morte dal desiderio di cose terrene “per lo primo strale / de le cose fallaci”, lo tratta come un fanciullo, più ingenuo di un “novo augelletto” che almeno aspetta due o tre colpi prima di diventare esperto dei pericoli: il poeta qui impersona il cammino di tirocinio dell’Ordine francescano che deve avvenire, almeno, in due o tre generazioni (ottava ratio), fino alla perfetta età virile (seconda ratio), che è il momento in cui Dante inizia il viaggio [13]. Così egli sta dinanzi alla donna muto e vergognoso, come un fanciullo nel pentimento, mentre Beatrice, nel chiedergli di alzare la barba, segno di virilità, usa un argomento ‘velenoso’ (Purg. XXXI, 49-75). I temi del “mal seme” e dell’infanzia sono pure presenti nel canto precedente, appropriato l’uno al “buon vigore terrestro” delle doti del poeta, l’altro agli “occhi giovanetti” della donna, diventati dopo la morte men cari e men graditi, come gli avversari della povertà evangelica sentono meno la necessità della rinuncia ai beni mondani (Purg. XXX, 118-123, 127-129). Sarà lo stesso Dante, ormai pienamente maturato, a chiedere a Cacciaguida di prepararlo alle insidie future, “ché saetta previsa vien più lenta” (Par. XVII, 27).
Come l’Italia, non disposta rispetto all’alto Arrigo, per cieca cupidigia si è resa simile “al fantolino / che muor per fame e caccia via la balia” (Par. XXX, 139-141), così Dante, rispetto a Beatrice, non ha aspettato la maturità per affrontare i pericoli e, fanciullo, ha smarrito “la diritta via”. Ma quali erano questi pericoli ai quali allude Beatrice, incontrati allorché “di carne a spirto era salita”? Nei versi essi sono presentati in varie forme: “via non vera” (Purg. XXX, 130), “imagini di ben … false” (ibid., 131), “memorie triste” (Purg. XXXI, 11), “fossi attraversati”, “catene” (ibid., 25), “agevolezze”, “avanzi” (ibid., 28), “le presenti cose / col falso lor piacer” (ibid., 34-35), “cosa mortale” (ibid., 53), “cose fallaci” (ibid., 56), “o pargoletta / o altra novità con sì breve uso” (ibid., 59-60). Questo non essere del tutto disposto, per il troppo riverire la sua donna, è ancora sottolineato da Beatrice a Purg. XXXIII, 19-21.
Da notare, nella sesta ratio ad Ap 6, 12, l’inciso “Christi persona et vita fuit exemplar totius ecclesie future”, da confrontare con la definizione che nella Monarchia (III, xiv, 3) Dante dà della forma della Chiesa, cioè della sua natura: “Forma autem Ecclesie nichil aliud est quam vita Cristi, tam in dictis quam in factis comprehensa: vita enim ipsius ydea fuit et exemplar militantis Ecclesie, presertim pastorum, maxime summi, cuius est pascere agnos et oves”.
Tab. II.1
[LSA, cap. VI, Ap 6, 12 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Hoc igitur commemorato, est adhuc notandum a quo tempore debeat sumi initium huius sexte apertionis. Videtur enim quibusdam quod ab initio ordinis et regule sancti patris prefati;aliis vero quod a sollempni revelatione tertii status generalis continentis sextum et septimum statum ecclesie facta abbati Ioachim, et forte quibusdam aliis sibi contemporaneis;aliis vero quod ab exterminio Babilonis, id est ecclesie carnalis, per decem cornua bestie, id est per decem reges, fiendo (cfr. Ap 17, 12/16);aliis vero quod a suscitatione spiritus seu quorundam ad spiritum Christi et Francisci, tempore quo eius regula est a pluribus nequiter et sophistice impugnanda et condempnanda ab ecclesia carnalium et superborum, sicut Christus condempnatus fuit a sinagoga reproba Iudeorum. Hoc enim oportet preire temporale exterminium Babilonis, sicut Christi et suorum condempnatio a Iudeis preivit temporale exterminium sinagoge.Sciendum autem quattuor sententias predictas sane assumptas non esse sibi contrarias, sed concordes. Sicut enim Luchas inchoat Christi evangelium a sacerdotio Zacharie, cui facta est prophetica revelatio de Christo statim venturo et de Iohanne eius immediato precursore; Mattheus vero ab humana Christi generatione; Marchus vero a Christi et Iohannis predicatione; Iohannes vero a Verbi eternitate et eterna generatione, sic hec sexta apertio sumpsit quoddam prophetale initium a revelatione abbatis et consimilium; a renovatione vero regule evangelice per servum eius Franciscum sumpsit sue generationis et plantationis initium; a predicatione vero spiritualium suscitandorum et a nova Babilone reprobandorum sumet initium refloritionis seu repullulationis; a destructione vero Babilonis sumet initium sue clare distinctionis a quinto statu et sue distincte clarificationis, iuxta quod et dicimus legalia quantum ad obligationem necessariam fuisse mortificata in Christi passione et resurrectione et tandem sepulta et effecta mortifera in evangelii pl[e]na promulgatione et in templi legalis per Titum et Vespasianum destructione.
|
|
Purg. XXXII, 52-60; XXXIII, 142-145Come le nostre piante, quando casca
|
Par. XII, 139-141Rabano è qui, e lucemi dallato
|
Tab. II.2
Tab. II.3
[LSA, cap. VI, Ap 6, 12 (IIa visio, apertio VIi sigilli)][secunda ratio] Secunda ratio est quia persone Christi correspondet in sexta apertione unus ordo plurium personarum sic secundum suam proportionem augendus, sicut Christus secundum suum corpus fuit usque ad perfectam etatem viriliter auctus. […][quarta ratio] Quarta est quia, prout super evangelia ostendi, Christus parvo tempore debuit inter nos vivere et pauciori predicare, nec suis discipulis altum spiritum debuit dare usque post eius mortem et resurrectionem, ac per consequens nec ecclesiam suam sollempniter instituere per eosdem, nec ipse per se eguit multo tempore roborari ad sustinendum condempnationem a summis pontificibus Iudeorum et ab omnibus consentientibus eis. Nisi autem ordo evangelicus, per Franciscum renovatus, esset in multis et saltem sub duabus vel tribus generationibus propagatus et sollempnizatus, non esset nec ipse nec populus ab eo ducendus sufficienter dispositus ad tam autenticam condempnationem condempnationi Christi consimilem subeundam. […][octava ratio] Octava ratio est quia spiritales errores contra regulam evangelicam oportuit prius callide et fortiter seminari et radicari antequam perfectas spinas emittant et priusquam evomant suum totale venenum. Institutio autem ordinis evangelici et regule eius dedit multis occasionem invidie et zeli amari contra ipsam et excogitandi contraria sibi. Unde et sicut primus Herodes necavit infantes ut occideret Christum infantem, sic circa primordialem infantiam huius ordinis regibus mundi devote adorantibus Christi paupertatem in ipso, novus Herodes doctorum carnalium dampnavit statum evangelice mendicitatis. Ex quo multi boni et teneri conceptus in pluribus sunt necati, isteque error varias radices misit et mittet usquequo surgat secundus Herodes, oportuit etiam, ut contra, electos per oppositum zelum et exercitium erudiri contra huiusmodi errorum fundamenta et machinamenta, ut in die temptationis minus feriantur et concutiantur a iaculis iam premissis.[Ap 7, 3 (IIa visio, apertio VIi sigilli; septima ratio)] Septimo quia prius expedit tirones intra suos exerceri et probari, antequam mittantur longe ad universalia bella cum extrinsecis gentibus totius orbis committenda. Unde et istum ordinem Christus servavit in apostolis suis. Nam primo dixit eis: “In viam gentium ne abieritis, sed ite ad oves domus Israel” (Mt 10, 5-6). Dixit etiam: “Sedete in civitate donec induamini virtute ex alto” (Lc 24, 49). |
|
Purg. XXX, 118-126Ma tanto più maligno e più silvestro
|
Par. VIII, 49-51Così fatta, mi disse: “Il mondo m’ebbe
|

Pskov (Federazione Russa) – Monastero Snetogorskij. Scene dall’Apocalisse (sec. XIV)
3. Evangelium aeternum (Ap 14, 6)
Sulla questione dell’evangelium aeternum, Bonaventura afferma chiaramente: “Post novum testamentum non erit aliud, nec aliquod sacramentum novae legis subtrahi potest, quia illud testamentum aeternum est” [1].
Olivi, nell’esegesi di Ap 14, 6 – versetto dove suonano le parole “habentem evangelium eternum” -, non cita Gioacchino da Fiore, i cui scritti avrebbero dovuto sostituire la Scrittura secondo Gerardo da Borgo San Donnino [2]. Vi è solo una citazione di Riccardo di San Vittore. L’angelo, al quale il versetto si riferisce (il primo dei tre ad Ap 14, 6-12), designa i predicatori degli ultimi tempi (“nove legis”, dunque del Nuovo Testamento), la cui dottrina concernente il disprezzo del mondo, l’altissima povertà e la vita eterna, non è caduca ma, appunto, eterna.
La scritta sulla porta dell’inferno mostra temi provenienti dall’esegesi del primo dei tre angeli di Ap 14, 6-12. La prima “ratio motiva”, che cioè muove, il primo angelo (Ap 14, 6-7), è il timore della “potestativa deitas”; la seconda è la vicinanza del giudizio; la terza il riconoscere a Dio la creazione di tutte le cose; la predicazione di questo angelo è inoltre eterna e riguarda cose eterne. Sono motivi scritti sulla porta: “Giustizia mosse il mio alto fattore; / fecemi la divina podestate / … Dinanzi a me non fuor cose create / se non etterne, e io etterno duro” (Inf. III, 4-5, 7-8). Si rileva la corrispondenza, con in entrambi i casi la presenza avverbiale, tra “e io etterno duro” e “sempiternaliter … perdurat” ad Ap 19, 3 (cfr. Par. XV, 11-12).
All’esegesi dell’angelo rinviano le parole dell’aquila a Par. XIX, 40-42 (Dio creatore di tutte le cose), 106-108 (la prossimità del giudizio, variata come propinquità nel giudizio) nonché la prima alta e volante voce che esorta all’amore nel girone degli invidiosi purganti: «“volantem per medium celi” … “habentem evangelium eternum” … quia altius et ferventius predicabunt mundi contemptum et paupertatem altissimam et eternam vitam … non predicabit tepide vel remisse aut inefficaciter, immo modis omnino contrariis et supremis, unde subdit: “dicentem magna voce” …│ La prima voce che passò volando / ‘Vinum non habent’ altamente disse, / e dietro a noi l’andò reïterando» (Purg. XIII, 28-30).
Tab.III.1
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 6-7 (IVa visio, VIum prelium)] “Et vidi alterum angelum” (Ap 14, 6). Hic subditur trina predicatio trini ordinis doctorum, per tres angelos designatorum non solum propter misterium Trinitatis sed etiam propter tria ad mundum convertendum vel plenius elevandum in Deum valde utilia.
|
|
Inf. III, 4-8Giustizia mosse il mio alto fattore;
|
Purg. XIII, 28-30La prima voce che passò volando
|
L’esegesi di Ap 14, 6 può essere collazionata con quella dei versetti che precedono.
La quarta delle sette prerogative attribuite ai compagni dell’Agnello che stanno sul monte Sion è la magnificenza del cantico di giubilo, la cui voce o suono ha a sua volta sette proprietà (Ap 14, 2) [3].
Il primo modo della voce è lì dove dice: “Poi udii una voce dal cielo” (Ap 14, 2), con il che intende che la voce, ovvero il risuonare del canto, era in eccesso sublime e celeste.
Il secondo modo sta nell’essere questa voce irrigua e feconda e procedente in modo concorde e unito da più affetti virtuali di un grande e numeroso collegio di santi, lì dove dice: “come la voce di molte acque”. La voce di una grande e abbondante pioggia procede infatti da molte e quasi innumerevoli gocce come un solo suono proveniente da un solo suonatore, e lo stesso si può dire del suono delle acque del mare o di un fiume. Suona come irrigando di lacrime che impinguano, lavano e rinfrescano e con sospiri che ruggiscono.
Il terzo modo consiste nell’essere la voce altissima, acutissima, possente al massimo nel suo pervadere e scuotere tutto, per cui soggiunge: “e come la voce di un grande tuono”.
Il tema della “vox aquarum multarum”, che nello stesso tempo è “unus sonus” (secondo modo), è appropriato nel cielo di Giove alla bella immagine dell’aquila, che Dante vede e anche sente parlare (citazione da Ap 8, 13: «“Et vidi et audivi vocem unius aquile volantis per medium celi”. Vidit quidem ipsam aquilam et audivit vocem ipsius.│ch’io vidi e anche udi’ parlar lo rostro»), la quale suona nella voce al singolare («e sonar ne la voce e “io” e “mio”») pur essendo formata da molti amori e dunque al plurale nel pensiero (“quand’ era nel concetto e ‘noi’ e ‘nostro’ ”), come un solo calore si fa sentire da molti carboni ardenti, come un unico profumo da molti fiori (Par. XIX, 10-12; 19-24). Il tema è ripreso all’inizio del canto successivo, allorché l’aquila tace e gli spiriti di cui è contesta iniziano a cantare, come il cielo, che di giorno solo del sole si accende, dopo il tramonto torna ad essere visibile per le molte luci delle stelle, nelle quali una sola luce, quella del sole, risplende (Par. XX, 1-12). Poi, cessati gli angelici squilli degli spiriti, è di nuovo l’aquila a parlare con voce che si forma nella gola ed esce “per lo suo becco in forma di parole, / quali aspettava il core ov’ io le scrissi” (ibid., 28-30): scrivere nel cuore il “nome” di Dio trino e uno e del Figlio incarnato è la terza prerogativa dei compagni dell’Agnello, di cui ad Ap 14, 1.
Questa voce una, che procede concordemente da molte voci (“ex magno et multo collegio sanctorum et plurium virtualium affectuum ipsorum procedens et concorditer unita”), formata da più individui che al tempo stesso trascende in quanto una, è un concetto teologico che veste l’immagine dell’aquila. Ma il procedere dell’aquila, uno e molteplice, ha un risvolto filosofico in quell’operazione propria dell’intera umanità alla quale i singoli, presi per sé, non possono pervenire, sulla quale Dante stava nel frattempo fondando la Monarchia: “Est ergo aliqua propria operatio humane universitatis, ad quam ipsa universitas hominum in tanta multitudine ordinatur; ad quam quidem operationem nec homo unus, nec domus una, nec una vicinia, nec una civitas, nec regnum particulare pertingere potest” (I, iii, 4). Questa moltitudine attua la più alta potenza dell’umanità, cioè la facoltà intellettiva e su ciò, afferma Dante, concorda Averroè nel commento al De anima di Aristotele (ibid., I, iii, 7-9). È questo esempio di come il rapporto fra la Commedia e la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi sia volto alla ricerca di quella universale e superiore concordia in terra fra opposte fazioni cittadine, fra posizioni speculative o teologiche avverse, fra impero e papato sottolineata da Grundmann.
Cantano insieme “ad una voce” il salmo “In exitu Isräel de Aegypto” (Ps 113, 1) le più di cento anime che siedono nella navicella che le porta dalla foce del Tevere alla riva dell’isola del Purgatorio, guidata dal “celestial nocchiero, / tal che parea beato per iscripto” (Purg. II, 43-48; il tema della “patens inscriptio et expressio”, da Ap 14, 1, rende preferibile questa lezione a quella del Petrocchi “tal che faria beato pur descripto”).
Il “nome”, con il quale “famosa notitia designatur, que respectu Dei non reputatur nisi sit amativa”, che ad Ap 14, 1 viene scritto nel cuore o sulla fronte, ed è espresso con le parole e con le opere, coincide con la “signatio” sulla fronte di quanti (nello stesso numero, 144.000, dei compagni dell’Agnello sul monte Sion) all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3-4) vengono assunti alla professione della perfezione evangelica, di una più alta milizia cristiana; il segno comporta una loro maggiore configurazione e trasformazione nella passione di Cristo. Le anime giunte alla spiaggia del Purgatorio sono ‘segnate’ dall’angelo nocchiero (“Poi fece il segno lor di santa croce”, Purg. II, 49), si volgono verso Dante e Virgilio alzando la fronte (ibid., 58). Sono ben finiti, già spiriti eletti, dunque amici di Dio.
Ma c’è il caso di chi a Dio non è amico. “Frons vero est suprema pars faciei omnibus patula, et ideo quod est scriptum in fronte omnibus se prima facie offert, ita quod potest statim ab omnibus legi. In fronte etiam signa audacie vel sui oppositi cognoscuntur”. I motivi offerti dall’esegesi si ritrovano, scomposti e diversamente appropriati, nell’opposto atteggiarsi di Farinata (“ed el s’ergea col petto e con la fronte”) e di Cavalcante, che si rivolge a Dante piangendo per poi alla risposta ricadere supino nell’avello, in modo disperato. Anche per costui interviene in parte il tema dell’iscrizione sulla fronte, nel momento in cui, per “le sue parole e ’l modo de la pena”, il poeta riesce subito a ‘leggerne il nome’ senza che questi gli si palesi (Inf. X, 35, 64-65).
Il tema della voce una e molteplice risuona nel Limbo, dove la voce che onora l’altissimo poeta Virgilio onora tutti gli altri che hanno in comune il nome di poeta (Inf. IV, 91-93). Nella “bella scola”, formata da più poeti, uno parla a nome di tutti come avviene con l’aquila del cielo di Giove, e la voce è quella di Omero, “di quel segnor de l’altissimo canto / che sovra li altri com’ aquila vola” (ibid., 94-96; cfr. Ap 8, 13): il terzo modo della voce cantante è appunto di essere altissima, come quella di un tuono (cfr., a Par. XXI, 140-142, il grido con cui gli spiriti contemplanti confermano l’invettiva di Pier Damiani contro i prelati). Il “nome”, che designa l’esser noti per fama, è motivo che appartiene alla terza prerogativa dei santi che stanno con Cristo sul monte Sion, interpretato come “specula” in quanto designa lo stato dei contemplativi (Ap 14, 1).
Nella lettera dei versi si registrano anche signacula che inviano la mente ad Ap 14, 6-7, i versetti dell’evangelo eterno:
Secundo in omnibus operationibus et intentionibus nostris eius honorem et gloriam prosequi et intendere, unde subdit: “et date illi honorem”. […] Angelum autem hec predicantem eiusque predicationem magnificat quoad quattuor. Primo scilicet quantum ad eminentiam seu volatum celestis conversationis et contemplationis, cum ait: “volantem per medium celi”. Secundo quia eius doctrina non est terrena nec de temporalibus et caducis, sed potius eterna et de eternis, cum ait: “habentem evangelium eternum”. Licet enim omnium sanctorum nove legis sit talis, istorum tamen erit magis anthonomasice talis, quia altius et ferventius predicabunt mundi contemptum et paupertatem altissimam et eternam vitam. Tertio quia eius predicatio non est ad solam unam gentem sed ad omnem et in totum orbem, unde subdit: “ut evangelizaret sedentibus super terram et super omnem gentem et tribum et linguam et populum”. Quarto quia non predicabit tepide vel remisse aut inefficaciter, immo modis omnino contrariis et supremis, unde subdit: “dicentem magna voce”.
Inf. IV, 76-81, 91-96: “L’onrata nominanza … Onorate l’altissimo poeta … fannomi onore, e di ciò fanno bene. / Così vid’ i’ adunar la bella scola / di quel segnor de l’altissimo canto / che sovra li altri com’ aquila vola.
Del particolare significato, connesso alla contemplazione, contenuto nell’esser “sospesi” si è detto altrove.
Tab. III.2
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 1-2.6-7 (IVa visio)] Tertium est fidei et amoris et contemplationis Dei Patris et Filii humanati in istorum corde et ore singularis et patens inscriptio et expressio, unde subditur: “habentes nomen eius et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis” (Ap 14, 1). Per “nomen” famosa notitia designatur, que respectu Dei non reputatur nisi sit amativa. Frons vero est suprema pars faciei omnibus patula, et ideo quod est scriptum in fronte omnibus se prima facie offert, ita quod potest statim ab omnibus legi. In fronte etiam signa audacie vel sui oppositi cognoscuntur. Est ergo sensus quod maiestas Dei trini et Filii humanati sic erat in cordibus istorum impressa et sic per apertam et constantem confessionem oris et operis expressa, quod ab omnibus poterat statim legi et discerni quod ipsi erant de familia Agni et singulares socii eius.
|
|
Purg. II, 43-48Da poppa stava il celestial nocchiero,
|
Par. XIX, 10-12, 19-25; XX, 1-6, 28-30ch’io vidi e anche udi’ parlar lo rostro,
|
Ad Ap 2, 7 Olivi spiega perché l’istruzione data al vescovo di Efeso, il metropolita delle sette chiese d’Asia, venga proposta come detta dapprima da Cristo e per ultimo dallo Spirito Santo. Ciò avviene per quattro motivi. Il primo è affinché essa sia intesa provenire da tutta la Trinità.
Il secondo è perché due sono i modi di questo insegnamento, uno per mezzo della voce esteriore, l’altro tramite l’ispirazione e la suggestione interiore: il primo spetta a Cristo in quanto uomo, il secondo alla sua divinità ed è appropriato allo Spirito Santo. Il primo modo predispone al secondo come al suo fine ed è inutile senza di esso. Di questi due modi parla Cristo in Giovanni 14, 25-26: “Queste cose vi ho detto rimanendo tra di voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi suggerirà tutto ciò che io vi ho detto”. A Cristo, in quanto Verbo e verbale sapienza del Padre, è appropriato anche il parlare interiore che avviene per mezzo della luce della semplice intelligenza. Il parlare che avviene tramite il gusto e il sentimento dell’amore è appropriato allo Spirito Santo. Il primo modo si pone rispetto al secondo come la disposizione materiale rispetto all’ultima forma.
Il terzo motivo, infatti, è perché il tempo da Cristo fino al sesto stato è appropriato a Cristo, a partire dal sesto stato è appropriato allo Spirito Santo.
Il quarto motivo è perché a muoverci sia una duplice autorità magistrale e una duplice solenne testimonianza: dapprima l’evidente esempio delle opere di Cristo mostrate nella sua umanità, poi la fiamma e l’efficacia dello Spirito.
Questa duplice autorità si ritrova in Inf. II, 94ss., nell’episodio delle “tre donne benedette” che curano del poeta nella corte del cielo. Nell’Empireo una “donna … gentil”, cioè la Vergine la quale, come detto nella quarta visione, partorisce di continuo il corpo mistico di Cristo (Ap 12, 2) e dunque “si compiange / di questo ’mpedimento”, cioè dell’ostacolo che impedisce il parto della buona prole (la salita del “dilettoso monte” impedita dalla lupa), ha chiamato Lucia, cioè la “lux simplicis intelligentie”, perché presti aiuto al poeta, suo devoto. Lucia, mossasi, si è recata da Beatrice, che siede “con l’antica Rachele” (la vita contemplativa), come l’ “interna locutio que fit per lucem simplicis intelligentie” predispone al suo fine e alla sua ultima forma, cioè al gusto e al sentimento dell’amore, che avviene per mezzo della fiamma e dell’efficacia dello Spirito Santo. Mossa da amore, Beatrice discende veloce all’ “uscio d’i morti”, cioè al Limbo, per muovere Virgilio.
Dante è mosso da due maestri. Virgilio, da una parte, è “voce esteriore”, assimilato a Cristo uomo; partecipa tuttavia anche del secondo tipo di insegnamento, quello che avviene per ispirazione e suggestione interiore, in quanto “lux simplicis intelligentie”: “Quanto ragion qui vede, / dir ti poss’io” (Purg. XVIII, 46-47). Lucia, che di questa luce è la più alta figura (designa Cristo “in quantum est Verbum et verbalis sapientia Patris”), agevola la salita del poeta dormiente dalla valletta dei principi alla porta del Purgatorio e mostra a Virgilio l’ “intrata aperta” verso di essa (Purg. IX, 52-63). Con la porta comincia il sesto stato dell’Olivi (contraddistinto, appunto, dalla ‘porta aperta’) ovvero l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Beatrice rappresenta il gusto e il sentimento dell’amore, appropriato allo Spirito Santo. Mossa da amore, fa muovere Virgilio alla salvezza del suo amico: “Or movi, e con la tua parola ornata … l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata … amor mi mosse, che mi fa parlare” (Inf. II, 67-72). Virgilio e Beatrice operano entrambi per mezzo della “locutio”, cioè della favella, il primo con la “parola ornata”, la seconda con il parlare dettato da amore che suggerisce all’altro ciò che debba fare in modo da esserne consolata (lo Spirito Santo è Paraclito, cioè ‘consolatore’) [4].
Ad Ap 21, 22-23 (settima visione) Olivi sostiene che nella Chiesa peregrinante del settimo e ultimo stato non ci sarà più bisogno di molte dottrine precedenti, poiché nell’eccesso della contemplazione lo Spirito di Cristo le insegnerà ogni verità senza l’ausilio della voce esteriore e, denudata di quanto è temporale, adorerà Dio Padre in spirito e verità (cfr. Giovanni 4, 24), anche se non verrà completamente abbandonato, come nella Chiesa trionfante, ogni uso delle cose temporali o dell’esteriore dottrina e scrittura. La Chiesa di Cristo non occupa il luogo arto e corporeo del tempio dell’antica Gerusalemme e della Sinagoga, né ha bisogno della luce cerimoniale e del culto della legge e dei profeti, in quanto Cristo, la sua vita e la sua dottrina sono tempio, sole e lucerna della luce solare della sua divinità. Si tratta, come confermato dall’autorità di Gregorio Magno, di maggiore illuminazione data alla fine dei tempi: “Urgente enim mundi fine superna scientia proficit et largius cum tempore excrescit”. Il sesto e il settimo stato dell’Olivi corrispondono all’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore, nella quale “non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris” (Ap 3, 7; pagina pregna di citazioni occulte da Gioacchino).
Ecco che la “voce esteriore” di Virgilio, all’apparire di Beatrice, sparisce (Purg. XXX, 49-51). Lo stesso poeta pagano, sulla soglia dell’Eden, invita il discepolo a prendere per guida il proprio piacere (“non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia”), cioè il proprio gusto interiore, perché “fuor se’ de l’erte vie, fuor se’ de l’arte. / Vedi lo sol che ’n fronte ti riluce …” (Purg. XXVII, 131-133).
A Filadelfia, la sesta delle sette chiese d’Asia, Cristo dice: “Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere” (Ap 3, 8). Bonaventura aveva detto in proposito che l’intelligenza della Scrittura era stata finora data a un singolo o a più persone: “Et dixit, quod adhuc intelligentia Scripturae daretur vel revelatio vel clavis David personae vel multitudini; et magis credo, quod multitudini” [5].
Per Olivi si tratta di apertura interiore, allorché il predicatore sente nell’animo l’ordine dato da Cristo, interno dettatore, alla propria volontà di dire perché si parli di lui aprendo il cuore delle genti. Qualcosa di simile dovette provare il giovane Dante, il quale volendo lodare la sua gentilissima, restò “alquanti dì, con disiderio di dire e con paura di cominciare”, finché un giorno gli “giunse tanta volontà di dire” che la sua lingua “parlò quasi come per sé stessa mossa e disse: ‘Donne ch’avete intellecto d’amore’” (Vita Nova, 10. 11-13). Nel 1290, l’anno dopo la partenza dell’Olivi da Firenze, moriva Beatrice; attorno a quella data uscivano le “nove rime”. Con la teologia di Cristo interno dettatore si accompagnava la poetica dello spirare d’Amore: “I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro vo significando” (Purg. XXIV, 52-54).
Anni dopo, nell’esilio, uno dei passi capitali della LSA, quello che riguarda l’ingiunzione dell’angelo a Giovanni di inviscerare il libro prima amaro e poi dolce e di predicare ancora a tutto il mondo dopo gli Apostoli (Ap 10, 8-11), dovette dare a Dante la consapevolezza della propria missione nello scrivere una vera visione e la libertà di usare parole gravi anche nei confronti dei papi. Al passo rinvia il momento in cui Dante ascolta da Cacciaguida il suo futuro destino e le vicende dolorose dell’esilio, e gusta insieme l’amaro del suo futuro patire con il dolce della fama che gli è riservata. Questo essere dolce e amaro non è solo nel gusto di Dante che ascolta le parole dell’avo, ma pure negli effetti del libro, molesto nel primo gusto ma poi salutare. Come ai nuovi predicatori del sesto stato viene confermato dai sacri dottori il loro essere destinati alla predicazione universale in modo che non temano di venirne impediti dalla moltitudine dei nemici, così Cacciaguida invita Dante a non essere “al vero … timido amico” e a manifestare senza timore tutta la sua visione, nonostante i molti che si troveranno ad avere “coscïenza fusca / o de la propria o de l’altrui vergogna” (Par. XVII, 124-142). Singularis persona, corifeo del nuovo Ordine, Dante proverà nel salire al cielo una “gustativa et palpativa experientia” (proprio negli anni nei quali il concetto suscitava l’interesse inquisitorio di Giovanni XXII) – trasumanar – quale fu quella del pescatore Glauco “nel gustar de l’erba / che ’l fé consorto in mar de li altri dèi” (Par. I, 67-72).
Tab. III.3
[LSA, cap. II, Ap 2, 7 (Ia visio, Ia ecclesia)] Quadruplici enim ex causa hec informatio primo proponitur ut a Christo dicta et ultimo ut dicta a Sancto Spiritu.
|
|
Purg. XIV, 10-15e disse l’uno: “O anima che fitta
|
Purg. XXVII, 121-142Tanto voler sopra voler mi venne
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 7 (Ia visio, VIa ecclesia)] Significatur etiam per hoc proprium donum et singularis proprietas tertii status mundi sub sexto statu ecclesie inchoandi et Spiritui Sancto per quandam anthonomasiam appropriati. Sicut enim in primo statu seculi ante Christum studium fuit patribus enarrare magna opera Domini inchoata ab origine mundi, in secundo vero statu a Christo usque ad tertium statum cura fuit filiis querere sapientiam misticam rerum et misteria occulta a generationibus seculorum, sic in tertio nichil restat nisi ut psallamus et iubilemus Deo, laudantes eius opera magna et eius multiformem sapientiam et bonitatem in suis operibus et scripturarum sermonibus clare manifestatam*. Sicut etiam in primo tempore exhibuit se Deus Pater ut terribilem et metuendum, unde tunc claruit eius timor, sic in secundo exhibuit se Deus Filius ut magistrum et reseratorem et ut Verbum expressivum sapientie sui Patris, sic in tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum et ut tripudium spiritualium iubilationum et iocunditatum, per que non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris. Christus enim promisit quod “cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem” et “ille me clarificabit” et cetera (Jo 16, 13-14).* Cfr. Expositio, pars I, ff. 85va-b (ad Ap 3, 7, cit. quasi letterale da Sicut enim a laudantes), 87rb. |
|
________________________________________________________________________________________________________________
INTRODUZIONE
[1] Cfr. G. MONOD, La vie et la pensée de Jules Michelet, Paris 1923, II, p. 156.
[2] A. FRUGONI, Gioachino (Giovacchino) da Fiore, in Enciclopedia Dantesca, III, Roma 19842 (Istituto della Enciclopedia Italiana), pp. 165-167: p. 167.
[3] L. TONDELLI, Il Libro delle Figure dell’abate Gioacchino da Fiore, I. Introduzione e commento. Le sue rivelazioni dantesche, Torino 19532 (19391), pp. 217-399.
[4] R. MANSELLI, Dante e l’ “Ecclesia Spiritualis”, in Dante e Roma. Atti del Convegno di studio a cura della “Casa di Dante”, sotto gli auspici del Comune di Roma, in collaborazione con l’Istituto di Studi Romani, Roma 8-9-10 aprile 1965, Firenze 1965, pp. 115-135, ripubblicato in ID., Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo. Studi sul francescanesimo spirituale, sull’ecclesiologia e sull’escatologisno bassomedievali, introduzione e cura di P. Vian, Roma 1997 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici, 36), pp. 55-78.
[5] A. DEMPF, Sacrum Imperium. Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen Renaissance, Darmstadt 1954 (München-Berlin 1929), p. 293: “[…] und er (Olivi) schrieb 1295 seine Postille zur Apokalypse, die Parallele zur Johannesapokalypse, vielleicht in dem ganz tiefen Sinn, daß auch diese ein visionärer Kommentar zu prophetischen und apokryphen Weltendschriften gewesen ist. […] Und kurz danach schrieb der größte Dichter an der Wende der beiden Äonen, Dante, seine divina commedia, auch sie eine joachitische Apokalypse. Nur sollte bei ihm nach dem Renaissancekopf seines Janushauptes halb ein philosophischer Weltkaiser und halb der spiritualistische Dux die neue Friedenszeit bringen”.
[6] H. GRUNDMANN, Dante und Joachim von Fiore. Zu Paradiso X-XII, in “Deutsches Dante-Jahrbuch”, 14 (NF 5) 1932, pp. 210-256, ripubblicato in ID., Ausgewählte Aufsätze, 2. Joachim von Fiore, Stuttgart 1977 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica. Band 25, 2), pp. 166-210.
[7] E. BENZ, Ecclesia Spiritualis. Kirchenidee und Geschichtstheologie der Franziskanischen Reformation, Stuttgart 1934, pp. 201-205: p. 203: “Das Leben des Heiligen Franziskus selbst, von Thomas von Aquin besungen, zeigt bereits das ins Messianische erhobene endzeitliche Franzbild des Spiritualenkreises, wie es sich in der Apokalypsenpostille Olivis findet und wie es Dante aus dem Munde Olivis selbst dem Sinne nach gehört haben mochte”.
[8] E. BUONAIUTI, Storia del Cristianesimo, II, Milano 1941, p. 544. Il cap. XVIII della parte II (Evo Medio) dell’opera è rielaborazione del cap. V (L’Apocalissi dantesca) di Dante come profeta, Modena 1936, pp. 113-163, dove (p. 151) scriveva in modo meno assertorio: “Forse egli aveva udito colà [nella scuola francescana della vecchia Santa Croce] Pietro Olivi interpretare gioachimiticamente proprio l’Apocalissi canonica. Ad ogni modo, conosceva molto bene i testi canonici ed apocrifi della tradizione profetica, sbocciata sulla Sila e propagatasi lungo la dorsale appenninica d’Italia, all’alba del Duecento”. Buonaiuti, al quale negli anni ’30 gli studi su Gioacchino da Fiore presso l’Istituto Storico Italiano erano stati di provvidenziale conforto dopo l’allontanamento dalla cattedra romana, avrebbe scritto che “mai e poi mai avremmo dovuto dissociare le due grandi figure che Dante, e con lui la migliore tradizione religiosa del suo tempo, hanno visto indissolubilmente avvinte l’una all’altra: la figura di Gioacchino e quella di Francesco. La catena appenninica non è soltanto fisicamente la spina dorsale della penisola. Dalla Sila al Subasio è corsa, nella maturità del Medioevo italiano, una stupenda continuità spirituale. Avervi inciso una frattura è stato gesto di improvvida iconoclastia” (E. BUONAIUTI, Pellegrino di Roma. La generazione dell’esodo, a cura di M. Niccoli, introduzione di A. C. Jemolo, Bari 1964 [Biblioteca di cultura moderna, 604], p. 256).
[9] M. BARBI, Il Gioachinismo francescano e il Veltro, in “Studi danteschi”, 18 (1934), pp. 209-211; L’Apocalissi dantesca, ibid., 22 (1938), pp. 195-197; Veltro, Gioachinismo e Fedeli d’Amore: sbandamenti e aberrazioni, ibid., 23 (1938), pp. 29-46.
[10] B. NARDI, Dante e la cultura medievale. Nuovi saggi di filosofia dantesca, Bari 1942 (Biblioteca di cultura moderna), pp. 270-271.
[11] B. NARDI, Pretese fonti della «Divina Commedia», in “Nuova Antologia”, 90 (1955), pp. 383-398, ripubblicato in ID., Dal “Convivio” alla “Commedia”. Sei saggi danteschi, Roma 1960 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi storici, 35-39), pp. 351-370: pp. 364-365.
[12] M. REEVES, The Third Age: Dante’s Debt to Gioacchino da Fiore, in L’età dello Spirito e la fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel gioachimismo medievale. Atti del II Congresso internazionale di studi gioachimiti 6-9 set. 1984, a cura di A. Crocco, San Giovanni in Fiore 1986 (Centro internazionale di studi gioachimiti), pp. 125-139.
[13] Cfr. P. VIAN, Tempo escatologico e tempo della Chiesa: Pietro di Giovanni Olivi e i suoi censori, in Sentimento del tempo e periodizzazione della storia nel Medioevo. Atti del XXXVI convegno storico internazionale, Todi, 10-12 ottobre 1999, Spoleto 2000 (Atti dei Convegni del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo-Accademia Tudertina e del Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale dell’Università degli Studi di Perugia, n.s., 13), pp. 137-183: p. 183: “[…] con la sua concezione del tempo e della storia, appare come l’estrema espressione dell’escatologismo medievale […]”.
[14] G. INGLESE, in Dante Alighieri, Inferno. Revisione del testo e commento, Roma 2007, p. 9.
[15] G. BRUGNOLI, Tracce di Pierre de Jean Olieu nella Divina Commedia, in San Francesco e il francescanesimo nella letteratura italiana dal XIII al XV secolo. Atti del Convegno Nazionale (Assisi, 10-12 dicembre 1999), a cura di Stanislao da Campagnola e P. Tuscano, Assisi 2001 (Accademia Properziana del Subasio. Assisi), pp. 139-168.
[16] Al di là dell’assoluta novità e complessità della ricerca, che traccia sentieri sulla nuova terra ma è comunque sgomentante per chi intenda accingersi a una verifica o a una sua continuazione, i silenzi accademici nascono soprattutto da un problema di ambiti di competenza. I “dantisti” non conoscono se non superficialmente la Lectura dell’Olivi e non considerano, salvo rarissimi casi, l’arte della memoria: non sono dunque in grado di confermare o confutare alcunché. Viceversa, nel campo degli studi storici l’Olivi è confinato nell’ambito francescano, mentre Dante è appannaggio della storia della letteratura. Non ha certo giovato il fatto che la Lectura sia rimasta inedita per settecento anni e conosciuta soltanto per estratti, né giova alla sua conoscenza la recente “edizione critica” di Warren Lewis (cfr. Avvertenze).
[17] NARDI, Dal “Convivio” alla “Commedia” (nota 11), p. 356.
[18] Cfr., ad esempio, S. CRISTALDI, Dante di fronte al gioachimismo. I. Dalla «Vita Nova» alla «Monarchia», Caltanissetta-Roma 2000.
[19] Cfr., ad esempio, N. HAVELY, Dante and the Franciscans. Poverty and the Papacy in the ‘Commedia’, Cambridge University Press, 2004; S. CASCIANI (ed.), Dante and the Franciscans, Leiden-Boston 2006 (The Medieval Franciscans, 3).
[20] Cfr. P. VIAN, «Noster familiaris solicitus et discretus»: Napoleone Orsini e Ubertino da Casale, in Ubertino da Casale. Atti del XLI Convegno Internazionale. Assisi 18-20 ottobre 2013, Spoleto 2014 (Società Internazionale di Studi Francescani – Centro Interuniversitario di Studi Francescani), pp. 217-298: pp. 246-249.
[21] G. PETROCCHI, Biografia. Attività politica e letteraria, in Enciclopedia Dantesca, Appendice, Roma, 19842, p. 41. Luigi Pietrobono anticipava alla Vita Nova il ‘misticismo’ dantesco: cfr. CRISTALDI, Dante di fronte al gioachimismo, pp. 15-17.
[22] Cfr. G. L. POTESTÀ, Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Bari 2004, pp. 286-287.
[23] Il numero delle citazioni può lievemente variare secondo i criteri assunti nel computarle.
[24] Cfr. R. MANSELLI, La terza età, “Babylon” e l’Anticristo mistico (a proposito di Pietro di Giovanni Olivi) (1970), in ID., Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo (nota 4), p. 155.
[25] POTESTÀ, Il tempo dell’Apocalisse, p. 217.
[26] Cfr. P. VIAN, Dalla gioia dello Spirito alla prova della Chiesa. Il tertius generalis status mundi nella Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi, in L’età dello Spirito e la fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel gioachimismo medievale (nota 12), pp. 165-215.
[27] Cfr. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno (Francesca e la «Donna Gentile»).
[28] Cfr. VIAN, Tempo escatologico e tempo della Chiesa: Pietro di Giovanni Olivi e i suoi censori (nota 13), p. 171.
[29] P. VIAN, Fra Gioacchino da Fiore e lo spiritualismo francescano: Lo Spirito Santo nella Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi, in Lo Spirito Santo, in “Parola spirito e vita. Quaderni di lettura biblica”, 38 (1998/2), p. 248.
[30] D. BURR, Olivi’s Peaceable Kingdom. A Reading of the Apocalypse Commentary, Philadelphia 1993 (Middle Ages Series), pp. 115-116.
[31] GRUNDMANN, Dante und Joachim von Fiore (nota 6), p. 193: Am ehesten scheint mir dafür die von Erich Auerbach geprägte Formel von Dantes Wille zu universaler Konkordanz, zu universaler Einheit zutreffend [E. Auerbach, Dante als Dichter der irdischen Welt, Berlin 1929]. Aber diese Wille geht nicht auf Ausgleich von Gegensätzen in einem Mittelweg. Sondern es ist der Wille und der Glaube und die Sehnsucht, dass sich über allem Streit und Gegensatz der politischen, religiösen, wissenschaftlichen Parteien eine Haltung, eine Gesinnung, eine geistige und politische Bildung und Gestaltung der Menschheit müsse gewinnen lassen, in der alle religiösen und politischen Parteien ihr Recht und alle wissenschaftlichen Richtungen ihre Wahrheit wiederfinden können, ohne wie bisher untereinander in parteiischem Kampfe zu liegen. Damit aber erweist sich Dante gerade hier, wo man seine kirchliche Rechtgläubigkeit glaubte in Frage stellen zu dürfen, als ein im wahren Sinne des Wortes katholischer Geist.
[32] Cfr. De vulgari eloquentia, I, vi, 5-7.
[33] UBERTINO DA CASALE, Arbor vitae crucifixae Iesu, V, ix, Venetiis, 1485, rist. anast. a cura di C. T. Davis, Torino, 1961, f. 470b; F. X. KRAUS, Dante. Sein Leben und sein Werk. Sein Verhältniss zur Kunst und zur Politik, Berlin 1897, pp. 720-746: 736-746.
[34] Queste parole sono riferite al periodo (si tratta, nella quarta visione, dell’esegesi congiunta della terza e della quarta guerra) in cui la donna (la Chiesa) venne nutrita lontano dal serpente nel deserto dei Gentili, il luogo preparatole da Dio come suo, e dove le vennero date le due ali di una grande aquila (Ap 12, 14). Su tale inciso, secondo Olivi, Gioacchino da Fiore ha fondato tutta la sua Concordia. L’espressione indica un periodo di tre anni e mezzo, formati da quarantadue mesi (12 mesi x 3 anni + 6 mesi) nei quali i trenta giorni dei singoli mesi corrispondono a trenta anni: si ha così una permanenza della donna nel deserto di 1260 anni. “Tempus” sta per un anno, “tempora” per due anni e “dimidium temporis” per sei mesi. I “due anni” derivano dal duale greco, lingua nella quale scrisse Giovanni. Questo numero compare anche ad Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra) per indicare il periodo in cui la donna venne nutrita nel deserto (dove era fuggita dalla durezza dei Giudei), mentre in Daniele 7, 24-25 si dice che il re undicesimo distruggerà i santi dell’Altissimo che gli saranno dati in mano “per un tempo, due tempi e la metà di un tempo” e in Daniele 12, 6-7 che “fra un tempo, due tempi e la metà di un tempo si compiranno tutte queste cose meravigliose”.
[35] Cfr. Il sesto sigillo, cap. 2b (La perfezione stellare della “prima” grazia [Ap 3, 3]).
[36] Si può anche intendere la ‘sottrazione’ di Ulisse come speculare a quella di Elia: questi fu sottratto a Gezabele, quello fu sottratto da Circe “più d’un anno”. La figura di Gezabele, moglie di Achab re di Israele e fautrice dei quattrocento profeti di Baal, svolge un ruolo importante nell’istruzione data a Tiàtira, quarta delle sette chiese d’Asia alle quali scrive Giovanni nella prima visione apocalittica (Ap 2, 18-25). I temi che le vengono appropriati (concentrati attorno all’ipocrisia falsa e seducente) subiscono multiformi variazioni nei versi. Cfr. Il sesto sigillo, 7c (La «bestia saracena»), tab. LIII-LV.
[37] Cfr. Il sesto sigillo, 2d.3 (“Maria rimase giuso”).
[38] Sulla questione cfr. R. E. LERNER, Frederick II, Alive, Aloft and Allayed in Franciscan-Joachite Eschatology, in The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages, edited by W. Verbeke, D. Verhelst, A. Welkenhuysen, Louvain 1988, pp. 359-384, trad. it. Federico II mitizzato e ridimensionato post mortem nell’escatologia francescano-gioachimita, in Refrigerio dei santi. Gioacchino da Fiore e l’escatologia medievale, Roma 1995 (Centro Internazionale di Studi Gioachimiti. S. Giovanni in Fiore, Opere di Gioacchino da Fiore, 5), pp. 147-167.
[39] Cfr. Il sesto sigillo, 3 (Libero volere, libero salire, libero parlare).
CAPITOLO I
[1] Cfr. Dante all’ “alta guerra” tra latino e volgare. Postilla alle ricerche di Gustavo Vinay sul De vulgari eloquentia, 2.5 (Legge, lingua, ragione, governo).
[2] Cfr. INGLESE (nota 14), Inf. X, 23, pp. 129-130.
[3] Cfr. Ulisse perduto. Un viaggio nel futuro, dove si mostra anche la rilevante presenza di temi da Ap 2, 5.
[4] Cfr. “In mensura et numero et pondere”. Nella fucina della Commedia: storia, poesia e arte della memoria, 4 (Salmi polisensi).
[5] Cfr. INGLESE (nota 14), Inf. II, 113-114, pp. 58-59.
[6] Cfr. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno, 8 (Beatrice ritrovata e subito perduta).
[7] Olivi sottolinea in più luoghi la soggezione del Figlio al Padre, a motivo della sua mortale umanità: «(LSA, Ap 2, 7) Dicit autem “Dei mei” quia Christus in quantum homo minor est Deo Patre, ita quod in quantum homo habet Patrem pro Deo et Domino et etiam totam Trinitatem. […] (Ap 3, 12) Quod Christus hic vel alibi dicit “Dei mei” vel “a Deo meo”, non dicit nisi tantum ratione sue humanitatis, secundum quam est subiectus Patri et toti Trinitati tamquam Deo suo. […] (Ap 8, 3) Qui “venit”, per nature humane et mortalis assumptionem, “et stetit ante altare”, id est ante curiam seu hierarchiam celestem. Pro quanto enim, secundum carnis sue passibilitatem, minoratus est paulo minus ab angelis (cfr. Heb 2, 7; Ps 8, 6), habuit eos quasi ante se. […] (Ap 14, 18) Per illum vero angelum qui clamat ad alterum ut vindemiet dicit designari angelos bonos, qui non solum de templo sed etiam de altari exeunt quia non tantum ecclesiam electorum sed etiam Christum, qui est nostrum altare, respectu sue carnis transcendunt, secundum illud Psalmi (Ps 8, 6): “Minuisti eum paulo minus ab angelis”».
[8] Cfr. G. SASSO, Le autobiografie di Dante, Napoli 2008, p. 94: “Per sforzi che avesse compiuti per conferire il maggior pregio possibile al momento terreno (e cioè imperiale) della sintesi filosofico/teologica, era inevitabile che anche in lui, pensatore cristiano, a prevalere fosse l’altro termine. Ma questo non significa quel che tante volte si è detto; e cioè che, rinunziando all’idea che il primo termine godesse di autonomia nei confronti del secondo, a questo Dante lo avesse in sostanza subordinato”. Non c’è subordinazione di un termine all’altro, ma una sua “consumazione”, cioè una conduzione a compimento.
[9] Cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, 2.12 (Le rime aspre e dolci), tab. XXVI.
[10] Sull’equivoca figura di Salomone, cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, 3.6 (Il libro scritto dentro e fuori), tab. XLII.
[11] Cfr. Il sesto sigillo, 1d (La venuta del ladro).
[12] Cfr. RICHARDI S. VICTORIS In Apocalypsim libri septem, I, 9; V, 8, PL 196, coll. 730 C, 828 D-829 A.
[13] Cfr. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno, 2, tab. V (1-2).
[14] Cfr. Il sesto sigillo, 2d.3 (“Maria rimase giuso”).
[15] Ad Ap 22, 2 Olivi si sofferma a lungo sul Lignum vitae di Bonaventura (cfr. l’edizione in rete della Lectura super Apocalipsim).
[16] Cfr. La settima visione, I, 1 (La luce della città [Ap 21, 11]).
[17] Cfr. Il sesto sigillo, cap. 2c (L’apparizione di Beatrice nell’Eden: un’Apocalisse dei tempi moderni).
[18] Cfr. ibidem, tab. XV.
[19] Cfr. A. FORNI, Pietro di Giovanni Olivi nella penisola italiana: immagine e influssi tra letteratura e storia in Pietro di Giovanni Olivi frate minore. Atti del XLIII Convegno Internazionale. Assisi 16-18 ottobre 2015, Spoleto 2016 (Società Internazionale di Studi Francescani – Centro Interuniversitario di Studi Francescani), pp. 428-430.
CAPITOLO II
[1] Cfr. J. RATZINGER, S. Bonaventura. La teologia della storia, ed. L. Mauro, S. Maria degli Angeli – Assisi 2008, p. 66 e nota 113.
[2] Cfr. POTESTÀ, Il tempo dell’Apocalisse (nota 22), pp. 311-313: p. 313.
[3] Ibid., p. 178.
[4] Ibid., pp. 255-259: pp. 257, 259.
[5] RATZINGER, S. Bonaventura, pp. 71-72.
[6] Ibid., pp. 80-82.
[7] Il termine “Minori” compare una sola volta nella LSA (cap. VI, Ap 6, 12), con riferimento alla Regola.
[8] Cfr. F. SIMONI, Il Super Hieremiam e il gioachimismo francescano, in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano”, 82 (1970), pp. 44-46.
[9] L’episodio è narrato nella Lectura super Lucam, cap. 1, ed. F. IOZZELLI, Grottaferrata 2010 (Collectio Oliviana, V), pp. 230-231; cfr. D. PACETTI, Petrus Ioannis Olivi O. F. M., Quaestiones quatuor de domina, Quaracchi, Florentiae, 1954 (Bibliotheca Franciscana Ascetica Medii Aevi, VIII), p. 37, nota 1.
[10] Cfr. BONAVENTURA, Quaestiones disputatae de perfectione evangelica, q. 2, a. 3, ad 12, in Opera omnia, V, Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam 1891, p. 164 b): “Et quia Ecclesiae iam ditatae magis indigebant spiritualibus operariis quam vinitoribus et agricolis; hinc est, quod Spiritus sanctus religiones pauperculas suscitavit, quarum sollicitudo et cura tota esset ad signandos servos Dei in frontibus eorum signo Dei vivi, vocando ad poenitentiam et ad gratiam Spiritus sancti”.
[11] Cf. le parole di Cacciaguida, che subì il martirio per opera dei Saraceni, a Par. XV, 142-144: “Dietro li andai incontro a la nequizia / di quella legge il cui popolo usurpa, / per colpa d’i pastor, vostra giustizia”. Più avanti, nelle parole di san Pietro, sarà lo stesso pastore romano “quelli ch’usurpa”.
[12] Un passo simmetrico del notabile VII del prologo indica una situazione simile per i Gentili, non sufficientemente disposti, al momento della conversione, alla perfetta imitazione di Cristo e pertanto da condurre a essa attraverso successive illuminazioni nei vari esempi di stati e con varie guide.
[13] Questo attendere è sottolineato anche nella settima delle dieci rationes poste successivamente, ad Ap 7, 3: “quia prius expedit tirones intra suos exerceri et probari, antequam mittantur longe ad universalia bella cum extrinsecis gentibus totius orbis committenda”.
CAPITOLO III
[1] BONAVENTURA, Collationes in Hexaëmeron, XVI, 2, in Sancti Bonaventurae Sermones Theologici, Roma 1994 (Sancti Bonaventurae Opera, VII/1), p. 290; RATZINGER, San Bonaventura (nota II.1), pp. 45-46.
[2] RATZINGER, San Bonaventura (nota II.1), p. 45, n. 71; M. REEVES-W. GOULD, Joachim of Fiore and the myth of the Eternal Evangel in the nineteenth century, Oxford 1987, trad. it., Gioacchino da Fiore e il mito dell’Evangelo eterno nella cultura europea, Città di Castello 2000 (Centro Internazionale di Studi Gioachimiti. S. Giovanni in Fiore. Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti, 12), pp. 7-9.
[3] Cfr. Cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, 2.12 (Le rime aspre e dolci).
[4] Il parlare consolando per amore si ritrova nella preghiera di Guido del Duca al poeta perché si riveli in Purg. XIV, 12-13: “per carità ne consola e ne ditta / onde vieni e chi se’ …”, dove il ‘dittare’ rende l’ispirazione e la suggestione interiore appropriata al Paraclito consolatore (l’espressione “onde vieni e chi se’” traduce inoltre l’ “hii qui sunt et unde venerunt” di Ap 7, 13). Il consolare e l’idioma sono pure congiunti nella donna della Firenze antica la quale, come dice Cacciaguida, “… vegghiava a studio de la culla, / e, consolando, usava l’idïoma / che prima i padri e le madri trastulla” (Par. XV, 121-123): l’idioma è quello puerile e giocoso con cui i genitori parlano ai propri nati, e la “iocunditas” fa parte del gustare e sentire lo Spirito.
[5] BONAVENTURA, Collationes in Hexaëmeron, XVI, 29, p. 308.
INDICE GENERALE – AVVERTENZE