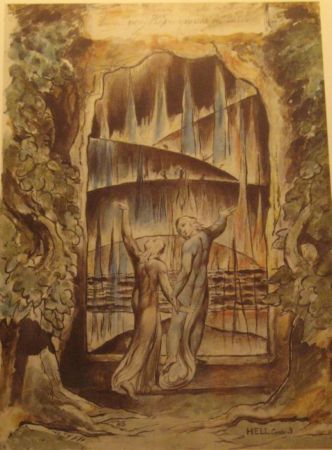1. Una scimmia eterodossa. 2. Dante e Guido Cavalcanti (Inferno X). 2.1. La nuova era s’avvicina, ma quando inizia? 2.2. Un passato remoto equivoco (“ebbe”): morte corporale o sostituzione nel primato della “gloria de la lingua” ?. 3. Essere “sospesi”: desiderio inappagato di Dio o vita contemplativa? 4. La vittoria dei contemplativi. 5. Le incertezze cognitive del diavolo. 6. Dante profeta. 7. Apocalisse. 8. Alleluia. 9. Conclusioni.
1. Una scimmia eterodossa
Allora Don Chisciotte domandò chi era quel mastro Pietro, e che cos’erano questa scimmia e questo teatrino che si portava dietro. – È un famoso giocoliere – rispose l’oste – che da molto tempo va su e giù per questa parte della Mancia aragonese, facendo vedere un quadro della liberazione di Melisendra per opera del famoso Don Gaifero, che è una delle storie migliori e meglio rappresentate che da parecchi anni in qua si sien viste in questi posti. Porta anche con sé una scimmia ammaestrata, d’una bravura che non s’è mai vista l’eguale tra le scimmie, e che uno non si può nemmeno immaginare. Perché, se le domandan qualche cosa, sta attenta a quel che le domandano, poi salta sulle spalle del padrone, e accostandosi al suo orecchio gli sussurra la risposta a quello che le hanno domandato, e, dopo, mastro Pietro la ridice forte. Sui fatti passati parla molto di più che sui futuri, e sebbene non sempre e non in tutti i casi ci indovini, il più delle volte non sbaglia; di modo che ci sarebbe da credere ch’abbia il diavolo in corpo. Piglia due reali per domanda, se la scimmia risponde, cioè se risponde il padrone per lei dopo che essa gli ha parlato all’orecchio; e quindi si crede che il nominato mastro Pietro sia ricchissimo. È anche un galantuomo e un buon compagno, che fa la miglior vita del mondo: discorre per sei, e beve per dodici, e tutto a spese della sua lingua, della sua scimmia e del suo teatro. A questo punto arrivò mastro Pietro, e su una carretta venivano il teatrino e la scimmia, che era grande e senza coda, con le natiche che parevan di feltro, ma non tanto brutta di viso. Don Chisciotte, appena la vide, le domandò: – Dica un po’ la Signoria Vostra: signora indovina, che pesci si piglia? Che succederà di noi? Ecco qui i miei due reali. E ordinò a Sancio che li desse a mastro Pietro: il quale rispose per la scimmia, e disse: – Signore, questo animale non risponde né dà notizia di ciò che deve succedere; dei fatti passati sa qualche cosa, e parecchio dei presenti. […] Don Chisciotte non era rimasto troppo soddisfatto del talento divinatorio della scimmia, perché non gli pareva cosa normale che una scimmia indovinasse né le cose future, né quelle passate; e perciò nel tempo che mastro Pietro preparava il suo teatrino, si ritirò insieme con Sancio in un angolo della stalla, dove nessuno potesse sentirli, e gli disse: – Senti, Sancio, io ho riflettuto bene alla straordinaria bravura di questa scimmia, e per conto mio ritengo sicuramente che questo mastro Pietro, suo padrone, deve avere, o tacito o espresso, patteggiato un patto col diavolo. – Pasticciato un patto col diavolo? Allora, se è un pasticcio fatto col diavolo, dev’esser di molto schifoso. Ma par farne che? – Tu non mi capisci. Voglio dire che deve essersi accordato col demonio, perché infonda quell’abilità nella scimmia e così gli faccia guadagnar da vivere, e dopo, diventato ricco, gli darà la sua anima, che è il compenso preteso da questo nemico del genere umano. E questo me lo fa credere anche il vedere che la scimmia non risponde se non alle cose passate o presenti, e infatti la sapienza del diavolo non può andar più in là; perché quelle future non può saperle se non per congettura, e non tutte le volte, perché solo a Dio è riservato il conoscere i tempi e i momenti, e per Lui non c’è passato né futuro, ma tutto è presente. Stando così le cose, come certamente stanno, è chiaro che questa scimmia parla per bocca del demonio, e mi meraviglio che non l’abbiano ancora accusata al Sant’Uffizio per esaminarla e mettere in chiaro in virtù di qual potere indovini le cose; perché è certo che questa scimmia non è un astrologo […] [1].
Nella seconda parte del Don Chisciotte (II, 25), l’hidalgo incontra all’osteria un burattinaio, mastro Pietro, che possiede una scimmia portentosa: conosce il presente, non prevede però il futuro. William T. Avery [2], nella sua efficace carrellata di elementi della Commedia presenti nel Quijote, ritenne che l’animale ‘scimmiotti’ la prescienza dei dannati di cui parla Farinata degli Uberti in Inferno X, per cui essi conoscono le cose lontane, non però quelle vicine o presenti:
Inf. X, 94-108“Deh, se riposi mai vostra semenza”,
|
Don Qijote de la Mancha, II, XXVEn esto, volvió maese Pedro, y en una carreta venía el retablo, y el mono, grande y sin cola, con las posaderas de fieltro, pero no de mala cara; y, apenas le vio don Quijote, cuando le preguntó:
|
Questo stravolgere invertendo le parole del fiero ghibellino non è, secondo Avery, una parodia senza ragione: “Cervantes mirerebbe soprattutto a screditare quegli elementi della Commedia dantesca che contraddicevano il cattolicesimo ortodosso spagnolo: e principalmente l’attribuzione di lucidità e potere divinatorio ai morti. Avery, insomma, attraverso una campionatura di esempi […] ha individuato nel Chisciotte passi derivati parodicamente dal testo dantesco, rilevando così in Cervantes un atteggiamento critico nei confronti di Dante” [3]. Fedele ai dettati tridentini, metterebbe in ridicolo l’eterodossia di Dante [4].
Tuttavia bisogna distinguere l’autore dal protagonista, Cervantes da Don Chisciotte, per cui le idee del secondo non coincidono necessariamente con quelle del primo. Se l’hidalgo vorrebbe far esaminare la scimmia dal Sant’Uffizio, non per questo Cervantes, in quanto campione della Controriforma, intendeva per essa segnalare alle autorità ecclesiastiche la strana soluzione che Dante aveva dato al problema della prescienza dei dannati [5]. Tanto più in un’opera dove, come scritto da Cesare Segre, l’autore si sdoppia: “in prima persona … è portavoce della poetica rinascimentale; travestito da Cide Hamete, crea personaggi e vicende barocchi nel gusto dei contrasti, nella voluta disarmonia, nel senso della labilità del reale” [6].
Ha ragione, invece, Avery nel sottolineare la conoscenza della Commedia da parte di Cervantes e i rivolgimenti parodistici di punti del testo dantesco, il più efficace dei quali è nella spaventevole avventura dei mulini a vento, creduti da Don Chisciotte giganti (I, 8), ironico rovesciamento di Inferno XXXI. L’Inferno fu tradotto in castigliano a Burgos nel 1515. Lope de Vega citò frequentemente la Commedia nelle sue opere; sapeva, ad esempio, del “calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato” (Par. XII, 139-141)[7]. In generale, Cervantes non si propone di scrivere, “in pro del mondo che mal vive”, un “poema sacro, / al quale ha posto mano e cielo e terra”:
“… ni tiene para qué predicar a ninguno, mezclando lo humano con lo divino, que es un género de mezcla de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento” [8].
Tornando alla questione della prescienza dei dannati, c’è poi da chiedersi se quest’attività divinatoria dei defunti fosse davvero espressione dell’eterodossia dantesca. Per il suo tempo queste idee erano del tutto ortodosse [9]. Nonostante Pietro di Dante rilevasse l’assenza di accordo fra i teologi sul punto – “Circa hoc videtur esse dubitatio in scriptura nostra sacra ut inter nostros theologos” [10] – chiarissima era l’autorità di Tommaso d’Aquino. Le anime dei morti ignorano ciò che avviene presso di noi; sono infatti, per disposizione divina, da noi segregate e in rapporto solo con le altre sostanze spirituali separate dal corpo. Tuttavia Agostino e Gregorio Magno ritengono che le anime beate, che vedono in Dio, conoscano il nostro presente, anche se non vi interferiscono. Ancora, afferma l’Aquinate, l’anima separata conosce “per species ex influentia divini luminis participatas”. Dunque Tommaso attribuisce ai soli beati la capacità di conoscere il presente, ma pure afferma la possibilità che i defunti in generale possano, per illuminazione divina, conoscere il futuro.
Summa Theologiae I, 89, 1, ad tertium: “Ad tertium dicendum quod anima separata non intelligit per species innatas; nec per species quas tunc abstrahit; nec solum per species conservatas, ut obiectio probat: sed per species ex influentia divini luminis participatas, quarum anima fit particeps sicut et aliae substantiae separatae, quamvis inferiori modo. Unde tam cito cessante conversione ad corpus, ad superiora convertitur. Nec tamen propter hoc cognitio non est naturalis: quia Deus est auctor non solum influentiae gratuiti luminis, sed etiam naturalis”.
I, 89, 4, resp.: “Alius modus intelligendi est per influentiam specierum a Deo: et per istum modum intellectus potest singularia cognoscere. Sicut enim ipse Deus per suam essentiam, inquantum est causa universalium et individualium principiorum, cognoscit omnia et universalia et singularia, ut supra dictum est; ita substantiae separatae per species, quae sunt quaedam participatae similitudines illius divinae essentiae, possunt singularia cognoscere”.
I, 89, 8: “Respondeo dicendum quod, secundum naturalem cognitionem, de qua nunc hic agitur, animae mortuorum nesciunt quae hic aguntur. Et huius ratio ex dictis accipi potest. Quia anima separata cognoscit singularia per hoc quod quodammodo determinata est ad illa, vel per vestigium alicuius praecedentis cognitionis seu affectionis, vel per ordinationem divinam. Animae autem mortuorum, secundum ordinationem divinam, et secundum modum essendi, segregatae sunt a conversatione viventium, et coniunctae conversationi spiritualium substantiarum quae sunt a corpore separatae. Unde ea quae apud nos aguntur ignorant […] Magis tamen videtur, secundum sententiam Gregorii [11], quod animae sanctorum Deum videntes, omnia praesentia quae hic aguntur cognoscant. Sunt enim angelis aequales: de quibus etiam Augustinus [12] asserit quod ea quae apud vivos aguntur non ignorant. Sed quia sanctorum animae sunt perfectissime iustitiae divinae coniunctae, nec tristantur, nec rebus viventium se ingerunt, nisi secundum quod iustitiae divinae dispositio exigit”.
Che è poi quello che avviene con Cavalcante e Farinata. Il padre di Guido è dannato in quanto epicureo e dunque non ha cognizione del presente, per cui si dispera udendo Dante usare il passato remoto riferito al figlio come fosse morto – “forse cui Guido vostro ebbe a disdegno” -; il fiero ghibellino parla dell’influenza del gratuito lume divino per cui può profetizzare l’esilio di Dante:
Inf. X, 58-63, 67-69piangendo disse: “Se per questo cieco
|
Inf. X, 79-81, 100-105Ma non cinquanta volte fia raccesa
|
Considerati dai critici un espediente artistico per ampliare la prospettiva temporale del viaggio datato al 1300, i versi di Inf. X relativi alla prescienza dei dannati fanno segno, come qualunque punto del poema, di qualcosa di più profondo. La Commedia, infatti, rivela anche un’eccezionale arte della memoria, per cui le singole parole si leggono, nel contesto dei versi, come segni che conducono ad altro testo dottrinale in prosa, la Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi, consentendo così il passaggio dal senso letterale, che è per tutti, a quelli mistici (allegorico, morale, anagogico) in esso racchiusi, riservati ai depositari della ‘chiave’, cioè agli Spirituali francescani. Costoro, campioni della riforma della Chiesa, avrebbero trovato nel “poema sacro” materia predicabile in volgare che dava “e piedi e mano” alla dottrina apocalittica oliviana aggiornata, secondo gli intenti di Dante, in senso aristotelico e imperiale. Le esigenze ‘laiche’ nell’uso del volgare, nella definizione del regime politico, nell’ambito della natura e della ragione, nella valorizzazione degli autori classici, venivano rese sacre, inserite nella storia della salvezza collettiva, della quale la Lectura super Apocalipsim fu l’estrema espressione. Dante stesso definì la Commedia poema “polisemos, hoc est plurium sensuum” (Epistola XIII, 20). Avere “più significati” vuol dire rivolgersi a più lettori. Dante aveva concepito un pubblico di chierici per il quale la Lectura dell’Olivi e la Commedia avrebbero dovuto porsi come vessilli; questo pubblico non si formò per le note vicende che portarono alla persecuzione degli Spirituali e alla quasi sparizione della Lectura, condannata nel 1326 da Giovanni XXII. Ma il confronto fra i testi (non si tratta di interpretazione, ma di raccolta di dati) [13] consente di far rivivere quel particolare senso che si era perduto, tutto medievale pregno com’è di segni, e al tempo stesso di constatarlo applicato al nuovo “viver bene” dell’ “omo in terra”. La Commedia fu scritta in un’età di crisi, tra storia collettiva e solitudine individuale, come lo fu il Don Chisciotte, tra armonia rinascimentale e disarmonia barocca.
2. Dante e Guido Cavalcanti (Inferno X)
2.1. La nuova era s’avvicina, ma quando inizia?
Nell’esegesi di Ap 12, 6 – allorché la donna (la Chiesa) fugge dall’ostinata durezza giudaica nel deserto della gentilità, e ivi rimane per 1260 anni, ovvero per “un tempo, (due) tempi e la metà di un tempo”, come detto in seguito (Ap 12, 14) – Olivi propone numerose citazioni dalla Concordia di Gioacchino da Fiore. Precisa che esse non esprimono asserzioni ma opinioni. Questa presa di distanza da parte del francescano è più volte ribadita, soprattutto quando il testo sacro, attraverso i numeri mistici in esso contenuti, induce a determinare con precisione gli eventi del prossimo futuro. In questi casi Olivi tende a destoricizzare Gioacchino, a sottolinearne le incertezze, a lasciare in sospeso l’identificazione dei fatti e delle persone verso le quali si appuntano i termini del computo delle generazioni. Se, scrive Raoul Manselli, sottolinea tutta l’importanza di una “figura così terribile” come l’Anticristo mistico, il finto cristiano capo della Chiesa carnale e persecutore dei seguaci della regola evangelica, non la applica concretamente a questo o a quello, come farà poi il suo discepolo Ubertino da Casale: “tendeva piuttosto a pensare ad un antipapa, sostenuto ed appoggiato da qualche grande potenza politica. Ma più non volle dire; e mai si pronunciò sull’altra grande figura apocalittica, ‘Babilon’, la ‘meretrix magna’ che è certo a Roma, ma che non è mai fatta esplicitamente coincidere con la Curia papale” [14].
Convinto di trovarsi sulla soglia dell’apertura del sesto sigillo (il “novum seculum” dell’Olivi), corrispondente all’età dello Spirito che si apre nella quarantunesima generazione, l’abate calabrese in più di un punto della Concordia si mostra volutamente incerto: “esito e preferisco esitare piuttosto che determinare”. Non c’è da meravigliarsi, afferma Olivi, se pur tra tanta luce datagli, quasi nell’aurora del terzo stato, permangono le tenebre del tempo precedente (il quinto stato della Chiesa per Olivi, l’età del Figlio per Gioacchino) che avvolgono la notizia delle cose future. Circa l’apertura del sesto sigillo, Gioacchino afferma che il tempo è vicino ma che il giorno e l’ora sono conosciuti solo da Dio: “i tempi e i momenti mi sono ad ogni modo sospetti”. E trattando delle quarantadue generazioni del secondo stato, ciascuna di trent’anni, e dei 1260 anni che le compongono, esita a stabilire se, per integrare il numero, Zaccaria e suo figlio Giovanni Battista siano da considerare come due generazioni, oppure se alla quarantesima generazione, che è quella in cui vive, ne seguano altre due che non abbiano la medesima durata delle precedenti ma vengano abbreviate per gli eletti [15].
Il ‘sospetto’ di Gioacchino da Fiore sui tempi e le generazioni segna il comportamento dell’epicureo Cavalcante, il padre di Guido: levatosi in ginocchio nell’avello infuocato dove sta dritto Farinata, guarda intorno a Dante per vedere se altri sia con lui, “e poi che ’l sospecciar fu tutto spento”, chiede nel pianto: “mio figlio ov’ è? e perché non è teco?” (Inf. X, 55-60).
Osserva Gioacchino da Fiore, nel V libro della Concordia: “Se dunque Zaccaria, il padre di Giovanni Battista posto tra la Sinagoga e la Chiesa, predisse vicino il tempo e la nascita di Cristo, ma non gli fu concesso di far sapere nella loro successione le cose che Cristo avrebbe fatto, così anche a noi, posti tra il secondo e il terzo stato, è concesso di contemplare molte cose del terzo, ma non possiamo determinarne l’ordine per numero e distinzione di fatti, se non forse qualcosa del principio” (ad Ap 12, 6).
L’incertezza di Gioacchino da Fiore nella contemplazione del tempo che s’appressa e nella determinazione delle ultime generazioni si trasforma nel limite posto ai dannati nel vedere il futuro prossimo o il presente. Le parole di Cavalcante – «Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora? / non fiere li occhi suoi lo dolce lume?» (Inf. X, 67-69) – mostrano come egli ignori se il figlio, nell’anno 1300, sia ancora in vita. Eppure Ciacco aveva profetato il futuro prossimo di Firenze (Inf. VI, 64-75). Di qui la preghiera del poeta dubbioso a Farinata, anch’egli profeta del suo destino (Inf. X, 79-81), di spiegargli come mai i dannati prevedano gli eventi futuri ma non conoscano il presente. La risposta di Farinata conferma la “mala luce” dei dannati, che vedono le cose lontane ma hanno vano intelletto di quelle che si avvicinano o che sono (Inf. X, 97-105).
Talora, afferma Gioacchino, le generazioni sono doppie, come nel caso di Ioacaz, deposto dal faraone Necao e sostituito nel regno con Ioiakìm (4 Rg 23, 34); e di Ieconia, figlio di Ioiakìm, deposto da Nabucodonosor e sostituito con Sedecia (4 Rg 24, 15-17; 1 Par 3, 16-17). E gli esclusi talora restano nel numero delle precedenti generazioni, talora sono esclusi anche da queste, come Samgar, che al tempo di Aod giudice difese Israele contro i Filistei (Jd 3, 31) e come Isboset, il figlio di Saul che regnò su Israele al tempo in cui Davide regnò in Hebron su Giuda (2 Rg 2, 10-11; 4) [16].
Ancora, se non è certo sotto quale generazione avvenne la distruzione di Babilonia o si verificarono le persecuzioni dei tempi di Giuditta e di Ester, così anche nel Nuovo Testamento non si può avere concordia certa. È infatti necessario che l’intelletto venga meno nel Nuovo dove consta sia venuto meno per confusione nel Vecchio, non nel senso che si ignori la vicinanza del tempo, ma che non si conosca il giorno e l’anno.
Il tema della sostituzione nelle generazioni mentre si è in vita – “cum viventi adhuc … substitutus est …” – risuona nella disperata domanda di Cavalcante: “Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora?” (Inf. X, 67-68). Una ripresa del tema è al v. 111, allorché il poeta prega Farinata di dire a Cavalcante, “caduto” per disperazione nell’avello, “che ’l suo nato è co’ vivi ancor congiunto”, e se egli ha indugiato a rispondere provocando la disperazione del padre è stato per il dubbio sulla prescienza dei dannati che il ghibellino gli ha risolto. La poesia fa risuonare due registri differenti: Cavalcante pensa alla morte corporale; Dante, nella risposta, pensa alla sostituzione in vita. L’amico Guido, ancora vivo nella primavera 1300, non è infatti con lui. Zaccaria, il padre di Giovanni Battista divenuto muto sulle cose che avverranno, è figura che ben si addice al padre di Guido, che non vede il tempo che s’appressa. Guido stesso, “quelli cui io chiamo primo delli miei amici”, è controfigura del Battista nella sua donna, quella monna Vanna-Primavera che nella Vita Nova (cap. 15; ed. a cura di G. Gorni, Torino 1996) viene prima di monna Bice-Amore, «però che lo suo nome Giovanna è da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce dicendo: “Ego vox clamantis in deserto: parate viam Domini” (Jo 1, 23)».
Si possono notare le tracce di questa esegesi nel caso della Tolomea, lì dove i traditori degli ospiti ‘cadono’ prima di morire, mentre un demonio ne “governa” il corpo in terra. Un’invenzione di Dante, che il figlio Pietro si affrettò a difendere contro possibili riserve teologiche affermando trattarsi di finzione poetica, di un’allegoria dello stato di disperazione di quei peccatori. Ma la meravigliata domanda a frate Alberigo: «“Oh!” diss’ io lui, “or se’ tu ancor morto?”» (Inf. XXXIII, 121-123) è una variante di quella fatta dal padre di Guido: “non viv’ elli ancora?”, ed è cucita, e ad essa rinvia, con gli stessi fili di un’esegesi che sottolinea, utilizzando Gioacchino da Fiore, l’incertezza sulle generazioni e la traslazione ad altri del governo di chi è ancora in vita.
Il caso di Cavalcante non resta isolato, perché un momento simmetrico, per la presenza dei temi del ‘sospetto’ e del guardarsi attorno, si ha in Purg. XXII, 115-126, allorché Virgilio e Stazio, sulla soglia del sesto girone della montagna, tacciono “di novo attenti a riguardar dintorno”, presi dal “sospetto” su quale via prendere, finché Virgilio determina che, come fatto fino allora, si debba volgere “le destre spalle” all’orlo esterno del balzo. Stazio, “anima degna”, dà il suo assenso. L’ora – indicata dall’essere già le prime “quattro ancelle … del giorno / rimase a dietro, e la quinta era al temo” – è fra le dieci e le undici antimeridiane: l’ora del sesto stato è il mezzogiorno, e ciò significa che i tre poeti si trovano prossimi al sesto ma ancora sotto il regime del quinto. Il sesto e il settimo stato della Chiesa coincidono, nella teologia dell’Olivi, con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Che la consuetudine tenuta per il passato, di girare verso destra, venga mantenuta nella circostanza – “così l’usanza fu lì nostra insegna” – corrisponde al fatto che a illuminare il sesto stato cooperano tutte le illuminazioni degli stati precedenti e la fama di Cristo, della sua fede e della sua Chiesa diffusa per il mondo a partire dal primo stato fino ai tempi moderni [17]. Il “nuovo” è segno del sesto stato, che è di “renovatio” della vita evangelica: così Virgilio e Stazio sono “di novo attenti a riguardar dintorno”. Il sesto girone del purgatorio è quello dove Dante incontra Bonagiunta da Lucca, il poeta che gli chiede se sia “colui che fore / trasse le nove rime” (Purg. XXIV, 49-51). Nel Limbo, alle quattro grandi ombre di Omero, Orazio, Ovidio e Lucano si aggiunge la quinta di Virgilio: “tra cotanto senno” Dante è sesto (Inf. IV, 102) [18]. Da notare altre simmetrie tra Inf. X, 55-60 e i versi che precedono Purg. XXII, 115-126, nel colloquio tra Stazio e Virgilio: “per questo cieco carcere / nel primo cinghio del carcere cieco”, “mio figlio, ov’ è? / dimmi dov’ è Terrenzio nostro antico”, “e perché non è teco? / che sempre ha le nutrice nostre seco”. Virgilio dunque determina, con l’assenso di Stazio, la via da seguire per andare al sesto stato, che è la compiuta età dello Spirito (già iniziata in Purg. IX con l’apertura della porta del purgatorio, la “porta di san Pietro”). Come Virgilio, Cavalcante dubita sull’imminente inizio dell’età dello Spirito ma, a differenza del poeta pagano, equivoca nella risposta di Dante sulla sorte del figlio.
Una curiosa variazione è a Purg. XII, 127-136, allorché Dante, passato l’angelo dell’umiltà, scopre di essere libero dalla prima delle sette “P” incise sulla sua fronte dall’angelo portiere con la punta della spada. Anche qui è presente il tema del sospetto: “Allor fec’ io come color che vanno / con cosa in capo non da lor saputa, / se non che ’ cenni altrui sospecciar fanno”, per cui, senza vedere, si aiuta con la mano a ritrovare le sei lettere restanti impresse sulla fronte.
Le citazioni di Gioacchino da Fiore sul proprio “sospetto”, riportate ad Ap 12, 6, possono essere confrontate con un passo del quarto libro della Concordia citato da Olivi prima di procedere, nella terza visione, all’esegesi della sesta tromba (Ap 9, 13). Gioacchino ritiene incauto definire con precisione gli anni dopo la quarantesima generazione, cioè a partire dal sesto stato, che coincide con la quarantunesima generazione. Usa l’immagine dei marinai, i quali in vista del porto ammainano le vele e utilizzano altri strumenti per venire a proda, oppure quella di coloro che, dopo aver navigato per lidi sicuri e conosciuti, iniziano a solcare acque sconosciute in modo cauto e circospetto.
Sono questi alcuni dei motivi presenti nell’episodio della corda che Virgilio, volgendosi verso il lato destro, getta nel burrone dove cade il Flegetonte verso Malebolge (Inf. XVI, 106-120). Dante pensa tra sé a questo atto come a un “novo cenno”, che il maestro segue con attento sguardo e al quale “e’ pur convien che novità risponda”. Poi afferma apertamente che si deve essere “cauti” (hapax) presso a coloro i quali, come Virgilio, non solo vedono gli atti esteriori ma penetrano col senno nei pensieri altrui. Comune con l’immagine di Gioacchino da Fiore è l’essere cauti (proprio di Dante nei confronti di Virgilio) o circospetti (proprio di Virgilio) di fronte alle novità. La corda, “novo cenno” al quale viene in su Gerione, è uno dei momenti che nell’Inferno sono segnati, topograficamente, dalla prevalenza dei temi del sesto stato [19].
Purg. XII, 127-129, luogo sopra ricordato, sembra riferibile ad Ap 9, 13 per l’espressione “come color che vanno / con cosa in capo non da lor saputa”; ad Ap 12, 6 per il “sospecciar”. Da confrontare il “novo cenno” di Inf. XVI, 116 (la corda gettata) con i “cenni altrui” di Purg. XII, 129. È da considerare che siamo nel primo girone della montagna dopo l’apertura della porta del purgatorio, che coincide con l’inizio del sesto stato oliviano o con l’età dello spirito di Gioacchino. Non sarà pertanto casuale l’espressione “trovai pur sei le lettere che ’ncise / quel da le chiavi a me sovra le tempie” (Purg. XII, 134-135) , che un esperto lettore o ascoltatore non avrebbe mancato di rilevare.
Il tema del “sospetto” si trova anche in Purg. VI, 25-48, allorché Virgilio invita Dante a non fermarsi “a così alto sospetto”, cioè a un dubbio sì profondo, senza una spiegazione data da Beatrice – “se quella nol ti dice / che lume fia tra ’l vero e lo ’ntelletto” -, dalla sua donna che potrà vedere sulla cima della montagna. Il dubbio è il seguente: nell’Eneide la Sibilla, supplicata dall’insepolto Palinuro di portarlo oltre l’Acheronte, aveva risposto che i decreti divini non si possono modificare con la preghiera – “desine fata deum flecti sperare precando” (Aen., VI, 376) -; è dunque vana la preghiera delle tante anime purganti che pregano Dante perché ricordi al mondo di pregare per loro? Virgilio risponde che la preghiera dei pagani non era udita in cielo e che, adesso, il giudizio divino non subisce alcun mutamento per il fatto che l’ardore della carità soddisfi “in un punto”, cioè in un istante, quanto dovuto dai peccatori per il riscatto delle loro colpe. Il “sospetto” di Dante riguarda dunque la possibilità che le preghiere abbrevino la permanenza nel purgatorio delle anime già elette – “sì che s’avacci lor divenir sante” -, come l’esitazione di Gioacchino da Fiore verte sul fatto se i giorni delle ultime due generazioni siano o meno abbreviati in favore degli eletti. Da notare che, secondo quanto Olivi afferma nel notabile VIII del prologo della Lectura, il sesto stato è il “punto” da cui dipendono gli altri stati, perché esso appare nel testo dell’Apocalisse in modo più evidente degli altri, che da esso assumono chiarezza quanto alla loro manifestazione nella storia, come l’intelligenza delle cose ordinate ad un fine dipende dal fine. È questo un tema che si ritrova nel punto luminosissimo – Dio – da cui dipende il cielo e la terra, circondato dai nove cerchi di fuoco, che Dante vede nel Primo Mobile, nono ma sesto, a partire dal cielo del Sole, dei cieli senza il cono d’ombra proiettato dalla terra (Par. XXVIII, 16-18, 40-42, 94-96) [20].
Il discorso di Virgilio, nel quale il poeta pagano si rimette a quanto dirà Beatrice, “quella … / che lume fia tra ’l vero e lo ’ntelletto” (Purg. VI, 44-45), corrisponde in parte a quanto Olivi dice delle affermazioni di Gioacchino da Fiore, molte delle quali ritiene non asserzioni ma opinioni. Nell’esegesi della quinta tromba (Ap 9, 11), il francescano sostiene che come per mezzo della naturale luce dell’intelletto conosciamo alcune cose in modo certo, quali i primi princìpi (“lo ’ntelletto de le prime notizie”, che l’uomo non sa da dove venga, a Purg. XVIII, 55-56); alcune come necessariamente da essi dedotte, altre invece opiniamo in base a ragioni probabili, e in queste opinioni possiamo errare senza che per questo sia falso il lume dell’intelletto a noi concreato, ma non erriamo in quanto siamo consapevoli che si tratta di opinioni e non di scienza infallibile, così per mezzo del lume dato in virtù della gratuita rivelazione conosciamo alcune cose come princìpi indubitabili, altre come conclusioni necessarie, altre ancora come probabili congetture (cfr. le espressioni “nec pro tanto fallimur … e la speranza di costor non falla”, Purg. VI, 35). A una precedente domanda su quanto sia lunga l’ascesa della montagna, Virgilio ha risposto che la salita, grave all’inizio, si fa poi sentire sempre più leggera, concludendo: “Più non rispondo, e questo so per vero” (Purg. IV, 96). Sa queste cose in modo indubitabile come fossero primi princìpi.
Dante evita di applicare ai ragionamenti di Virgilio il termine “opinioni”, come fa Olivi a proposito di Gioacchino da Fiore; il poeta pagano è mosso dal lume di Beatrice, per cui le sue sono asserzioni della ragione illuminata. È il “lume che nel ciel s’informa”, che muove l’ “alta fantasia”, cioè l’ “imaginativa” che fa a meno dei sensi. La fantasia è la virtù organica che media tra il sensibile e l’intelletto: chi la fa operare, si chiede il poeta, se la materia non è fornita dalle percezioni sensibili? Essa, nelle visioni estatiche di ira punita apparse nel terzo girone della montagna, viene stimolata da un lume che prende forma nel cielo, o per influsso astrale o perché mandato da Dio (Purg. XVII, 13-45; cfr. nota). Così è per Virgilio, che nel secondo girone si è rivolto al lume del sole, perché guidi il cammino coi suoi raggi (Purg. XIII, 13-21). ‘Opinione’ è quando la ragione va dietro ai sensi, per cui “ha corte l’ali”, ed “erra … dove chiave di senso non diserra”, come afferma Beatrice all’inizio della confutazione circa la provenienza delle macchie lunari dal raro e dal denso della materia, teoria averroista creduta da Dante (Par. II, 52-57). Virgilio non rappresenta soltanto, come si suole affermare, la ragione in quanto tale, ma la ragione vittoriosa sui sensi. Questa vittoria è prerogativa del terzo stato, dei dottori che confutano con la ragione le eresie e i loro fantastici e sensibili errori. Questo stato, che è della Chiesa ma che ha una sua prefigurazione nella legge data nell’Antico Testamento, Dante lo appropria agli Antichi, convinti sostenitori del libero arbitrio: “Color che ragionando andaro al fondo, / s’accorser d’esta innata libertate; / però moralità lasciaro al mondo” (Purg. XVIII, 67-69). Il terzo stato corrisponde all’intelligenza morale della Scrittura, che gli Antichi non conobbero, ma dei cui sviluppi furono ‘figura’ per essere poi da essa ricompresi attraverso la loro ‘vita nova’ nel poema sacro. La ragione illuminata ‘aspetta’ la fede, e qui Virgilio riconosce il suo limite: «Ed elli a me: “Quanto ragion qui vede, / dir ti poss’ io; da indi in là t’aspetta / pur a Beatrice, ch’è opra di fede”» (Purg. XVIII, 46-48).
Grande valore, considerata l’esegesi del “sospetto” sulla concordia gioachimita tra Vecchio e Nuovo Testamento, assume l’espressione di Virgilio sul fatto che non ci sia contraddizione tra la preghiera un tempo disgiunta da Dio (come fu vana la richiesta alla Sibilla di essere traghettato da parte dell’insepolto Palinuro) e l’odierno “foco d’amor” che soddisfa la colpa: “La mia scrittura è piana” (Purg. VI, 34). L’antico poeta non intende soltanto ‘il mio testo scritto’, bensì ‘quel che scrissi, che è anch’essa Scrittura antica da concordare con la nuova’. Essa è come l’angelica favella di Beatrice, “soave e piana” (Inf. II, 56-57), di cui è figura, per cui l’alta tragedia si è fatta, convertendosi, “sermo humilis”.
Nel Notabile VII del Prologo della Lectura, Olivi inserisce il celebre passo sulla “commutatio” del pontificato. I temi presenti in questo passo sono principalmente due: l’alterno succedersi delle stirpi sacerdotali nell’Antico Testamento, per disegno divino o per deposizione da parte di un re (il caso di Abiatar da parte di Salomone), e una sorta di corsi e di ricorsi tra povertà e ricchezza del pontificato nel Nuovo Testamento, fino al definitivo ritorno, nel sesto stato, alla stabilità dell’originaria povertà evangelica. Se si collazionano i temi propri della sesta vittoria (Ap 3, 12) con quelli propri della “commutatio” del pontificato (Notabile VII), si deduce che il sesto stato si presenta come “novum seculum” che rinnova il vecchio e in cui ritorna l’originaria povertà del primo stato. La nuova Gerusalemme, ossia la pace, discende dal cielo e una nuova progenie spirituale viene creata. La virginea prole è pure tema della quarta visione, che inizia con il capitolo XII, dove appare la donna (la Chiesa) vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle (cfr. l’esegesi ad Ap 12, 7). Questi motivi sono la veste spirituale, perfettamente aderente, dei versi della quarta egloga virgiliana che celebrano la rinnovata età dell’oro, versi che Stazio ripete nel dichiarare il suo debito verso Virgilio: “Per te poeta fui, per te cristiano” (Purg. XXII, 64-73). Se tra i due poeti sta il mistero della predestinazione per cui uno fu toccato dalla Grazia e l’altro no, qui Virgilio è non solo profeta del primo avvento di Cristo ma anche della seconda e altrettanto grande “renovatio”, quella del sesto stato, in cui ha luogo la conversione delle genti e del popolo d’Israele fino allora escluso. La lode che Stazio fa di Virgilio assomiglia a quella che nel cielo del Sole Bonaventura pronuncia del “calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato” (Par. XII, 139-141), il quale, come dice Olivi, vide in spirito il sesto stato. Nel Limbo, alle quattro grandi ombre di Omero, Orazio, Ovidio e Lucano si aggiunge la quinta di Virgilio: “tra cotanto senno” Dante è sesto (Inf. IV, 102). Si noterà che “Secol si rinova” non c’è in Virgilio, ma in Olivi; e se ciò non bastasse, si aggiunga “torna giustizia e primo tempo umano”.
____________________________________________________________________________________________________________________
[Nota alla tabella precedente]
La terza vittoria (la cui esegesi conclude l’istruzione data a Pergamo, la terza chiesa d’Asia) consiste nella vittoriosa ascesa al di sopra della fantasia mossa dal senso, che è causa di errore e di eresia. Questa salita avviene tramite la prudenza che mette in fuga le nebbie, gli errori e gli impulsi precipitosi e temerari. È propria dei dottori che vincono gli errori della fantasia eretica, a loro spetta il premio del singolare apprendimento e del gusto dell’arcana sapienza di Dio. Così alla terza chiesa d’Asia (Pergamo) viene detto: “Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza lucida sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve” (Ap 2, 17). La fantasia erronea è pure il difetto che rende chiuso il terzo sigillo (ad Ap 5, 1).
I temi della fantasia e dell’errore, dalla terza vittoria, emergono con evidenza (accanto ad altri del terzo stato) nel terzo girone del Purgatorio. Cessate le visioni estatiche di mansuetudine, che precedono l’episodio di Marco Lombardo, il poeta, tornato con l’anima “di fori / a le cose che son fuor di lei vere”, riconosce che le cose da lui viste erano “non falsi errori”, errori in quanto non esistenti nella realtà, non falsi come esperienza di visione soggettiva (Purg. XV, 115-117). Dopo l’uscita dal fumo degli iracondi (momento in cui il poeta si appella all’immaginazione del lettore, Purg. XVII, 1-9), è la volta delle visioni di ira punita. La loro descrizione è preceduta da un’apostrofe all’ “imaginativa”, cioè alla fantasia, la facoltà dell’anima che media tra il sensibile e l’intelletto: chi la fa operare, si chiede il poeta, se la materia non è fornita dalle percezioni sensibili? Essa, in questo caso, viene stimolata da un lume che prende forma nel cielo, o per influsso celeste o perché mandato da Dio (Purg. XVII, 13-18). Nel caso delle visioni estatiche, pertanto, il poeta consegue la terza vittoria, cioè ascende al di sopra della fantasia che muove dal senso, causa di errore e di eresia: il lume celeste che muove l’ “imaginativa” corrisponde al lume dei dottori (prologo, Notabile X). È l’ “alta fantasia” (Par. XXXIII, 142), cioè la visione intellettuale che, come quella dell’Apocalisse avuta da Giovanni, non viene sminuita dal fatto di essere aiutata da figure (Ap 1, 2). È da notare, nell’apostrofe all’ “imaginativa”, la presenza di un altro tema del terzo stato (la tuba dottorale: prologo, Notabile I) nel riferimento al suonar delle “mille tube” che non potrebbero impedire il rapimento dell’anima dalle impressioni del mondo esterno (l’espressione “ch’om non s’accorge” contiene il motivo dell’uomo razionale, sempre dal Notabile I). Il rapporto equivoco tra l’immagine vera e quella erronea (le cose vere fuori dell’anima e i “non falsi errori” all’interno) continua nelle visioni di ira punita, nell’immaginazione di Aman crocifisso, tra Assuero, Ester e il giusto Mardocheo, la quale si rompe da sola, come una bolla d’aria che viene meno al rompersi del velo d’acqua che l’avvolge (Purg. XVII, 31-33): il tema del rompere l’errore (in questo caso non falso) è proprio della terza chiesa (Pergamo), alla quale Cristo si presenta come colui che ha la rumphea, cioè la spada acuta che scinde e divide (Ap 2, 12). La fine delle visioni (ibid., 40-45) corrisponde al cader giù dell’immaginare del poeta percosso nel volto dal lume dell’angelo della pace, come il sonno “si frange” (altro motivo appropriato alla chiesa di Pergamo) guizzando allorché il viso è percosso da “nova luce” (la pietruzza lucida che contiene il nome nuovo, premio della terza vittoria ad Ap 2, 17).
____________________________________________________________________________________________________________________
[LSA, prologus, Notabile VI] Tertia ratio magis litteralis est quia ut quidam finis sollempnis et quoddam sollempne initium novi seculi monstretur esse in sexto statu et plenius in septimo […][LSA, prologus, Notabile VII] […] sicque tertio, reiecta tota vetustate huius seculi, renovaretur et consumaretur seculum per gloriam et in gloria Christi. […]
|
|
Purg. XXII, 67-72Facesti come quei che va di notte,
|
Egloga IV, 5-7Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo
|
2.2. Un passato remoto equivoco (“ebbe”): morte corporale o sostituzione nel primato della “gloria de la lingua”?
Cosa intendeva dire Dante a Cavalcante – «E io a lui: “Da me stesso non vegno: / colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”» (Inf. X, 61-63)? Cosa comprende il padre di Guido – «Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora? / non fiere li occhi suoi lo dolce lume?» (ibid., 67-69)? Per intendere bene l’equivoco fra i due bisogna esaminare il tessuto spirituale di Purg. XI.
Al vescovo di Efeso, il metropolita delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione, viene minacciato lo spostamento del candelabro, cioè la “translatio” del primato ad altra chiesa, qualora nel suo allontanarsi, discendendo in basso, non ritorni, risalendo, alla carità originaria: “Memor esto itaque unde excideris et age penitentiam et prima opera fac. Sin autem, venio tibi et movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi penitentiam egeris” (Ap 2, 5).
Efeso viene assimilata all’ “Ecclesia ex circumcisione”, che aveva sede a Gerusalemme. Questa peccò di vanagloria nella superba presunzione del suo primato che le derivava dall’essere stata la prima a credere in Cristo, dal fatto che i Gentili la onoravano e seguivano come maestra che li aveva illuminati in Cristo e tratti a Cristo, dalla gloria dei suoi patriarchi e profeti e dalla legge e dal culto di Dio per lungo tempo in essa sola fondati. Tra i motivi della traslazione, avvenuta con la fissazione della sede in Roma da parte di san Pietro, rientra anche quello per cui i Giudei dovevano essere, all’avvento di Cristo, abbandonati nella loro cecità e la sede somma di Cristo posta a Roma, nella principale sede dell’Impero dei Gentili. Ad umiliazione di questo superbo primato, Cristo si mostra all’inizio dell’istruzione rivolta alla chiesa di Efeso come “Colui che tiene le sette stelle nella sua destra” (Ap 2, 1), cioè tutti i preclari prìncipi e prelati di ogni chiesa, e che è presente in tutte le chiese attuali e future, che percorre e visita. Egli è il sommo re e pontefice, molte altre importanti chiese sono e dovranno porsi sotto Cristo oltre alla superba Gerusalemme. Olivi, a differenza di Riccardo di San Vittore che si mantiene nell’interpretazione letterale e morale, fa della “translatio” uno dei motori della storia. Essa infatti non avviene solo con la chiesa di Gerusalemme, perché si verificherà ancora, alla fine del quinto stato della Chiesa, con la traslazione del primato della nuova Babilonia alla nuova Gerusalemme e, al termine dell’ultima e prava parte del settimo stato, nella traslazione alla Gerusalemme celeste.
Se alla chiesa di Efeso (la prima delle sette chiese d’Asia) viene minacciato lo spostamento del candelabro, alla sesta chiesa, Filadelfia (il sesto stato è il tempo di Olivi e di Dante), viene minacciata la perdita della corona se non persevererà nella fede e nelle buone opere. Come infatti il primo stato della Chiesa, designato con la chiesa di Efeso, ebbe il primato rispetto al secondo stato generale del mondo (la gioachimita età del Figlio), definito da san Paolo il tempo della pienezza delle genti (Rm 11, 25-26), così il sesto stato avrà il primato rispetto al terzo stato generale, che durerà fino alla fine del mondo (l’età dello Spirito, che coincide appunto con gli ultimi due stati della Chiesa, il sesto e il settimo). La traslazione viene minacciata affinché le chiese e i loro vescovi non insuperbiscano credendo che altri non possa sostituirle in modo ugualmente degno. Inoltre, sia la Chiesa primitiva sia quella del sesto stato subentrano nella gloria ad un’altra, la prima alla Sinagoga, la seconda alla meretrice Babilonia, che verrà condannata agli inizi del sesto stato (Ap 3, 11).
La collazione dei due luoghi relativi alla chiesa di Efeso (Ap 2, 5) e alla chiesa di Filadelfia (Ap 3, 11) conduce al primo girone del Purgatorio, quello dei superbi, dove Oderisi da Gubbio riconosce la superiorità nell’arte della miniatura di Franco Bolognese e cita altri due celebri esempi di “translatio”. Come Cimabue è stato superato da Giotto nella pittura, “così ha tolto l’uno a l’altro Guido / la gloria de la lingua; e forse è nato / chi l’uno e l’altro caccerà del nido” (Purg. XI, 79-84, 94-99). L’essere onorati e “illuminati”, vanto della chiesa di Efeso, viene appropriato a Oderisi, “l’onor d’Agobbio” e, in senso equivoco, all’arte della miniatura, “ch’alluminar chiamata è in Parisi” (il francese “enluminer”). Oderisi, con atto di umiltà, afferma che tutto l’onore è di chi gli è subentrato, ed è suo solo in parte.
“Credette Cimabue ne la pittura / tener lo campo”: il verbo tenere designa il potere di Cristo che “tiene” nella mano destra le sette stelle, cioè tutte le chiese presenti e future (cfr. Ap 2, 1), le quali ‘tengono’ un primato solo temporaneo. Non diversamente Provenzan Salvani, un altro purgante nel girone dei superbi, “fu presuntüoso / a recar Siena tutta a le sue mani” (Purg. XI, 121-123).
La gloria preparata per la Sinagoga e poi traslata alla Chiesa di Cristo, o quella che dal quinto stato viene passata al sesto, è appropriata ai due Guidi (per lo più intesi come Guido Cavalcanti e Guido Guinizzelli), che verranno superati dalle nuove rime di Dante (il quale non a caso è “sesto tra cotanto senno” nella “bella scola” dei poeti del Limbo, Inf. IV, 100-102). L’espressione “ha tolto l’uno a l’altro Guido” corrisponde all’evellere per cui il candelabro viene spostato.
I temi propri del primato della chiesa di Gerusalemme, onorata maestra illuminatrice e per lungo tempo sola depositaria della legge divina e del culto, si trovano nelle parole che Dante rivolge a Virgilio subito dopo l’apparizione di questi nella “diserta piaggia”: egli è “onore e lume” degli altri poeti, solo maestro da cui il fiorentino ha tolto “lo bello stilo che m’ha fatto onore”, cioè lo stile tragico o elevato (Inf. I, 82-87). L’espressione “da cu’ io tolsi”, considerato il significato, di passaggio del primato, che il verbo ‘togliere’ assume nel discorso di Oderisi relativo ai due Guidi, adombra forse un’idea di onorevole “translatio” del primato poetico da Virgilio a Dante (senza, ovviamente, alcun riferimento alla superbia). Non diversamente si rivolge Stazio a Virgilio, che per primo lo avviò alla poesia e lo illuminò nella fede cristiana (Purg. XXII, 64-66: non c’è il verbo ‘togliere’, ma a Virgilio è attribuito per due volte un “prima”; “tamquam per eam illuminati in Christo et tracti ad Christum … e prima appresso Dio m’alluminasti).
In Purg. XI, per bocca di Oderisi da Gubbio che purga la superbia nel primo girone della montagna, Dante fa dunque risuonare i temi propri del primato della superba chiesa di Gerusalemme, onorata maestra illuminatrice e per lungo tempo sola depositaria della legge divina e del culto, primato traslato ad altri per presunzione e minacciato ad Efeso, la principale delle sette chiese d’Asia. L’esegesi della prima chiesa (Ap 2, 5) è da collazionare con quella della prima tromba (Ap 8, 7), la quale risuona contro la durezza giudaica che non volle riconoscere Cristo. Il male venuto sui Giudei viene così espresso: “e la terza parte della terra fu combusta, e la terza parte degli alberi fu bruciata e ogni erba verde fu combusta”. Secondo una delle interpretazioni proposte, nessuno che non sia fermo nella fede e nella carità come la terra o un albero può vincere quella che fu la tentazione giudaica contro Cristo, forte di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’ (cioè degli avi) e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo. A questa tentazione non può resistere chi è fragile e instabile come l’erba che inaridisce.
Il panno, che cuce insieme Ap 2, 5 (prima chiesa) e Ap 8, 7 (prima tromba), si mostra il medesimo per Inf. X e Purg. XI. Si confrontino, ad Ap 2, 5, le espressioni “Si vero queratur plenior ratio sui casus vel translationis predicte … Primum est inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et primitate, quam scilicet habuit” con le parole “forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”, dette da Dante a Cavalcante (Inf. X, 63), e con “ogn’ uomo ebbi in despetto tanto avante” dette da Omberto Aldobrandesco (Purg. XI, 64), ed anche la superbia di Capaneo, che “ebbe e par ch’elli abbia / Dio in disdegno, e poco par che ’l pregi” (Inf. XIV, 69-70). Per quanto le situazioni siano diverse o solo parzialmente simili e i motivi variamente appropriati, la memoria del lettore consapevole doveva essere sollecitata verso quei punti esegetici. In ogni caso habuit, nell’esegesi, è tempo incontestabilmente legato a una “translatio” avvenuta. Nella risposta di Dante a Cavalcante, “ebbe” è parola chiave dell’equivoco: il padre di Guido pensa alla morte corporale; Dante pensa alla traslazione del primato, vivente ancora il primo dei suoi amici, nella “gloria de la lingua”. La domanda di Cavalcante – «piangendo disse: “Se per questo cieco / carcere vai per altezza d’ingegno, / mio figlio ov’ è? e perché non è teco?”» (Inf. X, 58-60) – vuole anche dire: ‘perché mio figlio non è come te sesto, cioè della generazione che ha messo fuori le nove rime?’.
Unito alla primitas da Ap 2, 5, l’avere dalla propria parte “auctoritatem et testimonium maiorum et antiquiorum”, da Ap 8, 7, è nella domanda di Farinata – «guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, / mi dimandò: “Chi fuor li maggior tui?”» (Inf. X, 41-42) –, nelle successive parole dopo che l’ubbidiente poeta tutto gli ha aperto in merito – «poi disse: “Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte”» (ibid., 46-47) -, nonché nel riconoscimento della propria arroganza da parte di Omberto – “L’antico sangue e l’opere leggiadre / d’i miei maggior mi fer sì arrogante” (Purg. XI, 61-62).
“Ma i vostri non appreser ben quell’ arte … forse cui Guido vostro ebbe a disdegno” (Inf. X, 51, 63): alla presunzione del primato politico in Farinata, il quale viene a sapere da Dante che i suoi ghibellini non hanno appreso l’arte di rientrare a Firenze, a differenza degli avversari per due volte dispersi che ne sono stati capaci in entrambi i casi, fa seguito la presunzione che alla poesia basti l’ “altezza d’ingegno” senza guida [21].
Capopopolo e capitano d’arte, Farinata assume la veste di vescovo di una chiesa detentrice di un primato solo temporaneo e soggetto a “translatio”. Ad Ap 2, 1 Olivi precisa che per ‘chiese’ (quelle d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione), le cui qualità positive o negative si sviluppano nella storia, non sono da intendere soltanto i vescovi, perché vi compartecipano tutti i fedeli: “[…] episcopi istarum ecclesiarum non commendantur vel increpantur vel instruuntur solum pro se, sed etiam sub nomine eorum intelliguntur ecclesie ipsorum commendari et increpari et moneri”. Lo dice nel male Farinata, al quale Dante chiede conto dello strazio di Montaperti: “A ciò non fu’ io sol ”, non fu cioè solo lui, capo dei ghibellini, a muovere contro la sua città; lo fece con gli altri della sua parte, assimilata a una ‘chiesa’ (Inf. X, 89-90). Lo ripete nel bene Ugo Capeto, fra gli avari e i prodighi purganti che dicono durante il giorno gli esempi virtuosi: “dianzi non era io sol ” (Purg. XX, 122).
3. Essere “sospesi”: desiderio inappagato di Dio o vita contemplativa?
La descrizione della pena degli eresiarchi conduce ai primi versetti del capitolo IV, in relazione al cielo, cioè alla Scrittura, che viene aperto a Giovanni elevato a visioni sempre più nuove e ardue (Ap 4, 2: “et ecce ostium apertum in celo”; cfr. nota) [22]. Come sulla porta della tomba di Cristo era posta una pietra grande e pesante che fu rimossa al momento della resurrezione e dell’uscita di Cristo dal sepolcro, così il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso all’intelligenza spirituale. Nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. L’assenza di grandi opere nella Chiesa era anch’essa come una porta chiusa che impediva di contemplare la “fabrica ecclesie”. Colui che per primo aprì la porta e diede la prima voce che ci fece salire al cielo fu Cristo, con la sua illuminazione e dottrina. La voce degli antichi profeti, che chiuse la porta con figure e promesse terrene, depresse il senso carnale dei Giudei piuttosto che elevarlo. Cristo, invece, con l’esempio della sua vita spiritualissima, con la morte della sua carne e con l’abbondante infusione del suo spirito, fece in modo che gli apostoli e qualunque uomo spirituale fossero in spirito e quasi non in carne (“et statim fui in spiritu”), secondo quanto detto ai Corinzi da san Paolo: “L’uomo animale non percepisce né può comprendere le cose dello Spirito di Dio, l’uomo spirituale invece giudica ogni cosa”, cioè è dotato di discernimento (1 Cor 2, 14-15). Cristo, in Giovanni 10, 1-9, definisce sé “porta” e “portinaio”. Chi con chiara fede e intelligenza si fissa in lui in modo che gli venga incontro in ogni luogo della Scrittura e in ogni fatto della Chiesa, lo avrà in quei luoghi e in quei fatti come il sole che irraggia fugando le tenebre.
Il tema, da Ap 4, 2, della pietra rimossa che chiudeva la tomba, congiunto con quello della durezza, si trova nelle arche degli eretici, “monimenti”, o “sepolcri”, dai “coperchi” “sospesi” e “levati” fino al momento in cui verranno chiusi il giorno del giudizio, ma dai quali “fuor n’uscivan sì duri lamenti” (Inf. IX, 121-123, 131; X, 7-12).
Questi significati, appropriati alle arche infuocate, non escludono il senso letterale, in cui sono racchiusi; si tratti di un calco dei roghi comminati come pena degli eretici da Federico II [23] oppure del Salmo 48, 12-13, dove è presente la medesima equiparazione fra uomini e bestie data da Ecclesiaste 3, 18-19, con l’aggiunta: “sepulchra eorum domus illorum in aeternum”, luogo addotto da Salimbene nel noto passo su Federico II epicureo.
L’essere “sospesi” ha qui un senso proprio, da connettere alla contemplazione. Dei quattro animali (leone, bue o vitello, simile a un uomo, aquila) che ad Ap 4, 7-8 sono in mezzo e intorno al trono della sede divina, quello simile a un’aquila che vola designa coloro i quali “sono sospesi nella contemplazione” (“in aquila [accipiamus] contemplatione suspensos”). L’apertura del coperchio ‘sospeso’ delle arche allude dunque alla possibilità di vedere il futuro da parte dei dannati. Farinata vede, cioè contempla, le cose che sono lontane nel tempo, senza sapere nulla degli eventi vicini o presenti (Inf. X, 97-108). Ma questa “mala luce”, cui fa riferimento la sospensione del coperchio, verrà meno il giorno del giudizio, allorché non ci sarà più futuro e l’avello verrà chiuso e con esso l’accesso all’illuminazione divina che “cotanto ancor ne splende” e consente al ghibellino di profetizzare l’esilio di Dante.
Di qui il valore equivoco dell’esser “sospesi”, che designa sì lo stato di coloro che, nel Limbo, vivono in eterno nel desiderio di Dio senza speranza di appagamento, ma pure lo stato di chi, contemplando, è capace di vedere più degli altri. Il volare di Omero sopra gli altri è un filo tratto dalla quarta tromba (il quarto stato è per antonomasia quello dei contemplativi): si tratta di un’altra citazione gioachimita, relativa a Gregorio Magno che molto scrisse sulla fine del mondo e che seppe meglio di chiunque percorrere i sentieri dell’allegoria, “ardue vie del cielo” (Ap 8, 13): “quique allegoriarum semitas ac si arduas celi vias altius pre ceteris prevolavit │ che sovra li altri com’ aquila vola” (Inf. IV, 96) [24].
In tal senso è da intendere la curiosa terzina riferita a Maometto in Inf. XXVIII, 61-63, il quale nella nona bolgia parla di Fra Dolcino ‘sospendendo’, cioè alzando, un piede per rimettersi in cammino e distendendolo poi a terra, finito di parlare, nell’allontanarsi. Maometto è dotato di spirito profetico, per cui contempla la futura fine (nel 1307) dell’eretico novarese per “stretta di neve” e fa concordare il movimento del piede con il quarto senso della Scrittura, l’anagogico, assimilato all’aquila sospesa nella contemplazione e al profetare. Cessata la profezia, il piede si distende per terra in quanto dal senso anagogico, in virtù del quale stava sospeso, scende al senso letterale designato dal vitello (o bue) che solca la terra [25]. Maometto riprende “la dolente strada” verso il diavolo che riapre le ferite con la spada, perché tale è “il martiro” inflitto ai seminatori di scandalo e di scisma, e anche questo concorda con l’animale sofferente, aggiogato, destinato al martirio che designa il senso storico o letterale.
L’essere sospesi nella contemplazione come un’aquila (Ap 4, 7-8) si accompagna allo stare fissi nel tempio come una colonna, proprio della sesta vittoria (Ap 3, 12) [26]. Ne è esempio Beatrice la quale, nell’attesa che le schiere del trionfo di Cristo discendano al cielo delle stelle fisse, “stava eretta e attenta”, “sospesa e vaga” verso il mezzogiorno, come sta l’uccello che con ardente affetto attende la luce del sole (Par. XXIII, 1-15: l’attendere è tema del quinto sigillo, ad Ap 6, 11; il meriggio è proprio del sesto stato, allorché la faccia di Cristo luce come il sole in tutta la sua virtù, ad Ap 1, 16). Ne è ulteriore esempio il pellegrino che, pervenuto all’Empireo, “si ricrea / nel tempio del suo voto riguardando” e comprende con lo sguardo la forma generale del paradiso “in nulla parte ancor fermato fiso”, per cui si rivolge a Beatrice desideroso di domandare “di cose / di che la mente mia era sospesa” (Par. XXXI, 43-57).
‘Sospeso’ ha però anche un senso negativo di interruzione del canto di lode cui subentra il pianto, secondo quanto è scritto nel Salmo: “Sui fiumi di Babilonia sedevamo piangendo, e ai salici sospendemmo le nostre cetre dicendo: come canteremo il cantico del Signore in una terra straniera?”, cioè in Babilonia (Ps 136, 1-4). Ne conseguono, analogicamente, confusione, disordine nelle virtù, pianto, ‘sospensione’ del parlare (a Purg. XXXI, 9, “li organi suoi”, cioè quelli che esprimono la voce di Dante, fa segno mnemonico degli “organa nostra”, cioè delle cetre, di cui dice il Salmo), come nel corso del ‘giudizio’ che Dante deve sostenere di fronte a Beatrice apparsagli nell’Eden [27].
Il dubbio di Cavalcante, espresso in forma interrogativa, si appunta sulla lacrimosa espressione: “mio figlio ov’ è? e perché non è teco?” (Inf. X, 60). A lui, dannato, è appropriato il forte pianto di Giovanni ad Ap 5, 4. Questo pianto, sostiene Olivi, è proprio dei momenti (al tempo degli apostoli, delle grandi eresie e dell’Anticristo) nei quali quanti sono inconsapevoli della ragione che permette le tribolazioni e le “pressure” causate dalle eresie, e il terrore provocato dall’imminenza dei pericoli, piangono e sospirano affinché il libro segnato da sette sigilli venga aperto, almeno per la parte che è consentito aprire in quel tempo. Il pianto di Cavalcante, quasi un lamento femminile [28], si ritroverà nel pianto di Lavinia per la morte suicida della madre Amata, della quale non comprende il motivo (“O regina, / perché per ira hai voluto esser nulla?”, Purg. XVII, 35-36). Il dubbio inconsapevole si insinua anche nella statuaria effigie di Farinata: “E se tu mai nel dolce mondo regge, / dimmi: perché quel popolo è sì empio / incontr’ a’ miei in ciascuna sua legge?” (Inf. X, 82-84). A differenza di Cavalcante non vi sarà pianto, ma solo sospiro dopo la risposta di Dante.
Così piange la Roma «vedova e sola, e dì e notte chiama: / “Cesare mio, perché non m’accompagne?”» (Purg. VI, 112-114), nella “pressura” dei “gentili” (ibid., 109-110; hapax): l’apostrofe ad Alberto tedesco ripete quattro volte (ibid., 106, 109, 112, 115) il “veni et vide” apocalittico detto a Giovanni all’apertura dei primi quattro sigilli. Anche Virgilio mostra di non comprendere la ragione della ‘pressura’ di Dante nella “diserta piaggia”: “Ma tu perché ritorni a tanta noia?” (Inf. I, 76). Il lutto, proprio di Lavinia, segna anche Aristotele e Platone e molti altri, dei quali dice Virgilio, che desiderarono vedere tutto senza frutto, “tai che sarebbe lor disio quetato, / ch’etternalmente è dato lor per lutto” (Purg. III, 34-45); in questo caso il sospiroso desiderio, che fu già dei Padri nel Limbo, di vedere tutto il libro aperto (che solo Cristo, nei suoi tre avventi, avrebbe aperto compiutamente) sostituisce il pianto.
[nota alla tabella precedente]
Il tema giovanneo di Cristo come porta – “Ego sum hostium. Per me, si quis introierit …” – inizia, con l’anafora del “per me”, i tre versi della prima terzina che contiene la scritta della porta dell’inferno. Su di essa sono scritte parole di colore oscuro e dal senso duro, non solo minacciose, ma pure chiuse a ogni illuminazione spirituale (Inf. III, 10-12). I motivi del chiudere e della durezza segnano la descrizione del fondo dell’inferno, “nel loco onde parlare è duro”, che necessita di rime “aspre e chiocce”: in suo aiuto il poeta invoca le Muse, che aiutarono Anfione “a chiuder Tebe” traendo con il suono della lira le pietre delle mura dalle falde del monte Citerone (Inf. XXXII, 10-14). È anche “cosa dura” dire della “selva selvaggia e aspra e forte” (Inf. I, 4-5).
L’Inferno è la cantica dell’antica durezza lapidea, dell’impetrarsi, del parlare duro di cose dure a dirsi, del duro giudizio, del senso duro della scritta al sommo della porta, dei duri lamenti, dei duri demoni, dei duri veli del gelo, della gravezza. Il conte Ugolino incarna la durezza nel più alto grado. Eppure, da peccatore dannato, alle parole del poeta “la bocca sollevò dal fiero pasto”, quasi aprendo per un attimo uno spiraglio nella sua bestialità. Quel “sollevò” contiene in sé il tema, da Ap 4, 1-2, dell’aprirsi della porta alla voce di Cristo che solleva con la sua illuminazione e dottrina dal senso carnale chiuso e impetrato. E ciò anche se il levarsi avviene per puro odio, affinché le parole che seguono “esser dien seme / che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo”, ed anche se al termine del suo parlare e lacrimare insieme il conte riprende a rodere coi denti il misero teschio del vicino. Solo la parola del poeta riesce per un attimo a farlo levare, ripetendo nel “cieco carcere” senza tempo il gesto compiuto dai suoi figli nella Muda, i quali “di sùbito levorsi” allorché videro il padre mordersi le mani. Più avanti, nella Tolomea, a frate Alberigo non saranno ‘levati’ dal viso i duri veli (Inf. XXXIII, 112). A Filadelfia, la sesta chiesa d’Asia, viene data la libertà di parlare per dettato interiore (le viene aperto l’ “ostium sermonis”, Ap 3, 8). Questo tema cristiforme è cantato anche nell’inferno. Far parlare liberamente, per dettato interiore, quasi invitando a un convivio spirituale e rompendo, per quanto dura il parlare, la vecchia roccia infernale, corrisponde alla poetica di Dante che nasce per interno dettato e ispirazione d’Amore, dietro al quale il poeta si tiene stretto come alla sua Regola. Così i dannati vengono con desiderio e volontario consenso, con “disio” e con “velle”, e varcano questa ideale porta aperta al parlare in una pausa di conversione e di pace. All’ “affettuoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono “dal voler portate” verso un momento di mutazione, sebbene limitata al successivo colloquio, “mentre che ‘l vento, come fa, ci tace”. Tutto l’Inferno è un contrappunto tra la durezza del giudizio eterno e l’attimo in cui la parola, quasi frangendo il giudizio, sospende la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi subitamente per poi ricadere al modo di Ciacco, sollevarsi da atti bestiali per ritornare ad essi dopo aver parlato, come nel conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per sé stesse mosse, sta un solo desiderio, il vivere ancora nel grande libro che è stato a Dante aperto e che questi trascrive nel corso del suo viaggio. [Sul conte Ugolino cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, 2.7, tab. X; L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno, 2, tab. IV, V, 1-6]
Il levarsi quasi al di fuori del corpo, in puro spirito, viene sperimentato dal poeta nell’ascesa al cielo, cui viene levato grazie al lume divino riflesso in lui dagli occhi di Beatrice, e si esprime nelle parole “S’i’ era sol di me quel che creasti / novellamente, amor che ’l ciel governi, / tu ’l sai …”, cioè solo Dio sa se io ero solo anima o anche col corpo, che corrisponde nell’esegesi al “fecit suos apostolos et quoscumque spirituales suos esse in spiritu et quasi non esse in carne”, per quanto fossero ancora in vita (Par. I, 73-75; gli echi del passo paolino [2 Cor 12, 2-4] sono incastonati nell’esegesi apocalittica, dove pure è citato san Paolo, in un passo diverso [1 Cor 2, 14-15]). Creato “novellamente” fu lo spirito, da ultimo, dopo il corpo: nel commento dell’Olivi l’aggettivo “novus”, appropriato alla visione, è collegato all’essere “in spiritu” di Giovanni (Ap 4, 1).
Di fronte al “muro” della fiamma, si apre la durezza di Dante al nome di Beatrice, “come al nome di Tisbe aperse il ciglio / Piramo in su la morte, e riguardolla” (Purg. XXVII, 34-42); i motivi del levarsi e del diradarsi delle tenebre sono, dopo l’ultima notte, congiunti nella salita all’Eden: gli “splendori antelucani” mettono in fuga le tenebre e il sonno del poeta, che si leva al vedere già levati i due “gran maestri” Virgilio e Stazio (ibid., 109-114).
Il diradarsi delle tenebre è accostato al discernere (nel senso del discernere le cose dello spirito) nel Limbo: un “foco” rompe le tenebre a metà, e il poeta, pur da lontano, discerne che il luogo è posseduto da gente degna di onore (Inf. IV, 67-72).
____________________________________________________________________________________________________________________
[LSA, cap. IV, Ap 4, 7-8 (radix IIe visionis)] Dividit (Ioachim) enim viginti quattuor legiones in quattuor partes secundum quattuor animalia, ita ut in leone accipiamus fortes in fide, in vitulo autem robustos in patientia, in homine preditos scientia, in aquila contemplatione suspensos.[LSA, cap. VI, Ap 6, 6 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] (secundum Ioachim) Per ordeum vero designatur (intelligentia) ystorica seu litteralis, que habet tres bilibres propter sex tempora laboriosa et servilia sub servitute legis currentia ab Abraam usque [ad] Iohannem Baptistam, que Mattheus enumerat per tres quaterdenas generationum (cfr. Mt 1, 1-17). Et quia quelibet quaterdena duas habet hebdomadas seu septenas, ideo hic vocantur “tres bilibres ordei”. […] Secunda (intelligentia) vero convenit secundo (animali), scilicet vitulo, quia instar vituli sulcat terram, id est terrena et corporalia gesta patrum, et etiam quia martires per vitulum designati predicaverunt paganis, qui ystoricam litteram legis et prophetarum non noverant, et ideo ante allegoriam oportuit eos doceri ystoriam. […] |
|
Inf. II, 52-54Io era tra color che son sospesi,
|
Inf. IV, 43-45, 94-96Gran duol mi prese al cor quando lo ’ntesi,
|
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 13 (IIIa visio, IVa tuba)] Per aquilam designantur hic alti contemplativi quarti temporis, qui prophetico spiritu presenserunt et predixerunt mala que post finem quarti temporis debebant subsequi. Inter quos credit Ioachim per hanc aquilam specialius designari beatum papam Gregorium, qui utique fuit in quarto tempore, prout supra fuit in principio prenotatum. Ipse enim «libere plurima de mundi fine et de pressura seculi scripsisse dinoscitur, quique allegoriarum semitas ac si arduas celi vias altius pre ceteris prevolavit, neque enim invenitur alius similis eius, qui ista erumpnosa tempora appropinquasse in suis operibus testaretur». Hec Ioachim. |
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 8 (IVa visio, VIum prelium)] Secundus autem angelus seu doctor predicat amotionem precipui impedimenti ad agendum predicta seu expeditionem intrinseci et domestici obstaculi. Predicat enim casum Babilonis, id est ecclesie carnalis, dicens: “Cecidit, cecidit Babilon illa magna” (Ap 14, 8).
|
Purg. XXXI, 7-15Era la mia virtù tanto confusa,
|
4. La vittoria dei contemplativi
Nella prima visione apocalittica, a ciascuna delle sette chiese d’Asia è data una vittoria (le sette vittorie sono trattate in principio del cap. II della LSA, anche se, per la quinta, la sesta e la settima chiesa, si riferiscono formalmente al cap. III). La più importante è quella conseguita da Filadelfia, la sesta chiesa, perché la visione è maggiore; essa porta a consumazione la vittoria conseguita da Tiàtira, la quarta chiesa, che rappresenta per antonomasia lo stato dei contemplativi.
La sesta vittoria (Ap 3, 12) per Olivi è l’ingresso in Cristo, che si consegue con una perfetta configurazione e trasformazione della mente in lui. Del vincitore si dice: “lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà più; scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo dal mio Dio, insieme al mio nome nuovo”. Chi entra in Dio riceve Dio dentro sé e Dio entra in lui. L’ingresso avviene in due modi. Il primo con l’essere stabilito nella Chiesa o nella vita religiosa per mezzo della professione; il secondo con la contemplazione, che apprende Dio e le sue opere.
Il primo ingresso è reso con l’immagine della colonna che sta all’interno del tempio, immobile, lunga, eretta, solida, densa, rotonda o quadrata, ferma, fissa, sostentativa e decorativa: così sta, nella Chiesa, nella vita religiosa, o nella curia celeste, un uomo evangelico configurato a Cristo. Sostiene, in quanto superiore, gli inferiori; si contrappone, con la sua semplicità e spiritualità, alla grossezza degli altri, per i quali si pone come il centro della sfera: la colonna, infatti, occupa meno spazio del tempio che sostiene. Stare fisso nel tempio indica il divieto di qualsiasi apostasia, negozio o distrazione temporale.
Il secondo ingresso viene indicato con lo scrivere nella mente il nome di Dio, il nome della nuova Gerusalemme che discende dal cielo e il nuovo nome di Cristo.
In primo luogo, viene inscritta la visione e la contemplazione della divinità delle tre persone. In secondo luogo, la visione della città, ossia del collegio dei santi, che si dice discendere dal cielo sia perché da Dio deriva, sia perché inferiore all’immensità divina designata con il cielo, sia per l’umiltà con cui si reputa indegna non solo di Dio ma anche del proprio celeste luogo, sia in quanto Chiesa militante che riceve le grazie da Dio e dalla gerarchia dei beati. Viene chiamata “nuova” per la novità della grazia e della gloria; è la Chiesa dei beati ma anche quella che, in questo mondo, è stata finora nei primi cinque stati dopo la venuta di Cristo e il ripudio della vecchia legge, e sarà nel sesto (nei tempi ‘moderni’) e settimo stato. Viene chiamata “Gerusalemme”, ossia “visione della pace”, perché di essa gusta o ad essa sospira.
In terzo luogo, viene inscritta la visione di Cristo uomo, nostro redentore e mediatore. Il suo nome viene definito “nuovo” sia per la novità della resurrezione e della gloria, sia perché l’unione personale della divinità e dell’umanità e in generale quanto si trova in lui contengono e palesano una mirabile novità.
E come la città discende da Dio e poi a lui ritorna, così la contemplazione, formando un circolo glorioso, inizia da Dio e per la città di Dio ascende in Cristo suo re, da dove ritorna e rientra in Dio.
Il nome di Dio padre viene inscritto quando l’immagine paterna si imprime come quella di un padre spirituale nella prole, di un abate nella propria religione.
Il nome della nuova Gerusalemme si inscrive allorché la mente, per la soavità dell’amore, è degna di essere definita sposa di Cristo e pia madre e nutrice di prole spirituale.
Il nuovo nome di Cristo viene inscritto intendendo “cristiano” come “unto del Signore”, nel senso del Salmo 104, 15: “Non toccate i miei consacrati”.
I temi della sesta vittoria forniscono molto panno ai versi, che ad essi rinviano con parole-chiave che costituiscono imagines agentes sulla memoria del lettore spirituale. Nel primo momento della visione finale, in cui vede l’unità dell’universo in Dio, Dante sta come una colonna nel tempio, con la mente “fissa, immobile e attenta” (Par. XXXIII, 97-98), di fronte a una luce che non consente di “volgersi da lei per altro aspetto”, come lo stare fisso nel tempio non consente distrazioni (ibid., 100-105). Si tratta di motivi connessi nell’esegesi con la totale configurazione e trasformazione in Cristo dell’uomo evangelico. Stare “tutto fisso” nella contemplazione è tema presente anche ad Ap 19, 17, proprio dell’angelo che, con gli occhi fissi al sole, invita al convivio spirituale. Ne è ancora esempio Beatrice la quale, nell’attesa che le schiere del trionfo di Cristo discendano al cielo delle stelle fisse, “stava eretta e attenta”, “sospesa e vaga” (l’essere ‘sospesi’ designa pure il contemplare: è appropriato all’aquila ad Ap 4, 7-8) verso il meridiano, cioè verso quella parte del cielo dov’è il sole a mezzodì, come sta l’uccello che con ardente affetto attende la luce del sole (Par. XXIII, 1-15: l’attendere è tema del quinto sigillo, ad Ap 6, 11; il meriggio è proprio del sesto stato, allorché la faccia di Cristo luce come il sole in tutta la sua virtù, ad Ap 1, 16). Ne è ulteriore esempio il pellegrino che, pervenuto all’Empireo, “si ricrea / nel tempio del suo voto riguardando” e comprende con lo sguardo la forma generale del paradiso “in nulla parte ancor fermato fiso”, per cui si rivolge a Beatrice desideroso di domandare “di cose / di che la mente mia era sospesa” (Par. XXXI, 43-57). Nel cielo Stellato, degli apostoli Pietro e Giacomo il poeta dice che “tacito coram me ciascun s’affisse”; di Giacomo è proprio lo scrivere sulla speranza (star fisso e scrivere sono i due elementi della sesta vittoria, e tra l’altro sono in rima; la speranza, ad Ap 21, 16 [cfr. nota] corrisponde all’altezza della città celeste), anzi il suo ‘figurarla’ tante volte quante Cristo mostrò la sua predilezione ai tre maggiori apostoli (Par. XXV, 25-33). Nel meriggio dell’Eden, le sette donne “s’affisser” dinanzi alla sorgente del Lete e dell’Eunoè (Purg. XXXIII, 103-111). Il tema della colonna interviene nel riconoscimento del ruffiano Venedico Caccianemico: “Per ch’ ïo a figurarlo i piedi affissi” (Inf. XVIII, 43; i dannati sono immagini ‘torte’ di Cristo). Ha poi un’applicazione più letterale ai superbi purganti i quali, curvi sotto il peso di grossi macigni, paiono mensole che sostengono tetti (Purg. X, 130-132).
Nella visione finale di Dio, il poeta vede prima l’unità dell’universo in Dio (Par. XXXIII, 85-93), poi contempla il mistero della Trinità (ibid., 115-120), infine quello dell’Incarnazione (ibid., 127-145). La contemplazione dell’unità dell’universo in Dio è assimilata all’interno del libro segnato da sette sigilli (i temi provengono dalla parte proemiale o radicale della seconda visione; cfr. nota). La contemplazione della Trinità e quella di Cristo in quanto uomo si conseguono con la sesta vittoria: “In huius[modi] autem mente tria inscribuntur, scilicet excessiva visio vel contemplatio deitatis trium personarum // parvermi tre giri / di tre colori e d’una contenenza … Tertium quod sibi [in]scribitur est contemplatio Christi secundum quod homo et secundum quod redemptor noster et mediator // mi parve pinta de la nostra effige”. “Qual è ’l geomètra che tutto s’affige / per misurar lo cerchio” (nel “tutto s’affige” è il tema della colonna), Dante si trova di fronte “a quella vista nova” – il “nomen novum” di Cristo uomo, redentore e mediatore -, incapace di comprendere come l’effigie umana si adatti e si collochi nel cerchio (tema del “circulus gloriosus”; Par. XXXIII, 133-138).
Il tema della “visio pacis” e della contemplazione come circolo appare nella rosa celeste, che ha la sua pace solo nel vedere Dio, distendendosi “in circular figura” (Par. XXX, 102-103). Da notare che la ‘circolarità’ è propria sia della rosa, cioè della città – “Vedi nostra città quant’ ella gira” dice Beatrice (ibid., 130) -, da cui le schiere del trionfo di Cristo, insieme a questi e sua madre, sono in precedenza discese al cielo delle stelle fisse per poi risalire all’Empireo (Par. XXIII; XXVII, 67-72); sia del Figlio fattosi uomo nella visione finale – “Quella circulazion che sì concetta / pareva in te come lume reflesso” (Par. XXXIII, 127-132). Contemplare e gustare la pace in questo mondo sono appropriati a san Bernardo (Par. XXXI, 110-111): l’esegesi della sesta vittoria è da collazionare con un passo del notabile VIII del prologo della Lectura, relativo al settimo stato, nel quale si potrà pregustare in questa vita, poco prima della fine del mondo, la vita eterna.
L’ingresso (in Cristo) e il ritorno (appropriato alla contemplazione, che ritorna in Dio), insieme combinati (“intrammo a ritornar”), sono motivi della salita di Dante e Virgilio per il “cammino ascoso” attraverso il quale escono “a riveder le stelle” (Inf. XXXIV, 133-134). L’ascesa al cielo del poeta è un tornare al proprio sito (Par. I, 92-93); il suo “trasumanar” avviene fissando gli occhi al sole, atto che si genera da quello di Beatrice come il raggio riflesso suole generarsi dal raggio di incidenza “e risalire in suso, / pur come pelegrin che tornar vuole” (ibid., 49-51). Nella candida rosa, i beati – “quanto di noi là sù fatto ha ritorno” – stanno “intorno intorno” e sopra la luce divina (Par. XXX, 112-114, dove la circolarità è in rima col tornare; cfr. Par. IX, 107-108: “… e discernesi ’l bene / per che ’l mondo di sù quel di giù torna”, cioè lo circuisce ma anche lo trae col desiderio di ‘tornare’ a lui; e Par. XI, 13-15: “Poi che ciascuno fu tornato ne lo / punto del cerchio in che avanti s’era”). Discendere e risalire, prerogativa della città dei contemplativi, appartiene agli angeli che s’infiorano come api, partecipando ai beati la pace e l’ardore, e poi ritornano “là dove ’l süo amor sempre soggiorna” (Par. XXXI, 4-18).
Il discendere dal cielo della città è appropriato a Beatrice, donna scesa dal cielo, come dice Virgilio a Catone (Purg. I, 53): il “nome nuovo” di Gerusalemme è d’altronde assimilato a una madre pia e nutrice di prole spirituale. La donna discende al Limbo da Virgilio ma arde di tornare all’Empireo (Inf. II, 82-84).
L’ingresso in Cristo e la pace sono congiunti nel parlare di Casella, secondo il quale l’angelo nocchiero, che porta le anime dalla foce del Tevere alla riva del purgatorio, “veramente da tre mesi”, ossia dall’indizione del Giubileo il 22 febbraio 1300 (con effetto retroattivo al Natale 1299), “elli ha tolto / chi ha voluto intrar, con tutta pace” (Purg. II, 98-99).
Nella profezia fatta dal goloso Bonagiunta, una donna di nome Gentucca farà piacere al poeta Lucca, città altrove ripresa a motivo dei barattieri: più oltre, l’angelo della temperanza – il sesto angelo dei gironi della montagna – indica ai tre poeti che “quinci si va chi vuole andar per pace” (Purg. XXIV, 43-45, 141).
Il tema dell’iscrizione del nome di Dio padre, immagine paterna che si imprime come quella di un padre spirituale nella prole, di un abate nella propria religione, tocca la mente di Dante nella quale è fitta “la cara e buona imagine paterna” di Brunetto Latini, che gli insegnava “come l’uom s’etterna”, immagine che ora l’ “accora” per “lo cotto aspetto” e “’l viso abbrusciato” (Inf. XV, 82-85). Anche nell’inferno esistono momenti di apertura all’imitazione di Cristo, per quanto solo nel ricordo della vita passata. Come pure sono presenti momenti di quiete e di silenzio, tipici del settimo stato (Francesca parla e ascolta “mentre che ’l vento, come fa, ci tace”, Inf. V, 94-96). Brunetto, poco prima, ammonisce i fiorentini a ‘non toccare’ la pianta in cui rivive il santo seme dei Romani, trasponendo su Dante, unto di Dio, quanto scritto nel Salmo 104, 15 sul popolo di Israele (Inf. XV, 73-78) [29]. Lo stesso tema della “paternitatis imago”, unito a quello della soavità d’amore per cui si inscrive il nome della nuova Gerusalemme, ritorna con Guido Guinizzelli, “il padre / mio e de li altri miei miglior che mai / rime d’amor usar dolci e leggiadre”, il quale parla di Cristo come “abate del collegio” per chiedere a Dante di recitare “un paternostro” (Purg. XXVI, 97-101, 127-130; da notare, qui e nel caso di Brunetto, l’uso di “quando”).
Il tema del ritorno, unito a quello della soavità d’amore espressa nel nome della nuova Gerusalemme, è nelle parole dello scomunicato Manfredi, che conosce come la maledizione dei pastori (la quale appartiene alla vecchia legge) non impedisce “che non possa tornar, l’etterno amore, / mentre che la speranza ha fior del verde” (Purg. III, 133-135; da notare i motivi del ritorno e dell’ingresso nelle parole delle anime purganti, ibid., 100-102: «“Tornate”, disse, “intrate innanzi dunque”»).
Sposa e Pia – altri due motivi propri del nome della nuova Gerusalemme inscritto nella mente – è colei che chiede al poeta di ricordarla ai vivi: “Deh, quando tu sarai tornato al mondo / e riposato de la lunga via …” (Purg. V, 130-136). Tornare al mondo, dopo tanto viaggio, è come conseguire la sesta vittoria, dopo la piena contemplazione, propria dell’uomo evangelico; riposarsi equivale a trionfare nello stadio. La misura della città celeste, descritta nella settima visione (Ap 21, 16), è di 12.000 stadi (i lati della città sono uguali). Lo stadio è lo spazio al cui termine si sosta o “si posa” per respirare e lungo il quale si corre per conseguire il premio. Esso designa il percorso del merito che ottiene il premio in modo trionfale, secondo quanto scrive san Paolo ai Corinzi: “Non sapete che tutti corrono nello stadio, ma di costoro uno solo prende il premio?” (1 Cor 9, 24). Ciò concorda con il fatto che lo stadio è l’ottava parte del miglio, e in questo senso designa l’ottavo giorno di resurrezione. L’ottava parte del miglio corrisponde a 125 passi, che rappresentano lo stato di perfezione apostolica adempiente i precetti del decalogo (12 apostoli x 10 comandamenti), cui si aggiunge la pienezza dei cinque sensi e delle cinque chiese patriarcali. Dicendo “e riposato de la lunga via”, la Pia identifica il viaggio del suo interlocutore con lo stadio paolino, al termine della corsa che conquista trionfalmente il premio. Della città misurata dallo ‘stadio’, chiamata anche ‘visione di pace’, partecipa la Pia, la quale sta nel gruppo di spiriti “ben nati” e usciti di vita “a Dio pacificati” ai quali si rivolge il poeta proprio in nome della pace (Purg. V, 56, 58-63). Per lei certamente la morte violenta subìta è sentita come «un ricordo di dolce speranza femminile: quella speranza fu illusoria quanto al suo oggetto, ma ben autentica nel soggetto, e vive ancora come sentimento del bene, e si conserva come “gemma” preziosa» [30]. Ma il sentimento realistico, la dolce speranza femminile illusa, è rivissuto da un’anima che spera di diventare “cittadina d’una vera città”, come dirà Sapia senese (Purg. XIII, 94-96). Di questa città chiamata, ad Ap 21, 2, “sposa” [31], fa segno la Pia. Le fondamenta della città sono ornate con dodici pietre preziose: diaspro, zaffiro, calcedonio, smeraldo, sardonice, cornalina, crisòlito, berillo, topazio, crisopazio, giacinto, ametista (Ap 21, 19-20) [32]. Queste gemme sono virtù. Nel “poema sacro” si impersonano nei beati, come nella “luculenta e cara gioia” (Folchetto di Marsiglia, Par. IX, 37) o nelle “molte gioie care e belle” dei solari spiriti sapienti, tanto ineffabili che si trovano solo nella “corte del cielo” e da essa non si possono sottrarre (Par. X, 70-72). Oppure può trattarsi effettivamente di virtù, come nel caso della fede – “questa cara gioia / sopra la quale ogne virtù si fonda” (corrisponde al verde diaspro, prima pietra fondante; cfr. il passo simmetrico di Ap 21, 12, relativo al muro della città, di verde diaspro per viva fede) – dal poeta professata a san Pietro (Par. XXIV, 89-91). Può essere una vera “gemma”, come quella con cui la Pia fu “ ’nnanellata pria / disposando”, che fa però segno di altro.
L’arrivo al cielo della Luna è tanto veloce quanto il ‘posarsi’ di una freccia (“un quadrel”, per concordare con l’ambito tematico della città: «“Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum”»: Dante stesso pone sé “in quadro”, per sentirsi “ben tetragono ai colpi di ventura”, Par. XVII, 23-24), la quale vola dopo essersi staccata dalla balestra (Par. II, 23-25). Dal momento in cui inizia la descrizione dell’ascesa al cielo (con il verso 43 del primo canto del Paradiso), fino al congiungersi “con la prima stella” (che coincide – “giunto mi vidi” – con il 25° verso del secondo canto), sono esattamente 125 versi (100 nel primo canto, 25 nel secondo), come i passi dello stadio (Ap 21, 16). La navigazione, della quale il poeta ha premesso in principio di Par. II, è dunque un correre al premio paolino (“L’acqua ch’io prendo già mai non si corse”), un solcare “l’acqua che ritorna equale” (la Scrittura) verso Dio, “la prima equalità” (Par. XV, 74).
Gli angoli delle dodici porte della città (Ap 21, 12; tre per ciascuno dei quattro lati) designano la forza e l’ornato, perché nelle case le pareti si congiungono agli angoli. In tal senso si dice di Cristo che è pietra angolare, oppure in Zaccaria si afferma la futura forza del vittorioso regno di Giuda definendolo angolo, palo e arco, cioè capace di sostenere (Zc 10, 4; qui Olivi si discosta dall’interpretazione di Riccardo di San Vittore, secondo il quale gli angoli designano coloro i quali si distinguono per meriti più occulti). Il tema degli angoli si annida dietro al “congiungersi”: l’arrivo al cielo della Luna è appunto una congiunzione (“giunto mi vidi … che n’ha congiunti con la prima stella”) che avviene velocemente, “… e forse in tanto in quanto un quadrel (“et civitas in quadro posita est”) posa (tema del posarsi o dello stadio, che è misura della città) / e vola e da la noce si dischiava …” (Par. II, 23-30).
I motivi del posarsi e del congiungersi tornano uniti a Par. IV, 127-128, riferiti all’intelletto umano che si riposa nel vero divino “come fera in lustra, / tosto che giunto l’ha; e giugner puollo”, e a Par. VI, 25-27, dove Giustiniano ricorda come i successi militari di Belisario contro i Goti, “cui la destra del ciel fu sì congiunta”, furono segno che dovesse tutto dedicarsi (‘posarsi’) all’alto lavoro di trarre “d’entro le leggi … il troppo e ’l vano”.
A Inf. XV e Par. XXV emerge ancora il tema paolino del vincere il premio correndo nello stadio, che è la misura della città. Nel primo caso allorché Brunetto Latini lascia la compagnia del suo discepolo: “Poi si rivolse, e parve di coloro / che corrono a Verona il drappo verde / per la campagna; e parve di costoro / quelli che vince, non colui che perde” (Inf. XV, 121-124). Più che lo sfuggire alla pena di giacere cent’anni sotto la pioggia di fuoco senza potersi far schermo con le mani in quanto correndo riesce a raggiungere la sua schiera, il premio che egli consegue è la fama del suo Tesoro che ha raccomandato a Dante. Il paragone con il palio di Verona (la corsa a piedi nella prima domenica di quaresima), che chiude il canto, contiene il riferimento alla vittoria nel 124° verso, uno in meno dello “stadio” paolino. Uscire in campo apparendo vittorioso, non pavido o infermo, è tema proprio di Cristo all’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2 [33]. Dal confronto è possibile rilevare più di un aspetto, nel rispondersi fra i due testi: la compresenza di elementi semantici; la collazione di passi simmetrici della Lectura (da Ap 6, 2); una figura retorica (la perissologia, cioè un’affermazione seguita dalla negazione del suo contrario: “e parve di costoro / quelli che vince, non colui che perde”) suggerita dalla prosa (“apparuit in ipso exitu totus victoriosus et ac si iam totus vicisset […] exivit in campum totius orbis non quasi pavidus aut infirmus”); l’appropriazione a Brunetto, che è un dannato, di motivi propri di Cristo. Si è visto sopra come proprio a Brunetto, e così avverrà poi per Guinizzelli, venga attribuito quell’essere abate di una prole spirituale il cui insegnamento si imprime nella mente come l’immagine di Dio padre, cioè uno dei conseguimenti più alti della sesta vittoria, la più cristiforme fra tutte (Ap 3, 12). Nel finale di Inf. XV non viene assegnata a Brunetto una vittoria postuma [34]. Il suo correre non è degradante [35], è però solo parvenza di vittoria, un’imitazione di Cristo non riuscita, una corsa senza vero premio. Chi prenderà quel premio – “la gloria de la lingua” – sarà Dante, il quale, come dice lo stesso Latini, è “sementa santa” dei Romani, vero loro erede nell’universalità dell’eloquio.
A Par. XXV, di san Giacomo è proprio, oltre ai motivi dei lati della città (cfr. Ap 21, 16; cfr. nota), anche il tema della folgorante luce di Cristo (vv. 79-81, dal notabile XII del prologo: “… dentro al vivo seno / di quello incendio tremolava un lampo / sùbito e spesso a guisa di baleno”). Emblematica la presenza del verbo respirare (che è hapax nel poema: «Indi spirò: “L’amore ond’ ïo avvampo … vuol ch’io respiri a te che ti dilette / di lei …”», cioè della speranza; vv. 82-86), richiamato dal ‘posarsi’ nella descrizione finale del quietarsi del suono, dolcemente mischiato, delle voci dei tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, come i remi che “per cessar fatica o rischio … tutti si posano al sonar d’un fischio”, i quali prima percuotevano l’acqua (vv. 130-135). Respirare e posarsi sono segno del conseguimento del premio, dopo il correre nello stadio (Ap 21, 16). “L’uscir del campo” (v. 84) per san Giacomo, una volta conseguita la “palma” del martirio, fu vera vittoria, non sua parvenza come nel caso di Brunetto (ad Ap 6, 2, Cristo esce vittorioso nel campo del mondo; san Giacomo, invece, esce da esso). Il tema del posarsi è congiunto con quello della quiete e della pace proprio del settimo stato, libero da ogni fatica o opera servile (prologo, notabile XIII; cap. X, Ap 10, 5-7).
Con san Domenico, una delle due ruote, insieme a san Francesco, della biga della Chiesa, questa “si difese / e vinse in campo la sua civil briga”, ossia la lotta contro gli eretici (Par. XII, 106-108), altra variazione di Cristo che esce vittorioso nel campo del mondo.
[LSA, cap. II, Ap 3, 12 (Ia visio, VIa victoria)] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et transformationem mentis in ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. Hiis autem promittitur premium de quo sexte ecclesie dicitur: “Qui vicerit, faciam illum columpnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius; et scribam super illum nomen Dei mei et nomen civitatis Dei mei, nove Iherusalem, que descendit de celo a Deo meo et nomen meum novum” (Ap 3, 12). Quod Christus hic vel alibi dicit “Dei mei” vel “a Deo meo”, non dicit nisi tantum ratione sue humanitatis, secundum quam est subiectus Patri et toti Trinitati tamquam Deo suo. Quantum autem ad hoc premium, nota quod quia intrans in Deum recipit intra se Deum, ita quod et Deus intrat in ipsum, ideo hunc duplicem intrandi respectum hic ponit. Primum enim ponit sub typo columpne intra templum existentis et inde non egressure; secundum vero sub typo scripture per quam nomen Dei et sue civitatis inscribitur menti. Et secundum hoc templum significat Deum, prout infra XX[I°] dicitur: “Dominus Deus templum illius est”, scilicet civitatis Dei (Ap 21, 22). Sumendo tamen templum pro ecclesia sustentata a perfectis quasi a columpnis eius, tunc sub alio respectu significatur duplex ingressus. Quia enim et Deum et eius cultum intramus primo per professionis statum, per quem quis in Dei ecclesia et religione statuitur; secundo per contemplationis actum, per quem Deus cum suis operibus apprehenditur, idcirco primum significat per immobilem statum columpne in templo; secundum vero per inscriptionem divinorum in animo.
|
|
Par. XXXI, 43-45, 52-57E quasi peregrin che si ricrea
|
Par. XXXIII, 97-105, 133-134Così la mente mia, tutta sospesa,
|
[LSA, cap. II, Ap 3, 12 (Ia visio, VIa victoria)] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et transformationem mentis in ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. Hiis autem promittitur premium de quo sexte ecclesie dicitur: “Qui vicerit, faciam illum columpnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius; et scribam super illum nomen Dei mei et nomen civitatis Dei mei, nove Iherusalem, que descendit de celo a Deo meo et nomen meum novum” (Ap 3, 12). Quod Christus hic vel alibi dicit “Dei mei” vel “a Deo meo”, non dicit nisi tantum ratione sue humanitatis, secundum quam est subiectus Patri et toti Trinitati tamquam Deo suo. Quantum autem ad hoc premium, nota quod quia intrans in Deum recipit intra se Deum, ita quod et Deus intrat in ipsum, ideo hunc duplicem intrandi respectum hic ponit. Primum enim ponit sub typo columpne intra templum existentis et inde non egressure; secundum vero sub typo scripture per quam nomen Dei et sue civitatis inscribitur menti. Et secundum hoc templum significat Deum, prout infra XX[I°] dicitur: “Dominus Deus templum illius est”, scilicet civitatis Dei (Ap 21, 22). Sumendo tamen templum pro ecclesia sustentata a perfectis quasi a columpnis eius, tunc sub alio respectu significatur duplex ingressus. Quia enim et Deum et eius cultum intramus primo per professionis statum, per quem quis in Dei ecclesia et religione statuitur; secundo per contemplationis actum, per quem Deus cum suis operibus apprehenditur, idcirco primum significat per immobilem statum columpne in templo; secundum vero per inscriptionem divinorum in animo.
|
|
Inf. XV, 82-85ché ’n la mente m’è fitta, e or m’accora,
|
Purg. XXVI, 97-101, 127-132quand’ io odo nomar sé stesso il padre
|
_________________________________________________________________________________________________________________________
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 16 (VIIa visio)] “Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum.
|
|
Par. XV, 73-84Poi cominciai così: “L’affetto e ’l senno,
|
Par. XXXIII, 67-68, 82-84, 91-93, 139-145O somma luce che tanto ti levi
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (Ia visio)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
[Nota alla tabella precedente]
I quattro lati delle mura della città formano un quadrilatero (Ap 21, 16), che designa la solida quadratura delle virtù (a Cacciaguida il poeta dice di sentirsi “ben tetragono ai colpi di ventura”, Par. XVII, 23-24). I quattro lati sono uguali in lunghezza e in larghezza. La città dei beati quanto vede di Dio e dei suoi beni tanto ama, quanto è lunga nella visione tanto si dilata nella carità, quanto si prolunga nell’eterno tanto si dilata nel gaudio giocoso e glorioso. Lo stesso può dirsi di coloro che in questa vita raggiungono la perfezione, i quali quanto conoscono o credono tanto amano, quanto per la speranza si protendono nei beni eterni tanto si dilatano nel gaudio. Nei beati le quattro virtù cardinali – prudenza, fortezza, giustizia e temperanza -, designate dai quattro lati della città, hanno uguale misura. Anche l’altezza è uguale alla lunghezza e alla larghezza, poiché quanto i beati per la visione e per l’amore si protendono in lungo e in largo, tanto si elevano nell’alta lode e nella reverenza verso Dio e nell’alto apprendimento e degustazione della sua sublime maestà. Tuttavia in questa vita l’altezza, proporzionata alla misura della carità e del tendere in Dio, sta comunemente solo nel desiderio e nella speranza di raggiungere la compiuta misura della patria celeste. Un edificio si pone infatti diversamente nel suo inizio e nella perfezione del fine.
Anche un sommario esame rivela quanto siano importanti questi temi nel Paradiso [36]. Beatrice, spiegando la differenza tra l’ordine celeste e quello del mondo, definisce il Primo Mobile come la sfera corporea corrispondente al primo dei cerchi angelici, i Serafini, “che più ama e che più sape” (la larghezza e la lunghezza si equivalgono), invitando Dante ad applicare la sua misura (il misurare la città) al criterio della virtù (i lati della città designano le virtù) e non a quello della grandezza apparente dei cerchi (Par. XXVIII, 70-78). Più avanti la donna dice che tutte le intelligenze “hanno diletto” (il godere giocoso proprio della larghezza e anche la degustazione propria dell’altezza) quanto è profonda la visione di Dio (la lunghezza; ibid., 106-108). Soggiunge che l’essere beato si fonda nell’atto della visione, non nell’atto dell’amore, il quale consegue dal primo (Par. XXVIII, 109-111; cfr. Par. XXVI, 27-29; XXIX, 139-140). Secondo molti interpreti qui Dante accoglie la tesi tomista che fa precedere nella beatitudine l’atto dell’intelletto a quello della volontà se non nel tempo, almeno nella natura e nell’origine. Ernesto Buonaiuti notò una contraddizione tra la terzina di Par. XXVIII, 109-111 e la definizione del Primo Mobile come corrispondente “al cerchio che più ama e che più sape” (ibid., 72), dove invece prevarrebbe la tesi volontaristica francescana in quanto, in questo caso, l’amare è posto prima del sapere [37]. La questione viene affrontata dallo stesso Olivi ad Ap 21, 22, dove i due atti – la “visio” e il “beatificus actus caritatis” – sono considerati tanto compenetrati che nessuno dei due può ritenersi perfetto senza l’altro. Lo stesso Olivi, però, nel Notabile X del prologo della Lectura, afferma che non si può amare se non quello che si conosce, e che quindi la “notitia” precede l’amore come il terzo stato dei dottori (l’intelletto) precede storicamente il quarto stato degli anacoreti (l’affetto) [38]. La stessa questione viene posta nella domanda che Dante fa a Francesca: “Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, / a che e come concedette amore / che conosceste i dubbiosi disiri?”, e riecheggiata nella risposta: “Ma s’a conoscer la prima radice / del nostro amor tu hai cotanto affetto, / dirò come colui che piange e dice” (Inf. V, 118-120, 124-126).
Nei beati, come sa Dante che si rivolge a Cacciaguida, “l’affetto e ’l senno” (la larghezza e la lunghezza) sono di pari peso dal momento in cui essi hanno cominciato a contemplare Dio (definito, per restare nel medesimo ambito tematico, “la prima equalità”, il sole uguale nel calore della carità e nella luce della visione), diversamente dai mortali, nei quali “voglia e argomento” (corrispondenti all’affetto e al senno) hanno ali disuguali (Par. XV, 73-84). Al termine del viaggio, la lunghezza (“il mio disio”, che esprime anche l’altezza, “secundum mensuram sue tensionis”, e dunque la “sete natural” di cui a Purg. XXI, 1-4) e la larghezza (“’l velle”) saranno in Dante “sì come rota ch’igualmente è mossa” (Par. XXXIII, 143-145). Lo Spirito di Cristo, nell’invitare alla gloriosa cena delle nozze dell’Agnello, dice: “Et qui sitit veniat. Et qui vult accipiat aquam vite gratis”, perché, aggiunge Olivi, “nullus cogitur nec potest venire nisi per desiderium et voluntarium consensum” (ad Ap 22, 17) [39]. Nella descrizione dell’empirea rosa, la fiumana luminosa, che prima appariva in lunghezza, successivamente diviene tonda distendendosi in figura circolare, con una circonferenza che sarebbe cintura “troppo larga” per il sole (Par. XXX, 88-90, 103-105). La rosa sempiterna “si digrada” (si allunga nel senso di protendersi), “e dilata” (si allarga) “e redole / odor di lode al sol che sempre verna” (l’elevarsi dell’altezza; ibid., 124-126). Il digradare fa comunque riferimento ai “gradi”, che nella misura della città sono uguali per ciascun lato: secondo Gioacchino da Fiore, ovunque si ritrova il numero 6, in quanto il senario, riflesso su sé stesso ed elevato in alto, dà 36, e 36.000 (6 volte 6000) si ottiene dividendo 144.000 (dodici volte la misura della città, che è di 12.000 stadi) per i 4 lati.
Nel riferire l’ultima visione, Dante prima ricorda “l’abbondante grazia ond’ io presunsi / ficcar lo viso per la luce etterna” (la visione corrisponde alla lunghezza), poi afferma di aver visto la forma universale del nodo che unisce tutte le cose perché, dicendo ciò, prova un godimento più largo (i perfetti, i quali “in gaudio dilatantur” in questa vita, designano la larghezza; Par. XXXIII, 82-84, 91-93) [40]. Il vedere del poeta è tanto più sincero quanto più entra nel raggio dell’alta luce (ibid., 52-54), che tanto si eleva sui concetti mortali (ibid., 67-68: l’altezza).
Pier Damiani ‘pareggia’, cioè rende uguale, la chiarezza della visione di Dio (“la vista mia, quant’ ella è chiara”) con “l’allegrezza ond’ io fiammeggio” – in lui sono pertanto uguali la lunghezza della visione e la larghezza del gaudio che deriva dalla carità – e, grazie alla virtù della luce divina che si congiunge con il suo vedere, può levarsi tanto sopra di sé (uguaglianza anche nell’altezza) nell’intelligenza della somma essenza (Par. XXI, 82-90).
L’altezza della città, in questa vita, si consegue solo parzialmente, secondo la misura del proprio tendere nella lunghezza e nella larghezza verso Dio con la speranza di apprenderlo. La montagna del purgatorio, nei suoi sette gironi (corrispondenti ai sette stati della Chiesa secondo Olivi) rappresenta la Chiesa militante verso la ‘nobil patria’ celeste, che procedendo nella storia spera e consegue una misura sempre maggiore dei suoi lati. Di tale speranza, che è l’altezza dei lati del muro della città, dice Beatrice a san Giacomo: “Inclita vita per cui la larghezza / de la nostra basilica si scrisse, / fa risonar la spene in questa altezza (Par. XXV, 29-31). Un confronto fra Par. XXV, 28-33 e Par. XXXII, 85-90 mostra nel primo caso la rima larghezza / altezza / carezza variata in chiarezza / allegrezza / altezza nel secondo. In entrambi i casi è fatto segno dell’altezza e della larghezza (che equivale alla “iocunditas”) della città celeste; nel secondo si menziona anche la lunghezza (equivalente alla chiarezza, cioè alla luce della visione). Sia in Par. XXV come in Par. XXXII si registrano parole-chiave che rinviano ad Ap 1, 16-17 (lo splendore solare del volto di Cristo, decima perfezione del sommo pastore; il non poterla sostenere, undecima perfezione): vincëa ’l mio volto (ex materiali fragilitate subiecti seu organi ipsius videntis) … ridendo (il ridere di Beatrice corrisponde sempre allo splendor faciei di Cristo) … Iesù ai tre fé più carezza (in cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis) / la faccia (facies eius) … la sua chiarezza (sue claritatis). In questa rosa di segni, appropriata in modo variato a Beatrice e alla Vergine, ci si domanda se non sia da prendere in debita considerazione la variante chiarezza al posto di carezza (Par. XXV, 33): Iesù ai tre fé più chiarezza (et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis … in cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis). Cristo, nella Trasfigurazione, si mostrò ai tre apostoli più luminoso, piuttosto che farsi più ‘caro’, cioè con maggior carità e amore; oppure con il dar loro maggior ‘pregio’ e onore rispetto agli altri. Carezza compare solo in un altro luogo, a Par. XXIV, 19 (in rima con chiarezza al v. 21), nel senso di ‘prezioso’, della cara gioia (v. 89), e in questo corrisponde alla Gerusalemme celeste “omni lapide pretioso ornata” (Ap 21, 19) [41].
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
[Ap 4, 2-3; IIa visio, radix] Quoniam autem presentatio seu descriptio summe magnificentie et reverentie et sapientie maiestatis Dei et assistentium sibi plurimum confert ad advertendum profundam et altam et gloriosam continentiam huius libri a Dei dextera tenti, idcirco in prima parte magnificatur Dei maiestas ex septem.
|
|
Purg. XXVIII, 7-12, 25-27, 61-63, 103-111Un’aura dolce, sanza mutamento
|
Par. XXXIII, 109-111, 115-120, 124-133, 144Non perché più ch’un semplice sembiante
|
[Nota alle due tabelle precedenti]
I. La sede divina descritta nella seconda visione apocalittica è circondata dall’iride, simile allo smeraldo, cioè alla gemma incomparabilmente più verde (Ap 4, 3). In essa il colore verde supera in intensità quello delle erbe e delle fronde e impregna l’aria ripercossa, riempie gli occhi al solo sguardo e non lo sazia, tanto è grazioso a vedersi. Per quanto il colore verde sia più appariscente e grazioso, l’iride ha vari colori, secondo la densità o rarità della nube acquosa percossa dai raggi del sole: nella densa è rosso, nella più densa ceruleo (verde e nero, è il colore del mare profondo) oppure di colore livido oppure purpureo (commisto di nero e rosso), nella densissima nero; nella rara verde, nella più rara croceo, nella rarissima bianco. L’iride designa la grazia che preesiste causalmente ed esemplarmente in Dio e che si diffonde in giro a ornamento della sede della Chiesa celeste e subceleste: essa ha il colore della fiamma per la carità, il nero o il livido per l’umiltà, il verde per la sobrietà, il bianco per la chiarezza che proviene dalla sapienza.
Gli “spiriti magni” del nobile castello del Limbo vengono mostrati a Dante su un “prato di fresca verdura … sovra ’l verde smalto” (Inf. IV, 111, 118-119). Si è altrove mostrato come questa zona del poema sia cucita sul panno della sede divina. Ma solo con alcuni dei possibili fili, relativi ai sette punti in cui si distende l’ordito: l’altezza (I), l’assistenza dei seniori attorno a chi siede (IV), al quale viene reso onore (VII). Il verde è “verde smalto”, cioè impetrato (Colui che siede è simile nell’aspetto, perché fermo e immutabile nella giustizia, a pietra di diaspro, anch’essa verde, e di cornalina); l’iride (III) non si dispiega nei suoi vari colori: i doni dello Spirito non sono mancati agli “spiriti magni”, ma non si sono storicamente sviluppati. Dei tre elementi che emanano dalla sede (V), nel Limbo non ci sono né folgori né tuoni, ma le voci umane e razionali, proprie del senso morale.
Lo sviluppo della tematica segue il viaggio di Dante; nel Paradiso terrestre i temi dell’iride si mostrano compiutamente, e ancor più nell’Empireo e nella visione finale. Il tema dello smeraldo che impregna l’aria intorno di color verde fa infatti parte della spiegazione che Matelda dà sull’origine del vento che spira nel Paradiso terrestre (Purg. XXVIII, 103-120). L’aria si muove in cerchio con il Primo Mobile (la “prima volta”, che corrisponde all’essere l’iride “in circuitu”) e percuote l’ “alta selva” (l’ “alta eminentia” della sede) facendone stormire le fronde, cosicché le piante impregnano del loro seme l’aria che lo diffonde nell’altra terra, cioè nel mondo abitato dagli uomini, il quale, secondo disposizione, concepisce e produce da diversi semi diverse piante [42]. Anche se nessun colore viene indicato, non è difficile scorgere in questo circuire dell’aria a percuotere la selva e nel suo secondo girare, impregnata di riflesso dai semi delle piante percosse che essa diffonde, un valore assai simile a quello dell’iride, multiforme grazia che preesiste in Dio causa ed esempio e da lui emana su tutta la sede celeste e subceleste attorno alla quale gira.
I temi propri della sede (Ap 4, 2-3) trovano collocazione nella visione finale della Trinità. In quattro versi (Par. XXXIII, 115-118) si ritrovano almeno sei elementi semantici che nella Lectura designano altrettanti attributi della sede: la “sussistenza” (che corrisponde alla “stabilitas essentie” della maestà divina; cfr. Par. XXIX, 15) dell’ “alto” lume è “profonda” e “chiara” (l’essere alto e profondo è proprio del contenuto del libro, la chiarezza appartiene al mare trasparente che sta dinanzi alla sede) [43]; in essa Dante vede tre cerchi di tre colori e “d’una contenenza” (di una medesima dimensione, che corrisponde alla “continentia” del libro; anche i tre “giri” hanno un riferimento allo stare “in circuitu” dei seniori) e il secondo dei tre giri (il Figlio) che pareva riflesso dall’altro (il Padre) “come iri da iri” (la sede rifulge nell’arco dell’iride). Le parole “e l’un da l’altro come iri da iri / parea reflesso” sono sviluppo del tema dell’aria che gira con il Primo Mobile ed è ripercossa dalla folta selva dell’Eden verso la terra abitata dall’uomo, appunto “come iri da iri”. Lo ‘spirare’ come fuoco del terzo giro (lo Spirito Santo) in modo uguale dal primo e dal secondo è pure tema connesso alla sede e al libro, come appare dall’esegesi delle coppe spiranti d’amore ad Ap 5, 8 (cfr. nota) [44].
Il libro, definito ad Ap 5, 1 “volumen”, scritto dentro e fuori, che sarebbe incongruo affermare distinto per quaderni e carte, ha una forma immaginaria a guisa di rotolo, con sette pieghe, ciascuna delle quali chiusa da un sigillo. A ciascuna apertura, si presentavano a Giovanni le immagini da lui descritte dei cavalli e dei cavalieri, come se uscissero vive da dentro le pieghe (Ap 6, 1). Sui motivi propri del libro è tessuta la visione finale dell’unità e semplicità di Dio, volume che nel profondo della sua essenza lega con amore tutto ciò che “si squaderna” in modo diffuso per l’universo (Par. XXXIII, 85-87). Ma è soprattutto in Inf. XI, il canto in cui Virgilio spiega l’ordinamento e la distribuzione dei dannati, che questi temi vengono sviluppati. L’Inferno è formato da nove cerchi ma, a ben vedere, nel discorso di Virgilio e nelle domande di Dante ne vengono enumerati solo sette. Tre sono dentro le mura della Città di Dite: il cerchio dei violenti (a sua volta diviso in tre gironi), il cerchio dei fraudolenti veri e propri (Malebolge, dove sono i fraudolenti verso chi non si fida) e il cerchio minore dei traditori (i fraudolenti verso chi si fida). Quattro sono fuori le mura, meno martellati dalla giustizia divina in quanto meno offesero: gli iracondi e gli accidiosi dello Stige (“quei de la palude pingue”), i lussuriosi (“che mena il vento”), i golosi (“che batte la pioggia”), gli avari e i prodighi (“che s’incontran con sì aspre lingue”). Se mancano all’appello il primo cerchio (il Limbo) e il sesto (gli eretici), ciò è forse perché Virgilio non ha bisogno di dire altro sul luogo dove sconta la pena e perché la sua spiegazione dell’ordinamento infernale avviene accanto all’arca dell’eretico papa Anastasio II, cioè nel sesto cerchio. Oppure essa è memore di quanto sostenuto da Tommaso d’Aquino circa l’eresia la quale, in modo analogo alla bestialità rispetto alla malizia umana, era da collocare “extra numerum peccatorum” [45]. In ogni caso, esempio di concordia fra la dottrina aristotelica e l’esegesi apocalittica, l’enunciazione dei sette cerchi corrisponde al tema del libro scritto “dentro e fuori” e segnato sulle sette pieghe. Anche il riferimento alle “carte” della Fisica di Aristotele, utilizzata da Virgilio per precisare la posizione degli usurai, concorda con siffatta tematica. Ad Inf. IX, 106-109, il desiderio di guardare “dentro” la città di Dite, una volta varcata la porta, è il desiderio di guardare l’interno del libro.
È da notare che alcuni elementi semantici presenti ad Ap 6, 1 (la forma immaginaria del libro, il suo essere scritto, la presenza di “pieghe” da cui le immagini si mostravano a Giovanni come se uscissero vive) si ritrovano in Par. XXIV, 25-27. Fra le anime discese dall’Empireo al cielo delle stelle fisse, che girano danzando, una si distacca dalle altre per volgersi attorno a Beatrice “con un canto tanto divo, / che la mia fantasia nol mi ridice”. Si tratta di san Pietro: la penna del poeta è incapace di descrivere quel canto, “ché l’imagine nostra a cotai pieghe, / non che ’l parlare, è troppo color vivo”. La variazione poetica è fra le più lontane dal tema originario. Si può tuttavia notare che, pur con i temi rovesciati nel significato e con diversa appropriazione, permane nei due testi il contrasto tra la forma immaginaria e la realtà viva, sensibile: come il libro era immaginario e non reale, e le immagini dei cavalli e dei cavalieri che uscivano dalle pieghe erano anch’esse immaginarie come se fossero vive, così l’ “imagine nostra”, cioè la nostra fantasia (e conseguentemente il parlare, che ha limiti ancor più ristretti) è “troppo color vivo” (cioè troppo sensibile) rispetto “a cotai pieghe”, cioè a tali sfumature (che costituiscono la parte interna del libro, quella più spirituale). Fin dall’esegesi del primo capitolo, Olivi ha posto la questione del rapporto tra la visione intellettuale di Giovanni e le similitudini corporee, di cui necessita per essere compresa ed espressa: in questa vita non si verificano visioni dell’intelletto che non facciano uso di similitudini corporee. Il non poter ridire il canto dei compagni dell’Agnello sul monte Sion è tema presente ad Ap 14, 3.
_________________________________________________________________________________________________________________________
[Nota alla tabella precedente]
Il trionfo di Maria in Par. XXIII è un concertato contenente tutti i temi di canto e di letizia che è possibile trarre dalla Lectura [46]. Nella lode angelica resa dalla facella scesa dal cielo (vv. 103-111), l’amore (proprio dell’angelo), lo spirare (del ventre) e il desiderare (Cristo da parte degli uomini e degli angeli) sono temi delle fiale o coppe da Ap 5, 8. Queste coppe auree e fiammeggianti, che i ventiquattro seniori (angeli o santi uomini) offrono prostrati dinanzi all’Agnello, ricolme di profumi che si diffondono come gli odori “ad varias rationes dilecti et ad varias rationes sancti amoris”, designano le preghiere dei santi, spirano di devoti affetti e di desideri dei cuori, con menti già disposte alla lode di Dio. I signacula, che rinviano a questo luogo esegetico, compongono una vera sinfonia dell’amor sacro che il poeta con libertà diffonde variamente combinandone i motivi. Ora inseriti in un solo endecasillabo (Par. X, 110: “spira di tale amor, che tutto ’l mondo”; Par. XV, 2: “sempre l’amor che drittamente spira”; Par. XXII, 121: “A voi divotamente ora sospira”; Par. XXIV, 82: “Così spirò di quello amore acceso”; Par. XXV, 82: «Indi spirò: “L’amore ond’ ïo avvampo”»; Par. XXXI, 96: “a che priego e amor santo mandommi”; Par. XXXII, 105: “innamorato sì che par di foco”), ora diffusi su più versi consecutivi (Par. X, 1-2: “Guardando nel suo Figlio con l’Amore / che l’uno e l’altro etternalmente spira”; Par. XIX, 24-25: “parer mi fate tutti vostri odori, / solvetemi, spirando, il gran digiuno”; Par. XXIII, 103-105: “Io sono amore angelico, che giro / l’alta letizia che spira del ventre / che fu albergo del nostro disiro”; Par. XXIV, 28-29: “O santa suora mia che sì ne prieghe / divota, per lo tuo ardente affetto), o distanziati (Par. XXIV, 32: “a la mia donna dirizzò lo spiro”); ora in rima (disiri / spiri, Par. II, 125.129; s’infiamma / oriafiamma / la fiamma, Par. XXXI, 125.127.129); ora ultime parole dei versi di una terzina (spira / innamora / disira, Par. VII, 142-144); ora presenti singolarmente (Par. XIV, 127: “Ïo m’innamorava tanto quinci”).
Né Ap 5, 8 serve solo il Paradiso, perché i suoi signacula si rinvengono, ad esempio, anche a Inf. X, 18, 20-21 (disio, cuor, disposto). Oppure nel ricordo della “Nella mia” (prieghi devoti, sospiri) fatto da Forese (Purg. XXIII, 88).
Non è infrequente che la presenza di questi sacri marcatori coincida numericamente in versi o in terzine diverse: si veda al verso 82 di Par. XXIV e XXV – riferiti il primo a san Pietro e il secondo a san Giacomo -; oppure ai versi 142-144 (48a terzina) di Par. VII e X – entrambi i canti sono di 148 versi -; o ancora ai versi 124-129 (42a-43a terzina) di Par. II e XXXI. Così la prima terzina in cui parla l’ “amore angelico” che scende nell’ottavo cielo (Par. XXIII) coincide nel numero (vv. 103-105; 35a terzina) con altra terzina in cui, nell’Empireo, Dante domanda a san Bernardo dell’arcangelo Gabriele (Par. XXXII). Un fenomeno indice del costante lavorio del poeta sull’esegesi latina, che ha creato nel poema una straordinaria arte della memoria per il lettore e per l’autore stesso [47].
Un lettore ‘spirituale’, con nella mente bene impressa la Lectura super Apocalipsim, non avrebbe avuto difficoltà a riconoscere questi sacri marcatori. Leggendo (o ascoltando) le parole dell’ “amore angelico” di Par. XXIII sarebbe subito andato con la memoria ad Ap 5, 8, nel luogo più eminente descritto nell’Apocalisse – la sede divina prima dell’apertura del libro segnato da sette sigilli e nel momento in cui Cristo, centro dei tempi che quei sigilli chiudono, si accinge ad aprirli – e nel punto più corale, la lode che i quattro animali e i ventiquattro seniori rendono a Cristo, lode che è anche devota preghiera, affetto e desiderio del cuore, santo amore che spira e piace alla curia celeste e subceleste. Da “la somma beninanza” e da “lo primo e ineffabile Valore” la scala delle note scende alla Vergine Madre, all’angelo che ne tesse la lode, ai beati – Bernardo, Giacomo, Pietro, Salomone -; alle luci che formano l’aquila nel cielo di Giove o la croce del cielo di Marte, fino a Dante.
____________________________________________________________________________________________________________________
5. Le incertezze cognitive del diavolo
“Dante l’ha ritrovata e subito dopo l’ha riperduta in quanto ideale ed espressione del suo cuore; il dramma dell’amore tace innanzi al gran còmpito di salire con lei di stella in stella, e tutto vedere e tutto udire e tutto apprendere”. Così scriveva Benedetto Croce dell’incontro di Dante con Beatrice nell’Eden [48].
Per comprendere la situazione psicologica di Dante al momento dell’apparizione della sua donna nell’Eden, bisogna introdurre i temi della prima delle sette guerre descritte nella quarta visione (Ap 12, 4). Il drago sta dinanzi alla donna, che è in procinto di partorire, per divorarne il figlio, cioè per trarlo in dannazione come gli altri uomini. Non si tratta del parto naturale della Vergine, che avvenne senza dolore, ma del parto spirituale di Cristo e dei suoi discepoli, e quindi della Chiesa come corpo mistico [49], accompagnato da sommo dolore nella croce e nelle tentazioni. Olivi pone qui la questione se il diavolo sapesse che Cristo era Dio o comunque senza peccato e non soggetto a dannazione. Viene citata la posizione di Gregorio Magno, contenuta nei Moralia su Giobbe 40, 19 – “nei suoi occhi lo prenderà come con l’amo” [50]. Secondo Gregorio, il diavolo sapeva trattarsi del Figlio di Dio incarnato per la nostra redenzione ma non conosceva l’ordine della redenzione stessa, per cui Cristo morendo sulla croce lo avrebbe trafitto. Olivi corregge Gregorio e sostiene che il diavolo prima della morte di Cristo non sapeva con certezza e senza dubbi che Cristo fosse il Figlio di Dio a lui consustanziale, né tanto meno che fosse senza peccato, altrimenti non lo avrebbe mai tentato, prima nel deserto e poi al momento della passione. Come afferma san Paolo (1 Cor 2, 7-8), nessuno dei prìncipi di questo mondo conobbe la sapienza divina; se l’avessero conosciuta, non avrebbero mai crocifisso o istigato alla crocifissione il Signore della gloria. Il diavolo pertanto non conobbe la divinità di Cristo, ma solo la sua mortale umanità. Questa, come afferma lo stesso Gregorio, era però un amo che ostendeva un’esca dentro la quale stava occulto un aculeo. Così, mentre il diavolo era attratto dall’esca corporea costituita dal corpo infermo per umanità, veniva trafitto, per occulta virtù, dall’aculeo della divinità.
La situazione del diavolo di fronte a Cristo è la medesima di Dante di fronte a Beatrice non più veduta da tanto tempo. Come l’avversario del Redentore venne attratto dall’esca del Cristo uomo, così il poeta crede di sentire con lo spirito la donna conosciuta in vita (“E lo spirito mio … d’antico amor sentì la gran potenza”). Ma come l’aculeo della divinità del Figlio di Dio trafisse per occulta virtù l’antico nemico, così “per occulta virtù che da lei mosse” vengono trafitti gli occhi di Dante da una donna ormai salita di carne a spirito, cresciuta in bellezza e virtù (Purg. XXX, 34-42). Egli riprova, a un livello superiore, l’esperienza de “l’alta virtù che già m’avea trafitto / prima ch’io fuor di püerizia fosse”. Il tema ritorna all’inizio di Purg. XXXII, con il poeta assorto nella contemplazione del “santo riso” di Beatrice appena svelata, che trae a sé gli occhi del poeta “con l’antica rete”, uno stato dal quale egli viene distolto per forza dalle tre virtù teologali, rimanendo per un po’ senza facoltà visiva. È direttamente riferito al diavolo in Purg. XIV, 145-146, a proposito degli esempi di invidia punita che dovrebbero essere il “duro camo”, cioè il freno agli uomini i quali invece, attirati dall’esca, sono presi dall’amo dell’antico avversario.
Il motivo paolino, per cui nessuno dei prìncipi di questo mondo conobbe la sapienza divina perché, se l’avessero conosciuta, non avrebbero mai crocifisso o istigato alla crocifissione il Signore della gloria (1 Cor 2, 7-8), è utilizzato nella spiegazione che Virgilio dà a Pier della Vigna sul perché Dante abbia strappato un ramoscello dal gran pruno nel quale è incarcerata la sua anima: se il discepolo avesse potuto credere prima quello che ha veduto tramite l’Eneide (“pur con la mia rima”), nell’episodio di Polidoro (Aen., III, 22-68), non avrebbe disteso la mano per troncare la frasca, ma la cosa incredibile ha spinto il maestro a indurlo a un atto che gli dispiace (Inf. XIII, 46-51). È da notare la diversa appropriazione dei motivi: la mancata conoscenza preventiva e l’istigare, che nell’esegesi scritturale sono del diavolo, nei versi appartengono rispettivamente a Dante e a Virgilio. Distendere la mano per cogliere il ramoscello dal gran pruno del suicida, che si fa poi “di sangue bruno”, richiama il crocifiggere, secondo quanto in Giovanni 21, 18 Cristo dice a Pietro: “distenderai le tue mani”, cioè in croce, passo citato ad Ap 11, 3. La “cosa incredibile” – un’anima incarcerata in una pianta –, vista fino allora solo con la rima di Virgilio, conduce ad Ap 10, 5-7 (terza visione, sesta tromba), al “mistero” che l’angelo dal volto solare giura si compirà al suono della tromba del settimo angelo: si tratta degli occulti e incredibili giudizi di Dio, chiamati “mistero” perché preannunciati sotto veli mistici, che nel caso sono i versi dell’Eneide.
Dante recita la parte che nell’esegesi spetta al diavolo ingannato dall’arte di Cristo, e ciò concorda con il fatto che egli si trova, nel ruolo di colpevole per aver seguito false immagini di bene, di fronte a un giudice regale e protervo, quale appare dalle severe prime parole della donna: “Come degnasti d’accedere al monte?” (Purg. XXX, 74). Anche la “gran potenza” dell’antico amore deriva da un motivo che nella Lectura viene attribuito al drago, cioè al diavolo (Ap 12, 3).
Come Dante è stato trafitto, nella sua umana infermità, dall’aculeo del Figlio di Dio pieno di occulta virtù, così Matelda assomiglia a Venere trafitta dal figlio Cupido: “Non credo che splendesse tanto lume / sotto le ciglia a Venere, trafitta / dal figlio fuor di tutto suo costume” (Purg. XXVIII, 64-66). I versi ovidiani (Metam. X, 525-528) che descrivono Cupido il quale, mentre bacia la madre, la ferisce al petto senza volerlo (inscius) e l’inganna con la ferita (primoque fefellerat ipsam) sembrano concordare con quanto cantato da Venanzio Fortunato nell’inno Pange, lingua, gloriosi proelium certaminis citato nell’esegesi di Ap 12, 4, cioè “quod nostre salutis ordo depoposcerat ut ars Christi falleret artem multiformis proditoris, de quo in versu priori premisit quod per pomum ligni fraudulenter fefellerat prothoplaustrum, id est primum hominem”. Anche “la bella Ciprigna” e Cupido, onorate da “le genti antiche ne l’antico errore” (Par. VIII, 1-9), rientrano nell’ordine provvidenziale che procede per passaggi dal vecchio al nuovo, e sono prefigurazione di più alta trafittura dell’antico nemico con la prima venuta di Cristo nella carne e con la seconda sua venuta nello Spirito, nel sesto stato della Chiesa.
Il ritrovare Beatrice, con la contestuale sparizione di Virgilio, segna per Dante il passaggio dal vecchio al nuovo, l’essere venuto, per una sorta di superiore astuzia, dall’umano al divino della sua donna, quell’umano che con Matelda procede in terra ordinatamente verso l’immortale felicità.
Il diavolo, sostiene Olivi, sapeva che Cristo era figlio di Dio per grazia; a questo aspetto si riferisce il Salmo 81, 6, citato ad Ap 12, 4: “Ego dixi: dii estis et filii excelsi omnes”. Ma non per questo sapeva che era figlio di Dio per natura. Nel cielo di Mercurio, Beatrice invita Dante a rivolgersi con sicurezza agli “spirti pii”, credendo loro “come a dii” (Par. V, 121-123). Il non sapere, nell’episodio citato, è proprio di Dante, che non sa chi sia lo spirito che gli ha parlato né perché manifesti la propria beatitudine nel secondo cielo (ibid., 127-129). L’anima è quella di Giustiniano, e forse non a caso si insinua nei versi il tema dell’essere figlio di Dio per natura tratto da Ap 12, 4, considerato che, nella metamorfosi poetica dell’esegesi del terzo stato (dei dottori, il cui simbolo è la spada) e del quarto stato (i contemplativi, che con vita divina si dedicano al “pasto” spirituale), i due soli, l’impero e il papato, sono equiparati alle due nature di Dio, umana e divina, che non possono essere ridotte a una, come è invece successo allorché uno dei due soli ha spento l’altro, congiungendo la spada al pastorale. Con coerenza Giustiniano premette al suo discorso sull’Impero il racconto della propria errata fede monofisita, che riconosceva in Cristo una sola natura, quella divina, prima che il benedetto papa Agapito lo riportasse alla fede sincera (Par. VI, 13-22). Dante, quindi, sapeva che lo spirito che gli aveva parlato era figlio di Dio per grazia (in quanto già beato), ma non per natura, cioè non sapeva che si trattava di un imperatore, assimilabile al Figlio di Dio. Così non aveva dubitato che la sua donna fosse beata, ma non aveva sospettato della sua natura divina.
[LSA, cap. XII, Ap 12, 4 (IVa visio, Ium prelium)] Sequitur de primo prelio: “Et dracho stetit ante mulierem” (Ap 12, 4), id est ante ecclesiam, “que erat paritura”, scilicet Christum in cruce et in suis primis discipulis. Non enim videtur hic agi de virginali et corporali partu Christi, quia Virgo tunc non parturivit illum cum dolore. In cruce tamen et in omnibus temptationibus Christum peperit cum summo dolore.
|
|
[LSA, cap. XI, Ap 11, 3 (IIIa visio, VIa tuba)] Quorum unus (testis) magis erit exteriori regimini et passionibus mancipatus, unde et Iohannis ultimo allegorice designatur per <Petrum>, cui di<c>it Christus: “Pasce oves meas”, et “cum senueris, extendes manus tuas”, scilicet in cruce, et “sequere me”, scilicet ad crucem (Jo 21, 17-19).
|
[LSA, cap. X, Ap 10, 5-7 (IIIa visio, VIa tuba)] Sciendum etiam quod prout tubicinium septimi angeli refertur ad extremum iudicium, de quo <Ia> ad Thessalonicenses IIII° (1 Th 4, 16; cfr. 2 Th 1, 7) dicitur quod “ipse Dominus in iu<s>su et in voce archangeli et in tuba Dei descendet de celo, et mortui, qui in Christo sunt, resurgent primi”, est simpliciter verum quod tempus huius seculi tunc omnino cessabit et plene implebitur quicquid Deus per suos prophetas prenuntiavit fiendum, quod vocat “misterium”, id est secre-tum, quia nichil mundanis occultius quam spiritalis gratia et gloria in electis consumanda, futura etiam Dei iudicia sunt eis occulta et quasi incredibilia.
|
6. Dante profeta
L’espressione “Dante profeta” ha sempre percorso, da Ignaz von Döllinger ed Ernesto Buonaiuti [51] ai tempi più recenti, gli studi sulla Commedia. Ma cosa significa realmente? E quale profeta imiterebbe Dante? Non si può certo limitare questo epiteto ai casi del Veltro, dell’ “un cinquecento diece e cinque”, o di quanto viene detto al poeta circa la sua vita futura. La questione richiederebbe un’adeguata trattazione; qui si sottolinea l’aspetto ‘profetico’ che sembra più incidere sul senso stesso del viaggio.
Il passaggio dall’universale al particolare, che nei primi due versi del poema porta da “Nel mezzo del cammin di nostra vita” a “mi ritrovai per una selva oscura”, corrisponde a una caratteristica dello spirito profetico di cui, ad Ap 13, 1, Olivi nota la capacità di salire dal particolare all’universale e di ricondurre questo al proprio particolare. L’ascendere all’universale avviene allorché lo spirito trova un luogo idoneo all’uscire per dilatarsi ed espandersi dalle cose speciali verso le generali. Così Isaia, parlando di Babilonia e del suo re, dilata il discorso rivolgendolo contro tutto il mondo simile a Babilonia e contro Lucifero re di tutti i superbi e i malvagi quasi fosse re della grande Babilonia (Is 14, 12). Così Ezechiele, parlando contro Tiro, si diffonde su tutto il mondo e sul supremo cherubino che sta nel mezzo delle pietre infuocate (Ez 28, 14-16). Così Cristo, che attribuisce tutti i mali provenienti da ogni generazione di reprobi alla particolare malvagia generazione dei reprobi Giudei del suo tempo, sulla quale ricade tutto il sangue versato dal tempo di Abele il giusto (Matteo 23, 35-36). Così Giovanni, autore dell’Apocalisse, toccando della bestia che sale dal mare (la bestia saracena: Ap 13, 1-10) si dilata a tutta la massa dei reprobi che dalla creazione alla fine del mondo combatte contro la Chiesa degli eletti e ha sette teste corrispondenti alle sette età.
Lo spirito profetico dà alle vicende un valore esemplare. Tutti i tre più gravi peccati capitali – “superbia, invidia e avarizia” -, secondo Ciacco, cooperano alle divisioni di Firenze, e ne sono concausa (Inf. VI, 74-75). Un particolare fatto cittadino viene elevato a modello di male universale, e questo espandersi verso l’universale al di là del proprio particolare, per poi ritornarvi, è appunto una caratteristica del modo tenuto dai grandi profeti, Isaia o Ezechiele.
Nell’apostrofe che apre Inf. XXVI, il nome di Firenze “si spande” per l’inferno come la fama della città fatta “sì grande” batte le ali per mare e per terra. Il passaggio dal particolare all’universale è ribadito nel cielo di Venere da Folchetto di Marsiglia, che dilata il suo discorso al modo dei profeti: Firenze, pianta di Lucifero, “produce e spande il maladetto fiore”, la moneta che ha traviato il gregge cristiano trasformando i pastori in lupi (Par. IX, 127-132).
In altro contesto, Virgilio è “quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume”, dotato anch’egli di spirito profetico (Inf. I, 79-80). L’uscire e il dilatarsi sono propri della mente di Dante la quale, come la folgore si dilata fuori della nuvola che la contiene, esce da sé stessa fatta più grande per i cibi spirituali offerti dalla visione del trionfo di Cristo nel cielo delle stelle fisse (Par. XXIII, 40-45).
Nell’Eden la “puttana sciolta” – la meretrice Babylon, la Chiesa carnale – viene mostrata darsi al gigante (il regno di Francia) e finir tratta nella selva: secondo gli esegeti, “Babylon confusio interpretatur”. Se la confusione babilonica si mostra sul piano dei due poteri universali, il temporale e lo spirituale, essa nondimeno agisce anche a livello individuale dove, come afferma Olivi, ciascuno deve bruciare la propria meretrice interiore [52]. Così la confusione è appropriata anche a Dante (Purg. XXXI, 7, 13), finito nella selva oscura dopo essersi tolto a Beatrice e dato ad altri, quasi specchio individuale della prostituta apocalittica (“questi si tolse a me, e diessi altrui … e come perché non li fosse tolta”: Purg. XXX, 126; XXXII, 151). La confusione agisce anche a livello cittadino: “Semper enim usque ad finem seculi erunt in hoc mundo aliqui babilonici, id est reprobi, a quorum peccatis est recedendum … Babilon enim confusio interpretatur – Sempre la confusion de le persone / principio fu del mal de la cittade (Ap 14, 8; 18, 4; Par. XVI, 67-69)”.
Come nella prima terzina del poema si scende da ciò che è comune al genere umano (“Nel mezzo del cammin di nostra vita”) al singolo individuo Dante (“mi ritrovai”), così all’inverso, nel rimprovero formulato da Beatrice nell’Eden, si sale da “quella scuola ch’hai seguitata”, che è all’opposto della “parola” della donna, alla “vostra via” che tanto dista da quella divina (Purg. XXXIII, 85-90) [53].
Dunque lo “spirito profetico”, nel suo trascorrere dall’individuale all’universale e viceversa, è, prima ancora che la prescienza tramite il lume divino di eventi futuri, lo strumento che consente di inserire fatti e personaggi contemporanei nel corso della storia provvidenziale; per esso il realismo radicato sull’ “aiuola che ci fa tanto feroci” diventa “sacro” e la terra adombra il cielo [54].
Vi è un libro della Scrittura al quale la Commedia è stata accostata anche da autori, come Michele Barbi [55] e Bruno Nardi [56], restii a scorgervi influenze dirette dell’esegesi contemporanea: l’Apocalisse. Come questa, il “poema sacro” è un libro scritto dentro (i sensi mistici) e fuori (il senso letterale). Si suole fare riferimento all’Apocalisse solo per quei luoghi del poema dove essa è palesemente citata, come nella bolgia dei simoniaci (Inf. XIX) o nelle visioni delle vicissitudini del carro-Chiesa militante che concludono Purg. XXXII. Un’attenta analisi toccherebbe molti altri punti, che permeano il tessuto dei versi. Il fiume luminoso dell’Empireo, con le sue due rive, è memore di quello che scorre nel mezzo della Gerusalemme celeste (Ap 22, 1-2); l’ascesa al cielo, che avviene guardando negli occhi di Beatrice fissi nel sole, ripete Ap 19, 17-18 (“Et vidi unum angelum stantem in sole”); le tre facce di Lucifero hanno i colori (rosso, nero, tra bianco e giallo) dei tre cavalli designanti gli eserciti contrari a Cristo rispettivamente all’apertura del secondo, terzo e quarto sigillo (Ap 6, 3-8); i motivi delle pungenti locuste che escono dal pozzo dell’abisso al suono della quinta tromba (Ap 9, 1-12) si rinvengono nella bolgia dei barattieri o nelle malefatte dei Capetingi descritte dal loro capostipite.
La città ideale – descritta nella settima visione apocalittica con similitudini materiali: fosse, muro, porte, case, piazza, angoli, misure dei lati, pietre preziose, fiume, rive, albero, frutti -, viene applicata agli uomini, che partecipano così delle sue divine qualità. Nell’esegesi essa è la Chiesa dei contemplativi, cioè dei beati; ma anche la Chiesa peregrinante e militante in terra ne può ben pregustare la pace. Nella storia terrena, nessuna città le è stata più somigliante della Firenze antica rimpianta da Cacciaguida. Nell’amarezza dell’esilio, fra rimproveri e invettive contro di essa, il poeta sempre ama un’idea della sua Firenze, patria di degni cittadini “ch’a ben far puoser li ’ngegni” (Inf. VI, 81). Come sarebbe stato un giorno per Savonarola, Firenze è l’eletta e diletta città, nuova Gerusalemme santa e pacifica [57]. Ma questa città ideale – “quella Roma onde Cristo è romano” (Purg. XXXII, 102) – subisce una degradazione nel mondo infernale, strutturato con le stesse similitudini che descrivono la Gerusalemme celeste, per cui la civitas Dei si fa civitas diaboli [58].
Una vera e propria messa in poesia della parola ‘apocalisse’ (“revelatio”) è lo svelamento nell’Eden di Beatrice, il cui nome coincide con il fine stesso dell’ultimo dei libri canonici (Ap 1, 3: “Beatus qui legit, et qui audit verba prophetie, et servat ea”).
Il libro dell’Apocalisse, con i suoi settenari, illumina il Vecchio Testamento. Con esso concordano i profeti [59], che intesero preannunciare i tre avventi di Cristo (nella carne, nello Spirito, nel giudizio); in esso Giovanni applica le figure e le sentenze dei profeti ad altri tempi e fatti:
(LSA, prologus, notabile XIII) Ex predictis autem faciliter patet qualiter per intelligentiam huius libri elucidatur obscuritas scripture veteris, et etiam explicatur implicatio septem statuum nove legis. Elucidat enim eam primo per concordiam. Si enim omnes septenarios in scripturis positos coaptes ad septenarios huius libri, innumerabilia misteria tibi clarescent, si diligenter attenderis ipsorum parilem concordiam et consignificantiam […].
Secundo elucidat ipsam distinguendo tres fines seu tres Christi adventus in prophetis indistincte involutos. […] Unde et spiritus propheticus prophetarum veteris testamenti ad istos tres principalius currit. Nec mirum, quia principalis intentio eorum de Christo et circa Christum fuit prophetare eius adventum in carnem passibilem et redemptionem nostram per eius mortem fiendam, ac deinde post conversionem plenitudinis gentium promittere conversionem omnis Israel et postremo mundum inde a Christo iudicandum et consumandum, electos quidem in eterna gloria et reprobos in eterna pena.
Tertio elucidat ipsam applicando figuras vel sententias eius ad alia facta et tempora quam in prophetis videantur applicari, ut verbi gratia quando prophete loquuntur de destructione Babilonis non applicant hoc expresse ad illam Babilonem de cuius dampnatione agit sexta visio huius libri, nec sibi aut bestie ipsam portanti ascribunt septem capita et septem reges secundum septem tempora ecclesiastica. Item quod Daniel videt quattuor bestias in mari pugnantes (Dn 7, 2-8), Iohannes in quarta visione aggregat eas in unam. Nam de quarta bestia assumit quod habet “capita septem et cornua decem” (Ap 13, 1) et “os loquens” ingentia (Ap 13, 5-6), de tertia vero sumit quod “erat similis pardo”, de secunda vero quod “pedes eius sicut pedes ursi”, de prima vero, scilicet de leena, quod “os eius sicut os leonis” (Ap 13, 2). Item quod Isaias et ceteri prophete dicunt de finali gloria populi Dei fienda sub magno messia, applicat septima visio huius libri ad celestem gloriam cum renovatione orbis post extremum iudicium fiendam. Et sic de ceteris consimilibus advertere potes.
Lo spirito profetico è la predicazione di Cristo, che gli dà testimonianza:
(LSA, cap. XIX, Ap 19, 10) Deinde subdit quem debeat adorare, dicens: “Deum adora”. Deinde exponit quid sit “testimonium Ihesu”, dicens: “Testimonium enim Ihesu est spiritus prophetie”, id est spiritualis prophetatio seu predicatio Christi est testimonium seu testificatio ipsius, quasi dicat: omnes qui Christo serviunt, ipsum per eius Spiritum predicando seu confitendo, sunt servi Christi sicut et ego, et ideo quoad hoc sumus invicem coequales. Vel habere “testimonium Ihesu” est credere spirituali prophetie et doctrine de Christo. Nam ipsa testificatur Ihesum.
I profeti, e i loro discepoli, “serbano le parole della profezia”; si cimentano in una beata contesa per l’umiltà, nella quale i primi rifiutano di essere riveriti mentre i secondi non cessano dall’ossequio:
(LSA, cap. XXII, Ap 22, 8-9) Quanto autem maior erit in discipulis humiliatio, tanto erit maior et in magistris, ita quod etiam ad litteram angeli erunt eis familiares quasi socii, et conservi tam “prophetarum”, id est doctorum, quam discipulorum “qui servant verba prophetie”, id est doctrine “libri huius”. Docemur etiam in hoc quod quamvis spirituales magistri, proprium honorem refugientes, prohibeant se a suis subditis et discipulis honorari, non debent propter hoc discipuli cessare, immo profundius se humiliare quanto plus magistri et prelati se exhibent humiles eis. Et hec est beata contentio evangelice humilitatis, per quam superiores se honorari prohibent, et inferiores honorare et se illis omnino subicere numquam cessant.
Camminando sull’argine che lo protegge dal sabbione su cui piove fuoco, Dante china il capo, “com’ uom che reverente vada”, verso il suo maestro Brunetto Latini, che tuttavia pare primo nell’umiliarsi dicendo: “Però va oltre: i’ ti verrò a’ panni”, cioè procedendo più in basso col capo che sfiora la veste del poeta (Inf. XV, 40, 43-45). L’umiliarsi di Brunetto è tuttavia obbligato dalla sua pena che lo costringe in basso nel sabbione, mentre il discepolo, portato dai margini di pietra del Flegetonte, è elevato su di lui. Il tema della gara d’umiltà è già presente al momento dell’incontro e del riconoscimento del maestro da parte del discepolo: prima Brunetto, che sta più in basso, prende Dante “per lo lembo”, cioè per la veste, gridando la sua meraviglia; poi Dante china la mano verso la faccia di lui (ibid., 22-30). Al maestro che gli promette glorioso porto e tanto onore il poeta si dichiara pronto a ‘serbare’ la profezia fattagli: “Ciò che narrate di mio corso scrivo, / e serbolo a chiosar con altro testo / a donna che saprà, s’a lei arrivo” (Inf. XV, 88-90).
Profeti non sono solo quelli dell’Antico Testamento, ma anche gli apostoli e i dottori del Nuovo:
(LSA, cap. X, Ap 10, 5-7) Nota etiam quod hic per prophetas non solum intelliguntur prophete veteris testamenti, sed etiam apostoli et ceteri doctores novi testamenti. Omnes enim prenuntiant consumationem ecclesie et operum Dei in finem seculi implendam.
“Et dixit michi: Oportet te iterum prophetare in gentibus et populis et linguis et regibus multis” (Ap 10, 11). Come l’angelo ingiunge a Giovanni di predicare ancora senza timore a tutto il mondo dopo gli apostoli, inviscerando il libro dal sapore amaro e dolce insieme (Ap 10, 9-10), così Dante ascolta da Cacciaguida il suo futuro destino e le vicende dolorose dell’esilio, e gusta insieme l’amaro del suo futuro patire con il dolce della fama che gli è riservata (Par. XVII). Questo essere dolce e amaro è pure negli effetti del poema, molesto nel primo gusto ma poi salutare. Dall’avo, e poi da san Pietro (Par. XXVII, 64-66), egli riceve, quasi “alter Iohannes”, l’ingiunzione di rendere manifesto quanto gli è stato mostrato nel corso del viaggio e che egli ha notato nel suo “poema sacro”, nuova Apocalisse di cui ha realmente percorso per grazia, portandoli a compimento, tutti i gradi temporali.
San Pietro, nel rivolgersi a Dante – “e tu, figliuol, che per lo mortal pondo / ancor giù tornerai, apri la bocca, / e non asconder quel ch’io non ascondo” – usa quell’avverbio che se è riferito all’essere il poeta un mortale che deve di nuovo tornare sulla terra, sembra bene alludere all’ “iterum” detto dall’angelo a Giovanni e ai suoi epigoni del sesto stato della Chiesa (che si tratti di un ordine di contemplativi evangelici o di “singulares persone”) [60] perché predichino ancora, dopo gli apostoli, a tutto il mondo “le cose che è necessario avvengano presto”, quanto cioè scritto nel libro loro aperto, consegnato e divorato con dolore e con dolcezza:
(LSA, cap. XXII, Ap 22, 6) Secundum est: “Et Dominus Deus spirituum prophetarum”, id est qui dat prophetis spiritum prophetandi vel creator et illustrator spirituum eorum, “misit angelum suum”, scilicet me, “ostendere servis suis que oportet fieri cito”, quasi dicat: singulari iussu et missione et auctoritate summi Dei ostendi hec, non quidem vana sed necessaria, nec tardanda sed cito fienda, nec quibuscumque sed servis Dei.
Dante intese il suo viaggio come una vera visione, ma da subito gli interpreti e la stessa Chiesa [61] privilegiarono la fictio poetica, l’elemento retorico-letterario ancor oggi largamente privilegiato dagli studiosi.
Lo “spirito profetico” doveva avere un suo pubblico di predicatori che rendessero manifesta la “profezia”. Costoro, leggendo i versi le cui parole fungevano da imagines agentes che indirizzavano la memoria alla dottrina contenuta nel “libro”, non avrebbero trovato alcuna contraddizione fra la dimensione allegorica e l’enunciazione letterale, non avrebbero dovuto decifrare alcun “segreto”. Il “libro” quasi scomparve e il pubblico non si formò [62]. Ai posteri restò la selva delle interpretazioni, la distinzione fra poesia e struttura, i tentativi di conciliare poesia e teologia. Restò, perché si perdé del tutto il significato spirituale del poema, il “segreto”.
7. Apocalisse
Mira profunditas eloquiorum tuorum,
quorum ecce ante nos superficies blandiens parvulis:
sed mira profunditas, Deus meus, mira profunditas!
Horror est intendere in eam, horror honoris et tremor amoris.
Agostino, Confessionum lib. XII, xiv, 17
“Apocalisse di Gesù Cristo”. Il libro si divide nell’esordio o proemio, nella narrazione e nella conclusione. La narrazione comincia ivi: “Io, Giovanni, vostro fratello” (Ap 1, 9); la conclusione, verso la fine del libro, ivi: “Poi mi disse: ‘Queste parole sono certe e veraci’” (Ap 22, 6). Nel proemio e nella conclusione viene raccomandata e magnificata la profezia di questo libro affinché sia maggiormente accettabile e degna di fede e venga accolta con più attenzione, amore e timore.
Il proemio del libro (Ap 1, 1-8) comprende il titolo e il saluto. Nel titolo (Ap 1, 1-3) viene spiegata la quadruplice causa del libro: formale, efficiente, materiale e finale. “Apocalisse” equivale a “rivelazione”, la quale può essere sia l’atto di colui che rivela, sia l’atto di colui che riceve o vede la rivelazione, sia la cosa stessa rivelata.
L’essere stato rivelato è la causa formale del libro, che meglio si definisce “rivelazione” piuttosto che “visione”, a sottolineare il dono e la grazia di colui che rivela e il suo arcano celarsi se il velo non venga tolto o aperto per dono divino. È nome greco (από = re, κάλυψις = velo) che è rimasto non interpretato in latino, come le parole ebraiche “amen” e “alleluia”, in segno di sacra riverenza verso l’arditezza della rivelazione.
“Apocalisse”, rivelazione dell’arcano per grazia, è il disvelarsi della bocca velata di Beatrice alla preghiera delle tre virtù teologali: “Per grazia fa noi grazia che disvele / a lui la bocca tua, sì che discerna / la seconda bellezza che tu cele” (Purg. XXXI, 136-138). Ed è rivelazione non interpretata, poiché quale poeta, quand’anche fattosi pallido nello studio della poesia o abbeveratosi alla fonte di Parnaso, sarebbe capace di renderla? (ibid., 139-145).
La riverenza di fronte al nome, “pur per Be e per ice” (che sembra far segno della disgiunzione di “apocalisse” in re e in velo), cioè anche senza interpretarlo, “s’indonna” di tutto il poeta, che nel dubbio non ha sufficiente ardimento a chiedere (Par. VII, 10-15; il ‘velare’ è appropriato al subitaneo sparire degli spiriti mostratisi nel cielo di Mercurio: “e quasi velocissime faville / mi si velar di sùbita distanza”, ibid., 7-9). Sulla soglia dell’Empireo, la bellezza della donna viene lasciata “a maggior bando / che quel de la mia tuba, che deduce / l’ardüa sua matera terminando”, come il nome del libro non viene interpretato “in signum singularis arduitatis et reverentie huius revelationis” (Par. XXX, 34-36).
Alla donna del poeta appartiene anche la parola alleluia, della quale ad Ap 19, 1 si dice: “Quod est hebreum et est idem quod laudare Deum”, e l’amen, di cui ad Ap 19, 4: «“Amen, alleluia”, id est vere est Deus ineffabiliter laudandus”». Lucia così le si rivolge nell’Empireo per muoverla a salvare l’amico: “Beatrice, loda di Dio vera” (Inf. II, 103), dice cioè tre parole non interpretate: ‘apocalipsis, alleluia, amen’.
Se “Beatrice” resta nome non interpretato, interpretato (così Uguccione) è invece quello della madre di san Domenico, Giovanna – ja = dominus, anna = gratia (Par. XII, 80-81).
La causa efficiente del libro dell’Apocalisse è quadruplice. La principale è Dio, la secondaria Cristo in quanto uomo, l’intermedia l’angelo, la prossima Giovanni. Così si dice della “rivelazione di Gesù Cristo”, cioè fatta da Cristo, “che Dio gli diede”, che gli fu cioè data dal Padre e da tutta la Trinità non solo per sua conoscenza ma “per render noto”, ossia per manifestare, “ai suoi servi le cose che è necessario avvengano presto”.
Parlando di “necessità” si tocca anche la causa materiale, costituita dagli eventi futuri, necessari non in senso assoluto, bensì rispetto all’infallibilità della prescienza divina, all’utilità e alla necessità della Chiesa, alla giustizia distributiva, alla malizia dei reprobi. Questi eventi futuri è necessario avvengano “presto” sia perché cominciano e continuano e si compiono senza interruzione; sia perché il tempo, comparato all’eternità, è quasi un momento; sia perché il tempo della nuova legge, rispetto ai tempi precedenti, viene computato come “l’ultima ora”, secondo quanto detto nella prima lettera di Giovanni (1 Jo 2, 18 “novissima hora est”).
Si soggiunge la causa intermedia e poi quella prossima, dicendo: “e che egli”, cioè Cristo, “manifestò”, cioè rivelò o mostrò per mezzo di segni figurali, “inviando il suo angelo”, per annunziarle, “al servo suo Giovanni”.
È da notare che il poema non viene definito “rivelazione”. Cacciaguida, nell’invitare il suo discendente a non essere timido amico del vero, parla di “visione”: “tutta tua visïon fa manifesta” (Par. XVII, 128). Si tratta però di una visione mostrata da altri, come dice lo stesso Cacciaguida: “Però ti son mostrate in queste rote, / nel monte e ne la valle dolorosa / pur l’anime che son di fama note” (ibid., 136-138). L’autore del libro dell’Apocalisse è colui che “questa revelazion ci manifesta”, come afferma il poeta di fronte al fratello di Giovanni, san Giacomo, con riferimento alle “bianche stole” (Ap 3, 4-5; 7, 9; Par. XXV, 94-96). Il verbo “revelare” ricorre solo altre tre volte nel poema. A Par. XXIX, 133, circa il numero degli angeli nella ‘rivelazione’ di Daniele (“ ’n sue migliaia”; cfr. Dn 7, 10), entro cui “si cela” un numero “determinato” ma inconcepibile per la mente umana: da notare la variante, perché Daniele rivela celando. A Par. XXI, 120, Pier Damiani lamenta la decadenza di Fonte Avellana: “Render solea quel chiostro a questi cieli / fertilemente; e ora è fatto vano, / sì che tosto convien che si riveli”, dove il rivelare è accostato alla necessità (“convien”) e al presto apocalittico (“tosto”). A Purg. III, 142-143, Manfredi, del cui destino eterno non si dice il vero tra i vivi, prega Dante che, una volta tornato, vada dalla figlia “revelando a la mia buona Costanza / come m’hai visto” (da intendere come un rivelare il mirabile giudizio divino sul padre, che ha stravolto il giudizio degli umani pastori).
La causa finale del libro, che si consegue attraverso la sua intelligenza e osservanza, è la beatitudine: “Beato chi legge e chi ascolta le parole della profezia, e chi le conserva” (Ap 1, 3).
I temi connessi al titolo del libro (Ap 1, 1) sono presenti in Purg. XXX, al momento dell’apparizione di Beatrice nell’Eden. La voce di Beatrice chiama l’amico con il proprio nome: “Dante, perché Virgilio se ne vada, / non pianger anco …” (vv. 55-57). Il poeta si volge “al suon del nome mio, / che di necessità qui si registra” (vv. 62-63). Un nome pregno di significato, che qui viene specificato come nel libro di Giovanni vengono poi specificati i nomi delle sette chiese alle quali deve essere inviata la visione: Dante – “colui che dà” [63] – riassume in sé, come la Chiesa universale, il settiforme spirito che la santifica. La necessità che giustifica l’unica registrazione nel poema del nome dell’autore, con il venir meno della norma retorica che vieta di parlare di sé, non è determinata soltanto, come pensava l’Ottimo, dal fatto che un rimprovero, quale quello cui si appresta Beatrice, diventa più pungente se si nomina la persona, ma anche dall’imminenza della fine dei tempi. Il poeta nominato è colui che riceve la rivelazione da divulgare, necessaria perché gli uomini si pentano per tempo [64]. Necessità e utilità già addotte nel Convivio (I, ii, 12.14), con l’esempio di Agostino, per giustificare il parlare di sé.
“Guardaci ben ! Ben son, ben son Beatrice” (Purg. XXX, 73): le parole della donna espongono il fine dell’Apocalisse, cioè la beatitudine: “Beatus qui legit, et qui audit verba prophetie, et servat ea” (Ap 1, 3). La triplice ripetizione dell’avverbio ben esprime la causa finale del libro. Dante ascolta e guarda. Ciò è dimostrato da altri versi che rinviano al medesimo punto esegetico: Purg. III, 124-126 (“Se ’l pastor di Cosenza, che a la caccia / di me fu messo per Clemente allora, / avesse in Dio ben letta questa faccia”, quella misericordiosa: “et sic omnia sunt a nobis servanda vel agendo illa vel credendo ea cum caritate et spe vel timore”); Par. X, 125-126 (“l’anima santa che ’l mondo fallace / fa manifesto a chi di lei ben ode”, cioè Boezio; il manifestare è verbo tipico della rosa offerta dall’esegesi dei primi versetti apocalittici); Inf. XIV, 16-18 (“O vendetta di Dio, quanto tu dei / esser temuta da ciascun che legge / ciò che fu manifesto a li occhi miei!”: senza l’avverbio “ben”, ma con l’accostamento del leggere il lato temibile del libro – “cum caritate et spe vel timore” – e del manifestare).
Ancora, nell’Eden Beatrice è velata e non appare manifesta; le sue parole ‘continuano’, quasi a sottolineare la necessità di cose che debbono avvenire presto (Purg. XXX, 71: “continüò come colui che dice”; «“[…] “que oportet fieri cito” … quia indistanter sunt inchoanda et absque interpolatione continuanda et consumanda”»): motivo che ritorna all’inizio del canto successivo, allorché Beatrice ricomincia a parlare, “seguendo sanza cunta” (Purg. XXXI, 4); un modo di parlare proprio anche di Farinata (Inf. X, 76), di Matelda (Purg. XXIX, 2) e ancora di Beatrice nel cielo della Luna (Par. V, 17-18). Simmetrico ad Ap 1, 1 è Ap 22, 10, dove alla fine del libro Cristo afferma la prossimità del suo avvento e giudizio. Ivi è ripreso il tema del continuare senza posa un discorso: “et continuat se ad immediate premissum”. Cristo dice anche (Ap 22, 12) che verrà presto a portare, “tamquam dantis”, la propria mercede a ciascuno secondo le sue opere, cioè ai buoni i premi e ai malvagi le pene. Che è poi quello che si propone la Commedia. Il tema della visione mostrata a Giovanni perché la manifesti ad altri si traspone sul poeta. A lui, dice Beatrice, sono state mostrate “le perdute genti” come ultimo argomento per la sua salute (Purg. XXX, 136-138); a lui, dice Cacciaguida, sono “mostrate” le anime perché ‘manifesti’ la sua visione (Par. XVII, 128, 136). Pentitosi di fronte a Beatrice del proprio traviamento, Dante riceverà dalla sua donna (Purg. XXXII, 103-105) e dal suo avo (Par. XVII, 127-128) l’ingiunzione di scrivere e di manifestare, come all’evangelista viene detto: “Scribe ergo que vidisti” (Ap 1, 19).
Nel poema si mostrano altre variazioni di questi temi. Al centauro Chirone Virgilio spiega che il mostrare a Dante vivo la buia valle infernale è indotto da “necessità” e non da diletto (Inf. XII, 85-87). Il ‘convenire’, cioè l’essere necessario, è verbo che già Virgilio ha usato per indurre Dante a “tenere altro vïaggio” se vuole salvarsi dalla lupa (Inf. I, 91-93). I motivi della necessità e della velocità sono pure appropriati alla Fortuna (Inf. VII, 89). La Fortuna s’appressa, “necessità la fa esser veloce” (Inf. VII, 89), ma Dante ad essa è “presto” (cioè pronto con altrettanta velocità), e ciò vuole “sia manifesto” al suo antico maestro Brunetto Latini (Inf. XV, 91-93; “manifesto” e “presto” si trovano qui anche in rima, come a Par. XXIV, 50.52). E Virgilio interloquisce variando il tema Beatus qui audit (Ap 1, 3): «poi disse: “Bene ascolta chi la nota”» (Inf. XV, 99).
L’aggettivo utile non compare mai nel poema; hapax è l’avverbio utilmente a Purg. XXIII, 6, non a caso riferito al “tempo che n’è imposto”, che secondo Virgilio deve essere adeguatamente impiegato perché, appunto, è poco, e le cose debbono necessariamente avvenire presto, e presto debbono esser vedute.
Il tema dei “signa figuralia”, attraverso i quali si attua la rivelazione (le similitudini a noi note, perché non è dato ripetere una visione che sia puramente intellettuale), è appropriato ai lumi che nel cielo di Giove si trasformano nell’aquila, mostrandosi dapprima come figure di lettere e come segni (Par. XVIII, 73-93). Segnare e manifestare sono congiunti nell’invocazione in principio della terza cantica (Par. I, 22-24: “O divina virtù, se mi ti presti / tanto che l’ombra del beato regno / segnata nel mio capo io manifesti”). I motivi della necessità e dei “signa figuralia” sono appropriati a Cacciaguida, il cui parlare per un po’ si cela “per necessità, ché ’l suo concetto / al segno d’i mortal si soprapuose”, per poi condiscendere “inver’ lo segno del nostro intelletto” (Par. XV, 37-48).
La necessità, afferma Olivi, non è da intendere in senso assoluto, bensì con rispetto all’infallibilità della prescienza e della giustizia divina e all’utilità della Chiesa (Ap 1, 1); il libro tratta pertanto degli eventi futuri che è necessario avvengano presto, non di fallibili contingenze. Così Cacciaguida, che legge “nel cospetto etterno”, afferma (Par. XVII, 37-42) che la contingenza è solo umana (“fuor del quaderno / de la vostra matera non si stende”), e che la necessità non è assoluta (“necessità però quindi non prende / se non come dal viso in che si specchia / nave che per torrente giù discende”).
Una ‘rivelazione’, cioè un disvelamento, si verifica nell’Empireo, allorché “ambo le corti del ciel”, angeli e beati, si rendono “manifeste” al poeta, “come gente stata sotto larve, / che pare altro che prima, se si sveste / la sembianza non süa in che disparve”; la città “si distende in circular figura” (Par. XXX, 91-96, 103-105).
Una variante della rima disvele / cele (Purg. XXXI, 136.138) è anticipata, rispetto al disvelarsi di Beatrice, a Purg. XXIII, 112.114, da ti celi / veli nella richiesta di Forese perché il suo interlocutore si riveli. Ma altri temi tratti dall’esegesi dei primi versetti del testo apocalittico si trovano nell’episodio: il manifestarsi (nell’accezione negativa della causa della magrezza delle anime, ibid., 37-39; cfr. Purg. XXX, 69), poi il palesarsi a Dante («“palam facere”, id est ad manifestandum») per grazia («poi gridò forte: “Qual grazia m’è questa?”», ibid., 42-45). I temi si intrecciano con quelli provenienti dall’esegesi di Ap 9, 16-17 (terza visione, sesta tromba), dove si distingue tra l’ascoltare il numero dei cavalieri e il vedere i cavalli dell’esercito sciolto al suono della sesta tromba, nel senso che l’ascoltare viene riferito ai più sapienti (i cavalieri), mentre il vedere alle plebi sensuali (i cavalli), perché con l’udito percepiamo ciò che è sottile, segreto e intelligibile senza vederlo o palparlo. Così Dante riconosce Forese, disseccato nella pelle dalla fame e dalla sete che lo purgano del peccato di gola, solo attraverso la voce udita – “Mai non l’avrei riconosciuto al viso”: l’essere ‘sottile’, appropriato alla magrezza di Forese, partecipa del tema dell’apprendimento con l’udito di ciò che è più sottile e segreto (Purg. XXIII, 43-45, 61-63). Forese è paragonato nel suo dipartirsi a un cavaliere (Purg. XXIV, 94-97); al suono della sesta tromba vengono seccate le acque del fiume Eufrate, cioè di quanto è umano e babilonico (Ap 9, 14).
Altri esempi di percezione uditiva (più sottile), non visiva: “Luogo è là giù da Belzebù remoto / tanto quanto la tomba si distende, / che non per vista, ma per suono è noto” (Inf. XXXIV, 127-129: il punto al quale Virgilio e Dante pervengono al termine della “natural burella”, percorsa dopo essersi staccati dal pelo di Lucifero e dal quale risalgono ed escono “a riveder le stelle”, cioè alla contemplazione; le parole luogo e remoto rinviano la memoria del lettore a Patmos, dove Giovanni scrisse l’Apocalisse: “Ecce quod locus erat divinis contemplationibus et visionibus aptus, tamquam remotus et quietus et secretus ac deliciis et divitiis carnalibus vacuus” [Ap 1, 19)]; «“Io ti seguiterò quanto mi lece”, / rispuose; “e se veder fummo non lascia, / l’udir ci terrà giunti in quella vece”», nell’incontro con Marco Lombardo (Purg. XVI, 34-36).
A Dante è appropriato il tema della singolare grazia concessa da Dio a Cristo perché riveli quel che è arcano e incomprensibile: a lui viene infatti ‘concesso’ per grazia di vedere i troni del trionfo eterno prima di abbandonare il militare terreno (Par. V, 115-117) e di venire d’Egitto in Gerusalemme (Par. XXV, 55-57).
A Par. V l’espressione “ben nato”, oltre che alla “beatitudo”, causa finale del libro, rinvia anche all’interpretazione del nome “Beniamin”, il figlio di Rachele chiamato dapprima dalla madre “Bennoni”, cioè figlio del dolore, perché nel darlo alla luce morì. Alla tribù di Beniamino è appropriata la pace, nella quale la mente muore a sé stessa e passa alla destra di Dio. Ben, con o senza nati, è accostato a pace a Purg. III, 73-74 e V, 60-61.
A Francesca e a Paolo Amore “concedette” di conoscere i “dubbiosi disiri” (Inf. V, 118-120), ma fu un concedere mal interpretato dai due amanti, nel senso dell’amore carnale [65]. Il tema del concedere da parte di Dio (Ap 1, 1) e della dignità di Giovanni, testimone del Verbo divino e insieme dell’umanità di Cristo (Ap 1, 2), è appropriato a sé stesso da Dante, dubbioso nel fare il viaggio proposto da Virgilio e accettato con troppa fretta: “Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede? / Io non Enëa, io non Paulo sono; / me degno a ciò né io né altri ’l crede” (Inf. II, 31-33; cfr. la richiesta a Virgilio circa le genti in riva all’Acheronte: «per ch’io dissi: “Maestro, or mi concedi / ch’i’ sappia quali sono …”», Inf. III, 72-73). “Lo tempo è poco omai che n’è concesso, / e altro è da veder che tu non vedi”, afferma Virgilio nel lasciare la nona bolgia (Inf. XXIX, 11-12).
‘Concedere’ è proprio di Dio e del suo provvedere. Cacciaguida, che pure in quanto beato va da tempo “leggendo del magno volume / du’ non si muta mai bianco né bruno” (Par. XV, 50-51), avrebbe voluto che almeno vi fosse stato mutato il destino di Buondelmonte, cosicché costui fosse morto, affogato nella sua Val di Greve, prima di entrare nella pacifica Firenze: “Molti sarebber lieti, che son tristi, / se Dio t’avesse conceduto ad Ema / la prima volta ch’a città venisti. / Ma conveniesi, a quella pietra scema / che guarda ’l ponte, che Fiorenza fesse / vittima ne la sua pace postrema” (Par. XVI, 142-147). “Ma conveniesi … oportet fieri”, cioè era utile e necessario, che Firenze piangesse.
Questa tematica iniziale concernente il titolo del libro si completa con le numerose ingiunzioni fatte a Giovanni perché scriva ciò che vede (in particolare, nella prima visione, ad Ap 1, 11; 1, 19; nella settima, ad Ap 21, 5), che possono essere confrontate con le ingiunzioni provenienti da Beatrice di scrivere le visioni avute nell’Eden “in pro del mondo che mal vive” (Purg. XXXII, 103-105; XXXIII, 52-55). Da notare, nel primo caso, la metamorfosi della prosa latina (con passi tra loro collazionati) nei versi in volgare: «(Ap 1, 19) “Scribe ergo que vidisti” … (Ap 1, 11) “Quod vides”, id est quod visurus es et videre iam cepisti, “scribe in libro”, id est fac inde librum sollempnem – Però, in pro del mondo che mal vive, / al carro tieni or li occhi, e quel che vedi, / ritornato di là, fa che tu scrive» (fa non deriva dal testo sacro, ma dalla sua esegesi). Alla conclusione del decimo capitolo, a Giovanni-Dante viene affidato il compito di predicare nuovamente il libro della sapienza cristiana (Ap 10, 9-11).
Si è detto che la causa finale del libro dell’Apocalisse, ciò che si consegue attraverso la sua intelligenza e osservanza, è la beatitudine: “Beato chi legge e chi ascolta” (Ap 1, 3). L’intelligenza si ottiene tramite la lettura e l’ascolto; la prima spetta ai dottori o ai letterati, il secondo ai laici. Per la salvezza non basta tuttavia apprendere o sapere senza conservare nell’affetto – con fede, speranza, carità e timore – e nelle opere, per cui si dice: “e chi conserva”.
Il passo tratto da Ap 1, 3 può essere collazionato con quello da Ap 3, 3, in cui alla quinta chiesa, e al suo intorpidito vescovo, viene raccomandato di avere sempre in mente, ripensandola con attenzione, la prima grazia ricevuta da Dio, ascoltata nella predicazione e dimenticata per torpore: una volta tornata alla mente, la prima grazia – che corrisponde a un principio di bellezza e di pienezza stellare [66] – deve essere conservata. Da questo difetto sono esclusi “pochi nomi”, cioè quelle persone i cui nomi sono “noti” a Cristo per la loro santità (Ap 3, 4).
Il tema del “beatus qui audit … et servat” costituisce il tessuto delle parole di Virgilio a Dante “sì smarrito” (rende il “sic torpens” di Ap 3, 3; cfr. quanto dice Beatrice allo stesso Virgilio a Inf. II, 64), che volge i passi da Farinata “ripensando / a quel parlar che mi parea nemico” in quanto gli aveva predetto sciagure (Inf. X, 121-132). Come il vescovo della quinta chiesa, Dante viene invitato a conservare nella mente quello che ha ascoltato (anche se non si tratta della “prima grazia”, ma di profezie contrarie). Il motivo dell’attenzione sta nel drizzare il dito da parte di Virgilio, per affermare che solo quando sarà dinanzi a Beatrice, “al dolce raggio / di quella il cui bell’ occhio tutto vede”, potrà conoscere il corso della propria vita. Il fine di chi ascolta, ripensa attentamente e conserva ciò che ha ascoltato è la beatitudine.
Altro esempio di variazione di questo gruppo tematico è il ‘serbare’ alle chiose di Beatrice quanto narrato al poeta sul proprio destino da Brunetto Latini: la donna saprà spiegare la profezia circa il conseguimento dell’infallibile glorioso porto insieme a quanto oscuramente dettogli da Farinata sul peso dell’arte del rientrare in patria (Inf. XV, 88-90). Anche l’espressione di Virgilio “Bene ascolta chi la nota” (ibid., 99) sembra derivare dai medesimi temi, se interpretata nel senso che solo chi “nota”, cioè ha in mente e conserva, ascolta bene. Virgilio interviene dopo che per due terzine Dante ha dichiarato di essere pronto ai colpi della Fortuna: “però giri Fortuna la sua rota / come le piace” (ibid., 91-96). La Fortuna, così come presentata a Inf. VII, 94-96, per quanto ministra di Dio, è il contrario del “beatus qui audit”: “ma ella s’è beata e ciò non ode” (nel senso che non ascolta il biasimo e la mala voce datale dai mondani; cfr., a Inf. X, 97, le parole di Dante a Farinata: “El par che voi veggiate, se ben odo …”). In presenza di Brunetto, per le parole di Virgilio, Dante le si oppone come colui che bene ascolta e conserva.
Ancora variante dell’ascoltare e del serbare “in affectu et opere”, da Ap 1, 3, è quanto il poeta dice ai tre fiorentini sodomiti: “e sempre mai / l’ovra di voi e li onorati nomi / con affezion ritrassi e ascoltai” (Inf. XVI, 58-60), dove il nominare è precipuo tema della quinta chiesa (Ap 3, 4) e, più in generale (nel senso di fama), di tutto il quinto stato. Serbare “ad salutem … in affectu” dopo aver visto (“beatus qui legit”) è nella preghiera alla Vergine di san Bernardo: “Ancor ti priego … che conservi sani, / dopo tanto veder, li affetti suoi” (Par. XXXIII, 34-36).
Stazio, iniziando la lezione sulla generazione umana, invita Dante a ricevere e a conservare nella mente le sue parole (Purg. XXV, 34-36; da Ap 3, 3). Un’ulteriore variante è l’inciso contro la gente che dovrebbe “esser devota” (gli ecclesiastici) in Purg. VI, 93: “se bene intendi ciò che Dio ti nota”. Ancora, l’attenzione e l’ascoltare sono propri di Virgilio, che in Inf. IX, 4 attende l’arrivo del messo celeste.
Il ricordare un ‘prima’ bello che non si ritrova più perché mutato in meglio si verifica nel riconoscimento di Piccarda. Nel rivelarsi, la donna invita il poeta a ricordare con mente attenta i “primi concetti” che ebbe di lei, cioè la prima immagine conosciuta in terra, e Dante replica che questi “primi” sono tanto trasfigurati dallo splendore divino da non avergli consentito un immediato riconoscimento senza l’aiuto delle parole del suo interlocutore (Par. III, 47-49, 58-63).
Trasposizione quasi letterale del testo teologico è l’invito di Beatrice ad aprire la mente per fermarvi dentro quanto il poeta ascolterà da lei sull’essenza del voto religioso, “ché non fa scïenza, / sanza lo ritenere, avere inteso” (Par. V, 40-42; cfr. Par. XIII, 1-3). Si tratta certo di un modo comune di dire: “il concetto ritorna frequente nelle raccolte medievali di massime, sulle orme di analoghe sentenze di Seneca e di Cicerone” (Sapegno). Ma anche questo concetto trova rispondenze nella Lectura che lo armino (è Beatrice ad esprimerlo, il cui nome coincide la causa finale dell’Apocalisse), e si tratta proprio di quelle parole che avrebbero convinto Machiavelli a notare le conversazioni da lui intrattenute “nelle antique corti delli antiqui huomini” e a comporre un opuscolo De principatibus, come scrisse a Francesco Vettori il 10 dicembre 1513.
[LSA, cap. I, Ap 1, 1.3 (prohemium, titulus)] “Apocalipsis Ihesu Christi” (Ap 1, 1). Liber iste dividitur in exordium seu prohemium et narrationem et conclusionem. Narratio autem incipit ibi (Ap 1, 9): “Ego Iohannes frater vester”. Conclusio vero circa finem libri, ibi (Ap 22, 6): “Et dixit michi: Hec verba fidelissima sunt et vera”. In prohemio autem et conclusione commendat et magnificat prophetiam huius libri, ut sit susceptibilior et fide dignior et ut attentius et amabilius ac timoratius suscipiatur.
|
|
Purg. XXXI, 133-145“Volgi, Beatrice, volgi li occhi santi”,
|
Purg. XXX, 55-75, 136-138; XXXI, 1-6“Dante, perché Virgilio se ne vada,
|
Inf. I, 91-93; XII, 85-87; XXVIII, 49-51“A te convien tenere altro vïaggio”,
|
Par. XVIII, 76-81, 88-90sì dentro ai lumi sante creature
|
Inf. XIV, 16-18O vendetta di Dio, quanto tu dei
|
Purg. III, 124-126, 142-144Se ’l pastor di Cosenza, che a la caccia
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 3 (prohemium, titulus)] Ostensa igitur causa formali et effectiva et materiali, subdit de causa finali, que est beatitudo per doctrine huius libri intelligentiam et observantiam obtinenda. Unde subdit (Ap 1, 3): “Beatus qui legit” et cetera. Quantum ad ea que proprio visu vel per propriam investigationem addiscimus, dicit: “qui legit”; quantum vero ad ea que per auditum et alterius eruditionem addiscimus, dicit: “qui audit”. Primum etiam magis spectat ad litteratos vel ad doctores, qui aliis legunt et exponunt; secundum vero ad laicos vel auditores.
|
|
Inf. IX, 4Attento si fermò com’ uom ch’ascoltaInf. X, 97-99, 121-132El par che voi veggiate, se ben odo,
|
Purg. VI, 93se bene intendi ciò che Dio ti notaPurg. XXV, 34-36Poi cominciò: “Se le parole mie,
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 1 (prohemium, titulus)] Nota etiam quod potius dicit revelatio quam visio, quia magis significat donum et gratiam revelantis et archanam occultationem eius, nisi dono Dei eius velamen auferatur seu aperiatur.
|
|
Inf. XXXIV, 127-129Luogo è là giù da Belzebù remoto
|
Purg. XXIII, 37-48, 61-63, 112-114Già era in ammirar che sì li affama,
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 1-2 (prohemium, titulus)] Nota etiam quod ex hoc quod dicit eam sibi esse datam “palam facere”, docet duo. Primum est quod multa dantur et revelantur non ad ali[is] revelandum nec cum auctoritate propalandi ea, immo cum precepto vel debito ea secrete servandi.
|
|
Inf. II, 31-33; III, 72-75Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede?
|
Par. V, 109-120Pensa, lettor, se quel che qui s’inizia
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 19 (Ia visio)] “Scribe ergo que vidisti” (Ap 1, 19). Hec est tertia pars visionis, in qua ponitur visio Christi mandantis Iohanni quod scribat et mittat ecclesiis totam hanc visionem, specificans duo ex scribendis, ibi: “Misterium septem stellarum”, et exponens illa ibi: “Septem stelle” et cetera (Ap 1, 20).
|
|
Purg. XXXII, 103-105; XXXIII, 55-57Però, in pro del mondo che mal vive,
|
Par. XVII, 37-42, 127-128La contingenza, che fuor del quaderno
|
8. Alleluia
L’esegesi di Ap 19, 1 tratta del festivo giubilo che segue la dannazione della nuova Babilonia; è particolarmente importante sotto l’aspetto della conversione finale dei Gentili e d’Israele i quali, rinnovando la festività delle Palme, entreranno in Cristo “in spiritu magno et alto”. Più avanti, ad Ap 19, 17-18, si tratta dello spirituale e serotino convivio al quale inviterà Elia (“Et vidi unum angelum stantem in sole”), passo fondamentale nella salita al cielo descritta nel primo canto del Paradiso.
Beatrice racchiude in sé tre nomi i quali, in segno di reverenza, non possono essere tradotti. Il primo è il greco “apocalisse” (che significa ‘rivelazione’): appartiene alla donna di Dante nel suo disvelarsi nell’Eden, insieme a tutti gli elementi semantici e concettuali che accompagnano, nei primi tre versetti del libro sacro, il termine apocalipis. Il nome della donna coincide anche con la causa finale del libro (la “beatitudo”).
Gli altri due nomi sono ebraici: “alleluia” (che significa ‘lodare Dio’, come detto ad Ap 19, 1: “Quod est hebreum et est idem quod laudare Deum”) e “amen” (che significa ‘veramente’, come ad Ap 19, 4: «“Amen, alleluia”, id est vere est Deus ineffabiliter laudandus») [67]. Lucia così le si rivolge nell’Empireo per muoverla a salvare l’amico: “Beatrice, loda di Dio vera” (Inf. II, 103), dicendo tre parole non interpretate, cioè non traducibili in segno di reverenza: ‘apocalipsis, alleluia, amen’. Beatrice è colei che nell’Empireo canta “alleluia”, come dice Virgilio a Chirone (Inf. XII, 88).
Da notare la rima in –uia a Par. IX, 73 (“Dio vede tutto, e tuo veder s’inluia”), nel rivolgersi di Dante a Folchetto di Marsiglia, spirito amante non ancora manifestatosi. ‘Inluiarsi’ è neologismo dantesco, e significa letteralmente ‘penetrare in Dio’. Ma l’alta retorica che sempre fascia i versi richiama “alleluia”, che secondo san Girolamo è uno dei nomi di Dio (ia), nel senso che il vedere dei beati si accompagna alla lode ineffabile. Di rilievo è anche l’esplicito riferimento al letiziar, per cui “là sù fulgor s’acquista” (ibid., 70). La lunghezza (il vedere), la larghezza (il gaudio) e l’altezza (la lode) sono le misure, perfettamente uguali fra loro, della città celeste [68].
Dice Adamo che “I s’appellava in terra il sommo bene / onde vien la letizia che mi fascia”: questo prima che, con la sua morte, scendesse al Limbo (“a l’infernale ambascia”). Poi – continua il progenitore – gli uomini diedero a Dio un altro nome, El, “e ciò convene, / ché l’uso d’i mortali è come fronda / in ramo, che sen va e altra vene” (Par. XXVI, 133-138). Questo variare dell’umano artificio, che la natura lascia agli uomini, è espresso da Adamo attraverso il tema della bellezza (“secondo che v’abbella”, ibid., 130-132), un tema proprio del quinto stato nel suo bell’inizio ripieno dei doni dello Spirito: il quinto stato è per eccellenza quello della vita associata [69].
La presenza della letizia nelle parole di Adamo sembra ricondurre il nome I non a un numero (l’unità di Dio), né genericamente a un nome di massima semplicità, bensì a Ia (I consonantica, pronunciata Ia) [70], cioè ad alleluia, nome che esprime l’ineffabilità di Dio e, dal punto di vista dell’uomo, la lode tributatagli. Tale è nell’esegesi di Ap 19, 1, dove sono citati Girolamo e Agostino [71]. Il primo nome di Dio fu dunque di ineffabile lode, espresso anche da Beatrice, “loda di Dio”.
[LSA, cap. XIX, Ap 19, 1 (VIa visio)] Pro primo dicit: “Post hoc”, id est post dampnationem Babilonis, “audivi vocem magnam quasi tubarum multarum in celo dicentium: Alleluia” (Ap 19, 1). Quot sancti erunt tunc tot erunt et tube, que per Spiritus Sancti vehementem flatum ex intimis visceribus usque ad celum et in totum orbem divinas iubilationes et laudes altissime et effusive resonabunt. Et quia magna multitudo Iudeorum et gentium, et Grecorum et Latinorum, tunc intrabit ad Christum in spiritu magno et alto, ideo tunc multe erunt tube magnis vocibus spiritalium intellectuum et affectuum resonantes, sicut et in huius typum sexta hebdomada quadragesim[e] sextoque die ante passionem Domini celebratur annuatim sollempnitas palmarum, in qua a multis populis glorificatus est Christus. Turbe enim que precedunt designant Grecos et que sequuntur Latinos; que autem occurrunt ad descensum montis Olivarum Iudeos, inter quos sunt et pueri Hebreorum. Igitur hii omnes cantabant “Osanna filio David” et ‘gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe redemptor’ (cfr. Mt 21, 9-15).
|
|
[LSA, cap. XIX, Ap 19, 4] Deinde ostendit quomodo communi laudi sanctorum correspondebit laus prelatorum presidentium collegiis sanctorum. Unde subdit (Ap 19, 4): “Et viginti quattuor seniores et quattuor animalia ceciderunt et adoraverunt Deum sedentem super tronum dicentes: Amen, alleluia”, id est vere est Deus ineffabiliter laudandus. Dicendo enim “amen” confirmant laudem communitatis suorum subditorum, et post hoc addunt et ipsi suam laudem […].Par. IX, 70-75Per letiziar là sù fulgor s’acquista,
|
Inf. II, 103-105Disse: – Beatrice, loda di Dio vera,
|
9. Conclusioni
Se don Chisciotte voleva affidare al Sant’Uffizio la scimmia eterodossa di mastro Pietro, per esaminarla, nessuno poté condannare compiutamente la Commedia, nonostante il bando dei Domenicani del Capitolo provinciale (della Provincia romana) di Firenze, intervenuto nel 1335. Eppure la Commedia era stata concepita e scritta per intero su un libro che, già censurato in Curia almeno dal 1317-18, a meno di cinque anni dalla morte di Dante sarebbe stato condannato in un concistoro pubblico da Giovanni XXII “tamquam continentem pestiferum et hereticum dogma contra unitatem Ecclesie catholice et potestatem summi pontificis romani”, come testimoniato dall’inquisitore domenicano Bernard Gui (8 febbraio 1326). Già allora nessuno poteva più comprendere il linguaggio interiore della Commedia; il pubblico al quale era destinato non si era formato; il libro-vessillo degli Spirituali veniva condannato e letto solo di nascosto. Il “poema sacro”, che per l’autore era stato il manifestare una vera visione, fu interpretato come finzione letteraria, e tale è rimasto fino ai giorni nostri.
Si registra qui di seguito lo stato della ricerca (31 dicembre 2016) [72].
L’accostamento della Commedia alla Lectura super Apocalipsim non è nuovo, da Ernesto Buonaiuti [73] a Raoul Manselli [74] a Ovidio Capitani [75], ma si trattava di vicinanza di idee e toccava solo alcuni punti della Commedia. La nuova scoperta, avvenuta nel corso di una ricerca ventennale, sta nel fatto che si tratta di un rapporto tecnico; esso riguarda tutto il poema per ognuno dei 14233 endecasillabi, nei quali i concetti teologici vengono incardinati e trasformati. Questa straordinaria metamorfosi testuale si fonda su precise e verificabili norme, già più volte indicate e che qui vengono riproposte.
a) Gruppi di parole ravvicinate presenti nella Lectura super Apocalipsim si ritrovano, con parole altrettanto ravvicinate, ma liberamente collocate nelle forme più varie, nella Commedia, quasi fili tratti da altro ordito e, intrecciati con altri, tessuti in uno nuovo. Il fenomeno risulta troppo diffuso perché sia casuale. Non si tratta di parole isolate, ma collocate in una rosa entro spazi testuali ristretti; gli accostamenti non sono banali o scontati. Non c’è calco o riscrittura; il travaso non è di frasi – e non potrebbe esserlo dalla prosa alla poesia – ma di elementi semantici che sono segnali, in un’alta retorica del significante. La compresenza risulta evidente per quanto, nel lessico della Commedia, proviene dal latino, si tratti di latinismi o di termini già entrati nell’uso fiorentino. Ma anche le voci fiorentine di ogni strato sociale, o quelle tratte da altri dialetti della penisola, i gallicismi, gli arabismi, i neologismi concordano con l’esegesi apocalittica, talora anche per somiglianza fonica, circondati da segnali che sollecitano il lettore verso l’altro testo.
A dimostrazione della costanza di questa norma, altrove è stato registrato (in un centinaio di esempi) come, a partire da singole parole, nello stesso verso o nei versi immediatamente circostanti se ne registrano altre che si riferiscono al medesimo luogo dell’esegesi apocalittica (non al solo testo dell’Apocalisse, ma a questo e alla sua esegesi).
b) Un medesimo luogo della Lectura conduce, tramite la compresenza delle parole, a più luoghi della Commedia. Ciò significa che la medesima esegesi di un passo dell’Apocalisse è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del poema.
A dimostrazione si vedano, ad esempio, i numerosi rinvii dai versi al passo sulla signatio (Ap 7, 3-4).
c) Più luoghi della Lectura possono essere collazionati tra loro, secondo un procedimento analogico tipico delle distinctiones ad uso dei predicatori. La scelta non è arbitraria. Vi predispone lo stesso testo scritturale, poiché l’Apocalisse contiene espressioni, come Leitmotive, che ritornano più volte. È determinata da parole-chiave che collegano i passi da collazionare. È suggerita dallo stesso Olivi, nel prologo, per una migliore intelligenza del testo. L’introduzione di categorie estranee di per sé al testo sacro – la divisione della storia della Chiesa in sette ‘stati’, ciascuno dei quali raccolga l’esegesi dei singoli elementi settenari in cui sono divise le visioni apocalittiche – fa sì che un commento sui ventidue capitoli dell’Apocalisse si trasformi in una teologia della storia. La mutua collatio di parti della Lectura arricchisce il significato legato alle parole e consente uno sviluppo tematico.
L’Apocalisse si articola in sette visioni: le sette chiese d’Asia, i sette sigilli, le sette trombe, la donna vestita di sole (le sette guerre sostenute dalla Chiesa), le sette coppe, il giudizio di Babylon nelle sette teste del drago, la Gerusalemme celeste. Le prime sei visioni possono essere a loro volta divise in sette momenti, ciascuno dei quali riferibile a uno dei sette stati. Assembrando, per le prime sei visioni, tutti i primi elementi (chiesa, sigillo, tromba, guerra, coppa, momento del giudizio di Babylon), tutti i secondi, i terzi e cosí di seguito, si ottengono sette gruppi di materia teologica, corrispondenti al complesso dei temi afferenti a ciascuno dei sette stati. A questi sette gruppi se ne aggiungono altri due: l’esegesi della settima visione (senza articolazioni interne) e l’esegesi di capitoli del testo scritturale, o di parti di essi, introduttivi delle successive specificazioni delle singole visioni per settenari, che l’Olivi definisce “radicalia” o “fontalia”. Si ottengono in tal modo nove gruppi: le parti proemiali, i sette assembramenti di settenari e la settima visione. Il grande prologo della Lectura, articolato in tredici notabilia, può essere anch’esso riaggregato secondo i sette stati.
Il principio è chiaramente affermato nel notabile VIII del prologo:
“[…] si omnia prima membra visionum ad invicem conferas et consimiliter omnia secunda et sic de aliis, aperte videbis omnia prima ad idem primum concorditer referri et consimiliter omnia secunda ad idem secundum et sic de aliis. Et hoc in tantum quod plena intelligentia eiusdem primi multum clarificatur ex mutua collatione omnium primorum, et idem est de omnibus secundis et tertiis et sic de aliis” (Par. lat. 713, ff. 12vb-13ra).
Un libro (la Lectura) contiene dunque, nel prologo, princìpi e criteri affinché l’accorto lettore possa trarne un altro libro, fatto con lo stesso materiale ma ricomposto e distribuito in forma diversa. Questa forma organizzatoria, proposta in contemporanea agli scritti di Raimondo Lullo, era certamente uno strumento mnemonico: i sette stati possono essere infatti assimilati agli innumerevoli settenari della storia sacra. In tal modo l’esegesi dell’ultimo libro canonico si trasforma in una teologia della storia, che comprende per settenari tutta la Scrittura, la quale a sua volta è forma, esempio e fine di ogni scienza:
“Si enim omnes septenarios in scripturis positos coaptes ad septenarios huius libri, innumerabilia misteria tibi clarescent, si diligenter attenderis ipsorum parilem concordiam et consignificantiam […]” (LSA, prologo, notabile XIII; Par. lat. 713, f. 20vb); “Ipsa [Scriptura] enim est principium omnis scientiae et comprehensiva omnis scientiae et forma seu exemplar omnis scientiae et finis omnis scientiae” [cfr. De causis Scripturae § 4, in Peter of John Olivi On the Bible. Principia quinque in Sacram Scripturam …, ed. D. Flood – G. Gál (Franciscan Institute Publications, Text Series, 18), New York 1997, 44].
Se la tradizione manoscritta non ci ha trasmesso alcun testimone contenente un’organizzazione per stati del testo della Lectura super Apocalipsim, questa forma è però attestata da fonti inquisitoriali. Nel 1318 due teologi – il carmelitano Guido Terreni e il domenicano Pietro de Palude – inviarono al papa Giovanni XXII un memoriale contenente quarantadue articoli erronei estratti da un compendio in catalano della Lectura dell’Olivi intitolato De statibus Ecclesiae secundum expositionem Apocalypsis [cfr. J. M. Pou y Martí, Visionarios, Beguinos y Fraticelos catalanes (Siglos XIII-XV), Vich 1930, pp. 255-258, 483-512]. Il medesimo titolo reca una versione (Venetiis 1516, 1525) del quinto libro dell’Arbor vitae di Ubertino da Casale, libro che è una riscrittura del commento dell’Olivi (“incipit tractatus de septem statibus ecclesie iuxta septem visiones beati Johannis in Apocalypsi ”). Esistevano inoltre compendi della Lectura (come il ms. Siena, Biblioteca comunale, F.IV.11, ff. 35v-76v), e anche volgarizzamenti parziali (un esempio dovrebbe essere pubblicato sulla rivista “oliviana” – [http://oliviana.revues.org/] – da Caterina Menichetti).
Non è d’altronde operazione molto complessa quella di scomporre analogicamente la Lectura secondo gli status (cfr. Il terzo stato, La settima visione) e con parole-chiave (si veda, ad esempio, il caso della parola “terremotus”).
d) L’intenso travaso semantico dalla Lectura nella Commedia si accompagna a un fatto strutturale. La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati della storia della Chiesa, cioè alle categorie con cui l’Olivi organizza la materia esegetica. È un ordine registrabile per zone progressive del poema dove prevale la semantica riferibile a un singolo stato, ordine dirompente i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ogni stato, che ha differenti inizi, è concatenato per concurrentia, come le maglie di un’armatura, con quello che precede e con quello che segue. Ciascuno stato ha in sé una grande ricchezza di motivi e contiene inoltre temi di tutti gli altri stati, consentendo innumerevoli intrecci e variazioni.
Si possono in tal modo redigere mappe che comprendano l’ordine spirituale della Commedia. La ricerca, collocata su un sito per sfruttare gli spazi offerti dalla rete, è pervenuta a una Topografia spirituale della Commedia, dove per quasi ogni verso, o gruppo di versi, collegamenti ipertestuali conducono al “panno” esegetico fornito dalla Lectura super Apocalipsim, sul quale il “buon sartore” ha fatto “la gonna”, per usare la similitudine proposta da san Bernardo nell’Empireo.
Il grado di certezza offerto dal confronto testuale, simile a quello che si registra nelle scienze della natura, consente ora allo storico di riflettere sulle cause di un legame così intenso ed esteso. Esso presuppone un messaggio, cioè un rapporto con un pubblico.
Si può in principio pensare che il messaggio in realtà non sia mai esistito, e ricordare quanto affermò Singleton nell’annunciare la scoperta del numero sette come numero centrale della Commedia, rivelatore di una mirabile struttura nascosta ancora tutta da decifrare. Come nella cattedrale di Chartres gli scalpellini lasciarono bellissimi fregi a grande altezza, dove occhio umano non sarebbe potuto arrivare, così l’ordine e l’intelligenza del poema non furono concepiti solo per la vista degli uomini: “quel disegno, qualunque fosse il suo posto nella struttura, l’avrebbe veduto Colui che tutto vede, Colui che ha creato il mondo con meraviglioso ordine, in pondere, numero, mensura; e l’avrebbe certo guardato come prova che l’architetto umano aveva imitato l’universo che Egli, divino architetto, aveva creato innanzi tutto per la propria contemplazione, e poi, per la contemplazione degli angeli e degli uomini” [76]. Quel disegno però qualche umano l’ha visto e registrato, anche se dopo un silenzio di sette secoli.
Premesso dunque che Dante non ha lavorato tanto sulla Lectura super Apocalipsim solo per il Primo lettore del suo “poema sacro”, non restano, al momento, che due risposte al problema.
Una prima risposta può essere, per così dire, di carattere tecnico. La persistenza di un “panno” – cioè di un altro testo da cui trarre i significati spirituali del poema, materialmente elaborati attraverso le parole – serve a mantenere l’unità e la coerenza interna dell’ordito della “gonna” (cfr. Par. XXXII, 140-141). Sia stata o meno la Commedia pubblicata (o meglio conosciuta da altri) per gruppi di canti, non più modificabili [77], sempre stava innanzi al poeta la medesima esegesi teologica con le innumerevoli possibilità di variazioni tematiche e di sviluppi. Dunque il legame con la Lectura dell’Olivi, con la sua struttura settenaria, sarebbe stato dettato dall’esigenza di un ordine mentale, dal “fren de l’arte”.
Questa struttura interna, tuttavia, si fonda su una semantica che proviene da un altro testo e al tempo stesso, liberamente adattata e disposta in volgare, ad esso rinvia. Quest’altro testo – la Lectura – non era sconosciuto, anche se principalmente diffuso nell’ambito francescano; chi lo conosceva a fondo non avrebbe avuto difficoltà a rileggerlo mentalmente, pur fra innumerevoli variazioni, nei versi in volgare. Dunque, un lettore diverso da sé il poeta l’aveva previsto anche per i sensi interiori.
Viene qui in rilievo la seconda risposta. L’elaborazione intertestuale che accompagnò l’intera stesura del “poema sacro”, con un procedimento analogico su singole parti della Lectura assimilabile alle “distinctiones” dei predicatori, costituisce un eccezionale esempio di arte della memoria. Nella struttura interna le imagines agentes sono le parole-chiave, che conducono il lettore alla dottrina contenuta nella Lectura super Apocalipsim. Le singole parole si leggono, nel contesto dei versi, come segni che conducono all’altro testo dottrinale consentendo così il passaggio dal senso letterale, che è per tutti, a quelli mistici in esso racchiusi, riservati ai depositari della chiave di sì alta crittografia.
Dalla poesia, dunque, il lettore spirituale sarebbe risalito a un testo dottrinale da lui già conosciuto. La poesia in volgare si poneva come “speculum clericorum”, con un fine devozionale e di edificazione di una cerchia di lettori dotti. Ma quel lettore, rafforzando la memoria della dottrina contenuta nella Lectura, scritta in latino, l’avrebbe trovata dotata di “e piedi e mano” per una predicazione in volgare. “Beatus qui legit, et qui audit verba prophetiae”: il fine dell’Apocalisse (Ap 1, 3), la beatitudine, è rivolto a due categorie: i chierici e i laici. Per entrambi si aggiunge: “et qui servat ea”. L’arte della memoria serve appunto, alla prima categoria, per fermare e conservare nella mente. Come la struttura esteriore offre luoghi e immagini, anche quella interiore consente di percorrere ‘zone’ del poema (non coincidenti con le divisioni letterali) nelle quali sono collocate le parole-chiave che si riferiscono ai sette stati e alla loro esegesi. Il legame fra le parole, nel senso letterale, descrive luoghi e vi colloca immagini impressionanti; in quello spirituale suscita alla mente concetti dottrinali.
Se si può affermare che valga per Dante quello che scrive Tommaso d’Aquino sul senso spirituale, nel quale non è contenuto nulla di necessario alla fede che non sia espresso in qualche luogo dal senso letterale, perché questo è fondamento di tutti gli altri (Summa Theologiae, I, qu. I, a. 10) [78], non si può negare che valga anche quanto Tommaso afferma poco prima (ibid., a. 9), sull’uso delle metafore nella Scrittura [79]. L’Aquinate distingue tra l’uso che ne fanno i poeti, “propter repraesentationem” e per fine di diletto, dall’uso che ne fa la Scrittura, “propter necessitatem et utilitatem”, avendo per fine di proporre a tutti verità spirituali, anche alla comprensione dei rudi, “qui ad intelligibilia secundum se capienda non sunt idonei”. La verità, rivelata dal raggio divino, rimane sempre tale, né viene meno per le figure sensibili, perché da esse la mente può elevarsi a ciò che è intellettuale. L’ “occultatio figurarum” è utile per l’esercizio negli studi e contro le derisioni degli infedeli, secondo quanto afferma Cristo: “non vogliate dare ai cani ciò che è santo” (Matteo 7, 6).
Né è possibile negare l’importanza per Dante di quanto afferma Bonaventura, sulla scia dell’interpretazione spirituale della Scrittura di Gioacchino da Fiore, circa l’allegoria che coglie “quid credendum”, che non è dato attraverso la lettera, acqua senza vino, pietra senza pane, scorza senza frutto lì dove la comprensione spirituale distingue il cristiano dal giudeo [80].
Come nella Scrittura esistono due livelli, il letterale e il mistico, così nella Commedia, che l’autore riteneva una nuova Apocalisse, scritta da un nuovo Giovanni. In essa la metafora dei poeti, che rappresenta dilettando, si sposa alla metafora della Scrittura, necessaria, utile e occulta per esercitare nello studio e contro le irrisioni degli infedeli.
Dante avrebbe voluto crearsi un nuovo pubblico. Il principio secondo il quale clerus vulgaria tempnit, per usare le parole di Giovanni del Virgilio nel carmen indirizzato a Dante, sarebbe stato smentito. Il senso letterale, rivolto a chiunque, ne avrebbe racchiuso altri ‘mistici’ rivolti ai pochi – agli Spirituali francescani, e forse non solo ad essi, se la Lectura si fosse diffusa anche presso altri Ordini – a coloro cioè che con la predicazione avrebbero potuto riformare la Chiesa. Un gruppo di lettori privilegiato che possedeva la Lectura super Apocalipsim avrebbe potuto leggerla, parafrasata e aggiornata, nei versi in volgare. I riformatori erano soprattutto predicatori. La Commedia è un viaggio per exempla. Se grazie alla Commedia Dante fosse tornato a Firenze “con altra voce omai, con altro vello”, quanti predicatori non l’avrebbero citata dai pergami cittadini?
Il “poema sacro” si sarebbe proposto come speculum per quel gruppo riformatore. Non solo avrebbero potuto predicarlo, ma sarebbe stato guida nella conduzione del gregge affidato. Un pastore devoto vicino al popolo cristiano, che lasci “seder Cesare in la sella”, non impegnato a discettare da opposti estremismi di rigoristi e rilassati, non timoroso della classicità tanto da riconoscere in Aristotele il “maestro di color che sanno”, ma con la non secondaria clausola di concordarlo con la visione apocalittica dell’Olivi (che riassume l’intera Scrittura); pronto ad ammettere gli antichi e i moderni poeti come figure del nuovo poeta “sesto tra cotanto senno” e della sua vera visione che, nuovo Giovanni, aveva avuto l’ordine di scrivere; convinto che la conversione della “prava terra italica” debba essere recata ad esempio universale della futura conversione finale delle genti e di Israele.
Quel pubblico non si formò. I testi mostrano come la renovatio cantata da Dante ponesse in perfetto equilibrio la storia della salvezza collettiva propria della “media aetas”, di cui la Lectura oliviana fu l’ultima espressione, e il singolo individuo con le sue nuove esigenze, la lingua, la natura, il regime politico, i classici. Lo sviluppo storico, che non registrò l’auspicata riforma della Chiesa, fattasi avara Babilonia avignonese, condannò la visione collettiva a vantaggio dell’individuo e dissociò il miles Christi nel cristiano e nel cittadino; si perse subito, se mai alcuno fece in tempo ad accorgersene, il linguaggio spirituale che porta i sensi interiori della Commedia, scritta come l’Apocalisse “dentro e fuori”, e ne rimase il senso letterale e la selva dei commenti e delle interpretazioni impotenti a spiegare l’altro nascosto. Quella perdita di coscienza, già nel secondo decennio del Trecento, fu sintomo evidente dell’ “autunno del Medioevo”.
La seconda risposta al problema della cause del rapporto tra Commedia e Lectura super Apocalipsim, il concepire da parte di Dante un pubblico di chierici riformatori, non esclude la prima, connessa ad utilità tecniche. L’arte della memoria per parole-chiave non serviva soltanto ai chierici. Il fatto che gruppi di terzine numericamente corrispondenti, a diversi stadi della Commedia, contengano parole-chiave che conducono alla medesima pagina esegetica sembra indicare che queste parole, se dovevano essere per il lettore spirituale signacula mnemonici di un altro testo, erano per il poeta anche segni del numero dei versi, ‘luogo’ dove collocare i medesimi signacula in forma e contesto diversi.
Proprio in questa ars memorativa, e nella sua chiave, sta quello che Alberto Asor Rosa ha definito “l’unico ma grandioso mistero, con cui ha a che fare ogni lettore di Dante (incomparabile con quei misteriucci da quattro soldi, con cui si sono misurati gli Aroux e i Guénon): il mistero del segno, o di quel sistema di segni, che ha racchiuso un mondo intero in un insieme d’immagini plurisense” [81].
La metamorfosi della Lectura super Apocalipsim nei versi in volgare non fa venir meno il voluto carattere polisemico del “poema sacro”, secondo quanto l’autore stesso afferma nell’Epistola a Cangrande (Ep. XIII, 20). Con l’esegesi dell’ultimo libro canonico, esposta in una teologia della storia che comprende per settenari tutta la Scrittura, la quale a sua volta è forma, esempio e fine di ogni scienza, concorda infatti ogni conoscenza, ogni esperienza, ogni soluzione indipendente data a questioni dottrinali. La Lectura non è una fonte, bensì il libro della storia delle illuminazioni sapienziali con cui tutto deve concordare. Si vedano, ad esempio, gli echi virgiliani incastonati nell’esegesi. L’ “umile Italia” è la Giudea, che si convertirà per ultima. La figura di Caronte è vestita in parte con i panni di Cristo sommo pastore (la canizie, la lana, gli occhi flammei rotanti). Il ramo che si vede in autunno dispogliato (Inf. III, 112-114) sollecita la memoria del lettore verso l’esegesi di due passi simmetrici, Ap 3, 3 e 16, 15 (i quali armano anche Stazio nel risveglio di Achille a Sciro a Purg. IX, 34-42). I Centauri sono una pessima Trinità, e con essa consuonano anche nei nomi (Inf. XII, 67-72). Omero, che vola sopra gli altri, è antica figura di Gregorio Magno, aquila nel percorrere i sentieri dell’allegoria. Aristotele, ” ‘l maestro di color che sanno”, occupa la sede divina da cui discende la sapienza, prima dell’apertura da parte di Cristo del libro segnato da sette sigilli. Non fanno eccezione Ovidio con Mirra o con il “trasumanar” di Glauco, Lucano con i serpenti o con Amiclate. Per Boezio si vedano Purg. XXX, 130-132 o Par. II, 127ss. A siffatta “concordia” è interessata la stessa Scrittura: i Salmi, ad esempio, non vengono molto citati nella Lectura, ma quando lo sono nella Commedia assumono una polisemia che fa segno anche di punti dell’esegesi apocalittica. L’egloga che canta l’età dell’oro coincide con la renovatio del sesto stato, il momento del secondo avvento di Cristo, nello Spirito, cioè nei discepoli che saranno inviati a predicare a tutto il mondo come lo fu Giovanni, autore dell’Apocalisse.
Ancora, sul piano dottrinale Gioacchino da Fiore può ben figurare insieme a Tommaso d’Aquino e a Bonaventura fra i sapienti del cielo del Sole. Il sesto e il settimo stato della Chiesa, nella prospettiva di Olivi, corrispondono alla terza età di Gioacchino, quella dello Spirito Santo ma, novità sostanziale rispetto all’abate calabrese, non sono appropriati a una persona della Trinità, bensì allo Spirito di Cristo, centro della storia in progressivo sviluppo. Dunque l’abate è presente nella Commedia in modo diffuso, perché le numerose sue citazioni nella Lectura sono inserite nella generale metamorfosi di questa. Si vedano le citazioni ad Ap 10, 1; 10, 3 e 7, 1-3 (quest’ultime giustapposte, come usa fare l’Olivi, a Riccardo di San Vittore; il Vittorino è largamente presente nell’istruzione data ad Efeso, prima delle sette chiese d’Asia: Ap 2, 2-7).
Si potrebbe pensare che la Commedia instauri con la Lectura quel tipo di corrispondenza emblematica, finalizzata alla costruzione di un sapere universale, che tanta parte avrà poi nella cultura del Rinascimento e del Barocco, da Bruno a Leibniz a Bach. Ciò può essere in parte vero se si considera che dal microcosmo locale si ascende al macrocosmo della Scrittura principio e fine di ogni scienza, di cui l’Apocalisse è sintesi. È inoltre proprio dello spirito profetico nel linguaggio di Isaia, di Ezechiele o di Cristo stesso passare dal particolare storico all’universale per poi di lì ridiscendere al contingente. La mnemotecnica che unisce i due testi non è però una ricerca di un’altra poesia, di qualcosa di occulto come avverrà nel Rinascimento, ma di altri ben precisi significati dottrinali vestiti dalla poesia. In questo l’arte della memoria dantesca è profondamente scolastica, come parte di una virtù cardinale, la prudenza, volta a fini missionari e devozionali. Quando Dante iniziò a scrivere la Commedia, Raimondo Lullo componeva la sua Ars Magna (1305-1308). In Dante non ci sono quegli artifici tipici del lullismo, non lettere alfabetiche significative di concetti, né cerchi concentrici, figure mobili, diagrammi di alberi. Tuttavia lo scopo dell’arte di Lullo e della Commedia è il medesimo: la conversione universale. Inoltre, se si considera la collocazione ai fini mnemonici delle parole nel poema, si può vedere come le rispondenze interne non siano statiche, ma sempre variate in una rosa semantica e poste in luoghi differenti all’interno degli endecasillabi. L’arte della memoria della Commedia è ispirata al medesimo dinamismo propugnato da Lullo.
Il volgare della Commedia, che tanto riceve dall’umile latino dell’esegesi e alla sua dottrina rinvia facendovi concordare ogni conoscenza, è vera “clavis universalis” del sapere. Eliot, scrivendo nel 1929 sulla sua esperienza di lettore di poesia, si dichiarava sorpreso dalla estrema facilità di lettura della poesia dantesca. Prova che un’emozione si possa comunicare anche senza una compiuta conoscenza della lingua in cui si esprime. Ma questa universalità di Dante “non è unicamente un fatto personale. La lingua italiana, e specialmente l’italiano dei tempi di Dante, ci guadagna molto per il fatto di essere il prodotto del latino, lingua universale” [82]. L’incontro con la Lectura dell’Olivi mostrò quanto potesse una lingua fattasi umile, rispetto all’antica gloria, ma che continuava ad essere universale per la visione del mondo e della storia che esprimeva. In fondo, l’esegesi apocalittica dell’Olivi insegnava che era giunto il tempo, per un nuovo Giovanni, di parlare a tutto il mondo, senza distinzione di razza e di terra: “Et dixit michi: Oportet te iterum prophetare in gentibus et populis et linguis et regibus multis” (Ap 10, 11). Questa parola, mossa per dettato interiore che fa dire e fa cambiare i cuori degli uomini che l’ascoltano, è pregna di tutto quanto è avvenuto prima nella storia, che non si perde, ma in essa è ricompreso. L’Altissimo non ha voluto tutto in un solo tempo; il libro che tutto racchiude è stato progressivamente aperto, e in modo sempre più ampio.
L’incontro con l’ultima e più viva testimonianza dell’escatologismo medievale avvenne nel momento della riflessione sul volgare illustre, sul rapporto fra questo e gli altri idiomi volgari, fra la tragedia e gli altri stili. Rapporti che solo la Commedia avrebbe risolto. Con essa il volgare diventa la lingua del nuovo Giovanni, non più solo illustre ma di tutti; gli stili possono essere liberamente variati, come lo sono nell’esegesi i quattro sensi scritturali; l’allegoria non è più finzione ma figura, cioè storia significante della prescienza e provvidenza divina. Il volgare è diventato una nuova “lingua gratiae” come lo fu l’ebraico, l’unico linguaggio dato da Dio ad Adamo prima della confusione babilonica, rimasta agli Ebrei e parlata dal Redentore nel suo primo avvento nella carne (De vulgari eloquentia, I, vi, 5-7). Non a caso Adamo, nel Paradiso, corregge questa posizione: l’ebraico non fu la lingua ispirata da Dio al primo uomo, perché fu, come tutti gli altri idiomi, costruzione umana (Par. XXVI, 124-138). Viene in mente quanto ha detto Oderisi da Gubbio nel primo girone della montagna sul primato nell’arte della miniatura, passato da lui a Franco Bolognese; nell’arte della pittura, traslato da Cimabue a Giotto; nella “gloria de la lingua”, tolta da Cavalcanti a Guinizzelli e a entrambi da Dante (Purg. XI, 79-117). L’uso, come la fama, “è color d’erba, / che viene e va”. Ma come l’ebraico fu la lingua del nostro Redentore nel suo primo avvento, così il volgare del “poema sacro” è ora la gloriosa lingua della renovatio operante nel secondo avvento, quello nello Spirito, interno dettatore dei suoi discepoli.
_________________________________________________________________________________________________________________________
[LSA, cap. I, Ap 1, 14 (radix Ie visionis)] Quarta (perfectio summo pastori condecens) est reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas per senilem et gloriosam canitiem capitis et crinium designata, unde subdit: “caput autem eius et capilli erant candidi tamquam lana alba et tamquam nix” (Ap 1, 14). Per caput vertex mentis et sapientie, per capillos autem multitudo et ornatus subtilissimorum et spiritualissimorum cogitatuum et affectuum seu plenitudo donorum Spiritus Sancti verticem mentis adornantium designatur.
|
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 7] Septimo ascribit ei primatum iudiciarie retributionis omnium bonorum et malorum, et ut hoc sensibilius et magnificentius ac terribilius nobis ingerat, introducit eius de celis maiestativum adventum quasi iam presentem seu in procinctu imminentem, dicens: “Ecce venit cum nubibus” (Ap 1, 7). Non solum autem propter causam predictam dicit “venit” de presenti, sed etiam quia sicut rex venturus Romam ad iudicia danda dicitur venire ex quo inchoat iter suum, et domificator dicitur hedificare domum ex quo incipit iacere fundamenta, sic Deus dicitur venire ad iudicium quia quicquid ab initio ecclesie facit est iter ad illud. Preterea nunc continue dat multa occulte iudicia, et pro tanto semper venit et per effectus iudiciorum. |
[LSA, cap. II, Ap 2, 12 (Ia visio, IIIa ecclesia)] “Si quo minus”, id est si in aliquo minus quam monui penitueris, id est si aliter quam dixi egeris, “veniam tibi”, id est contra te, “cito”. “Cito” dicit, ut ex propinquitate sui adventus magis timeat et citius ac fortius peniteat. “Et pugnabo cum illis in gladio oris mei”, id est per meas scripturas et per meos doctores gladium, id est verbum vivum spiritus mei, habentes illorum errores confundam et convincam cum auctoritatibus suis et tandem per meam iudiciariam sententiam condempnabo. Quasi dicat: per meum adventum te corrigam vel puniam illosque confundam, supple, nisi penitentiam egerint. |
Aen. VI, 298-301Portitor has horrendus aquas et flumina servat
|
Inf. III, 82-87, 97-99, 109-111Ed ecco verso noi venir per nave
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 14 (radix Ie visionis)] Quinta (perfectio summo pastori condecens) est contemplationis speculative et practice zelativus et perspicax fervor et splendor, omnes actus et intentiones et nutus ecclesiarum circumspiciens, unde subdit: “et oculi eius velut flamma ignis”.[LSA, cap. XIX, Ap 19, 12] “Oculi autem eius sicut flamma ignis” (Ap 19, 12), scilicet propter ardorem zeli ad faciendum iudicium et iustitiam de impiis et ad liberandum suos ab eis et ad inflammandum et illuminandum eos igne caritatis et amative sapientie. |
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 11] Deinde de eternitate et de irremissibilitate pene eorum subdit (Ap 14, 11): “Et fumus tormentorum eorum in secula seculorum ascendet”, id est in sua quasi infinita altitudine stabunt semper eis tormenta, ac si semper ascenderet ignis eorum et fumus. Ad litteram etiam innuit quod ignis infernalis, quo torquebuntur, erit fumosus et tenebrosus et semper in vivacissimo motu tamquam semper ardentissimus. Per hunc fumum etiam, secundum Ioachim, designatur dampnatorum murmur et blasphemia contra Deum semper ascendens. |
[LSA, cap. IX, Ap 9, 3.9] “De fumo” autem predicti casus et apertionis “putei exierunt locuste” (Ap 9, 3), id est religiosi illorum sequaces ac leves et volatiles et cupidi et carnales et ypocritales et detractores, qui et contra omnes eis non faventes animosissime concitantur quasi equi currentes in bellum (Ap 9, 7), et etiam contra omnia multum spiritalia contra que zelum acrem assumunt. “Vox” autem “alarum” (Ap 9, 9), id est suarum sententiarum quas altissimas et prevolantes esse presumunt, est sicut vox rotarum et tumultuosi exercitus currentis in bellum contra omnem sententiam contrariam quantumcumque veram. |
|
[Caronte è in parte vestito con la quarta prerogativa di Cristo sommo pastore: la senile bianca lanosa canizie (Ap 1, 14; ne sono partecipi anche Catone e Beatrice: cfr. Il sesto sigillo, 2c, tab. XIII). In Cristo i capelli sono gelidi come neve e caldi come lana: indicano le due vie, la rigida giustizia e la temperata pietà. In Caronte le due vie si unificano per la punizione dei dannati, portati “in caldo e ’n gelo”. Viene come Cristo al giudizio (Ap 1, 7; 2, 12). Gli occhi fiammeggianti e, a differenza dell’immagine virgiliana, rotanti, appartengono alla quinta prerogativa di Cristo sommo pastore, che con fervido zelo guarda attorno ogni atto delle chiese (Ap 1, 15; 19, 12; cfr. la “vox rotarum” ad Ap 9, 9). “Caron dimonio”, che l’anime “tutte … raccoglie”, reca ancora la memoria di “Karolus imperator”, che difese la Chiesa contro la nequizia del maggior pericolo cristiano. Se questi ‘raccolse’ la santa Chiesa a Roma cinquecento anni prima, c’è ancora, nel 1300, una Roma dei malvagi carnali che peregrina in terra con la Chiesa spirituale dei buoni, con essa commista e confliggente, che viene ‘raccolta’ sulle rive d’Acheronte da un demone vestito dell’antico pelo virgiliano di Caronte e con la moderna funzione storica di Carlo Magno (cfr. Il sesto sigillo, 7a, tab. XLV bis).] |
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 3 (Ia visio, Va ecclesia)] Deinde comminatur eidem iudicium sibi occulte et inopinate superventurum si non se correxerit, unde subdit: “Si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur”, qui scilicet venit latenter et ex improviso ut bona auferat et possessorem occidat. Unde subdit: “et horam nescies qua veniam ad te”. Iustum enim est ut qui se ipsum per negligentiam et torporem nescit, nesciat horam iudicii sui et exterminii. Talis etiam propter suas tenebras non videt lucem, ac erronee credit et optat se diu in prosperitate victurum et Dei iudicium diu esse tardandum, et etiam spe presumptuosa sperat se esse finaliter salvandum, propter quod Ia ad Thessalonicenses V° dicit Apostolus quod “dies Domini veniet in nocte sicut fur. Cum enim dixerint: pax et securitas, tunc superveniet eis repentinus interitus” (1 Th 5, 2-3). Quibus autem, scilicet sanctis, et quare non veniet sicut fur ostendit subdens: “Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos dies illa tamquam fur comprehendat; omnes enim vos estis filii lucis et diei. Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed vigilemus et sobrii simus. Qui enim dormiunt nocte dormiunt” et cetera (ibid., 5, 4-7). Nota quod correspondenter prefigurat hic occultum Christi adventum et iudicium in fine quinti status et in initio sexti fiendum, prout infra in apertione sexti signaculi explicatur.[LSA, cap. XVI, Ap 16, 15 (Va visio VIa phiala)] Quia vero Deus tunc ex improviso et subito faciet hec iudicia, ideo subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 15). Fur enim venit latenter ad furandum, ne advertat hoc dominus cuius sunt res quas furatur. Non autem dicit ‘veniam’ sed “venio”, et hoc cum adverbio demonstrandi, ut per hoc estimationem de sua mora nobis tollat et ad adventum suum nos attentiores et vigilantiores et timoratiores reddat. Ad quod etiam ultra hoc inducit per promissionem premii et comminationem sui oppositi, unde subdit: “Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus; “et videant ”, scilicet omnes tam boni quam mali, “turpitudinem eius”, id est sua turpissima peccata et suam confusibilem penam in die iudicii sibi infligendam. |
|
Aen VI, 309-310quam multa in silvis autumni frigore primo
|
Georg. II, 80-82plantae immittuntur; nec longum tempus, et ingens
|
Inf. III, 112-114Come d’autunno si levan le foglie
|
Par. XXVIII, 115-117L’altro ternaro, che così germoglia
|
Inf. XXVII, 121-123, 127-129Oh me dolente! come mi riscossi
|
Par. XII, 46-48In quella parte ove surge ad aprire
|
[Ap 3, 3 (prima visione, quinta chiesa) e 16, 15 (quinta visione, sesta coppa) sono passi simmetrici che sviluppano il tema del ladro (cfr. Il sesto sigillo, 1d). La terzina di Par. XXVIII, 115-117 è riferita al “secondo ternaro” delle gerarchie angeliche (Dominazioni-Virtù-Potestà), il quale germoglia “in questa primavera sempiterna / che notturno Arïete non dispoglia”, verso, quest’ultimo, che congiunge il tema della notte della citazione paolina in Ap 3, 3 (“dies Domini veniet in nocte sicut fur”) con quello dell’essere spogliato delle virtù in Ap 16, 15 («“ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus»). Poiché da un punto di vista astronomico l’Ariete è visibile di notte in autunno, la terzina rinvia ad altra assai più antica, quella che in Inf. III, 112-114 descrive il volontario gettarsi nella barca di Caronte del “mal seme d’Adamo”: “Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie”. È da notare l’accostamento del vedere («“et videant ” , scilicet omnes tam boni quam mali, “turpitudinem eius”»), appropriato al ramo, con lo spogliarsi, motivi non presenti nella reminiscenza virgiliana – “Quam multa in silvis autumni frigore primo / Lapsa cadunt folia …” (Aen. VI, 309-310) -, e che sono invece nell’esegesi di Ap 16, 15. All’opposto, nelle parole con cui Bonaventura tesse l’elogio di Domenico, sono “le novelle fronde / di che si vede Europa rivestire”, aperte da Zefiro, dove i temi dell’aprire e dell’essere nuovo sono tipici del sesto stato (Par. XII, 46-48). A Inf. XXVII, 127-129, il tema del “fur” è nel “foco furo” che fascia Guido da Montefeltro, il quale va “sì vestito” (“Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”) perché altri lo vedano («“et videant” , scilicet omnes tam boni quam mali, “turpitudinem eius” – là dove vedi»): sono tutti motivi da Ap 16, 15. Due terzine prima (ibid., 121-123), l’espressione “mi prese”, riferita al diavolo “löico” che argomenta contro Francesco, può essere ricondotta al “comprehendat ” della citazione paolina di Ap 3, 3.] |
|
[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 4 (VIa visio)] “Et audivi aliam vocem de celo dicentem” (Ap 18, 4). Recte dicitur alia, quia prior fuit de dampnatione reproborum, hec vero est de admonitione electorum, ne communicent cum reprobis in culpa et tandem in pena. Ait enim: “Exite de illa, popule meus, et ne participes sitis delictorum eius et de plagis eius ne accipiatis”. Idem dicitur Ieremie, L°, ubi dicitur Dei populo: “Recedite de medio Babilonis et de terra Caldeorum egredimini, et estote quasi edi ante gregem”, et subdit causam quia cito est capienda et destruenda (Jr 50, 8-9).
|
|
Inf. XXX, 37-39Ed elli a me: “Quell’ è l’anima antica
|
Met. X, 314-315e tribus una soror. Scelus est odisse parentem;
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 3 (Ia visio, Va ecclesia)] Deinde comminatur eidem iudicium sibi occulte et inopinate superventurum si non se correxerit, unde subdit: “Si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur”, qui scilicet venit latenter et ex improviso ut bona auferat et possessorem occidat. Unde subdit: “et horam nescies qua veniam ad te”. Iustum enim est ut qui se ipsum per negligentiam et torporem nescit, nesciat horam iudicii sui et exterminii. Talis etiam propter suas tenebras non videt lucem, ac erronee credit et optat se diu in prosperitate victurum et Dei iudicium diu esse tardandum, et etiam spe presumptuosa sperat se esse finaliter salvandum, propter quod Ia ad Thessalonicenses V° dicit Apostolus quod “dies Domini veniet in nocte sicut fur. Cum enim dixerint: pax et securitas, tunc superveniet eis repentinus interitus” (1 Th 5, 2-3). Quibus autem, scilicet sanctis, et quare non veniet sicut fur ostendit subdens: “Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos dies illa tamquam fur comprehendat; omnes enim vos estis filii lucis et diei. Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed vigilemus et sobrii simus. Qui enim dormiunt nocte dormiunt” et cetera (ibid., 5, 4-7). Nota quod correspondenter prefigurat hic occultum Christi adventum et iudicium in fine quinti status et in initio sexti fiendum, prout infra in apertione sexti signaculi explicatur. Deinde a predicto defectu excipit quosdam illius ecclesie, subdens: “Sed habes pauca nomina in Sardis” (Ap 3, 4). Nomina sumit pro personis quarum nomina sunt. Per nomina etiam intelligit personas merito sue sanctitatis notas Christo. Item proprium donum gratie, quod unusquisque accepit, dat cuique viro quasi proprium nomen ut cognoscatur ex nomine. Caritas autem Dei, in quantum communis omnibus bonis, dat commune nomen sanctis ut vocentur cives Iherusalem. “Qui non coinquinaverunt”, scilicet sordibus vitiorum et precipue carnalium, “vestimenta sua”, id est virtutes suas quibus quasi vestibus ornantur et vestiuntur, vel corpora sua que sunt quasi vestes anime, vel opera sua que sunt quasi vestes extrinsece ipsarum virtutum. “Ambulabunt mecum in albis”, scilicet vestibus, “quia digni sunt”. Per vestes albas intelligitur hic singularis candor et decor glorie correspondens merito predicte munditie.[LSA, cap. XVI, Ap 16, 15 (Va visio VIa phiala)] Quia vero Deus tunc ex improviso et subito faciet hec iudicia, ideo subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 15). Fur enim venit latenter ad furandum, ne advertat hoc dominus cuius sunt res quas furatur. Non autem dicit ‘veniam’ sed “venio”, et hoc cum adverbio demonstrandi, ut per hoc estimationem de sua mora nobis tollat et ad adventum suum nos attentiores et vigilantiores et timoratiores reddat. Ad quod etiam ultra hoc inducit per promissionem premii et comminationem sui oppositi, unde subdit: “Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus; “et videant ”, scilicet omnes tam boni quam mali, “turpitudinem eius”, id est sua turpissima peccata et suam confusibilem penam in die iudicii sibi infligendam.[LSA, cap. VI, Ap 6, 14-15 (IIa visio, apertio VIi sigilli; IVum initium)] Tunc etiam montes, id est regna ecclesie, et “insule”, id est monasteria et magne ecclesie in hoc mundo quasi in solo seu mari site, movebuntur “de locis suis” (Ap 6, 14), id est subvertentur et eorum populi in mortem vel in captivitatem ducentur. Tunc etiam, tam propter illud temporale exterminium quod sibi a Dei iudicio velint nolint sentient supervenisse, quam propter desperatum timorem iudicii eterni eis post mortem superventuri, sic erunt omnes, tam maiores quam medii et minores, horribiliter atoniti et perterriti quod preeligerent montes et saxa repente cadere super eos. Ex ipso etiam timore fugient et abscondent se “in speluncis” et inter saxa montium (cfr. Ap 6, 15). |
|
Stazio, Achill. I, 247-250cum pueri tremefacta quies oculique patentes
|
Purg. IX, 34-42, 52-63Non altrimenti Achille si riscosse,
|
Purg. XXX, 103-105Voi vigilate ne l’etterno die,
|
Par. XXVI, 70-75E come a lume acuto si disonna
|
[Ap 10, 1; IIIa visio, VIa tuba] Et (Ioachim) subdit: «Ego autem angelum istum secundum litteram aut Enoch fore puto aut Heliam. Verum, prout hoc Deus melius novit, unum dico pro certo, quod hic angelus significat personaliter magnum aliquem predicatorem, quamvis spiritaliter ad multos viros spiritales tunc temporis futuros competenter valeat intorqueri. Sane facies angeli similis est soli, quia in hoc sexto tempore oportet Dei contemplationem in modum solis splendescere et perduci ad notitiam eorum qui designantur in Petro et Iacobo et Iohanne, id est Latinorum et Grecorum et Hebreorum, primo quidem Latinorum, deinde Grecorum, tertio Hebreorum, ut fiant novissimi qui erant primi et e contrario». Hec Ioachim. |
Purg. XXXII, 37-39, 64-82Io senti’ mormorare a tutti “Adamo”;
|
[Altro luogo fasciato dall’esegesi teologica di Ap 3, 3 e 16, 15 è il risvegliarsi di Dante dal sonno della prima notte passata nel purgatorio (Purg. IX, 34ss.). Se i motivi dello svegliarsi o del dormire non possono certo, presi da soli, essere connessi al testo della Lectura, tuttavia l’introduzione del tema del fuggire, appropriato al sonno (prefigurato dal trafugamento di Achille sottratto a Chirone dalla madre Teti, che recita la parte del “fur”, e portato a Sciro per impedirgli di prendere parte alla guerra di Troia), e dello scuotersi per lo spavento conducono all’apertura del sesto sigillo ad Ap 6, 12 (lo scuotersi corrisponde alla “fortis concussio” causata dal terremoto che allora si verifica, che non è solo scuotimento fisico, ma anche interiore). Come pure lo svegliarsi volgendo gli occhi attorno senza sapere il luogo in cui ci si trova è un filo tratto dal torpore che rende inconsapevoli dell’ora del giudizio di cui si parla ad Ap 3, 3. È da notare che i versi sono segnati dalla reminiscenza dell’Achilleide (I, 247-250), ma mentre Stazio sottolinea la meraviglia dell’eroe nel vedere, svegliandosi, cose sconosciute, Dante insiste sul terrore provocato dal risveglio, che è proprio quanto suggerito dall’esegesi del “fur”. In questo spavento viene confortato da Virgilio, il quale gli dice che all’alba è venuta Lucia, ha preso il suo fedele che dormiva e, come il giorno è stato chiaro, lo ha portato presso la porta del purgatorio. Il passo paolino dalla prima lettera ai Tessalonicesi, incastonato nell’esegesi di Ap 3, 3, distingue tra coloro che dormono e che vengono sopraffatti dal ladro, e quelli che vigilano e che sono “filii lucis et diei”. La similitudine con Achille trafugato nel sonno dalla madre consente di dare il valore di madre anche a Lucia che prende Dante, il quale è veramente il “figlio della luce e del giorno” di cui dice san Paolo. L’ “intrata aperta” (la fenditura nel balzo al là della quale è la porta del purgatorio) corrisponde alla “porta aperta” data alla sesta chiesa, Filadelfia (Ap 3, 8) e alla sesta vittoria, che è ingresso in Cristo (Ap 3, 12). Per altri rinvii dai versi alla medesima esegesi, mostrati nella tabella, cfr. Il sesto sigillo, 1d, tab. VIII, 1-6. Da notare in particolare il risveglio di Dante nell’Eden, quasi ritorno dall’aver assistito a una nuova Trasfigurazione, descritto con parole-chiave che fanno segno, oltre di Ap 3, 3, anche della citazione di Gioacchino da Fiore ad Ap 10, 1 (nel sesto stato è necessario che la contemplazione di Dio splenda come il sole per condurre alla verità coloro che sono designati in Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè i Latini, i Greci e gli Ebrei, prima i Latini, poi i Greci e infine gli Ebrei, perché siano ultimi coloro che furono primi).] |
|
GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527 (rist. an. Minerva, Frankfurt a. M. 1964).RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888 (= In Ap). |
|
[Ap 7, 1-3; IIa visio, apertio VIi sigilli] “Post hec vidi” et cetera (Ap 7, 1). Hic ostenditur quomodo, post prefatum iudicium et exterminium carnalis ecclesie, nitentur demones et homines impii impedire predicationem fidei et conversionem gentium ad fidem et etiam conservationem fidelium in fide iam suscepta. Unde ait: “Post hec”, id est post predictum iudicium, “vidi quattuor angelos stantes super quattuor angulos terre”.
|
|
Inf. I, 34-36, 94-96; II, 61-63, 94-96; III, 94-98e non mi si partia dinanzi al volto,
|
Inf. V, 4, 21-24; VI, 28-33; VII, 3-6Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia … … Minosse
|
1 In Ap II, ix (PL 196, col. 770 C).2 Expositio, pars II, f. 120va. |
3 Expositio, pars II, ff. 120vb-121ra.4 In Ap II, ix (PL 196, col. 771 B). |
L’esegesi dell’angelo del sesto sigillo, che rimuove l’impedimento frapposto dai quattro angeli malvagi quietandoli, viene appropriata a Virgilio che rimuove gli impedimenti posti dalla lupa e da quattro antichi demoni (Caronte, Minosse, Cerbero, Pluto). Cfr. Il sesto sigillo, 2a, tab. X. |
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (IIa visio, Ium sigillum)] Tertia ratio septem sigillorum quoad librum veteris testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. Primum est falsitas promissionum, quia iuxta quod superficialiter sonant non sunt implete nec etiam possibiles impleri, quia impossibile est per eas hominem beatificari et satiari, quod tamen ipse promittunt. Hanc autem evacuat veritatis Christi splendor in prima apertione notatus. |
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 2 (Va visio, Ia phiala)] Unde subditur: “et factum est vulnus sevum ac pessimum”, id est turbatio ire crudelis et pessime, “in homines qui habebant caracterem bestie”, id est formam bestialis vite et intelligentie sibi impressam, “et in eos qui adoraverunt imaginem eius”. Omnes reprobi habent aliquam falsam estimationem eius [quod] prave sequuntur et amant et in quo, tamquam in Deo, suam beatitudinem estimant et querunt, et ideo id quod adorant est potius falsa imago quam realis veritas Dei et vere glorie. Est tamen realiter et veraciter bestiale; et ideo illud prout est in estimatione eorum est imago bestie, prout vero est in re est bestia seu bestiale tamquam carens intellectu et ratione. |
Purg. XXX, 130-132e volse i passi suoi per via non vera,
|
Boezio, Cons., III, pr. 9: Haec igitur vel imagines veri boni, vel imperfecta quaedam bona dare mortalibus videntur; verum autem atque perfectum bonum conferre non possunt. |
Inf. XII, 11-19e ’n su la punta de la rotta lacca
|
Inf. XXIV, 124-126Vita bestial mi piacque e non umana,
|
[LSA, prologus, Notabile VI] Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix visionum proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. Nunc tamen in generali breviter demonstretur. Constat enim quod totum imperium potestatis ecclesiastice (I), ac sacerdotale sacrificium martirizationis sue (II), et sapientiale magisterium sue doctrine (III), ac altivolum supercilium vite anachoritice (IV), et condescensivum contubernium vite domestice seu cenobitice (V), et nuptiale connubium seu familiare vinculum singularis amicitie (VI), ac beatificum convivium divine glorie (VII), sunt in Christo exemplariter et etiam contentive et effective. Contentive quidem, tum quia ab eterno est presens omnibus futuris, tum quia virtus, per quam unumquodque in suo tempore efficit et conservat et continet, est sibi essentialis et eternaliter presens.[LSA, cap. XIV, Ap 14, 2 (IVa visio)] Quarto erat suavissima et iocundissima et artificiose et proportionaliter modulata, unde subdit: “et vocem, quam audivi, sicut citharedorum citharizantium cum citharis suis”. Secundum Ioachim, vacuitas cithare significat voluntariam paupertatem. Sicut enim vas musicum non bene resonat nisi sit concavum, sic nec laus bene coram Deo resonat nisi a mente humili et a terrenis evacuata procedat. Corde vero cithare sunt diverse virtutes, que non sonant nisi sint extense, nec concorditer nisi sint ad invicem proportionate et nisi sub consimili proportione pulsentur. Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi et sub debitis circumstantiis unam virtutem et eius actus aliis virtutibus et earum actibus proportionaliter concordare et concorditer coherere, ita quod rigor iustitie non excludat nec perturbet dulcorem misericordie nec e contrario, nec mititatis lenitas impediat debitum zelum sancte correctionis et ire nec e contrario, et sic de aliis.
|
|
Par. II, 70-72, 112-120, 127-148Virtù diverse esser convegnon frutti
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (Va ecclesia)] Vocatur autem congrue hec ecclesia Sardis, id est principium pulchritudinis, tum quia in suis paucis incoinquinatis habet singularem gloriam pulchritudinis, quia difficillimum et arduissimum est inter tot suorum luxuriantes se omnino servare mundum; tum quia primi institutores quinti status fuerunt in se et in suis omnis munditie singulares zelatores, suorumque collegiorum regularis institutio, diversa membra et officia conectens et secundum suas proportiones ordinans sub regula unitatis condescendente proportioni membrorum, habet mire pulchritudinis formam toti generali ecclesie competentem, que est sicut regina aurea veste unitive caritatis ornata et in variis donis et gratiis diversorum membrorum circumdata varietate.Lo moto e la virtù d’i santi giri,
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 11 (VIIa visio)] Formam (civitatis) autem tangit tam quoad eius splendorem quam quoad partium eius dispositionem et dimensionem, unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et sub igne et ab igne caloratur et ignis speciem sumit, non autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar speculi polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide incorporata et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter representans et omnium virtutum temperie virens. Est etiam perspicua et transparens non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim lune humilitatem celestium mentium designat.[LSA, cap. XXII, Ap 22, 1-2 (VIIa visio)] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum. |
|
Per la descrizione dettagliata della tabella cfr. Il Cristo di Dante, 6.2. |
|