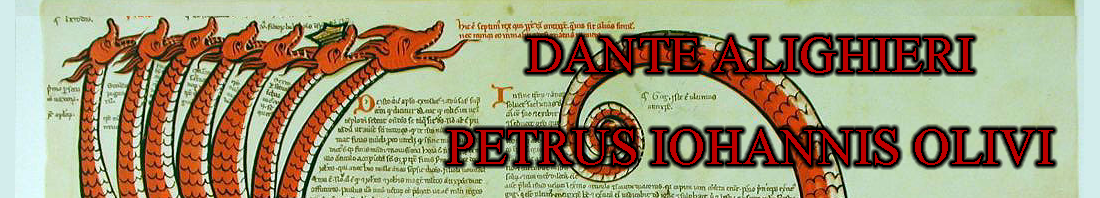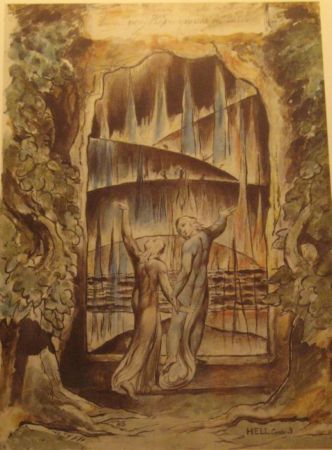Relazione al Convegno Dante Alighieri nel 700° anniversario della morte.
Roma 13-15 aprile 2021.
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Cattedra Marco Arosio di Alti Studi Medievali.
Università Europea di Roma.
Sinossi: Ap 7, 3-4; 1, 16-17; 8, 8-9; prologus, notabile X; Vita Nova
3, 12; Par. V; 13, 18; Romeo; 2, 5-3, 11; 3, 3; 19, 17-18; 22, 1-2; mappe; 6, 8; vox; 6, 12-17
4, 3-4; sede divina; 5, 8; 7, 2-10, 1; 1, 10-19, 6; 16, 12-14; in medio
1. Firenze, 1287. Nella “città partita”, la quale, da “tanta discordia assalita”, muta di continuo la propria costituzione voltandosi nel letto di dolore come un’inferma [1], la tensione fra Magnati e Popolani porta a un allargamento democratico nei consigli comunali, aperti anche ai rappresentanti delle arti medie [2]. Si lavora da tre anni alla nuova cerchia delle mura. Fervono i preparativi della guerra contro Arezzo, che si concluderà due anni dopo con la vittoria di Campaldino. È vescovo Andrea de’ Mozzi, la “tigna” sodomita ricordata nell’Inferno da Brunetto Latini [3]. Il più autorevole filosofo della città, Remigio de’ Girolami, discepolo a Parigi di Tommaso d’Aquino, insegna nello studio domenicano di Santa Maria Novella da più di dieci anni [4]. A Santa Croce, edificio ancora modesto prima della rifondazione nel 1294 per opera di Arnolfo di Cambio, arriva, come lettore di teologia dello Studium francescano, il frate provenzale Pietro di Giovanni Olivi, punto di riferimento degli Spirituali. Vi rimane fino al 1289, quando viene inviato allo Studium di Montpellier [5].
Nato nel 1248 a Sérignan, novizio a dodici anni nel convento di Béziers, nella città che nel 1209 aveva visto i massacri di Simone di Montfort nella crociata contro gli Albigesi; discepolo a Parigi di Bonaventura nel 1266; presente a Roma e ad Assisi nel 1279, per collaborare alla redazione della Exiit qui seminat, la costituzione con la quale Nicolò III aveva cercato di risolvere i dissidi all’interno dell’Ordine francescano, Olivi al suo arrivo a Firenze aveva già composto numerose opere filosofiche e commentato quasi tutta la Scrittura. Alcune sue quaestiones avevano suscitato accuse da parte di alcuni membri dell’Ordine, dove era stato definito “caput superstitiosae sectae et divisionis et plurium errorum”. Ma non erano di questo parere il nuovo Ministro generale Matteo d’Acquasparta, eletto nel capitolo di Montpellier il 25 maggio 1287, e perfino il papa Nicolò IV, che lo destinarono a Firenze [6].
L’insegnamento di Olivi a Santa Croce fu la premessa di un più stretto rapporto fra i gruppi provenzali e italiani dello spiritualismo francescano, originariamente segnati da considerevoli differenze [7]. Come scrisse Raoul Manselli, gli Spirituali non erano “un partito o una fazione ma un fermento di vita fra i Minori, una presa di coscienza, la ferma rivendicazione della peculiarità dell’Ordine, una ‘attitude critique’, un ‘mouvement d’espérance’; e di tutto questo Olivi è colui che sa meglio cogliere il valore e il senso religioso, storico e umano” [8]. Volevano il ritorno alla Regola di san Francesco, mantenendo uno stato di povertà assoluta all’interno dell’Ordine.
Il francescano Ubertino da Casale ascoltò le lezioni di Olivi, l’effetto fu dirompente: “qui me modico tempore … sic introduxit ad altas perfectiones anime dilecti Iesu … et ad profunda scripture et ad intima tertii status mundi et renovationis vite Christi, ut iam ex tunc in novum hominem mente transiverim” [9]. Lo spirito di Cristo fermentava anche in altri, come nel terziario senese Pier Pettinaio, ricordato da Sapìa nel secondo girone del Purgatorio di Dante come colui che le aveva, con le sue preghiere, abbreviato la penitenza (Purg. XIII, 127-129).
Quale il contenuto di un insegnamento tanto sconvolgente? Fortemente antiaristotelica e antitomista, la visione di Olivi è cristocentrica come quella di Bonaventura. L’esemplare vita di Cristo – o la sua legge (la Regola è per il francescano sinonimo di “vita”) [10] -, imposta agli Apostoli e scritta nei Vangeli, deve essere dalla nostra vita perfettamente imitata e partecipata e porsi come fine di ogni nostra azione [11]. “Caput universale omnis temporis”, Cristo è centro del tempo [12]. Persona mediana della Trinità, mediatore tra l’uomo e Dio, è il punto sul quale convergono i raggi della sfera-Chiesa nella sua storia passata, presente e futura [13]. Per quanto concerne la persona umana, Olivi è strenuo fautore del libero arbitrio, comprovato dall’intimo sentire con il quale la volontà, riflessa su di sé, sperimenta l’esistere [14].
Sul piano storico, Olivi ritiene di vivere un periodo – il sesto dei sette stati della storia della Chiesa – nel quale sta fermentando un novum saeculum, una palingenesi universale che infine porterà alla conversione a Cristo degli infedeli e degli Ebrei (non diversamente la pensava il suo confratello e contemporaneo Raimondo Lullo) [15]. Su questo sesto stato, che per Olivi corrisponde ai tempi moderni e, unitamente al settimo e ultimo periodo, coincide con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore, ricadono tutte le illuminazioni e il male delle epoche passate. Nel sesto stato, il secondo avvento di Cristo nello Spirito (dopo il primo, nella carne, e molto prima del terzo, nella parusia) reca nei suoi discepoli, siano essi membri di un ordine religioso o singole persone [16], una vita nova. L’homo novus sente gli insegnamenti che vengono da Cristo interno dettatore, è testimone di miracoli non corporali, come nei primi tempi della Chiesa, ma intellettuali; gli è serbata l’esperienza di gustare in questa vita il divino [17]. In siffatta età rinnovata per lo Spirito di Cristo, tanto attesa come quella augustea preconizzata nella quarta egloga di Virgilio, una rivoluzione interiore viene compiuta con la parola che converte e rompe la durezza dei cuori, che l’interno dettatore spira nei predicatori aprendo la loro volontà al dire [18]. Se finora Cristo, in quanto uomo, ha insegnato con la dottrina esteriore, e in quanto Verbo con la luce intellettuale, d’ora in poi insegnerà anche tramite il gusto d’amore proprio del suo Spirito [19].
Prima che la pace e la giustizia trionfino, l’uomo del sesto stato dovrà però affrontare terribili prove e sofferenze, indotte dall’Anticristo e dai suoi seguaci. I nuovi martiri non provano soltanto il tormento del corpo, sono soprattutto tormentati dal dubbio sulla vera fede, suggestionati dalla sottigliezza degli argomenti filosofici, da ingannevoli Scritture, dall’ipocrita simulazione di santità, dalla falsa immagine dell’autorità papale, in quanto falsi pontefici insorgono, come Anna e Caifa insorsero contro Cristo. Per rendere più intenso questo martirio psicologico, i carnefici stessi operano miracoli. La tentazione così induce in errore persino gli eletti, come testimoniato da Cristo nella grande pagina escatologica di Matteo XXIV [20].
Dov’è Dante negli anni dell’insegnamento santacrociano di Olivi? Entro il 1287 è probabilmente a Bologna: a tale anno risale infatti la più antica trascrizione di un testo del poeta, il sonetto della Garisenda registrato in un Memoriale notarile. L’11 giugno 1289 Dante combatte come feditore a Campaldino, nello scontro che vede i fiorentini vittoriosi su Arezzo; il mese dopo assiste alla capitolazione del castello di Caprona. Quegli anni vedono l’uscita delle “nove rime”, alcune inserite nella Vita Nova dopo la morte di Beatrice, avvenuta l’8 giugno 1290. Non sappiamo se Dante abbia frequentato le lezioni di Olivi a Santa Croce. Non si può tuttavia non rilevare che la teologia oliviana dei tempi moderni, coincidenti con il sesto stato della storia della Chiesa, caratterizzato dal libero parlare per dettato interiore che apre i cuori, è singolarmente consonante con la poetica del contemporaneo Dante. Tale viene definita nel sesto girone del purgatorio nell’incontro con Bonagiunta da Lucca: una poetica fondata sullo spirare di Amore, interno “dittator”, e sul notare significando in modo stretto i suoi dettati, quasi fossero quelli di una regola evangelica imposta e accettata (Purg. XXIV, 49-63). L’inizio delle “nove rime” dantesche avvenne per virtù di un interno dettatore: “Allora dico che la mia lingua parlò quasi come per sé stessa mossa e disse: ‘Donne ch’avete intellecto d’amore’” (Vita Nova, 10. 13 [XIX 2]). La Vita Nova è la storia di un nuovo avvento di Cristo, del “miracolo” Beatrice, venuta in tanta grazia delle genti da operare mirabilmente in esse.
2. Trasferitosi a Montpellier nel 1289, Olivi si dedicò principalmente alla Lectura super Apocalipsim, completata poco prima di morire a Narbonne nel 1298. La Lectura portava al sommo l’escatologismo che, per citare Arsenio Frugoni, “oltre che ideologia di lotta e di riforma del gruppo spirituale, era anche un vero e proprio sentimento storico […] una tensione di rinnovamento, una ansia di salvezza, che nel 1300, l’anno centenario della Natività, aveva trovato come una attivazione, in un senso di pienezza dei tempi, cui doveva corrispondere un fatto, un accadere meraviglioso e nuovo” [21]. Un escatologismo che Bonifacio VIII stava per cristallizzare in norma con l’indizione del primo giubileo.
Summa di vita, di ideali, di pensiero del suo autore, la Lectura fu anche il vessillo degli Spirituali e, per più di un quarto di secolo, oggetto di persecuzione senza pari “anche oltre la morte, quando le sue ossa saranno impietosamente disseppellite e oltraggiate, i suoi scritti confiscati e distrutti, il suo nome aborrito e taciuto” [22]. Nel 1326 la Lectura sarebbe stata condannata da papa Giovanni XXII in quanto “pestiferum et hereticum dogma contra unitatem ecclesie catholice et potestatem summi pontificis romani et apostolice sedis”.
Mentre Olivi scriveva, fra Montpellier e Narbonne, il commento all’Apocalisse, Dante, consolatosi per la morte di Beatrice con Boezio e Cicerone, nel sentire la dolcezza della Filosofia era andato, dopo la metà del 1293, “là dov’ella si dimostrava veracemente, cioè nelle scuole delli religiosi e alle disputazioni delli filosofanti” (Convivio, II, xii, 7). Le “scuole” erano la domenicana a Santa Maria Novella, la francescana a Santa Croce, dove insegnava un discepolo di Olivi, Pietro delle Travi, e l’agostiniana a Santo Spirito [23]. Sono gli anni di redazione della Vita Nova, il prosimetro che comprende rime scritte prima e dopo la morte di Beatrice. Se nel libello giovanile si registrano tracce di studi filosofici, ancor maggiori sono le vestigia teologiche. Ma Dante parla solo della sua formazione filosofica, tace su quella teologica, che pure lo renderà presso i contemporanei il poeta theologus per eccellenza [24].
Il 1294 è l’anno dell’elezione e della rinuncia al papato di Celestino V. La posizione di Dante, che porrà fra gli ignavi Celestino, è simile a quella di Ubertino da Casale e degli Spirituali italiani che consideravano la rinuncia come qualcosa di ianudito, un’“horrenda novitas”. Opposta la posizione di Olivi, che in una quaestio e in una lettera al confratello Corrado da Offida ne sostenne invece la legittimità.
Sempre nel 1294 Dante incontrò a Firenze Carlo Martello, primogenito di Carlo II d’Angiò e re d’Ungheria, gioiosamente ricordato in Paradiso VIII per l’intenso “amor amicitiae”, interrotto dalla morte del re l’anno dopo. I fratelli di Carlo Martello – Ludovico, Roberto e Raimondo Berengario – educati in Provenza, fatti prigionieri dagli Aragonesi, ricevettero una lettera di Olivi, pregna di escatologismo, il 18 maggio 1295 [25]. Nello stesso anno venne scacciato da Firenze Giano della Bella, promotore due anni prima degli Ordinamenti di giustizia contro i Magnati, e iniziò l’attività politica di Dante, iscrittosi all’Arte dei Medici, degli Speziali e dei Merciai.
3. La Lectura super Apocalipsim si diffuse subito in Italia. Bonifacio VIII (morto l’11 ottobre 1303) ne affidò all’agostiniano Egidio Romano una confutazione non pervenutaci; Ubertino da Casale, nel 1305, l’aveva accanto a sé mentre scriveva a La Verna l’Arbor vitae crucifixae Jesu riportandone nel quinto libro interi ed estesi brani. L’anno dopo Ubertino divenne cappellano del cardinale Napoleone Orsini, il quale, fra le varie legazioni affidategli da Clemente V, nel 1307 si adoperò per il ritorno a Firenze degli esiliati, azione che fallì dopo il mancato scontro a Gargonza tra i Neri e le truppe del Cardinale, ospite dei conti Guidi [26]. Nell’ottobre 1306 Dante era in Lunigiana come procuratore di pace con il vescovo di Luni per conto dei Malaspina; nel 1307 si trovava forse in Casentino, da dove inviò a Moroello la canzone Montanina. Dopo la delusione seguita alla sconfitta dei Bianchi a La Lastra nel 1304, il poeta era aperto ai tentativi di riconciliazione. Negli stessi mesi, e in luoghi contigui se non coincidenti, Dante e Ubertino lavoravano per la pace, e si può ben immaginare quanto l’attività del frate e del cardinale stesse a cuore al poeta. Fu quella l’ultima possibilità che Dante ebbe di rientrare a Firenze prima dell’inizio della stesura della Commedia.
Dante lasciò incompiuti il Convivio e il De vulgari eloquentia per dedicarsi al “poema sacro”, un’opera radicalmente diversa, come scrisse Giorgio Petrocchi: “un totale commovimento etico-religioso, […] ben oltre la visione allegorica della Vita Nuova, irrompe nelle prime terzine dell’Inferno” [27]. Cosa gli fece cambiare idea tra il 1307 e il 1309? Fu la scoperta della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi, datagli probabilmente da Ubertino da Casale.
4. L’accostamento dei due testi non è nuovo, da Ernesto Buonaiuti a Raoul Manselli a Ovidio Capitani, ma si trattava di vicinanza di idee e toccava solo alcuni punti della Commedia. La nuova scoperta, avvenuta nel corso di una ricerca durata un quarto di secolo, sta nel fatto che si tratta di un rapporto tecnico; esso riguarda tutto il poema per ognuno dei 14233 endecasillabi, nei quali i concetti teologici vengono incardinati e trasformati. Questa straordinaria metamorfosi testuale si fonda su precise e verificabili norme.
a) Gruppi di parole ravvicinate presenti nella Lectura super Apocalipsim si ritrovano, con parole altrettanto ravvicinate, ma liberamente collocate nelle forme più varie, nella Commedia, quasi fili tratti da altro ordito e, intrecciati con altri, tessuti in uno nuovo. Il fenomeno risulta troppo diffuso perché sia casuale. Non si tratta di parole isolate, ma collocate in una rosa entro spazi testuali ristretti; gli accostamenti non sono banali o scontati. Non c’è calco o riscrittura; il travaso non è di frasi – e non potrebbe esserlo dalla prosa in poesia – ma di elementi semantici che sono segnali, in un’alta retorica del significante. La compresenza risulta evidente per quanto, nel lessico della Commedia, proviene dal latino, si tratti di latinismi o di termini già entrati nell’uso fiorentino. Ma anche le voci fiorentine di ogni strato sociale, o quelle tratte da altri dialetti della penisola, i gallicismi, gli arabismi, i neologismi concordano con l’esegesi apocalittica, talora anche per somiglianza fonica, circondati da segnali che sollecitano il lettore verso l’altro testo.
b) Un medesimo luogo della Lectura conduce, tramite la compresenza delle parole, a più luoghi della Commedia. Ciò significa che la medesima esegesi di un passo dell’Apocalisse è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del poema.
c) Più luoghi della Lectura possono essere collazionati tra loro, secondo un procedimento analogico tipico delle distinctiones ad uso dei predicatori. La scelta non è arbitraria. Vi predispone lo stesso testo scritturale, poiché l’Apocalisse contiene espressioni, come Leitmotive, che ritornano più volte. È determinata da parole-chiave che collegano i passi da collazionare. È suggerita dallo stesso Olivi, nel prologo, per una migliore intelligenza del testo.
d) La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati della storia della Chiesa, cioè alle categorie con cui l’Olivi organizza la materia esegetica. Questo ordine interno è registrabile per zone progressive del poema dove prevale, tramite le parole-chiave, la semantica riferibile a un singolo stato. È un ordine dirompente i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ogni stato, che ha differenti inizi, è concatenato per concurrentia, come le maglie di un’armatura, con quello che precede e con quello che segue. Si possono in tal modo redigere mappe che comprendano l’ordine spirituale della Commedia. La ricerca, collocata su un sito per sfruttare gli spazi offerti dalla rete, è pervenuta a una Topografia spirituale della Commedia, dove per quasi ogni verso, o gruppo di versi, collegamenti ipertestuali conducono al “panno” esegetico fornito dalla Lectura super Apocalipsim, sul quale il “buon sartore” ha fatto “la gonna”.
Questa intertestualità diffusa per tutto il “poema sacro”, regolata da precise norme la cui costanza non consente dubbio sul fatto in sé, lascia aperto il campo alla ricerca delle possibili cause di tanta tecnica e intima rispondenza dei due testi. Per il momento si affacciano tre ipotesi:
a) Il senso letterale della Commedia contiene parole che sono chiave di accesso a un altro testo, la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi. Si tratta di un procedimento di arte della memoria: le parole-chiave operano sul lettore come imagines agentes che lo sollecitano verso un’opera di ampia dottrina, che già conosce, ma che rilegge mentalmente parafrasata in volgare, profondamente aggiornata secondo gli intenti propri del poeta, in versi che le prestano “e piedi e mano” e la dotano di exempla contemporanei e noti. Nel senso letterale del “poema sacro” sono incardinati gli altri sensi interpretativi: allegorico, morale, anagogico (che Dante, nell’Epistola a Cangrande, definisce collettivamente “mistici” o “allegorici”). Dante mirava non solo a un pubblico di laici, ma anche di predicatori e riformatori della Chiesa – agli Spirituali francescani, e forse non solo ad essi, se la Lectura si fosse diffusa anche presso altri Ordini -, a coloro cioè che con la predicazione avrebbero potuto riformare la Chiesa e con la “lingua erudita” – il suo volgare – convertire il mondo. Questo pubblico di chierici non si formò, perché gli Spirituali (non un gruppo organizzato, ma di sensibilità comune), i quali dovevano conoscere la Lectura oliviana, furono perseguitati e il loro libro-vessillo, censurato nel 1318-1319 e condannato nel 1326, fu votato alla clandestinità e quasi alla sparizione.
b) La persistenza di un “panno” – cioè di un altro testo da cui trarre i significati spirituali del poema, materialmente elaborati attraverso le parole – è servita a mantenere l’unità e la coerenza interna dell’ordito, della “gonna”, per usare l’immagine di san Bernardo a Par. XXXII, 139-141. Che il poema sia stato pubblicato per gruppi di canti, non più modificabili, oppure per cantiche riviste, sempre stava innanzi all’autore la medesima esegesi teologica con le innumerevoli possibilità di variazioni tematiche e di sviluppi.
c) Come terza ipotesi si può ricordare quanto affermò Charles Southward Singleton nell’annunciare la scoperta del numero sette come numero centrale della Commedia, rivelatore di una mirabile struttura nascosta ancora tutta da decifrare. Come nella cattedrale di Chartres gli scalpellini lasciarono bellissimi fregi a grande altezza, dove occhio umano non sarebbe potuto arrivare, così l’ordine e l’intelligenza interiore del poema non furono concepiti solo per la vista degli uomini: “quel disegno, qualunque fosse il suo posto nella struttura, l’avrebbe veduto Colui che tutto vede, Colui che ha creato il mondo con meraviglioso ordine, in pondere, numero, mensura; e l’avrebbe certo guardato come prova che l’architetto umano aveva imitato l’universo che Egli, divino architetto, aveva creato innanzi tutto per la propria contemplazione, e poi, per la contemplazione degli angeli e degli uomini” [28]. La struttura semiotico-spirituale del “poema sacro”, espressione dell’io del pellegrino, sarebbe stata concepita solo “al servigio dell’Altissimo”.
La prima ipotesi è la più probabile. In primo luogo, perché la Commedia mostra un ordine interno diverso, fondato sui sette stati della storia della Chiesa, da quello che appare al comune lettore che non conosce la Lectura super Apocalipsim. Questo andamento ciclico per stati risponde a un percorso interiore, di progressiva illuminazione della verità, che non è riservato al solo autore.
In secondo luogo, perché la collocazione delle parole-chiave, che sollecitano la memoria verso l’ampia dottrina apocalittica, è tale da richiedere la collaborazione del lettore consapevole, facendo appello al suo ingegno.
In terzo luogo, perché nel “poema sacro” che si propone come nuova Apocalisse, scritta da un nuovo Giovanni, all’allegoria intesa come “una veritade ascosa sotto bella menzogna” (Convivio II, i, 3), cioè sotto la lettera della poesia che diletta, si sostituisce la metafora della Scrittura, che Tommaso d’Aquino riteneva necessaria, utile e occulta per esercitare nello studio e contro le irrisioni degli infedeli (Summa Theologiae, I, qu. I, a. 9), e dunque i “sensi mistici”, come nella Bibbia, sono rivolti a un pubblico che può intenderli.
5. La Divina Commedia, dunque, è un universo di segni [29]. Per essa la Lectura super Apocalipsim non è una fonte, bensì il libro della storia delle illuminazioni sapienziali con cui tutto deve concordare. Con l’esegesi dell’ultimo libro canonico, esposta in una teologia della storia che comprende per settenari tutta la Scrittura, la quale a sua volta è forma, esempio e fine di ogni scienza, concorda ogni conoscenza, ogni esperienza, ogni soluzione indipendente data a questioni dottrinali. Virgilio, Ovidio o Lucano, Boezio, Aristotele, Alberto Magno o Tommaso d’Aquino, la stessa Scrittura in quanto tale, le più svariate esperienze poetiche o le conoscenze di astronomia sono, nel poema, tutte fonti ordinate alla Lectura.
Fra le auctoritates citate nella Lectura molte appartengono alla tradizione altomedievale: Agostino, Girolamo, Gregorio Magno, Beda, Cassiano, lo Pseudo Dionigi. Rimarchevole la presenza di Riccardo di San Vittore, la cui esegesi viene confrontata con quella di Gioacchino da Fiore.
Il sesto e il settimo stato della Chiesa, nella prospettiva di Olivi, corrispondono alla terza età di Gioacchino da Fiore, quella dello Spirito ma, novità sostanziale rispetto all’abate calabrese, non sono appropriati a una persona della Trinità, bensì allo Spirito di Cristo, centro della storia in progressivo sviluppo. L’abate è presente nella Commedia non per conoscenza diretta ma in modo diffuso attraverso le numerose sue citazioni nella Lectura, le quali partecipano della generale metamorfosi di questa.
6. Come all’apertura del sesto sigillo i segnati si distinguono, perché amici di Dio, dalla volgare milizia, così Dante per l’amica Beatrice è uscito dalla “volgare schiera” dei poeti (Inf. II, 103-105). Come l’angelo ingiunge a Giovanni di predicare ancora senza timore a tutto il mondo dopo gli Apostoli, inviscerando il libro dal sapore amaro e dolce insieme, così a Dante, quasi alter Iohannes, viene ingiunto da Cacciaguida di rendere manifesta la sua visione nel “poema sacro”, nuova Apocalisse, anch’essa, come quella di Giovanni, amara nel primo gusto ma poi salutare (Par. XVII, 127-132). Anche nella Commedia, come nell’Apocalisse secondo Olivi, le realtà divine e intellettuali vengono comprese per mezzo di similitudini sensibili e corporali. Come l’insegnamento del Cristo uomo, per mezzo della voce esteriore, lascia il posto al gusto interiore dettato dallo Spirito, così Virgilio lascia il campo nell’Eden all’arrivo di Beatrice (Purg. XXX, 49-51). L’ascesa del poeta al cielo – un sentimento simile, nel “trasumanar” a quello provato da Glauco, il pescatore di Ovidio, “nel gustar de l’erba / che ’il fé consorto in mar de li altri dèi” – è reale applicazione del vedere la verità “non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia” (Par. I, 67-72). La prova della pietà di fronte ai dannati, ingannati da una falsa Scrittura (come Francesca e Paolo) o da una falsa autorità papale (come Guido da Montefeltro), equivale per Dante al martirio psicologico degli ultimi tempi inferto dal dubbio. Come al vescovo di Filadelfia, la sesta chiesa d’Asia, è data la “porta aperta”, cioè la capacità di aprire i cuori con la parola, così nella dura roccia infernale i dannati parlano per dettato interiore, interrompendo la pena.
7. Ubertino da Casale e Dante fecero un uso diverso della Lectura super Apocalipsim. Il primo ne trascrisse diversi brani nel V libro dell’Arbor vitae. Si è sempre sostenuto che Dante conoscesse l’Arbor, e ciò non è certo escluso. Fatto sta che l’esame intertestuale fra Commedia e Lectura mostra chiaramente come Dante abbia elaborato anche i numerosi passi che Ubertino non aveva incluso nel V libro dell’Arbor. Si tratta dei passi strettamente esegetici, che spesso si estendono per parecchi fogli dell’opera oliviana e non sono secondari nell’economia di questa. Il commento apocalittico di Olivi fu per Ubertino una fonte, Dante lo scelse come canovaccio spirituale della Commedia.
Le strade di Ubertino da Casale e di Dante, il cui incontro è ipotizzabile fra il 1307 e il 1309, si separarono. Si pone qui la questione dei rapporti fra Dante e gli Spirituali francescani: se concepì per essi un viaggio dottrinale interiore organizzato sulla Lectura, come si deve considerare il giudizio negativo che Bonaventura dà di Ubertino a Par. XII, 124-126? La risposta sta nel separare gli opposti estremismi riprovati da Bonaventura – coartare la Regola da parte del rigorista Ubertino oppure fuggirla da parte del rilassato Matteo d’Acquasparta – dalla sua vera interpretazione data dall’Olivi. Nell’ultima fase della stesura del poema l’autore volle con nettezza distinguersi dall’estremista Ubertino da Casale, che pure attorno al 1307, in un periodo nel quale la riforma della Chiesa era ancora possibile, fu probabilmente colui che gli diede in mano la Lectura super Apocalipsim perché la volgarizzasse nei suoi modi poetici. Questo cambiamento intervenne dopo il Concilio di Vienne (1311-1312) e la “magna disceptatio” che lacerò l’Ordine francescano fra i seguaci dell’una e dell’altra parte. Alle parole di Bonaventura contro estremisti e rilassati nell’Ordine si potrebbe aggiungere che l’uno e l’altro estremo contrastavano con gli insegnamenti di frate Pietro di Giovanni Olivi il quale, con salomonico equilibrio, condannò la rilassata gerarchia dell’Ordine ma pure si oppose all’estremismo degli Spirituali italiani. Il francescanesimo di Dante, come intuì Raoul Manselli, è quello di Olivi [30].
8. Il realismo dantesco porta nell’aldilà le passioni dell’individuo ma, dando ad esse una veste sacra per mezzo della dottrina contenuta nella Lectura super Apocalipsim, estrema espressione di una storia della salvezza collettiva, le inserisce in un processo storico universale che manifesta i segni della volontà divina.
Dante ha propri motivi di interesse, primi fra tutti la lingua volgare, Aristotele e l’Impero. Olivi – che scrive in latino – è avverso alla filosofia aristotelica, non è un fautore dell’Impero. Proprio su questi punti distanti si misura la portata della metamorfosi.
Il poeta ha sempre tenuti fissi gli occhi al latino come a modello ideale di una nuova lingua universale. Il latino era una lingua per pochi, non bastava più per tutte le necessità espressive. Il latino dell’esegesi è vicino al volgare, ed è forse l’effetto più evidente del confronto testuale. Lavorando su questo latino umile, Dante diede al volgare la “gloria de la lingua”.
Con un aggiornamento di quanto esposto nella Lectura super Apocalipsim sull’incorporazione delle genti nella Roma dei giusti o dei reprobi, che peregrinano insieme in terra, Dante perviene ad attribuire ai classici, in primo luogo ad Aristotele e a Virgilio, una sacralità fino ad allora propria solo della Chiesa in sé.
All’Impero viene applicata la concezione che l’Olivi ha della Chiesa: passa di mano in mano, può rimanere temporaneamente “sanza reda”, ma di per sé è immutabile, tunica inconsutile. Lo stesso voto evangelico secondo Olivi e la monarchia secondo Dante hanno qualcosa di essenziale in comune: l’immutabilità, l’indissolubilità.
La nuova ricerca, apparentemente, ripristina un Dante tutto “medievale”. Richiede infatti al lettore, come invitava Benedetto Croce, “che anzitutto si renda familiari le linee fondamentali dell’edifizio medievale e viva dentro questa figurazione, grandiosamente conclusa in sé ma a noi per ogni verso estranea” [31]. Viene in luce quella che Croce definiva “[…] una didascalica, di eccelso argomento, di grandioso movimento, di altissima intonazione, ma una didascalica con gli espedienti della didascalica” [32]. Questa didascalica consente tuttavia di avvicinarci storicamente a Dante, nel suo tempo e nei suoi sentimenti, guardando alla poesia secondo la sua idea senza confronti con la nostra, come intendeva Croce. In tal modo è possibile registrare l’intima metamorfosi per la quale la storia sacra della Chiesa si travasa nello stato umano, sull’“aiuola che ci fa tanto feroci”. Quanto Olivi scrive della storia della Chiesa e della gloria di Cristo viene nella Commedia diffuso su tutte le persone e le forme, antiche e nuove, del nostro mondo con le sue passioni. Il saeculum humanum rivendica l’autonomia nell’uso del volgare, nella definizione del regime politico, nell’ambito della natura e della ragione, nella valorizzazione degli autori classici, in quelli che sarebbero stati gli ideali laici del Rinascimento. Delle due nature dell’anima di Dante, duplice come quella di Faust – per usare ancora una celebre definizione del Croce [33] -, “divisa tra Medioevo persistente e incipiente Rinascimento”, viene messa in luce la reciproca osmosi.
[1] Cfr. Inf. VI, 61-63; Purg. VI, 148-151.
[2] Cfr. G. SALVEMINI, Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295, a cura di E. SESTAN, Milano 1974, pp. 121-123.
[3] Cfr. Inf. XV, 110-114.
[4] Cfr. S. GENTILI, Girolami, Remigio de’, in Dizionario Biografico degli Italiani, 56 (2001).
[5] La notizia è contenuta nello scritto Sanctitati apostolicae di UBERTINO DA CASALE (1311), in F. EHRLE, Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne, in “Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters”, 2 (1886), p. 389: “Nam per dominum N[icolaum] IIII non solum nunquam fuit condempnatus ipse vel eius doctrina, sed fuit multipliciter commendatus ab eo et de eius voluntate primo per dominum fratrem Matheum tunc generalem factus est lector Florentiae in studio generali quoad ordinem nostrum et postmodum per fratrem Raymundum Gaufridi lector Montispessulanus”.
[6] Come introduzione alla biografia e all’opera del francescano provenzale cfr. PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Scritti scelti, a cura di P. VIAN, Roma 1989 (Fonti cristiane per il terzo millennio, 3).
[7] D. BURR, The Spiritual Franciscans. From Protest to Persecution in the Century after Saint Francis, University Park, 2001, pp. 47, 62. Sulle differenze fra gruppi provenzali e italiani cfr. R. MANSELLI, Divergences parmi les Mineurs d’Italie et de France méridionale, in Les mendiants en pays d’Oc au XIIIe siècle, Toulouse 1973 (Cahiers de Fanjeaux, VIII), pp. 355-373 [ripubblicato in ID., Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo. Studi sul francescanesimo spirituale, sull’ecclesiologia e sull’escatologismo bassomedievali, introduzione e cura di P. VIAN, Roma 1997 (Nuovi studi storici, XXXVI), pp. 243-256].
[8] Cfr. P. VIAN, “Se il chicco di grano …”. Raoul Manselli, Pietro di Giovanni Olivi e il francescanesimo spirituale. Nuovi appunti di lettura, in “Nisi granum frumenti…”. Raoul Manselli e gli studi francescani, a cura di F. ACCROCCA, Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 2011 (Bibliotheca Seraphico-Capuccina, 93), pp. 30-33.
[9] UBERTINO DA CASALE, Arbor vitae crucifixae Iesu, Venetiis 1485, rist. anast. a cura di C. T. DAVIS, Torino 1961, prologus I, f. 4a-b.
[10] Cfr. P. I. OLIVI, Expositio super Regulam Fratrum Minorum, ed. D. FLOOD, Wiesbaden 1972 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, 67), cap. I, p. 117: “Circa definitionem vero nota primo quam perfecte et proprie nomen sui definiti praemittitur dicendo: Regula et vita fratrum minorum, vocans eam non solum regulam sed et vitam, ut sit sensus quod est regula, id est, recta lex et forma vivendi et regula vivifica ad Christi vitam inducens; et iterum quod potius consistit in actu et opere vitae quam in charta vel littera aut in intellectu vel lingua”.
[11] PETRUS IOHANNIS OLIVI, Lectura super Apocalipsim, prologus, notabile VII: “Huius autem vite perfecta imitatio et participatio est et debet esse finis totius nostre actionis et vite”. Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim [d’ora in poi: LSA] sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713 [P], il testimone più antico (1318-1319) e autorevole, a disposizione fin dal 2009 sul sito www.danteolivi.com. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti si rinvia all’edizione in rete, i corsivi sono dell’autore del saggio. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Petrus Iohannis Olivi, Lectura super Apocalypsim, Saint Bonaventure University, Saint Bonaventure, NY, Franciscan Institute Publications, 2015, pp. lxxii-899): le problematiche da essa poste sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161. Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. Petrocchi, Firenze 1994.
[12] P. I. OLIVI, Quaestio de altissima paupertate, ed. J. SCHLAGETER, Das Heil der Armen und das Verderben der Reichen. Petrus Johannis Olivi OFM. Die Frage nach der höchsten Armut, Werl/Westfalen 1989 (Franziskanische Forschungen, 34), in quinta parte responsionis, pp. 151-152: “Si tamen quis contra hoc dicat quod secundum hoc status Christi et Apostolorum qui fuerunt in primo tempore ecclesiae, esset inferior statu sexti et septimi temporis: scire debet qui hoc dicit, quod Christus secundum aliquid est quasi pars, si tamen pars prioris temporis, secundum aliquid vero finalis temporis, simpliciter tamen ipse est caput universale omnis temporis”.
[13] LSA, cap. I, Ap 1, 13: « […] propter quod (Christus) apparuit “in medio septem candelabrorum” […] sicut centrum, in medio spere existens, exhibet se toti spere […] »; cap. II, Ap 2, 1: « “Hec dicit qui tenet septem stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum” […] tamquam infra se immediate vos omnes tenens et tamquam in medio vestrum existens et omnia vestra continue perambulans et perscrutans et immediate percurrens seu conspiciens […] »; cap. V, Ap 5, 6: « […] ipse est totius ecclesie mediator et quasi centrale medium ad quod tota spera ecclesie et omnes linee electorum suorum aspiciunt sicut ad medium centrum. […] “et in medio quattuor animalium”, id est vite et doctrine evangelice […] »; cap. VII, Ap 7, 17: « “Quoniam Agnus, qui in medio troni est” […] vel in intimo ecclesie quasi centrum ipsius […] »; cap. XIV, Ap 14, 4: « […] ad quos Christus tamquam dux et exemplator itineris ipsos deducit ».
[14] “[…] sentit intra se intima reflexione consistere”: cfr. Fr. PETRUS IOHANNIS OLIVI O. F. M., Quaestiones in secundum librum Sententiarum, ed. B. JANSEN, Ad Claras Aquas, prope Florentiam, 1922-1926 (Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi, IV-VI), II, p. 334 (q. LVII, An in homine sit liberum arbitrium).
[15] Le espressioni di Olivi relative al sesto stato – “quoddam sollempne initium novi seculi … renovaretur et consumaretur seculum” (LSA, prologus, notabilia VI, VII), nel quale il sacerdozio apostolico “redeat et assurgat ad ordinem primum” (LSA, prologus, notabile VII), la “nova Ierusalem” – interpretata come “visione di pace” – viene vista “descendere de celo” (LSA, cap. II, Ap 3, 12) e la Chiesa descritta come la donna vestita di sole con la sua “virginea proles” (LSA, cap. XII, Ap 12, 7) – sono la veste spirituale dei versi della quarta egloga virgiliana che celebrano la rinnovata età dell’oro, anche se il francescano non la cita esplicitamente: “Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo / iam redit et Virgo; redeunt Saturnia regna; / Iam nova progenies caelo demittitur alto” (Egloga IV, 5-7).
[16] LSA, cap. X, Ap 10, 11: « Sequitur: “Et dixit michi: Oportet te iterum prophetare in gentibus et populis et linguis et regibus multis”. In ipsa sapientia libri expresse continetur quod oportet iterum predicari evangelium in toto orbe, et Iudeis et gentibus, et totum orbem finaliter converti ad Christum. Sed quod per istum hoc esset implendum non poterat sciri nisi per spiritualem revelationem, et hoc dico prout per Iohannem designantur hic singulares persone quia, prout per ipsum designatur in communi ordo evangelicus et contemplativus, scitur ex ipsa intelligentia libri quod per illum ordinem debet hoc impleri ».
[17] Ciò appartiene al sesto periodo (status) della Chiesa, che con il settimo corrisponde alla terza età, quella dello Spirito, di Gioacchino da Fiore; cfr. LSA, cap. III, Ap 3, 7: « Significatur etiam per hoc proprium donum et singularis proprietas tertii status mundi sub sexto statu ecclesie inchoandi et Spiritui Sancto per quandam anthonomasiam appropriati. […] Sicut etiam in primo tempore exhibuit se Deus Pater ut terribilem et metuendum, unde tunc claruit eius timor, sic in secundo exhibuit se Deus Filius ut magistrum et reseratorem et ut Verbum expressivum sapientie sui Patris, sic in tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum et ut tripudium spiritualium iubilationum et iocunditatum, per que non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris. Christus enim promisit quod “cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem” et “ille me clarificabit” et cetera (Jo 16, 13-14) ». Il più alto grado del gusto d’amore è raggiunto in terra con il serotino convivio che segue la sconfitta dell’Anticristo. Cfr. LSA, cap. XIX, Ap 19, 17-18: « “Et vidi unum angelum stantem in sole”. Iste designat altissimos et preclarissimos contemplativos doctores illius temporis, quorum mens et vita et contemplatio erit tota infixa in solari luce Christi et scripturarum sanctarum, et secundum Ioachim inter ceteros precipue designat Heliam. “Et clamavit voce magna omnibus avibus que volabant per medium celi”, id est omnibus evangelicis et contemplativis illius temporis: “Venite, congregamini ad cenam Dei magnam”, id est ad spirituale et serotinum convivium Christi, in quo quidem devorabitur universitas moriture carnis, ut transeat quod carnale est et maneat quod spirituale est. […] Quibus autem verbis explicari posset quanto gaudio et amore et dulcore reficientur sancti de conversione omnium gentium et Iudeorum post mortem Antichristi fienda […] ».
[18] LSA, cap. III, Ap 3, 8: « “Ecce dedi coram te hostium apertum”. Hostium aperitur cum intellectus illuminatur et exacuitur ad scripturarum occulta expedite et faciliter penetranda et videnda, et cum predicationi datur spiritalis efficacia ad corda audientium penetranda, et cum incredulorum corda divinitus aperiuntur ad credendum et implendum Christi legem et fidem que predicatur eis, et etiam cum spiritus predicantium sentit ordinationem et assistentiam Christi ad aperiendum corda gentium per sermonem ipsius. Nam predicta Christi ordinatio seu voluntas est primum hostium seu prima apertio sue voluntatis et gratie dande auditoribus et sermoni predicantis. […] “Dedi”, inquam sic tibi “apertum”, “quia modicam habes virtutem”, scilicet ad miracula vel ad corporalia fortis active opera, que sensuales homines plus admirantur et estimant quam intellectualia et interna […] ».
[19] LSA, cap. II, Ap 2, 7: « […] Secunda (causa) est ut intelligatur duplex modus docendi. Quorum primus est per vocem exteriorem, secundus vero per inspirationem et suggestionem interiorem. Prima autem competit Christo in quantum homo; secunda vero eius deitati, appropriatur tamen Spiritui Sancto. Prima autem disponit ad secundam sicut ad suum finem et est inutilis sine illa. […] Item Christo, in quantum est Verbum et verbalis sapientia Patris, appropriatur interna locutio que fit per lucem simplicis intelligentie. Illa vero que fit per amoris gustum et sensum appropriatur Spiritui Sancto. Prima autem se habet ad istam sicut materialis dispositio ad ultimam formam. […] Quarta est ut ex duplici auctoritate duorum tam sollempnium testium et magistrorum fortius moveremur, et prima quidem moveret iterum per evidens exemplum operum Christi nobis in sua humanitate visibiliter ostensorum; secunda vero ulterius moveret per spiritualem flammam et efficaciam Spiritus Sancti ».
[20] Cfr. LSA, prologus, notabile X: « Sextus vero concurrit cum secundo non in eodem tempore sed in celebri multitudine martiriorum, prout in apertione quinti signaculi aperte docetur (cfr. Ap 6, 9), quamvis in modo martirii quoad aliqua differant. Nam martiria a paganis et idolatris facta nullum certamen dubitationis inferebant martiribus, aut probabilis rationis, propter nimiam evidentiam paganici erroris. Non sic autem fuit de martiriis per hereticos, unum Deum et unum Christum confitentes, inflictis. In sexto autem tempore non solum propulsabuntur martires per tormenta corporum, aut per subtilitatem rationum philosophicarum, aut per intorta testimonia scripturarum sanctarum, aut per simulationem sanctitatis ypocritarum, immo etiam per miracula a tortoribus facta. Nam, teste Christo, “dabunt signa et prodigia magna” (Mt 24, 24). Unde Gregorius, XXXII° Moralium super illud Iob: “stringit caudam suam quasi cedrum” (Jb 40, 12), dicit: «Nunc fideles nostri mira faciunt, cum perversa patiuntur; tunc autem Behemot huius satellites, etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit humane mentis illa temptatio, quando pius martir corpus tormentis subicit, et tamen ante eius oculos miracula tortor facit». Propulsabit etiam eos per falsam imaginem divine et pontificalis auctoritatis. Sic enim tunc surgent pseudochristi et pseudochristus contra electos, sicut Annas et Caiphas pontifices insurrexerunt in Christum. Erunt ergo tunc tormenta intensive maiora, tempore autem paganorum fuerunt extensive pluriora: nam plusquam per ducentos annos duraverunt ». Cfr. infra.
[21] A. FRUGONI, La Roma di Dante, tra il tempo e l’eterno, in ID., Pellegrini a Roma nel 1300. Cronache del primo Giubileo, presentazione di C. Frugoni, a cura e con Introduzione di F. ACCROCCA, Casale Monferrato 1999, 102-103.
[22] P. VIAN, Introduzione a PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Scritti scelti (cfr. nota 6), p. 8.
[23] È necessario distinguere i due momenti, quello della frequentazione da parte di Dante delle “scuole delli religiosi”, a partire dalla metà del 1293, per apprendervi la filosofia, e l’insegnamento di Olivi, lettore di teologia a Santa Croce fra il 1287 e il 1289. Non sappiamo se Dante abbia ascoltato direttamente le lezioni del frate provenzale, certamente conosceva bene le sue opere, come si mostra in Amore e vita di poeta. La Vita Nova e l’imitazione di Cristo. Il fatto che Santa Croce fosse un “centro di potere” e la sede del tribunale dell’Inquisizione non significa che le opere di Olivi non vi circolassero. Su queste opere si misura la portata del rapporto di Dante con lo spiritualismo francescano, che non può essere ridotto a un “cliché critico”, derivato dagli studi di Raoul Manselli, che “risulta ormai smentito da più parti”, come inteso da A. PEGORETTI, “Nelle scuole delli religiosi”: materiali per Santa Croce nell’età di Dante, in “L’Alighieri. Rassegna dantesca”, NS, 50 (2017), pp. 5-55: 6 e nota 4. La conoscenza da parte di Dante dell’esegesi oliviana va ben oltre i commenti alle Lamentazioni di Geremia e a Giobbe considerati alle pp. 36-39.
Sulla formazione filosofica di Dante cfr. L. DELL’OSO, Per la formazione intellettuale di Dante: i cataloghi librari, le tracce testuali, il ‘Trattatello’ di Boccaccio in “Le tre corone. Rivista internazionale di studi su Dante, Petrarca, Boccaccio”, 4 (2017), pp. 129-161; La formazione di Dante alle «scuole delli religiosi»
https://www.youtube.com/watch?v=hxY_qZnOWmI&t=7s&ab_channel=UniBgperDante20211.
[24] Giovanni del Virgilio così iniziò il suo epitaffio per la tomba del poeta fiorentino: “Theologus Dantes, nullius dogmatis expers / quod foveat claro phylosophya sinu”. E Cola di Rienzo, fuggitivo in Boemia, scriveva: “Hic Dans theologus magnus fuit, phylosophus clarus, poeta quidem eximius, civis plebeio genere florentinus, ex plaga ytalica, provincia tuscia” [P. G. Ricci, Il commento di Cola di Rienzo alla Monarchia di Dante, in Studi medievali, S. III, 6 (1965), p. 679; Cola di Rienzo, In Monarchiam Dantis Commentarium. Commento alla Monarchia di Dante, a cura di P. d’Alessandro, premessa di G. Ravasi, Città del Vaticano 2015 (Littera antiqua, 20), p. 48].
[25] Una traduzione italiana delle lettere ai figli di Carlo II d’Angiò (18 mag. 1295) e a Corrado di Offida (14 set. 1295) è in VIAN (cfr. nota 6), pp. 210-225. Sulla quaestio oliviana cfr. A. FORNI, Pietro di Giovanni Olivi di fronte alla rinuncia di Celestino V, in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo”, 99, 1 (1993), pp. 117-157.
[26] DINO COMPAGNI, Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi, introduzione e note di G. Bezzola, Milano 1995, l. III, capp. XV-XVIII, pp. 210-217; GIOVANNI VILLANI, Nuova Cronica, a cura di G. Porta, Parma 1991, tomo II, libro IX, cap. 85 (1306), pp. 653-654; cap. 89 (1307), pp. 657-659: (p. 653, anno 1306) “il quale (cardinale messer Nepoleone degli Orsini dal Monte, legato e paciaro generale in Italia) si partì da Leone sopra Rodano, e passò i monti, e mandando a’ Fiorentini che voleva venire in Firenze per fare pace e concordia da loro e i loro usciti […]”. Cfr. P. VIAN, « Noster familiaris solicitus et discretus »: Napoleone Orsini e Ubertino da Casale, in Ubertino da Casale. Atti del XLI Convegno Internazionale. Assisi 18-20 ottobre 2013, Spoleto 2014 (Società Internazionale di Studi Francescani – Centro Interuniversitario di Studi Francescani), pp. 217-298: 246-249.
[27] Cfr. G. PETROCCHI, Biografia, in Enciclopedia Dantesca, Appendice, p. 41.
[28] Ch. S. SINGLETON, La poesia della Divina Commedia, trad. it., Bologna, 1978, pp. 451-462.
[29] Cfr. A. ASOR ROSA, postfazione a L’idea deforme. Interpretazioni esoteriche di Dante, a cura di M. P. Pozzato, Milano 1989, p. 316: “Dante […] non si sarebbe mai sognato di non poter essere compreso. Che sia tanto difficile farlo, non dovrebbe condurci a rinunciarvi in favore di un arbitrio tutto calato nel punto di vista del lector. L’ermeneutica non può prescindere da un’ontologia della creazione poetica: se ne prescinde, è lettura del nulla. Questo è l’unico ma grandioso mistero, con cui ha a che fare ogni lettore di Dante (incomparabile con quei misteriucci da quattro soldi, con cui si sono misurati gli Aroux e i Guénon): il mistero del segno, o di quel sistema di segni, che ha racchiuso un mondo intero in un insieme d’immagini plurisense. Con questo mistero dobbiamo fare i conti”. Questo mistero, una vera e propria “Pompei dei segni”, è racchiuso nel confronto fra la Commedia e la Lectura super Apocalipsim.
[30] Cfr. R. MANSELLI, Il canto XII del Paradiso, in Nuove letture dantesche, VI, Firenze 1973, pp. 107-128: 126-127, ripubblicato in ID, Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo (cfr. nota 7), pp. 213-230: 228-229.
[31] B. CROCE, Due postille alla critica dantesca, in “La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia”, 39 (1941), pp. 133-141: 136.
[32] B. CROCE, L’ultimo canto della «Commedia», in ID., Poesia antica e moderna. Interpretazioni, Bari 19432 (Scritti di storia letteraria e politica, XXXIV), pp. 151-161: 151, 156. La “didascalica” era utile come speculum per il conseguimento della perfezione individuale e per l’omiletica. Fondamentale per la comprensione storica della Commedia è infatti la prospettiva della predicazione. Cfr. C. DELCORNO, Dante e il linguaggio dei predicatori, in “Letture Classensi”, 25 (1996), pp. 51-74; N. MALDINA, In pro del mondo. Dante, la predicazione e i generi della letteratura religiosa medievale, Roma 2017.
[33] B. CROCE, Ancora della lettura poetica di Dante (1948), in Letture di poeti e riflessioni sulla teoria e la critica della poesia, Bari 1950, pp. 3-20.
APPENDICE
Vengono qui di seguito esposti alcuni esempi di sinossi fra Commedia e Lectura super Apocalipsim, già collocati su questo sito, al quale si rinvia per maggori spiegazioni.
“L’essercito di Cristo, che sì caro / costò a rïarmar …” (Par. XI, 37-38)
L’angelo del sesto sigillo rimuove un impedimento, dopo di che il segno è posto sulla fronte, non vergognosa ma liberamente magnanima, degli eletti amici di Dio, difensori della fede fino al martirio da lui conosciuti per nome e ascritti alla più alta milizia dei baroni, dei decurioni, dei cavalieri che si distingue da quella volgare dei fanti. Questa esegesi, nella quale il sesto stato corrisponde agli ultimi sei anni della costruzione del Tempio dopo la cattività in Babilonia, è una sacra sinfonia militare i cui temi trascorrono in più luoghi: dalla “signatio” poetica di Dante, amico di Beatrice e “sesto tra cotanto senno” nella schiera dei sommi poeti del Limbo, alla “signatio” apostolica nelle virtù teologali di fronte a Pietro, Giacomo e Giovanni; dall’impossibile amicizia con Dio di Francesca e Paolo (anch’essi in una schiera) alle famiglie fiorentine, menzionate da Cacciaguida, che portano “la bella insegna” del marchese Ugo di Toscana, assunte a una milizia più alta rispetto a Giano della Bella, l’autore dei famosi Ordinamenti di giustizia (1293) anch’egli di essa insignito (la quale “fascia col fregio”), ma che oggi si raduna col popolo, corrispondente alla volgare e pedestre milizia che viene dopo i segnati, dai due campioni della Chiesa, Francesco e Domenico che riarmarono l’esercito di Cristo, a Cacciaguida crociato e martire. Questi eletti ‘sesti’ amati da Dio sono lo sviluppo sacro di coloro (De vulgari eloquentia, II, iv, 10-11) che Virgilio, nel sesto dell’Eneide, definisce “Dei dilectos”, i poeti tragici innalzati al cielo per ardente virtù (Aen., VI, 129-131: “Pauci, quos aequus amavit / Iuppiter”), designati dall’“astripeta aquila”.
Questa pagina esegetica viene compiutamente esaminata altrove.
L’arte della memoria per parole-chiave non serviva soltanto ai religiosi. Il fatto che gruppi di terzine numericamente corrispondenti, a diversi stadi della Commedia, contengano parole-chiave che conducono alla medesima pagina esegetica sembra indicare che queste parole, se dovevano essere per il lettore spirituale signacula mnemonici di un altro testo, erano per il poeta anche segni del numero dei versi, ‘luogo’ dove collocare i medesimi signacula in forma e contesto diversi. Esempi sono proposti qui di seguito nelle Tabelle IV-VI. Altri esempi in « In mensura et numero et pondere ». Nella fucina della Commedia: storia, poesia e arte della memoria (PDF, 2014), cap. 3.
(I) |
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 3 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Clamat ergo (Ap 7, 3): “Nolite”, id est non audeatis; vel si ad bonos angelos loquitur, dicit “nolite” quia, ex quo ipse prohibuit, non debuerunt velle; “nocere”, scilicet per effrenatam temptationem vel per predicationis et gratie impeditionem, “terre et mari neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum”.
|
|
Par. XXIV, 52-60, 115-117“Dì, buon Cristiano, fatti manifesto:
|
Par. XV, 139-141, 148; XVI, 22-27, 40-42, 127-132, 148-150Poi seguitai lo ’mperador Currado;
|
(II)
[Ap 7, 3] Clamat ergo (Ap 7, 3): “Nolite”, id est non audeatis; vel si ad bonos angelos loquitur, dicit “nolite” quia, ex quo ipse prohibuit, non debuerunt velle; “nocere”, scilicet per effrenatam temptationem vel per predicationis et gratie impeditionem, “terre et mari neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum”.
|
|
Purg. XXIII, 70-75; XXIV, 10-12, 16-18, 25-33, 94-99E non pur una volta, questo spazzo
|
Purg. XXIX, 151-154; XXXII, 16-24E quando il carro a me fu a rimpetto,
|
[Ap 7, 3] Ex predictis autem patent alique rationes quare ante temporale exterminium nove Babilonis sit veritas evangelice vite a reprobis sollempniter impugnanda et condempnanda, et e contra a spiritalibus suscitandis ferventius defendenda et observanda et attentius et clarius intelligenda et predicanda, ut merito ibi sit quoddam sollempne initium sexte apertionis. Quamvis autem a pluribus fide dignis audiverim sanctum patrem nostrum Franciscum hanc temptationem pluries predixisse, et etiam quod per eius status professores esset malignius et principalius exercenda, nichilominus quasdam rationes breviter subinsinuo. […] Tertio ut spiritus in viris evangelicis tepefactus et quasi extinctus seu consopitus suscitetur et fortissime accendatur, et per hoc disponantur et etiam promereantur ad potenter sustinendum et triumphaliter devincendum subsequentem temptationem sub magno Antichristo venturam. Quarto quia expedit veritatem evangelice vite et regule per concertationem validam prius clarificari et exaltari ante magni Antichristi adventum, quia aliter non posset sibi triumphaliter resistere nec esset dare tunc plures perfectos Christi milites ab ipso martirizandos. |
|
(III)
[Ap 7, 3] Clamat ergo (Ap 7, 3): “Nolite”, id est non audeatis; vel si ad bonos angelos loquitur, dicit “nolite” quia, ex quo ipse prohibuit, non debuerunt velle; “nocere”, scilicet per effrenatam temptationem vel per predicationis et gratie impeditionem, “terre et mari neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum”.
|
|
Inf. X, 35, 73-74, 93ed el s’ergea col petto e con la fronteMa quell’ altro magnanimo, a cui posta
|
Purg. XXVII, 133, 139-140Vedi lo sol che ’n fronte ti riluce ……Non aspettar mio dir più né mio cenno;
|
(IV)
[Ap 7, 3] Clamat ergo (Ap 7, 3): “Nolite”, id est non audeatis; vel si ad bonos angelos loquitur, dicit “nolite” quia, ex quo ipse prohibuit, non debuerunt velle; “nocere”, scilicet per effrenatam temptationem vel per predicationis et gratie impeditionem, “terre et mari neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum”.
|
| Purg. XXIV, 10-18 (4-6)
“Ma dimmi, se tu sai, dov’ è Piccarda; |
Par. XXV, 10-18
però che ne la fede, che fa conte |
|
| Purg. XXI, 19-24 (7-8)
“Come!”, diss’ elli, e parte andavam forte:
Inf. XVIII, 28-33 (10-11) come i Roman per l’essercito molto, |
Purg. XXXII, 16-24 (6-8)
vidi ’n sul braccio destro esser rivolto
Inf. XXXIII, 31-33 (11)
Con cagne magre, studïose e conte |
Par. XVI, 22-27 (8-9)
Ditemi dunque, cara mia primizia, |
(V)
[Ap 7, 3] Clamat ergo (Ap 7, 3): “Nolite”, id est non audeatis; vel si ad bonos angelos loquitur, dicit “nolite” quia, ex quo ipse prohibuit, non debuerunt velle; “nocere”, scilicet per effrenatam temptationem vel per predicationis et gratie impeditionem, “terre et mari neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum”.
|
| Par. XII, 37-42 (13-14) L’essercito di Cristo, che sì caro costò a rïarmar, dietro a la ’nsegna si movea tardo, sospeccioso e raro, quando lo ’mperador che sempre regna provide a la milizia, ch’era in forse, per sola grazia, non per esser degna |
Par. XVI, 40-42 (14)
Li antichi miei e io nacqui nel loco |
Par. XXV, 40-42 (14)
“Poi che per grazia vuol che tu t’affronti |
| Inf. III, 52-60 (18-20)
E io, che riguardai, vidi una ’nsegna |
Par. XXIV, 52-60 (18-20)
“Dì, buon Cristiano, fatti manifesto:
|
Par. XXV, 52-57 (18-19)
“La Chiesa militante alcun figliuolo |
| Inf. X, 73-74 (25)
Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta |
Inf. XXII, 73-75
Draghignazzo anco i volle dar di piglio
|
| Inf. IV, 100-102 (34); II, 103-105 (35)
e più d’onore ancora assai mi fenno, Disse: – Beatrice, loda di Dio vera,
|
Purg. XIII, 103-105 (35)
“Spirto”, diss’ io, “che per salir ti dome, |
Par. VI, 100-105 (34-35)
L’uno al pubblico segno i gigli gialli Faccian li Ghibellin, faccian lor arte |
(VI)
[Ap 7, 3] Clamat ergo (Ap 7, 3): “Nolite”, id est non audeatis; vel si ad bonos angelos loquitur, dicit “nolite” quia, ex quo ipse prohibuit, non debuerunt velle; “nocere”, scilicet per effrenatam temptationem vel per predicationis et gratie impeditionem, “terre et mari neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum”.
|
| Inf. II, 121-126 (41-42)
Dunque: che è? perché, perché restai,
Purg. XI, 133-135 (45)
“Quando vivea più glorïoso”, disse,
Purg. XXVII, 139-142 (47) Non aspettar mio dir più né mio cenno; |
Par. XVIII, 121-126
sì ch’un’altra fïata omai s’adiri
Par. XII, 130-135 (44-45) Illuminato e Augustin son quici,
Par. IX, 139-142 (47) Ma Vaticano e l’altre parti elette |
Par. XV, 139-141 (47)
|
Ap 4, 3-4
“Vidi ’l maestro di color che sanno / seder tra filosofica famiglia” (Inf. IV, 131-132)
Il Limbo corrisponde alla sede divina prima dell’apertura da parte di Cristo del libro segnato da sette sigilli (Ap IV, 1 – V, 1-4). Come questa apertura era desiderata e sospirata dagli antichi Padri, così lo è ora, nel secondo avvento di Cristo nello Spirito; come all’apertura del sesto sigillo i segnati per milizia e privilegio precedono la turba innumerevole, così la schiera dei sommi cinque poeti coopta Dante, “sesto tra cotanto senno”; come nel sesto stato le genti saranno convertite “in spiritu magno et alto”, così nel nobile castello albergano gli “spiriti magni”, cioè le genti giuste, antiche (prima del Cristianesimo) e ‘moderne’ (i maomettani Avicenna, Averroè e il Saladino) in un processo della Redenzione ancora aperto che guarda a una nuova età di palingenesi e di conversione universale, che nel caso di Dante si realizza tramite la poesia.
La curia celeste dove, nell’Empireo, è stato deciso il duplice destino imperiale e papale di Roma, è proiettata su quella terrena e sui suoi nuovi cittadini, anch’essa derivante dal fonte dell’universale sapienza. Tra gli “spiriti magni” Dante vede Aristotele: “vidi ’l maestro di color che sanno / seder tra filosofica famiglia” (Inf. IV, 131-132). La figura del maestro dell’umana ragione è tessuta con i fili di Colui che siede sul trono più alto, con il quale condivide i motivi della somma sapienza, del sedere, dell’essere circondato e onorato da “famuli” (i seniori) tra i quali, quasi consiglieri o assistenti a lui più propinqui, stanno Socrate e Platone. Gli attributi divini di cui è fregiato Aristotele significano che egli è il primo depositario di “gubernationes et documenta” che poi “per magistrorum consilium descendunt ad nos quasi a pastore uno” (cfr. Ecclesiaste, 12, 11). Ma nella curia celeste il libro, che sta nella mano destra di Colui che siede, resta ancora chiuso, in attesa dell’Incarnazione. Questa chiusura non fu tuttavia completa, perché esso venne parzialmente aperto, sotto il velo della profezia, ai più sapienti di ogni tempo. Di qui il valore equivoco dell’essere “sospesi”, che designa sì lo stato di coloro che, nel Limbo, vivono in eterno nel desiderio di Dio senza speranza di appagamento, ma pure lo stato di chi, contemplando, è stato capace di volare, come l’aquila, al di sopra degli altri. Con il primo avvento di Cristo, il libro non fu tutto aperto, in attesa ancora del sesto stato della Chiesa, allorché avverrà la conversione delle reliquie delle genti e poi, per ultimo, di tutto Israele. Aristotele è così oggetto della variazione più distante dai temi che Dante elabora. E anche della più sorprendente. Considerato da Olivi un pericolo per il pensiero cristiano, non solo non lo è per Dante, ma viene anzi da questi conciliato con la stessa teologia della storia concepita dal francescano.
Gli “spiriti magni” parlano come i saggi, con parole parche, discrete, ponderate: “parlavan rado, con voci soavi” (Inf. IV, 114). Dalla sede, come si afferma ad Ap 4, 5 (versetto in collazione con Ap 8, 5 e 11, 19), vengono emessi lampi, voci e tuoni: a differenza dei tuoni, che designano gli alti insegnamenti provenienti dal cielo, le voci sono modeste e soavi e provengono dalla ragione umana, da questa terra.
Il libro dell’Apocalisse contiene tutta la sapienza che governa il mondo: “liber signatus est comprehensivus summe sapientie Dei universi orbis gubernative et specialiter electorum suorum” (Ap 4, 4). Si può vedere come gli stessi elementi di esegesi che designano Colui che siede sul trono, “cuius gubernationes et documenta per magistrorum consilium descendunt ad nos quasi a pastore uno”, siano fili utilizzati nei versi per l’ordito di Aristotele (“vidi ’l maestro di color che sanno / seder tra filosofica famiglia”, Inf. IV, 131-132), di san Luca medico (“L’un si mostrava alcun de’ famigliari / di quel sommo Ipocràte che natura / a li animali fé ch’ell’ ha più cari”, Purg. XXIX, 136-138) e delle parole di Beatrice sul traviamento degli uomini (“Tu, perché non ti facci maraviglia, / pensa che ’n terra non è chi governi; / onde sì svïa l’umana famiglia”, Par. XXVII, 139-141). In tutti e tre i casi, si tratta appunto dell’ “umana famiglia”, cioè degli esseri razionali, i quali “per phylosophica documenta” dovrebbero conseguire la beatitudine in questa vita sotto le leggi dell’Imperatore (Monarchia, III, xv, 7-10). Una “famiglia” designata dai seniori, i quali circondano come “famuli” la sede divina. Il libro, che sta nella destra di Colui che siede sul trono, contiene le leggi e i precetti del sommo imperatore e le sentenze e i giudizi del sommo giudice.
Questa pagina esegetica viene compiutamente esaminata altrove.
[LSA, cap. IV, Ap 4, 3-4 (IIa visio, radix)] “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id est aspectibili seu visibili forme, “lapidis iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dicitur similis, quia Deus est per naturam firmus et immutabilis et in sua iustitia solidus et stabilis, et firmiter regit et statuit omnia per potentiam infrangibilem proprie virtutis. […]
|
|
Inf. IV, 112-114, 130-135Genti v’eran con occhi tardi e gravi,
|
Purg. XXXI, 106-108Noi siam qui ninfe e nel ciel siamo stelle;
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 5 (IIa visio, radix)] Voces enim in terra fiunt, tonitrua vero in celo seu ethere, vocesque sunt modice respectu tonitruorum.
|
|
[Ap 4, 3-4] “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id est aspectibili seu visibili forme, “lapidis iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dicitur similis, quia Deus est per naturam firmus et immutabilis et in sua iustitia solidus et stabilis, et firmiter regit et statuit omnia per potentiam infrangibilem proprie virtutis. […]
|
|
Inf. IV, 112-114, 130-135Genti v’eran con occhi tardi e gravi,
|
Purg. XXIX, 136-141L’un si mostrava alcun de’ famigliari
|
[Ap 4, 5] Voces enim in terra fiunt, tonitrua vero in celo seu ethere, vocesque sunt modice respectu tonitruorum.
|
|
Ap 1, 16-17
Il volto di Cristo sorridente
Fra le tante appropriazioni agli individui, registrabili nella Commedia, delle prerogative di Cristo descritte nella Lectura super Apocalipsim, eccellono quelle proposte ad Ap 1, 16-17. Si tratta della decima e undecima perfezione di Cristo sommo pastore, premesse alla prima visione. Queste perfezioni, afferma l’Olivi, possono adattarsi ai prelati, ma anche agli eletti, membra del corpo mistico di Cristo:
Notandum autem quod perfectiones predicte possunt anologice coaptari perfectis prelatis sub Christo, ita quod eorum perfectiones ascribantur Christo sicut cause efficienti et exemplari. Possunt sibi etiam ascribi tamquam capiti corporis mistici, et tunc per membra Christi hic posita possunt significari diversi electi, qui sunt mistica membra Christi, puta per oculos contemplativi, per pedes activi, per os autem seu per vocem doctores et iudices seu correctores.
La decima perfezione consiste nell’incomprensibile gloria che deriva a Cristo dalla chiarezza e dalla virtù, per cui si dice: “e la sua faccia riluce come il sole in tutta la sua virtù” (Ap 1, 16). Il sole riluce in tutta la sua virtù nel mezzogiorno, quando l’aere è sereno, fugata ogni nebbia o vapore grosso. Allora il viso corporeo di Cristo ha incomparabilmente più luce e vigore, e ciò designa l’ineffabile chiarezza e virtù della sua divinità e della sua mente. Lo splendore del volto indica l’aperta e fulgida conoscenza della Sacra Scrittura, che deve raggiare in modo più chiaro nel sesto stato, prefigurata dalla trasfigurazione sul monte avvenuta dopo sei giorni e designata dall’angelo che, al suono della sesta tromba, ha la faccia come il sole (cfr. Ap 10, 1).
L’undecima perfezione sta nell’imprimere negli inferiori, di fronte a tante sublimità, un sentimento di umiliazione, di tremore e di adorazione, per cui si dice: “e vedendolo”, cioè tanto e tale, “caddi ai suoi piedi come morto” (Ap 1, 17). Il cadere (è da intendere che Giovanni cadde col viso a terra in atto di adorazione, perché il cadere supino è segno di disperazione) è causato sia dall’intollerabile eccesso dell’oggetto visto, sia dall’influsso dell’angelo o dell’assistente divino che incute terrore e provoca un sentimento di mutazione, sia dalla materiale fragilità del soggetto o dell’organo visivo. Proprio il senso di intimo mutare rende colui che vede esperto del fatto che si tratta di una visione ardua, divina e derivata da cause supreme. Sentirsi annullato predispone a ricevere le visioni divine in modo più umile e timorato, e significa che la virtù e la perfezione dei santi provoca tremore e umiliazione negli inferiori. Significa anche che l’ascesa alla contemplazione divina avviene unicamente tramite l’oblio, la negazione, la mortificazione di sé stessi e la privazione di ogni cosa.
I signacula di questa esegesi del volto di Cristo che irradia, nel sesto stato, più luce e più rivelazione della Scrittura, percorrono tutta la terza cantica a partire dal principio, con la gloria della divina virtù che risplende, con l’essere il poeta disceso dal “ciel che più de la sua luce prende” (Par. I, 1-2, 4, 22). Lo splendor faciei di Cristo, che si incarna nel sorriso di Beatrice, discorre per tutto il Paradiso, con variazioni della rosa semantica che lo costella: l’essere più lucente, la troppa luce, il mettere in oblio, l’intimo accorgersi di più ardua visione. All’esegesi di queste due perfezioni di Cristo sommo pastore rimandano le parole incastonate nei versi come pietre miliari, a ricordare una dottrina poeticamente rivestita. Le variazioni, compiutamente mostrate e spiegate in altra sede, non sono solo interne al ristretto passo esegetico (Ap 1, 16-17), ma coinvolgono altri luoghi della Lectura. Un lettore ‘spirituale’, di fronte al ridere di Beatrice, avrebbe senz’altro rammentato l’esegesi del volto solare di Cristo. Non nel senso di una reale identificazione, ma della conformità che nasce dal seguirlo.
■ Beatrice, nell’attesa che le schiere del trionfo di Cristo discendano dall’Empireo al Cielo stellato, “stava eretta / e attenta, rivolta inver’ la plaga / sotto la quale il sol mostra men fretta” (Par. XXIII, 10-12), cioè verso mezzoggiorno quando, secondo l’esegesi di Ap 1, 16, il volto di Cristo si mostra, come il sole, di più luminoso splendore in tutta la sua virtù e chiarezza. È un sole che accende “migliaia di lucerne”, “quale ne’ plenilunïi sereni / Trivïa ride tra le ninfe etterne / che dipingon lo ciel per tutti i seni” (vv. 25-30). La luna che ride e accende le stelle appare con lo stesso splendore del sole-Cristo che illumina i beati; la similitudine raffigura il passo di Isaia 30, 26 “Erit lux lune sicut lux solis”, incipit della Lectura super Apocalipsim.
All’arrivo delle schiere, Beatrice dice a Dante di guardarla – “Apri li occhi e riguarda qual son io” -, perché egli ha veduto tali cose – “la lucente sustanza tanto chiara / nel viso mio, che non la sostenea”, cioè Cristo, che “è virtù da cui nulla si ripara” – che hanno reso la sua facoltà visiva disposta a sostenere il proprio sorriso (Par. XXIII, 31-36, 46-48). Il poeta è “come quei che si risente / di visïone oblita e che s’ingegna / indarno di ridurlasi a la mente” (vv. 49-51), deve rinunciare a cantare “il santo riso” (il sacro poema lo ‘salta’ nel descrivere il paradiso) perché il suo è omero mortale che si fa carico del “ponderoso tema”, e chi questo pensasse “nol biasmerebbe se sott’ esso trema” (vv. 55-69). Nei versi si ritrovano motivi da Ap 1, 16-17: la “claritas” e la “virtus” di Cristo, sole che accende migliaia di lucerne, cioè di anime luminose; l’ “aperta et superfulgida notitia scripture sacre” raggiante nel sesto stato della Chiesa, che corrisponde all’invito di Beatrice al poeta di aprire gli occhi; lo “splendor faciei”, che è lo stesso sorriso della donna, come nella similitudine di Trivia; la fragilità dell’organo visivo; l’ “oblivio sui”, sperimentato da Dante alle parole di Beatrice che lo richiamano dalla visione di Cristo che lo aveva fatto uscir di mente; la “tremefactio intuentium”, per cui il poeta trema nel tentativo, cui dice di rinunciare, di cantare l’aspetto della sua donna; l’arditezza della visione, che si traspone nell’ “ardita prora” del poema sacro.
La “lucente sustanza”, che “per la viva luce trasparea” (Par. XXIII, 31-32), deriva da Ap 22, 1, dall’esegesi del fiume che scorre nel mezzo della Gerusalemme celeste, il quale indica la sostanza della grazia e della gloria della somma Trinità che viene comunicata a tutti i beati e che procede ed è dispensata dal Cristo uomo e fa trasparire nelle sue acque vive, come in un cristallo solido e perspicuo, la luce della somma sapienza.
Fanno da contrappunto ad Ap 1, 16-17 anche le proprietà di almeno quattro delle dodici tribù d’Israele da cui proverranno i segnati all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 6-8; qui Olivi segue l’interpretazione delle dodici porte dei quattro lati della Gerusalemme celeste data da Bonaventura nelle Collationes in Hexaëmeron, XXIII, 15-31 a proposito dell’anima gerarchizzata nella contemplazione), quasi a voler significare una graduale ascesa alla perfezione “ad perfectum … nexum amoris”: la quarta tribù, Aser (“amor ad superna elavatus”): beatus, pinguis → Bëatrice, più pingue; la quinta, Neptalim (“amor ad fraterna dilatatus”: la virtù per cui ci si dilata all’eterno da ciò che è temporale, cosicché questo sia specchio dell’altro): se … dilatat → per dilatarsi; la sesta, Manasse (“amor inferiorum oblitus”: una volta passati all’intellettuale dal sensibile, sopravviene l’oblio di questo come una liberazione da veli tenebrosi): oblitus → oblita (hapax nella Commedia). Si aggiunge anche Isachar, la nona tribù rappresentante l’assiduo e fervido sospirare verso la ricompensa dell’eterna gloria che per essa si sottopone a ogni servizio di Dio e dei suoi: omni servituti Dei et suorum se subiciens … subposuit humerum suum ad portandum → in che gravi labor li sono aggrati … e l’omero mortal che se ne carca.
■ La stessa materia offerta da Ap 1, 16-17 e da Ap 22, 1, appropriata nell’ottavo cielo a Cristo e al riso di Beatrice, è stata già utilizzata, nell’Eden, per lo svelamento della donna “ne l’aere aperto” e, ancor prima, per descrivere il riflettersi del grifone-Cristo nei suoi occhi (Purg. XXXI, 121-126, 139-145). Nell’Eden, che sta in terra, Beatrice è “luce ” e “gloria de la gente umana” (Purg. XXXIII, 115), prerogative del sommo pastore nella sua decima perfezione.
Matelda, che viene prima di Beatrice, splende ridendo con gli occhi assai più di quanto capitò a Venere trafitta per errore dal figlio Cupido (Purg. XXVIII, 64-67): anche la “bella donna” si fregia dello “splendor faciei” di Cristo (Ap 1, 16).
■ I temi da Ap 1, 16-17 fasciano ancora il senso di annullamento e di oblio provato da Dante, sulla soglia dell’Empireo, di fronte alla bellezza di Beatrice, alla quale egli è tornato con gli occhi dopo l’estinguersi alla sua vista del trionfo dei cori angelici attorno al punto luminoso “che mi vinse”. Il solo ricordo “del dolce riso” – il ridere rende lo “spendor faciei” di Ap 1, 16 – annulla le facoltà della sua mente: “ché, come sole in viso che più trema, / così lo rimembrar del dolce riso / la mente mia da me medesmo scema” (Par. XXX, 25-27). L’espressione “come sole in viso che più trema” cuce i temi della decima perfezione di Cristo (“sicut sol”) e dell’undecima (la “tremefactio intuentium”), con il “più” trasferito dalla luce dell’una al render tremanti dell’altra. È da notare il riferimento all’ora sesta, cioè meridana, che “ferve” (vv. 1-2) e al trasmodare della bellezza della donna (vv. 19-21, “si trasmoda” è hapax nel poema), che corrispondono al sesto stato e alla trasfigurazione avvenuta dopo sei giorni. Il poeta si dichiara vinto: “Da questo passo vinto mi concedo / più che già mai da punto di suo tema / soprato fosse comico o tragedo” (vv. 22-24).
L’esame compiuto di questa esegesi è stato condotto altrove.
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
||
Par. XXIII, 10-12, 25-72 (cfr. incipit)così la donna mïa stava eretta
|
Par. XXX, 1-2, 10-15, 19-21, 25-27Forse semilia miglia di lontano
|
|
Purg. XXVIII, 64-69, 76-78, 94-96, 145-147Non credo che splendesse tanto lume
|
[IX-Isachar] Nono exigitur assidua et fervens suspiratio ad mercedem eterne glorie omni servituti Dei et suorum se subiciens pro illa, et hanc designat Isachar, qui interpretatur merces, de quo dicit Iacob: “Isachar asinus fortis; vidit requiem quod esset bona, et terram quod optima, et subposuit humerum suum ad portandum”, scilicet omne honus propter illam, “factusque est tributis serviens” (Gn 49, 14-15).
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. V, 94-105, 130-137Quivi la donna mia vid’ io sì lieta,
|
Par. X, 58-69come a quelle parole mi fec’ io;
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. XV, 70-72Io mi volsi a Beatrice, e quella udio
|
Purg. XXI, 109-114; XXII, 25-27Io pur sorrisi come l’uom ch’ammicca;
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 13-14 (radix Ie visionis)] Tertia (perfectio summo pastori condecens) est sacerdotalis et pontificalis ordinis et integre castitatis et honestatis sanctitudo, unde subdit: “vestitum podere” (Ap 1, 13). Poderis enim erat vestis sacerdotalis et linea pertingens usque ad pedes, propter quod dicta est poderis, id est pedalis: pos enim grece, id est pes latine. Poderis enim, secundum aliquos, erat tunica iacinctina pertingens usque ad pedes, in cuius fimbriis erant tintinabula aurea, et de hac videtur dici illud Sapientie XVI[II]° (Sap 18, 24): “In veste poderis, quam habebat, totus erat orbis terrarum, et parentum magnalia in quattuor ordinibus lapidum erant sculpta”. […]
|
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. XIII, 13-24aver fatto di sé due segni in cielo,
|
Par. XIII, 73-78, 115-123Se fosse a punto la cera dedutta
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 2 (IVa visio, VIum prelium)] Quarto erat suavissima et iocundissima et artificiose et proportionaliter modulata, unde subdit: “et vocem, quam audivi, sicut citharedorum citharizantium cum citharis suis”. Secundum Ioachim, vacuitas cithare significat voluntariam paupertatem. Sicut enim vas musicum non bene resonat nisi sit concavum, sic nec laus bene coram Deo resonat nisi a mente humili et a terrenis evacuata procedat.
|
|
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 17 (Va visio, VIIa phiala)] Secundum autem Ioachim, septima phiala effunditur super “aerem”, id est super electos, ut si que eis macule adheserunt de communione Babilonis, purgentur et dealbentur super nivem, et in percussione septima cessat plaga Domini a populo Dei. Et subdit: «In aere ergo spiritalis ecclesia designatur, que nichil iam sapiet terrenum atque carnale, sed sublimata a terra, munditia et sanctitate angelice vite appropinquabit. Tuncque “de templo”, id est de utroque testamento, et de “trono” Dei, id est de ecclesia, egredietur “vox magna”, id est manifesta intelligentia que docebit omnia esse consumata, nichilque superesse de reliquo nisi quod unusquisque propriam mercedem accipiat secundum suum laborem». Hec Ioachim*.
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).Par. XXVIII, 79-87Come rimane splendido e sereno
|
Purg. I, 13-18, 22-24Dolce color d’orïental zaffiro,
|
Par. V, 100; XIII, 4-6; XV, 13, 23-24; XXIII, 25-27Come ’n peschiera ch’è tranquilla e puraquindici stelle che ’n diverse plage
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. XXV, 25-33Ma poi che ’l gratular si fu assolto,
|
Par. XXVI, 25-30E io: “Per filosofici argomenti
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 16 (VIIa visio)] “Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum.
|
|
Par. XXIII, 103-111“Io sono amore angelico, che giro cfr. 5, 8
|
Par. XXVI, 10-12perché la donna che per questa dia
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Purg. XXXI, 139-145O isplendor di viva luce etterna,
|
Par. XXIII, 25-36Quale ne’ plenilunïi sereni
|
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 1 (VIIa visio)] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit*. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum.* In Ap VII, vii (PL 196, col. 875 C). |
|
Ap 8, 8-9
All’esegesi di Ap 8, 8-9 (terza visione, seconda tromba) fanno riferimento numerosi luoghi del poema. Il tema principale sono i Gentili dal cuore tempestoso come il mare e bellicoso. Fra i tanti luoghi interessati, da segnalare la presenza dei motivi (in particolare dei verbi ‘portare’ e ‘leggere’) nell’episodio di Paolo e Francesca (Inf. V).
Questa pagina esegetica viene compiutamente esaminata altrove.
[LSA, cap. V, Ap 5, 1] Prima (causa) est quia septem sunt defectus in nobis claudentes nobis intelligentiam huius libri. Secundus est sensualis et corporalis vite nimius amor, eiusque nimia brutalitas et impetuositas. (…) In secunda vero fervor fidei, usque ad martiriorum perpessionem, brutalem vitam gentilium et amorem ipsius extinxit.[LSA, cap. XI (IIa tuba moraliter exposita)] Quia vero amor sui parit anxios fluctus curarum et sollicitudinum, ideo contra earum excessum, quasi contra mare tempestuosum, fit secundum tubicinium, et [tertia] pars ei rebellis maiori pondere sollicitudinum aggravatur et maiori ardore ignescit.[Ap 8, 8-9; IIIa visio, IIa tuba] […] “et tamquam mons magnus igne ardens missus est in mare” (Ap 8, 8). Mons iste est diabolus, qui a gentilibus in idolis colebatur ut Deus, qui dicitur “mons magnus” tum propter magnum superbie sue tumorem, tum propter magnitudinem sue naturalis potentie, qui contra sanctos doctores, contra eius cultum et idolatriam predicantes et ipsam pro posse a toto orbe expellentes, exarsit igne ire et invidie contra ipsos, et per effectum impie suggestionis et successionis “missus est in mare”, id est in fluctuosis cordibus gentilium, quorum multitudo erat quasi mare magnum et inter quos non erat habitatio fidelium simplicium, quasi pecora et iumenta, et multo minus perfectorum et discretorum, qui sunt quasi homines. Per “mare” enim sepe in hoc libro designatur gentilitas, quia fuit erroribus fluctuans et bellis ac seditionibus procellosa et moribus carnalibus et idolatriis turpibus salsa et amara et malitiis profunda et voraginosa et multitudine plebium quasi infinita. Quid autem mali fecerit ostenditur cum subditur: “Et facta est tertia pars maris sanguis”, id est illa pars gentilium, que noluit in Christum credere, facta est persecutrix et interfectrix fidelium et effundens sanguinem eorum.
|
|
Inf. V, 28-30, 76-81, 100, 107Io venni in loco d’ogne luce muto,
|
Purg. II, 10-12, 106-114Noi eravam lunghesso mare ancora,
|
[Ap 8, 8-9; IIIa visio, IIa tuba] […] “et tamquam mons magnus igne ardens missus est in mare” (Ap 8, 8). Mons iste est diabolus, qui a gentilibus in idolis colebatur ut Deus, qui dicitur “mons magnus” tum propter magnum superbie sue tumorem, tum propter magnitudinem sue naturalis potentie, qui contra sanctos doctores, contra eius cultum et idolatriam predicantes et ipsam pro posse a toto orbe expellentes, exarsit igne ire et invidie contra ipsos, et per effectum impie suggestionis et successionis “missus est in mare”, id est in fluctuosis cordibus gentilium, quorum multitudo erat quasi mare magnum et inter quos non erat habitatio fidelium simplicium, quasi pecora et iumenta, et multo minus perfectorum et discretorum, qui sunt quasi homines. Per “mare” enim sepe in hoc libro designatur gentilitas, quia fuit erroribus fluctuans et bellis ac seditionibus procellosa et moribus carnalibus et idolatriis turpibus salsa et amara et malitiis profunda et voraginosa et multitudine plebium quasi infinita. Quid autem mali fecerit ostenditur cum subditur: “Et facta est tertia pars maris sanguis”, id est illa pars gentilium, que noluit in Christum credere, facta est persecutrix et interfectrix fidelium et effundens sanguinem eorum.
|
|
Inf. V, 40, 49, 58, 61-62, 84, 88, 108, 127-138E come li stornei ne portan l’aliombre portate da la detta brigaEll’ è Semiramìs, di cui si leggeL’altra è colei che s’ancise amorosa,
|
Inf. XIII, 62, 73-75fede portai al glorïoso offizioPer le nove radici d’esto legno
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] In scripturis tamen sepe angulus sumitur pro fortitudine et ornatu, quia in angulis domorum, in quibus parietes coniunguntur, est fortitudo domus. Unde Christus dicitur esse factus in caput anguli et lapis angularis; et Iob I° dicitur “ventus” [concussisse] “quattuor angulos domus” ut dirueret ipsam domum (Jb 1, 19), et Zacharie X°, ubi agitur de futura fortitudine et victoria regni Iude, dicitur quod “ex ipso” erit “angulus et paxillus et archus prelii” (Zc 10, 4), id est robusti duces qui erunt aliorum sustentatores sicut angulus et paxillus; et Sophonie I° dicitur quod “dies ire” erit “super civitates munitas et super angulos excelsos” (Sph 1, 15-16), et capitulo III° dicitur: “Disperdidi gentes et dissipati sunt anguli earum” (Sph 3, 6), id est robusti duces earum; et Io Regum XIIII° dixit Saul: “Applicate huc universos angulos populi” et cetera (1 Rg 14, 38). |
|
Prologus, Notabile X
L’agone del dubbio, ovvero il moderno martirio
I martiri del sesto stato soffrono nel dubbio, il loro è un “certamen dubitationis” che i primi testimoni della fede non provarono per l’evidenza dell’errore in cui incorrevano gli idolatri pagani. Nel sesto stato il martire non prova soltanto il tormento del corpo, viene anche spinto (“propulsabuntur martires”) dalla sottigliezza degli argomenti filosofici, dalle distorte testimonianze scritturali, dall’ipocrita simulazione di santità, dalla falsa immagine dell’autorità divina o papale, in quanto falsi pontefici insorgono, come Anna e Caifa insorsero contro Cristo. Per rendere più intenso il martirio, i carnefici stessi operano miracoli. Tutto ciò appartiene alla tribolazione del tempo dell’Anticristo, alla tentazione che induce in errore persino gli eletti, come testimoniato da Cristo nella grande pagina escatologica di Matteo 24: “dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi (cfr. Mt 24, 24)”. Scrive Gregorio Magno, commentando Giobbe 40, 12 – “stringe (nel senso di tendere) la sua coda come un cedro” -: “ora i nostri fedeli fanno miracoli nel patire perversioni, allora i seguaci di Behemot faranno miracoli anche nell’infliggerle. Pensiamo perciò quale sarà la tentazione della mente umana allorché il pio martire sottoporrà il corpo ai tormenti mentre davanti ai suoi occhi il carnefice opererà miracoli”.
Del tema del martirio inferto dal dubbio è pregno, in Inf. V, l’episodio di Francesca e Paolo, d’altronde principalmente ordito su temi del secondo stato, all’esegesi dei quali rinvia. I “dubbiosi disiri” vengono conosciuti mentre i due amanti leggono “di Lancialotto come amor lo strinse”, quella lettura “per più fïate li occhi ci sospinse”. Vinti dalla passione, essi non arrivano a sostenere fino in fondo il loro “certamen dubitationis”. Se è vero che al secondo e al sesto stato spetta il martirio e al tempo stesso la dolcezza del conforto e della promessa (ad Ap 3, 11), i “dolci sospiri” dei due amanti sono stati da loro male interpretati, nel senso dell’amore carnale e non dell’“amore acceso di virtù” di cui Virgilio avrebbe parlato a Dante nel purgatorio (cfr. Purg. XVIII, 13-75; XXII, 10-12). Al momento della prova, i due vengono sospinti dalla lettura di un libro (“Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse”) verso un punto che li vince, non diversamente da come i nuovi martiri vengono sospinti dagli “intorta testimonia scripturarum”. Ma il martirio non è stato inferto solo ai “due cognati” in vita, perché anche Dante sta dinanzi alle loro anime come un martire del sesto stato: prova pietà del loro male perverso, è tristo e pio fino alle lacrime dinanzi ai martìri, prova un’angoscia che chiude la mente. Perfino la domanda di Virgilio dopo le prime parole di Francesca – “Che pense?” – sembra ricalcare l’invito di Gregorio Magno a riflettere sulla singolarità della tentazione: “… tunc autem Behemot huius satellites, etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit humane mentis illa temptatio, quando pius martir corpus tormentis subicit, et tamen ante eius oculos miracula tortor facit”. Il passo del Notabile X del prologo della Lectura super Apocalipsim tocca molti altri punti del poema.
Lo stesso passo dei Moralia di Gregorio Magno su Giobbe 40, 12, citato nel Notabile X del prologo della Lectura super Apocalipsim, era già stato utilizzato dall’Olivi nell’Expositio in Canticum Canticorum (sicuramente precedente, poiché la Lectura venne completata nel 1298, anno della morte). La sposa dice allo sposo: “ti darò una coppa di vino aromatico, e il succo del mio melograno” (Cn 8, 2). Anche in questo caso Olivi fa riferimento alla tribolazione del tempo dell’Anticristo, alla tentazione che induce in errore gli eletti, allorché il pio martire è scosso nel profondo della mente dalle cose mirabili (ma erronee) che vede dinanzi ai propri occhi. In quei tempi la sposa (la Chiesa) offrirà a Cristo non solo il “dulcor contemplationis”, ma anche l’“expressum mustum difficillimorum et acerbissimorum martyriorum”. Come scritto in Matteo 24, 21-24, «tunc enim teste Christo “erit tanta tribulatio, ut si fieri potest, in errorem inducantur electi”». L’Olivi fu lettore in teologia nello “studium” di Santa Croce di Firenze fra il 1287 e il 1289, inviato dal nuovo Ministro generale Matteo d’Acquasparta, eletto nel capitolo generale di Montpellier il 25 maggio 1287. Due anni, dunque, prima del richiamo a Montpellier, che portarono a Firenze molte sue opere esegetiche. Una di queste opere, il commento al Libro delle Lamentazioni di Geremia, fu probabilmente scritta a Santa Croce. È nota la parafrasi di Lamentationes I, 12 nel sonetto O voi che per la via d’Amor passate (Vita Nova 2.14-17).
Come vari luoghi del poema rinviano alla citazione di Gregorio Magno incastonata nell’esegesi della Lectura super Apocalipsim, così sull’Expositio in Canticum Canticorum è tessuta la Donna Gentile o Pietosa della Vita Nova, l’antagonista di Beatrice. L’esame, qui solo superficialmente avviato, è sicuramente da approfondire, ma un occhio esperto potrà vedere come non sia temerario affrontare Cn 8, 2 con Vita Nova 24-28 [XXXV-XXXIX]. Potrà facilmente ritrovare la tribolazione del martire pietoso degli ultimi tempi, che ha dinanzi a sé una mirabile ma falsa immagine di vero che lo scuote, nel poeta pensoso e travagliato nella “battaglia de’ pensieri”, che ha dinanzi agli occhi e alla mente un viso di donna preso come mai “così mirabilmente” da “color d’amore e di pietà sembianti”, dalla cui vista “era sommosso”. La donna, “quella pietosa / che si turbava de’ nostri martiri”, è in realtà un subdolo martirio, passionato “adversario della Ragione … desiderio malvagio e vana tentatione” contro il quale si leva l’immagine di Beatrice: “Si direbbe – scrive Guglielmo Gorni – che la Donna Pietosa, in questo suo agire così affabile che risulta essere, alla riprova, un modo caricaturale d’imitazione della donna ideale, sia una vera e propria figura di Anticristo, sinistramente perversa nella sua colpevole indulgenza” [1]. A questa vera affermazione l’Olivi consente di togliere il condizionale. Anche qui, come nel poema, non c’è calco o riscrittura, ma metamorfosi di elementi semantici. L’essere pietoso, che nell’esegesi è proprio del martire, è proiettato sulla donna-carnefice. Nella vicenda della Gentile, il conflitto tra le due antagoniste è solo nella mente di Dante, come nel martirio interiore descritto dall’Olivi, di quelli che sono scossi “ab ipso cogitationis fundo”.
Il confronto fra la Vita Nova e il commento al Cantico dei Cantici di Olivi non si esaurisce con la citazione dai Moralia di Gregorio Magno. L’influenza dell’esegesi oliviana sulle “nove rime” dantesche è esteso e profondo, come viene altrove mostrato.
[1] Cfr. Dante Alighieri, Vita Nova, a cura di G. GORNI, Torino 1996, p. 273.
Vita Nova 25 [XXXVI]Avenne poi che là ovunque questa donna mi vedea, si facea d’una vista pietosa e d’un colore palido quasi come d’amore; onde molte fiate mi ricordava della mia nobilissima donna, che di simile colore si mostrava tuttavia. [2] E certo molte volte non potendo lagrimare né disfogare la mia tristitia, io andava per vedere questa pietosa donna, la quale parea che tirasse le lagrime fuori delli miei occhi per la sua vista. [3] E però mi venne volontà di dire anche parole parlando a.llei, e dissi questo sonetto, lo quale comincia Colore d’amore; ed è piano sanza dividerlo, per la sua precedente ragione.[4-5]Color d’amore e di pietà sembianti
|
Cn 8, 2, pp. 302, 304[326] “Ibi me docebis” doctrina scilicet altiori et experimentaliori, “et dabo tibi poculum ex vino condito” scilicet aromaticis speciebus, “et mustum malogranatorum meorum” (2cd). Nota quod usquemodo non fecit mentionem de “vino condito” nec de “musto malogranatorum”, sed solum de vino simplici et de arboribus ac fructibus et germinibus malorum punicorum. Dulcor enim contemplationis et expressum “mustum” difficillimorum et acer-bissimorum martyriorum circa tempus conversionis Iudaeorum et circa tempus Antichristi debent Christo ab ecclesia singularius ministrari. Tunc enim teste Christo “erit tanta tribulatio, ut si fieri potest, in errorem inducantur electi” (cfr. Mt 24, 21-24). Et Gregorius Moralium trigesimo secundo super illud Iob: “Stringit caudam suam quasi cedrum” (Iob 40, 12) praemittens quod per caudam illam Antichristus significetur, subdit causam, quare tribulatio elec-torum sub eo erit maior quam praecedens dicens: «Nunc enim fideles nostri mira faciunt, cum perversa patiuntur, tunc autem Behemoth huius satellites etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo quae erit humanae mentis illa tentatio: pius martyr et corpus tormentis subiicit et tamen ante eius oculos miracula tortor facit. Cuius tunc virtus non ab ipso cogitationum fundo quatiatur, quando is qui flagris cruciat, signis coruscat?» Haec Gregorius. Item Moralium trigesimo quinto super illud Iob ultimo: “Addidit Dominus omnia quaecumque fuerant Iob, duplicia” (Iob 42, 10) dicit: «Sancta quippe ecclesia etsi multos nunc percussione tentationis amittit, in fine tamen huius saeculi ea quae sua sunt, duplicia recipiet, quando susceptis ad plenum gentibus ad eius fidem currere omnis quae tunc inventa fuerit, etiam Iudaea consentit. Hinc namque in evangelio veritas dicit: “Elias veniet et ille restituet omnia”» (Mt 17, 11).Vita Nova 26 [XXXVII][6-8]«L’amaro lagrimar che voi faceste,
|
Incipit Vita Nova
Dante aveva a disposizione i testi della grande tradizione di interpretazione spirituale del Cantico dei Cantici avviata con Origene: da Bernardo di Clairvaux ai Vittorini – Ugo, Riccardo e Tommaso Gallo. Tradizione nella quale Olivi si inserisce per sua esplicita ammissione. Ma se il passo di Gregorio Magno, sopra esaminato, sulle tentazioni finali dell’Anticristo è peculiare dell’Olivi (in un’opera dove, in modo inconsueto, il frate non utilizza in modo sistematico le categorie dei sette stati della Chiesa), e se su di esso Dante ha tessuto la trama della Donna Gentile (o Pietosa) della Vita Nova, come poi, ritrovatolo nella Lectura super Apocalipsim, vi avrebbe tessuta la ‘gentile’ Francesca, allora non è inverosimile che l’intero commento oliviano al Cantico dei Cantici abbia svolto un ruolo traente e di apporto dei temi di quella tradizione. In modo non dissimile, come dimostra il confronto tra i testi, la Lectura super Apocalipsim è stata filtro per il poeta di non pochi autori, primi fra tutti Riccardo di San Vittore e Gioacchino da Fiore. Di conseguenza, acquistano significato confronti come quelli qui proposti.
Fin dal principio, la Vita Nova è pregna di elementi semantici che recano al “libello” temi salomonici. Per un esame compiuto cfr. altrove.
PETRI IOHANNIS OLIVI Expositio in Canticum Canticorum [ = Cn], ed. J. Schlageter, Ad Claras Aquas Grottaferrata 1999 (Collectio Oliviana, II) [le citazioni scritturali, anziché in corsivo, sono state poste fra “ ”] |
|
Cn, prologus, pp. 92, 94[1] In speculo brevi et apto contueri volentibus continentiam Cantici Canticorum occurrit somnium praepositi pincernarum quod habetur Genesis quadragesimo, quando ait: “Videbam coram me vitem in qua erant tres propagines, crescere paulatim in gemmas, et post flores uvas maturescere, calicemque Pharaonis in manu mea: tuli ergo uvas, et expressi in calicem quem tenebam, et tradidi poculum Pharaoni” (Gn 40, 9-11).
|
Cn 2, 11-12, pp. 162, 164[112] Secundo nota quod ex vernalis temporis proprietate septem inducentia ad accessum sibi proponit (cfr. 11-13), et possunt mystice ad internas sponsae proprietates aptari. Quia sicut appropinquatio solis ad regionem nostram in vere praedictas proprietates adducit, sic et divinae visitationis solaris adventus consimiles in spiritum proprietates inducit ex quibus sponsa habet merito festinare et currere ad sponsi amplexum. Possunt etiam aptari ad exteriorem statum ecclesiae illius temporis, quia tunc proprie formatur haec sponsa. […] [113] In primis autem duobus proponitur impedimentorum retrahentium amotio. Algor enim hiemalis et procella pluvialis et utriusque horrenda obscuritas solet sponsas retrahere, ne foras domum propriam ire velint. Veris ergo temperies et serenitas de se grata, sed propter praeeuntem pressuram hiemis et propter suam novitatem gratiosior, sponsam debet inducere ad spatiandum cum sponso extra arctitudinem domicilii sui, et ideo dicit: “Iam enim hiems transiit” (11a) etc. Sicut enim sub primo tempore regni Salomonis tempestates et obscuritates priorum temporum a Synagoga recesserant, ut tunc quietius et iucundius sapientiae divinae vacaret, sic pro tempore Christi Apostolus clamat: “Nox praecessit, dies autem appropinquavit” (Rom 13, 12) et: “Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis” (II Cor 6, 2). Nam algor et tenebra caeremoniarum carnalium Synagogae et idolatriae gentium longe abscesserant ab ecclesia Christi. Et sic de similibus temporibus consimilia intuere.
|
Vita Nova 1.1-4, 8, 12-13 [I 1, II 1-3. 7, III 1-2]In quella parte del libro della mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova. Sotto la quale rubrica io trovo scripte le parole le quali è mio intendimento d’asemplare in questo libello, e se non tutte, almeno la loro sententia. [2] Nove fiate già apresso lo mio nascimento era tornato lo cielo della luce quasi a uno medesimo puncto quanto alla sua propria giratione, quando alli miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. [3] Ella era già in questa vita stata tanto, che nel suo tempo lo Cielo Stellato era mosso verso la parte d’oriente delle dodici parti l’una d’un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, e io la vidi quasi dalla fine del mio nono. [4] Apparve vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima etade si convenia. […]
|
|
Cn 1, 1, pp. 114, 116[11] Quid autem eam ad hoc alliciat, subdit: “Quia meliora sunt ubera tua vino” (1b), quasi dicat: praedictam tui unionem sic desidero, quia ineffabilis exuberantia suavitatum a te manat.
|
Cn 7, 12d-13b, p. 292[312] Deinde sponsa tria sponso promittit, scilicet lac suorum ‘uberum’ (12d) et odorem suarum ‘mandragorarum’ (13a) seu suas ‘mandragoras’ valde odoriferas et ‘omnia poma sua’ (13b). Pro primo dicit: “Ibi dabo tibi ubera mea” (12d) id est: ibi in filiis tuis lac ipsorum in te et tui in ipsis nutritivum libere propinabo. Tunc enim animarum rectores libenter salutarem doctrinam eis infundunt, quando ipsos debite proficere et Dei gratiam et providentiam eis abunde cooperari et assistere vident. Vel: “Ibi dabo tibi ubera mea” (12c), id est: tunc cum hoc videro totam dulcedinem cogitatuum et affectuum pectoris mei, in te prae gaudio et devotione cum gratiarum actione effundam. |