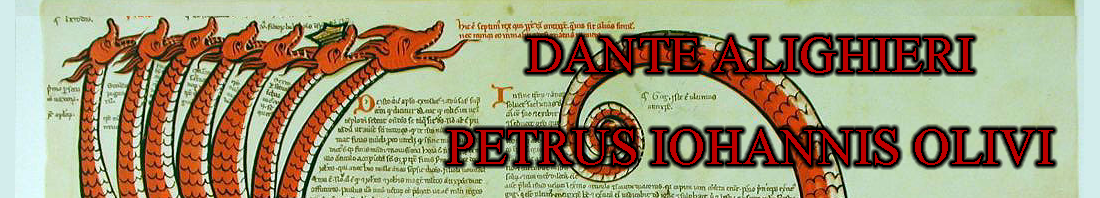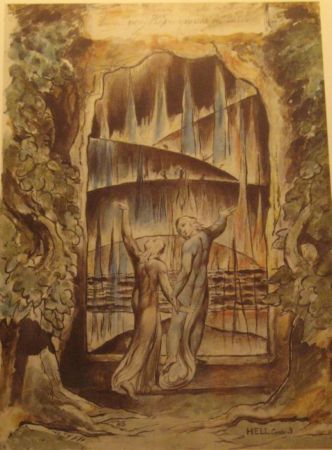INDICE GENERALE
INTRODUZIONE (III)
[3] = numero dei versi. 12, 1-2 = collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]. Not. VII = collegamento ipertestuale all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura.Qui di seguito viene esposto Paradiso XXXIII con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (PDF; introduzione in html). |
Paradiso XXXIII |
« Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 12, 1-2; qu. de angelicis influentiis
|
III
Il fine di tutti i desideri
III.1 Visione e martirio (tab. 28). III.2 L’apertura del libro segnato da sette sigilli (tab. 29-31). III.3 Ricordo cessato e linguaggio imperfetto (tab. 32-34). III.4 Il punto (tab. 35-36). III.5 La visione della sede divina (tab. 37-40). III.6 La vittoria dei contemplativi (tab. 41-43). III.7 La prima equalità (tab. 44). III.8 Il volto di Cristo sorridente (tab. 45-50). III.9 La misura del cerchio (tab. 51). III.10 L’amor che move il sole e l’altre stelle (tab. 52).
III.1 Visione e martirio (Tab. 28)
Nell’ultimo canto della Commedia è descritto lo stato d’animo del poeta tornato dalla visione di Dio, che si appresta a cantare nei versi. Dante prova ancora nel cuore il dolce della visione dimenticata, come dopo un sogno “la passione impressa rimane”, cioè, letteralmente, l’emozione, mentre il contenuto del sogno non ritorna alla memoria, venendo meno al modo con cui la neve si scioglie al sole o con cui al vento si perdevano i responsi della Sibilla scritti sulle foglie lievi (Par. XXXIII, 58-66). Il tema del rimanere, da Ap 12, 17, è appropriato a quel poco che rimane del sogno.
La quinta guerra viene condotta dal drago contro le rimanenze (le reliquie) del seme della donna (la Chiesa), rappresentate da coloro che custodiscono i precetti divini e danno testimonianza di Cristo (Ap 12, 17). Secondo Gioacchino da Fiore, il seme della donna è Cristo rapito in cielo con i suoi martiri, e questo è seme che precede; quello che rimane viene designato con l’evangelista Giovanni, cioè con i contemplativi propri del quarto stato. Olivi ritiene tuttavia che il testo sacro, nella quarta visione, dopo aver trattato le guerre sostenute in primo luogo da Cristo (Ap 12, 4-6), in secondo luogo dai martiri (Ap 12, 7-12) e in terzo e quarto luogo dalla Chiesa, prima dispersa e poi riunita da Costantino e dotata delle ali dei dottori e degli anacoreti per volare nel deserto dei Gentili e in quello della vita contemplativa (Ap 12, 13-16), si riferisca ora in parte ad eventi successivi allo stato degli anacoreti (il quarto), e precisamente a quanti di essi rimasero sopravvivendo alle distruzioni operate dai Saraceni e, comunque, alle reliquie lasciate al quinto stato. In entrambi i casi si parla di “reliquie” poiché, come in un vaso di vino purissimo rimangono, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e più pura, solo poche reliquie vicine alle impurità e quasi con esse mescolate, così della pienezza e purezza del vino dei dottori e degli anacoreti del terzo e del quarto stato prima rimasero solo le reliquie, al momento della devastazione saracena, poi, nel quinto stato, occupate molte chiese dai Saraceni e separatisi i Greci dalla fede romana, rimase solo la Chiesa latina come reliquia di un’istituzione che prima era diffusa in tutto l’orbe [1].
Da notare il forte contrasto, presente nella prosa, tra Cristo rapito al cielo (il seme che precede) e il suo seme che rimane: così “la passione impressa” che rimane dopo il sogno si contrappone alla “somma luce che tanto ti levi / da’ concetti mortali”, luce che di quel sogno-visione è stata oggetto (Par. XXXIII, 59-60, 67-68). Da confrontare il “ti levi” con il verso “quasi alimento che di mensa leve” (Purg. XXV, 39). Si tratta di due contesti diversi, ma che registrano motivi comuni come il rimanere di ciò che è puro (“la passione impressa” o il “sangue perfetto” che si fa seme nell’uomo), il levarsi, il distillare o gemere, e anche il patire.
La parole “che dopo ’l sogno la passione impressa / rimane” (Par. XXXIII, 59-60) non fanno riferimento solo a una generica emozione. La “passione” che Dante prova nella visione rinnova quella di Cristo. Ciò è dimostrato dalla presenza di altri temi che sono propri dello stato dei martiri (il secondo). Costoro, assimilati nella passione alla figura di Cristo, diedero testimonianza a lui e alla sua fede lasciando ai posteri un esempio di virtù per la sua maggior gloria (prologo, Notabile XII). Il “relinquere posteris”, proprio dei martiri, si intreccia con il rimanere delle poche reliquie pure del quinto stato (le quali, come i martiri, sono coloro che “testimonium perhibent de Christo”). Il poeta ‘soffre’ e ‘sostiene’ (due verbi appropriati ai martiri: vv. 76, 80) [2] l’acume del vivo raggio, e invoca la somma luce affinché offra di nuovo (‘ripresti’) alla sua memoria un barlume di quel che ha visto e affinché renda la sua lingua tanto possente da essere in grado, esprimendosi, di lasciare ai posteri anche solo una favilla della gloria divina. Così gli uomini meglio comprenderanno la “vittoria” di Dio, cioè il suo infinito valore, ma anche il suo trionfo sulla passione (Par. XXXIII, 67-75).
Una variazione di questi temi esegetici è già presente in fine di Inf. XIII. Altra, e in questo caso sinistra testimonianza lasciata ai posteri, è la statua di Marte rimasta a Firenze sul Ponte Vecchio: se non fosse per la sua presenza, afferma l’anonimo fiorentino suicida, il dio avrebbe già distrutto con la sua arte la città che mutò lui, primo padrone, nel Battista, e reso inutile il lavoro di coloro che, al tempo di Carlo Magno, la ricostruirono dopo che Attila (in realtà Totila) l’ebbe ridotta in cenere. Le parole del suicida sono in parte tessute coi motivi del secondo stato: il “rimane ancor di lui” è la testimonianza che rimane dei martiri (con cui Marte concorda non solo nel suono, ma per il comune combattere), e anche il “passo d’Arno”, che allude alla passione e alla tribolazione, rientra nella tematica. Come in Par. XXXIII, il tema del rimanere dalla quinta guerra (Ap 12, 17: “sovra ’l cener che d’Attila rimase”) si intreccia con il “relinquere” proprio dei martiri (prologo, Notabile XII: “rimane ancor di lui alcuna vista”). Da notare la presenza di un altro tema del quinto stato, il raccogliere le reliquie (prologo, Notabile V, dove l’essere raccolto e restituito è proprio della Chiesa di Roma da parte di Carlo Magno, lo stesso tempo della ricostruzione di Firenze) [3], appropriato alla raccolta e alla restituzione al cespuglio del suicida piangente delle sue fronde, disgiunte e lacerate dalle nere cagne correnti per la selva, fatta dal poeta stretto dalla “carità del natio loco” (Inf. XIII, 142; XIV, 1-3). Reliquie e martirio sono, in tutt’altra situazione, appropriati a Oloferne, scolpiti sul pavimento della cornice dei superbi purganti (Purg. XII, 58-60).
[1] La rosa tematica offerta dall’esegesi di Ap 12, 17 si presta a molteplici variazioni nel poema sacro.
[2] “E’ mi ricorda ch’io fui più ardito / per questo a sostener” (Par. XXXIII, 79-80). La variante a riguardar è da scartare; “sostener” richiama infatti “soffersi” al v. 76; si tratta di due verbi propri dei martiri.
[3] Cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare. …, 3. 2, tab. XXXIII. 2.
Tab. 28
III.2 L’apertura del libro segnato da sette sigilli (Tab. 29-31)
(Tab. 29; Par. XXXIII, 58-66, 73-75)
La Commedia, sul piano dei significati spirituali, è la metafora del libro segnato da sette sigilli, nuova Apocalisse scritta dal nuovo Giovanni inviato da Dio, come l’antico evangelista, a convertire l’orbe.
Ad Ap 5, 1 Olivi espone i vari significati del libro. Questo designa in primo luogo la prescienza divina e la predestinazione a riparare l’universo per opera di Cristo. Per appropriazione, è il Verbo stesso del Padre in quanto espressivo della sua sapienza e in quanto il Padre, nel generarlo, scrisse in esso tutta la sua sapienza.
In secondo luogo, il libro è la scienza delle intelligenze angeliche data ad esse da Dio e in esse scritta, che è scienza di tutta la grazia e la gloria degli eletti e del culto di Dio che deve compiersi per mezzo di Cristo. È pertanto, assai di più, la scienza universale scritta da Dio nell’anima di Cristo.
In terzo luogo, è il volume della Sacra Scrittura e in particolare dell’Antico Testamento, nel quale il Nuovo venne rinchiuso, sigillato e velato sotto varie figure.
Il libro sta nella destra di Dio (Ap 5, 1), sia perché è nel suo pieno potere e facoltà, sia perché contiene le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo, e le elargizioni e preparazioni che spettano alla destra, come le avversità e le cose temporali alla sinistra.
Sta nella destra di Colui che siede sul trono, sia perché contiene le leggi e i precetti del sommo imperatore e le sentenze e i giudizi del sommo giudice, sia perché la sua intelligenza richiede una mente alta, stabile, matura, quieta e raccolta, come è proprio dell’intelligenza divina.
È un libro scritto dentro e fuori, poiché il libro della Sacra Scrittura ha un senso letterale di fuori, mentre dentro contiene il senso anagogico, quello allegorico e quello morale. Di fuori il senso letterale narra le storie, le gesta e gli esempi dei santi e le loro opere esteriori; dentro sono le più profonde sentenze dei divini precetti e degli insegnamenti sapienziali.
Su questi vari significati recati dal “panno” esegetico sono cucite molte parti della “gonna”, e ciò è stato mostrato altrove.
Nel Notabile III del prologo Olivi si chiede perché la storia della Chiesa, che si sviluppa attraverso sette periodi, venga descritta nell’Apocalisse con altrettante visioni. Un primo motivo è per consentire che la magnificenza divina venga espressa con molteplici similitudini, cosicché più si concepisca di essa. Il secondo motivo è affinché si imprima meglio nella mente, come avvenne al faraone il cui sogno, interpretato da Giuseppe, si ripeté due volte in segno di conferma, data dalla parola di Dio, e di rapida esecuzione (Genesi 41, 32).
Dante, come il faraone, ha visto sognando (“Qual è colüi che sognando vede – Quod vidisti secundo sompnium”) ma difetta di un secondo sogno di conferma, perché impressa gli è rimasta solo “la passione”, il dolce ricordo che distilla nel cuore di una lotta sostenuta contro il raggio divino, “e l’altro a la mente non riede” (l’iscrizione nella mente e il tornare sono propri dei vittoriosi contemplativi: Ap 3, 12; la dolce impressione nel cuore, che è come gocce di pioggia, appartiene all’esegesi di Ap 14, 2: cfr. Par. XXV, 70-78).
“Quasi tutta cessa / mia visione”, afferma il poeta, come nell’ultimo periodo dell’Antico Testamento finirono le storie e le profezie (“cessaverunt ystorie et prophetie”: prologo, Notabile XII) e nella fase finale del Nuovo il transito all’estasi contemplativa sarà come sentirsi morire (“quasi totus moritur sibi ipsi”: Ap 20, 7-8). Come l’evangelista, Dante ricorre alle similitudini per dire l’indicibile; la loro ripetizione sarà di conferma di quanto visto sognando, per mezzo di esse “più si conceperà di tua vittoria” (“magnificentius … concipimus maiestatem”: prologo, Notabile III).
La prima delle due similitudini con le quali il poeta esprime il dissolversi della visione – “Così la neve al sol si disigilla” – fa riferimento alla “solutio sigillorum” del libro da parte di Cristo. La neve designa la sapienza di Cristo rigida, congelata, astratta, punitiva, che si scioglie temperandosi pietosamente nel caldo della lana, secondo l’interpretazione dei due aspetti dei capelli di Cristo sommo pastore ad Ap 1, 14. Un precedente sono le superbe parole di Beatrice la quale, apparsa nell’Eden, rimprovera l’amico il cui cuore si stringe – “sì come neve tra le vive travi / per lo dosso d’Italia si congela” -; poi, al canto temperato degli angeli, si scioglie facendosi “spirito e acqua” (Purg. XXX, 70-99).
La seconda similitudine – “così al vento ne le foglie levi / si perdea la sentenza di Sibilla” – accenna con immagine virgiliana al dissolversi di una sentenza, quella della Sibilla cumana scritta su foglie che il vento, penetrato nell’antro dalla porta, disperdeva. L’arcana profetessa è figura antica di una sentenza che si perde, quella per cui il libro della vita era chiuso da sette sigilli all’umana intelligenza prima che fosse pagato con la passione di Cristo il prezzo della colpa. Alle “foglie levi” agitate dal vento subentrano le foglie sacramentali del lignum vitae, l’albero che sta nel mezzo della Gerusalemme celeste, che ombreggiano entrambe le rive, la divina e l’umana, del fiume luminoso (Ap 22, 1-2; cfr. supra). Vento e leggerezza sono propri dell’adolescenza agitata dall’errore (prologo, Notabile III), un accostamento già presente in “quei due che ’nsieme vanno, / e paion sì al vento esser leggeri” (Inf. V, 74-75).
Così le due similitudini, che letteralmente descrivono il dileguarsi dalla mente della visione divina, indirizzano la memoria del lettore spirituale sull’apertura dei sigilli apposti al libro.
(Tab. 30)
Ad Ap 21, 22-23 è citato Gregorio Magno. Questi, commentando nei Moralia Giobbe 9, 9 – “Egli che crea Arturo e Orione e le Pleiadi” – insegna espressamente come verso la fine del mondo la luce solare della sapienza di Cristo si renda più manifesta: per i singoli giorni la scienza celeste si mostra più e più come un lume a noi interno, si apre il tempo primaverile, il nuovo sole sfavilla alle nostre menti e, reso a noi noto per il verbo dei dottori, riluce ogni giorno più chiaramente. All’appressarsi della fine del mondo la scienza superna avanza e col tempo cresce più larga (cfr. supra).
Terminata la preghiera di san Bernardo e indirizzatisi gli occhi della Vergine all’“etterno lume” [1], Dante porta a compimento in sé “l’ardor del desiderio” e si predispone alla visione (Par. XXXIII, 46-51). La vista del poeta “e più e più intrava per lo raggio / de l’alta luce che da sé è vera” (vv. 52-54), due versi che rinviano al passo gregoriano: “magis magisque scientia celestis ostenditur, quasi interni nobis luminis vernum tempus aperitur”. Entrare nella luce della sapienza divina e delle scritture per mezzo della contemplazione è inoltre proprio del sesto stato della Chiesa; a questa visione cooperano tutte le illuminazioni dei precedenti stati (Ap 3, 7): “oportet statum illius temporis elevari et intrare ad ipsa lumina suscipienda et contemplanda”.
La metafora del libro, che contiene al suo interno le più profonde sentenze divine e i documenti sapienziali, torna con la visione dell’unità del molteplice: “ciò che per l’universo si squaderna” – “sustanze e accidenti e lor costume”, che si mostrano in modo sparso e diviso -, “s’interna” nel profondo della luce eterna “legato con amore in un volume … quasi conflati insieme” (vv. 85-90). Dante vede “la forma universal di questo nodo”, che tiene unita in Dio la multiformità dell’universo, e crede che ciò sia vero “perché più di largo, / dicendo questo, mi sento ch’i’ godo” (vv. 91-93). Il tema dell’allargarsi della superna scienza, contenuto nel passo di Gregorio Magno, si congiunge con quello della larghezza della città celeste (Ap 21, 16; cfr. infra), che si dilata nel gaudio, dopo che il poeta, con il suo “ficcar lo viso per la luce etterna”, ne ha designato la lunghezza (vv. 82-84).
Il libro, definito ad Ap 5, 1 “volumen”, scritto dentro e fuori, che sarebbe incongruo affermare distinto per quaderni e carte, ha una forma immaginaria a guisa di rotolo, con sette pieghe, ciascuna delle quali chiusa da un sigillo. A ciascuna apertura, si presentavano a Giovanni le immagini da lui descritte dei cavalli e dei cavalieri, come se uscissero vive da dentro le pieghe (Ap 6, 1). Al libro, o piuttosto a un documento in forma di rotolo sigillato, fa riferimento il verbo dispieghi nella preghiera di san Bernardo alla Vergine (Par. XXXIII, v. 33; cfr. Purg. XXXIII, 116; Par. VII, 66): “Videtur etiam quod rotulus ille haberet in se septem plicas et super unaquaque erat sigillum unum impressum pro clausura ipsius”.
È da notare che alcuni elementi semantici presenti ad Ap 6, 1 (la forma immaginaria del libro, il suo essere scritto, la presenza di “pieghe” da cui le immagini si mostravano a Giovanni come se uscissero vive) si ritrovano in Par. XXIV, 25-27. Tra le anime discese dall’Empireo al cielo delle stelle fisse, che girano danzando, una si distacca dalle altre per volgersi attorno a Beatrice “con un canto tanto divo, / che la mia fantasia nol mi ridice”. Si tratta di san Pietro: la penna del poeta è incapace di descrivere quel canto, “ché l’imagine nostra a cotai pieghe, / non che ’l parlare, è troppo color vivo”. La variazione poetica è fra le più lontane dal tema originario. Si può tuttavia notare che, pur con i temi rovesciati nel significato e con diversa appropriazione, permane nei due testi il contrasto tra la forma immaginaria e la realtà viva, sensibile: come il libro era immaginario e non reale, e le immagini dei cavalli e dei cavalieri che uscivano dalle pieghe erano anch’esse immaginarie come se fossero vive, così l’“imagine nostra”, cioè la nostra fantasia (e conseguentemente il parlare, che ha limiti ancor più ristretti) è “troppo color vivo” (cioè troppo sensibile) rispetto “a cotai pieghe”, cioè a tali sfumature (che costituiscono la parte interna del libro, quella più spirituale). Fin dall’esegesi del primo capitolo, Olivi ha posto la questione del rapporto tra la visione intellettuale di Giovanni e le similitudini corporee, di cui necessita per essere compresa ed espressa: in questa vita non si verificano visioni dell’intelletto che non facciano uso di similitudini corporee. Non poter ridire il canto dei compagni dell’Agnello sul monte Sion è tema presente ad Ap 14, 3.
[1] Par. XXXIII, 43-45: “indi a l’etterno lume s’addrizzaro, / nel qual non si dee creder che s’invii / per creatura l’occhio tanto chiaro”. La variante s’inii non è del tutto da escludere. In primo luogo perché attestata ampiamente dalla tradizione. In secondo luogo perché le parole “occhio tanto chiaro” rinviano all’esegesi di Ap 15, 7-8, utilizzata anche in altri luoghi del poema come Par. VI, 86-87 e XIX, 139-141. Nell’esegesi si afferma che solo l’occhio purgato e reso chiaro entra nella contemplazione del divino. Inii non proverrebbe da un inesistente iniare (‘mettere dentro’, come inteso dal Buti) ma da inhiare, verbo tipico dello stato contemplativo del quale indica la brama, il desiderio (cfr. a Eneide VII, 812-814 la gioventù e la turba delle madri che contempla attonita la vergine Camilla). Ciò comporta che “l’occhio tanto chiaro” sia soggetto e non oggetto, nel senso: ‘non si deve credere che l’occhio tanto chiaro (come quello della Vergine) si indirizzi con desiderio da parte una creatura’.
quasi conflati insieme (Tab. 31)
La Scrittura è “pelago”, acqua che può smarrire. Così nell’appello al lettore di Par. II, 1-18: “O voi che siete in piccioletta barca … non vi mettete in pelago, ché forse, / perdendo me, rimarreste smarriti. / L’acqua ch’io prendo già mai non si corse”. Solo quei pochi che si sono volti per tempo “al pan de li angeli” possono seguire il suo “legno che cantando varca”. Il “pan de li angeli” è la “manna” del salmo 77, 23-25 citato da Olivi nel terzo dei Principia, a proposito della celestiale dolcezza della Scrittura. Rivolgendosi ai “voialtri pochi” con la metafora della barca che segna l’inizio di Par. II, il poeta prosegue: “metter potete ben per l’alto sale / vostro navigio, servando mio solco / dinanzi a l’acqua che ritorna equale. / Que’ glorïosi che passaro al Colco / non s’ammiraron come voi farete, / quando Iasón vider fatto bifolco” (vv. 13-18). Qui la metafora della navigazione è intrecciata con quella dell’agricoltura spirituale, tema che deriva dall’apertura del settimo e ultimo sigillo (Ap 8, 1).
“All’apertura del settimo sigillo si fece in cielo un grande silenzio”. Questo silenzio, che non sarà perfetto fino alla completa conversione del mondo a Cristo, durerà “mezz’ora”, espressione che sta a significare la brevità del settimo stato rispetto agli altri e che comunque l’apertura del settimo sigillo avverrà anche nel tempo di questa vita, nel suo momento finale e pacifico, non solo nello stato della gloria eterna. Allora si verificherà quanto profetizzato da Isaia: “Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; una gente non alzerà più la spada contro un’altra, non si eserciteranno più nella guerra […] Effetto della giustizia sarà la pace, la coltura della giustizia il silenzio” (Is 2, 4; 32, 17-18). Non solo cesseranno le guerre corporali, afferma Olivi, ma anche quelle spirituali dovute alle eresie, agli errori, agli scismi e ci si dedicherà all’agricoltura e alla mietitura spirituale piuttosto che ai litigi e alle dispute poiché le spade saranno anche vomeri spirituali, che solcano le menti, e le lance falci che mietono il grano spirituale. “Servando mio solco”, che è in rima con “bifolco”: la navigazione è anche agricoltura spirituale e pacifica (il poeta sta andando verso l’Empireo, il “ciel de la divina pace”), il solco tracciato nel pelago dalla nave del poeta è paragonato, con immagine ovidiana (Metam., VII, 100-130), al farsi bifolco del guerriero Giasone per conquistare il vello d’oro.
La visione, all’interno del “volume”, della molteplicità fusa in unità – “sustanze e accidenti e lor costume / quasi conflati insieme” (Par. XXXIII, 88-89) – evoca nel rarissimo latinismo conflati, che rinvia a Isaia 2, 4 – “Conflabunt gladios suos in vomeres” (l’immagine opposta, delle falci rifuse in spade, è deplorata da Virgilio nelle Georgiche I, 508: “curvae rigidum falces conflantur in ensem”) -, l’immagine di una pacifica unità nella luce divina. I discepoli di Cristo “de l’Evangelio fero scudo e lance” (Par. XXIX, 114).
“L’acqua … ritorna equale”. L’“equalitas” è la misura della Gerusalemme celeste, in cui lunghezza e larghezza si equivalgono (Ap 21, 16; cfr. infra). La misura della città è di 12.000 stadi. Lo stadio è lo spazio al cui termine si sosta o “si posa” per respirare e lungo il quale si corre per conseguire il premio. Esso designa il percorso del merito che ottiene il premio in modo trionfale, secondo quanto scrive san Paolo ai Corinzi: “Non sapete che tutti corrono nello stadio, ma di costoro uno solo prende il premio?” (1 Cor 9, 24). Ciò concorda con il fatto che lo stadio è l’ottava parte del miglio, e in questo senso designa l’ottavo giorno di resurrezione. L’ottava parte del miglio corrisponde a 125 passi, rappresentanti lo stato di perfezione apostolica che adempie i precetti del decalogo (12 apostoli x 10 comandamenti), cui si aggiunge la pienezza dei cinque sensi e delle cinque chiese patriarcali. L’arrivo al cielo della Luna è tanto veloce quanto il ‘posarsi’ di una freccia (“un quadrel”, per concordare con l’ambito tematico della città: «“Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum»), che vola dopo essersi staccata dalla balestra (Par. II, 23-25). Dal momento in cui inizia la descrizione dell’ascesa al cielo (con il 43° del primo canto del Paradiso), fino al congiungersi “con la prima stella” (che coincide con il 25° verso del secondo canto), sono esattamente 125 versi, come i passi dello stadio. La navigazione è dunque un correre al premio paolino (“L’acqua ch’io prendo già mai non si corse”), un solcare l’acqua (la Scrittura) verso Dio, “la prima equalità” (Par. XV, 74).
Gli angoli delle dodici porte della città (Ap 21, 12; tre per ciascuno dei quattro lati; l’esame compiuto è stato condotto altrove) designano la forza e l’ornato, perché nelle case le pareti si congiungono agli angoli. In tal senso si dice di Cristo che è pietra angolare, oppure in Zaccaria si afferma la futura forza del vittorioso regno di Giuda definendolo angolo, palo e arco, cioè capace di sostenere (Zc 10, 4). Il tema, tutto oliviano, degli angoli si annida dietro al “congiungersi”: l’arrivo al cielo della Luna è appunto una congiunzione (“giunto mi vidi … che n’ha congiunti con la prima stella”) che avviene velocemente, “forse in tanto in quanto un quadrel (“et civitas in quadro posita est”) posa (tema del posarsi o dello stadio, che è misura della città) / e vola e da la noce si dischiava …” (Par. II, 23-30).
Tab. 29
[LSA, cap. III, Ap 3, 12 (Ia visio, VIa victoria)] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et transformationem mentis in ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. […] Quantum autem ad hoc premium, nota quod quia intrans in Deum recipit intra se Deum, ita quod et Deus intrat in ipsum, ideo hunc duplicem intrandi respectum hic ponit. Primum enim ponit sub typo columpne intra templum existentis et inde non egressure; secundum vero sub typo scripture per quam nomen Dei et sue civitatis inscribitur menti. Et secundum hoc templum significat Deum, prout infra XX[I°] dicitur: “Dominus Deus templum illius est”, scilicet civitatis Dei (Ap 21, 22). […]
|
||
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 1-2 (IVa visio, VIum prelium)] Tertium est fidei et amoris et contemplationis Dei Patris et Filii humanati in istorum corde et ore singularis et patens inscriptio et expressio, unde subditur: “habentes nomen eius et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis”. Per “nomen” famosa notitia designatur, que respectu Dei non reputatur nisi sit amativa. Frons vero est suprema pars faciei omnibus patula, et ideo quod est scriptum in fronte omnibus se prima facie offert, ita quod potest statim ab omnibus legi. In fronte etiam signa audacie vel sui oppositi cognoscuntur. Est ergo sensus quod maiestas Dei trini et Filii humanati sic erat in cordibus istorum impressa et sic per apertam et constantem confessionem oris et operis expressa, quod ab omnibus poterat statim legi et discerni quod ipsi erant de familia Agni et singulares socii eius.
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 20 (Ia visio, VIIa ecclesia)] “Si quis audierit”, id est cordaliter seu obedienter receperit, “vocem meam”, scilicet monitionum mearum predictarum, “et aperuerit michi ianuam”, id est viscerales consensus et affectus cordis sui, “intrabo ad illum”, scilicet per influxus et illapsus gratie, “et cenabo cum illo”, scilicet acceptando et amative michi incorporando ipsum et omnia bona eius tamquam cibos michi amabiles et suaves, “et ipse mecum”, scilicet me et meam dulcedinem et bonitatem iocunde gustando et comedendo ac bibendo et incorporando. Nota quod non dicit: ‘prandebo’, sed “cenabo”, tum quia cena apud antiquos erat sollempnior quam prandium, tum quia in vespera et in fine huius seculi dabitur eterna gloria quasi cena, tum quia maior est refectio in finali consumatione perfectorum quam in initio con-versionis eorum, tum quia in fine legis veteris attulit Christus cenam nove legis et sue gratie, tum quia hec septima ecclesia designat septimum et ultimum statum ecclesie, qui erit quasi vespera, id est finis huius seculi: cena autem competit vespere.
|
|
Par. XXXIII, 61-63cotal son io, ché quasi tutta cessa
|
[LSA, prologus, Notabile III] Quantum ad tertium, quare scilicet per septem visiones describuntur septem status prefati, et quare in septima non sic distinguuntur sicut in ceteris. Quadruplex ratio de primo datur ad presens.
Prima est ad idem sub pluribus signis et similitudinibus plenius exprimendum et magnificandum. Nam alique proprietates predictorum statuum exprimuntur per unam visionem que non exprimuntur per aliam; magnificentius etiam concipimus maiestatem alicuius rei quando sub pluribus sollempnibus figuris nobis representatur quam si per solam unam illarum nobis presentaretur.
Secunda est ad idem firmius confirmandum et imprimendum, unde Genesis XL[I]° (Gn 41, 32) dicit Iosep Pharaoni: “Quod vidisti secundo sompnium ad eandem rem pertinens firmitatis indicium est, eo quod fiat sermo Domini et velocius impleatur”.
Par. XXXIII, 58-66, 73-75Qual è colüi che sognando vede,
|
[LSA, prologus, Notabile XII] Sciendum tamen quod ipse non intendit per hoc quin post illas quadraginta duas generationes perduret hec vita et sint sancti in hoc mundo. Nam, libro IIII° in fine prime partis eius, dictis consimilibus de generatione quadragesima prima et generatione quadragesima secunda, dicit quod illud tempus quod post quadragesimam secundam supererit erit absque humana estimatione annorum, velut in sabbatum absque bello et absque scandalo et cetera. Dicit etiam, tam ibi quam libro III°, quod sicut post septem signacula veteris testamenti consumata in Zorobabel cessaverunt ystorie et prophetie et data est requies populo Israel, et tandem circa finem ipsius post tribulationem factam sub Antiocho Christus venit in mundum, sic post septem apertiones septem sigillorum dabitur pax populo christiano, et tandem in fine mundi post per-secutionem Gog veniet Christus ad iudicium.
[LSA, cap. XX, Ap 20, 7-8 (VIIa visio)] Ad tertium, an scilicet Gog sit peior antichristus seu persecutor quam ille qui finget se messiam Iudeorum, dicunt quidam quod sicut certamen mortis corporis sanctorum se habet ad certamen mortis seu transitus ad statum extatice contemplationis, in quo quis quasi totus moritur sibi ipsi, sic se habet temptatio Gog novissimi ad Antichristum, qui dicet se messiam Iudeorum.
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (radix IIe visionis)] In solutione predictorum defectuum etiam includitur solutio culpe et sui debiti, quod per pretium passionis Christi solutum est Dei iusti[tie] et sententie, que secundum septuplam rationem iustitie habebat vim septem sigillorum nobis claudentium librum vite.
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 2 (VIIa visio)] Per folia enim designantur verba divina, tum quia veritate virescunt, tum quia fructum bonorum operum sub se tenent et protegunt, tum quia quoad vocem transitoria sunt. Sacramenta etiam Christi sunt folia, quia sua similitudine obumbrant fructus et effectus gratie quos significant et quia arborem ecclesie ornant.
[LSA, prologus, Notabile III] Item (zelus) est septiformis prout fertur contra quorundam ecclesie primitive fatuam infantiam (I), ac deinde (II) contra pueritiam inexpertam, et tertio (III) contra adolescentiam levem et in omnem ventum erroris agitatam […]
Inf. V, 73-75
I’ cominciai: “Poeta, volontieri
parlerei a quei due che ’nsieme vanno,
e paion sì al vento esser leggeri”.
Eneide, III, 441-452
Huc ubi delatus Cymaeam accesseris urbem
divinosque lacus et Averna sonantia silvis,
insanam vatem aspicies, quae rupe sub ima
fata canit foliisque notas et nomina mandat.
Quaecumque in foliis descripsit carmina virgo,
digerit in numerum atque antro seclusa relinquit.
Illa manent immota locis neque ab ordine cedunt;
verum eadem verso tenuis cum cardine ventus
impulit et teneras turbavit ianua frondes,
numquam deinde cavo volitantia prendere saxo
nec revocare situs aut iungere carmina curat.
Inconsulti abeunt sedemque odere Sibyllae.
[LSA, cap. I, Ap 1, 14 (radix Ie visionis)] Quarta (perfectio summo pastori condecens) est reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas per senilem et gloriosam canitiem capitis et crinium designata, unde subdit: “caput autem eius et capilli erant candidi tamquam lana alba et tamquam nix” (Ap 1, 14). Per caput vertex mentis et sapientie, per capillos autem multitudo et ornatus subtilissimorum et spiritualissimorum cogitatuum et affectuum seu plenitudo donorum Spiritus Sancti verticem mentis adornantium designatur. Sicut autem in lana est calor fomentativus et mollities corpori se applicans, et candor contemperatior et suavior quam in nive, sic in nive est frigiditatis et congelationis algor et rigor et candor intensior nostroque visui intolerabilior, est etiam humor sordium purgativus et terre impinguativus. Per que designatur quod Christi sapientia est partim nobis condescensiva et sui ad nos contemperativa nostrique fomentativa et sua pietate calefactiva, partim autem est a nobis abstracta et nobis rigida nimisque intensa, nostrarumque sordium purgativa nostreque hereditatis impinguativa.
Tab. 30
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 22-23 (VIIa visio)] Quod autem circa finem huius seculi amplius innotescat solaris lux sapientie Christi docet expresse Gregorius, libro IX° Moralium super illud Iob IX° (Jb 9, 9) “Qui facit Arturum et Orionem et Iadas”, dicens: «Dum, diebus singulis magis magisque scientia celestis ostenditur, quasi interni nobis luminis vernum tempus aperitur, ut novus sol nostris mentibus rutilet et doctorum verbis nobis cognitus se ipso cotidie clarior lucet. Urgente enim mundi fine superna scientia proficit et largius cum tempore excrescit. Hinc namque per Danielem dicitur: “Pertransibunt plurimi et multiplex erit scientia” (Dn 12, 4). Hinc Iohanni in priori parte revelationis angelus dicit: “Signa que locuta sunt septem tonitrua” (Ap 10, 4). Cui tamen in eiusdem revelationis termino precipit dicens: “Ne signaveris verba prophetie libri huius” (Ap 22, 10). Pars quippe revelationis anterior signari precipitur, terminus prohibetur, quia quicquid in sancte ecclesie initiis latuit, finis cotidie ostendit»*. Idem etiam docet libro IIII° Dialogorum, capitulo XLIII°**.
|
||
|
Purg. XIX, 34-39Io mossi li occhi, e ’l buon maestro: “Almen tre
|
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (radix IIe visionis)] “Et vidi in dextera sedentis super tronum librum scriptum intus et foris, signatum sigillis septem” (Ap 5, 1). Preostensa gloria et magnificentia maiestatis Dei, hic accedit ad ostendendum profunditatem incomprehensibilem libri sui. Qui quidem liber est primo idem quod Dei essentialis prescientia et totius reparationis universe fiende per Christum predestinatio, et per appropriationem est ipsum Verbum Patris prout est expressivum sapientie eius et prout Pater, ipsum generando, scripsit in eo omnem sapientiam suam.
|
||
Par. XXIV, 19-27Di quella ch’io notai di più carezza
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 3] Septimo quia tante erat precellentie quod nullus alius poterat pertingere ad hunc canticum, unde subdit: “Et nemo poterat dicere canticum, nisi illa centum quadraginta quattuor milia”. |
|
Tab. 31
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 1 (IIa visio, VIIum sigillum)] “Et cum aperuisset sigillum septimum” […] “Factum est” autem hoc “silentium in celo”, id est in celesti ecclesia et in celesti statu illius temporis, quod respectu primi status mundi durantis usque ad Christum et respectu secundi precedentis finalem conversionem Iudeorum, quod ab Apostolo vocatur tempus plenitudinis gentium (Rm 11, 25), erit quasi tertium celum ad quod raptus est Paulus. Quamvis autem hoc silentium, quoad exteriorem pacem, forsitan inchoetur ab interitu Antichristi et suorum complicum, non erit tamen interius et exterius perfectum usque post conversionem totius orbis ad Christum. “Factum est”, inquam, “quasi media hora”. […] Videtur etiam quibusdam per hoc verbum designari quod tempus septimi status, et etiam tertii status generalis, erit longe minus secundo statu generali continente quinque apertiones quinque sigillorum. Quantumcumque autem duret, in ipso plenius implebitur illud Isaie II°: “Conflabunt gladios suos in vomeres et lanceas suas in falces. Non levabit gens contra gentem gladium, nec exercebuntur ultra ad prelium” (Is 2, 4). Tunc enim ubique non solum cessabunt corporalia bella sed etiam spiritualia bella heresum et errorum et scismatum, et ideo potius vacabitur spirituali agriculture et messioni quam litigiosis argumentis et disputationibus, et ideo mutabuntur gladii in vomeres terre, id est mentis sulcativos, et lancee in falces messorias tritici spiritualis. Tunc etiam complebitur illud eiusdem Isaie XXXII° capitulo: “Et erit opus iustitie pax, et cultus iustitie silentium, et sedebit populus meus in pulchritudine pacis” et cetera (Is 32, 17-18).Peter of John Olivi. On the Bible. Principia quinque in Sacram Scripturam [ed. D. Flood – G. Gál, St. Bonaventure University, New York 1997 (Franciscan Institute Publications, Text Series, 18)], III, De doctrina Scripturae, p. 93: 46. De quarta apertione potest exponi quod in Psalmo (77, 23-25) legitur: Ianuas caeli aperuit, et pluit illis manna ad manducandum. Panem angelorum manducavit homo. In hac enim apertione, in qua sentitur abundanter manna absconditum et refectio Dei et angelorum et deliciae paradisi, quidquid occurrit in Scripturis quod sapiat iucunditatem et felicitatem carnalem, confestim transfertur a spiritu in dulcorem caelestem. |
||
Par. II, 1-30O voi che siete in piccioletta barca,
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 6 (radix IIe visionis)] “Et in conspectu sedis”, scilicet erat, “tamquam mare vitreum simile cristallo”. Per mare designatur Christi amara et quasi infinita passio et lavacrum baptismale et penitentialis contritio et martiriorum perpessio et pelagus sacre scripture.Par. XXIX, 94-96, 112-114Per apparer ciascun s’ingegna e face
|
|
Par. XXXIII, 85-90Nel suo profondo vidi che s’interna,
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] Secundum autem Ricardum, per duodecim angulos cuiuslibet porte intelliguntur universi minores et meritis occultiores, quia angulus occultum significat, et duodenarius universitatem. In scripturis tamen sepe angulus sumitur pro fortitudine et ornatu, quia in angulis domorum, in quibus parietes coniun-guntur, est fortitudo domus. Unde Christus dicitur esse factus in caput anguli et lapis angularis […]
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 16 (VIIa visio)] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia”. Stadium est spatium in cuius termino statur vel pro respirando pausatur, et per quod curritur ut bravium acquiratur, secundum illud Apostoli Ia ad Corinthios, capitulo IX°: “Nescitis quod hii, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium?” (1 Cor 9, 24), et ideo significat iter meriti triumphaliter obtinentis premium. Cui et congruit quod stadium est octava pars miliarii, unde designat octavam resurrectionis. Octava autem pars miliarii, id est mille passuum, sunt centum viginti quinque passus, qui faciunt duodecies decem et ultra hoc quinque; in quo designatur status continens perfectionem apostolicam habundanter implentem decalogum legis, et ultra hoc plenitudinem quinque spiritualium sensuum et quinque patriarchalium ecclesiarum.
III.3 Ricordo cessato e linguaggio imperfetto (Tab. 32-34)
ripresta un poco di quel che parevi (Par. XXXIII, 69; Tab. 32)
La Lectura si conclude, citando Gioacchino da Fiore, con un ringraziamento a Dio che dopo tanti mari percorsi ha condotto la nave in porto, e con la preghiera di prestare indulgenza se in qualche punto l’espressione non sia stata conforme alla Sua volontà. Olivi si dichiara pronto a ricevere correzioni mentre è ancora in vita, qualora ci sia qualche pio disposto a farlo. Se poi la veloce chiamata di Dio lo sottrarrà dalla luce terrena, allora il compito di emendare spetterà alla Chiesa romana, alla quale è stato dato il magistero universale. Citando Riccardo di San Vittore, il frate assegna infine a sé quanto detto da lui meno bene e, come i seniori di fronte al trono divino, attribuisce ciò che è degno a Colui che non occupa luogo né è mutato dal tempo.
Anche questa estrema parte non si sottrae a profonde metamorfosi poetiche. Il prestarsi, che nell’esegesi è un prestare indulgenza ai limiti dell’autore, si trasforma nel prestarsi della luce divina a una memoria incapace di seguire l’intelletto che in quella luce si profonda. Ciò è tema del primo e dell’ultimo canto del Paradiso. Nel primo caso, invocando il “buono Appollo”, il poeta ascrive alla virtù divina (“se mi ti presti / tanto …”) la dignità che gli darà l’amato alloro (Par. I, 22-27). Nel secondo caso, la somma luce viene invocata – “ripresta un poco di quel che parevi” -, affinché il poeta possa lasciare alla futura gente una sola favilla di quella gloria (Par. XXXIII, 67-75; altrove sono trattati temi differenti).
L’emendarsi (“rimendo qui la vita ria”: hapax, singolarmente congiunto col prestarsi, come nella Lectura) è proprio di Sapìa senese, la quale nel secondo girone della montagna purga l’invidia, “lagrimando a colui che sé ne presti”, affinché voglia concederne la visione (Purg. XIII, 106-108). Non sarà casuale questo appropriare le finali attestazioni di umiltà e di sottomissione dell’Olivi a colei che ebbe abbreviata la sua penitenza per le preghiere di Pier Pettinaio, uomo spirituale.
I motivi dell’indulgere, dell’essere veloce, di Dio che non ha luogo né tempo percorrono l’ascesa di Dante al nono cielo, il Primo Mobile o Cristallino, in Par. XXVII, 97ss. Lo sguardo di Beatrice ‘indulge’, cioè presta una virtù che sottrae il poeta alla costellazione dei Gemelli e lo spinge “nel ciel velocissimo”. Tutte le parti di questo cielo sono così uniformi, che Dante non sa dire quale luogo abbia scelto Beatrice per entrarvi. Il Primo Mobile, da cui comincia la natura del mondo, non ha altro luogo in cui si possa considerare situato che la mente divina, da cui deriva l’amore che lo fa girare e la virtù che fa piovere sugli otto cieli da esso contenuti. Non è misurato dal tempo, ma è la radice del tempo, che tiene “in cotal testo / le sue radici ” (vv. 118-119), cioè in tale vaso (da notare l’uso di termini presenti nell’incipit della Lectura, relativi alla dottrina di Cristo contenuta nel Vecchio Testamento “sicut nucleum in testa et pullum in ovo et fructum in semine vel radice”). Nel Primo Mobile, Beatrice ride “tanto lieta, / che Dio parea nel suo volto gioire” (vv. 103-105).
Tab. 32
[LSA, explicit] Ut autem verbis Ioachim* utar, referamus et nos gratiam ei qui nos, decursis tantis pelagis, perduxit ad portum, orantes ut si in aliquibus locis aliter locuti sumus quam ipse voluit, prestet indulgentiam delinquenti. Quod si est qui pie corrigat dum adhuc vivo, paratus sum recipere correctionem. Si autem velox vocatio Domini me subtraxerit ex hac luce, romana ecclesia, cui datum est universale magisterium, si qua indigna esse perspexerit, dignetur obsecro emendare.
|
||
Purg. XIII, 106-108“Io fui sanese”, rispuose, “e con questi
|
Par. XXVII, 97-105, 109-110, 115-120E la virtù che lo sguardo m’indulse,
|
|
[LSA, prologus, incipit] Hec autem lux habet septiformem diem transcendentem velamen umbre legalis, quoniam in hac aperitur trinitatis Dei archanum, ac culpe originalis et actualis vinculum et debitum, et incarnationis Filii Dei beneficium, et nostre redemptionis pretium, et iustificantis gratie supernaturale donum simul et predestinationis ac reprobative subtractionis eiusdem gratie incomprehensibile secretum, ac spiritualis et perfecti modi vivendi Deumque colendi saluberrimum exemplum ac preceptum et consilium, et eterne retributionis premium et supplicium cum finali consumatione omnium. Hec enim septem sunt velut septem dies solaris doctrine Christi, que sub velamine scripta et absconsa fuerunt in lege et prophetis. Eo ipso autem quod doctrina novi testamenti probat se ipsam contineri in veteri sicut nucleum in testa et pullum in ovo et fructum in semine vel radice et sicut lumen in lucerna lucente in loco caliginoso, eo ipso promovetur luna, id est vetus lex et scriptura, in lucem solis. |
||
Io credo, per l’acume ch’io soffersi / del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito, / se li occhi miei da lui fossero aversi (Par. XXXIII, 76-78; Tab. 33)
Ad Ap 3, 3 il vescovo di Sardi viene invitato a ricordare con la mente quale fosse la “prima grazia” e a conservarla, cioè la grazia ricevuta da Dio e ascoltata tramite la predicazione evangelica. Da quanto gli viene detto, si deduce che costui era tanto intorpidito nell’ozio da non ricordare più il primo stato di grazia e di perfezione. Se non si ravvedrà vigilando, il giudizio divino verrà da lui come un ladro (“sicut fur”). È giusto infatti che chi non conosce sé stesso a causa della negligenza e del torpore non conosca l’ora del proprio giudizio e sterminio. Costui non vede la luce a motivo delle sue tenebre; erroneamente crede e desidera di poter vivere a lungo nella prosperità ritenendo che il giudizio divino possa essere ritardato, e con presunzione spera di venire infine salvato. Ma l’Apostolo dice ai Tessalonicesi che “il giorno del Signore verrà di notte come un ladro. E quando diranno: ‘pace e sicurezza’, allora verrà su di loro una repentina distruzione” (1 Th 5, 2-3). Ma ai santi non verrà come un ladro, per cui san Paolo aggiunge: “Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro: voi tutti infatti siete figli della luce e del giorno. Pertanto, non dormiamo come gli altri, ma vigiliamo e restiamo sobri. Quelli che dormono, infatti, dormono di notte” (ibid., 5, 4-7). È questa una prefigurazione dell’occulto avvento e giudizio di Cristo alla fine del quinto stato e all’inizio del sesto, che verrà spiegato all’apertura del sesto sigillo. Un passo simmetrico è ad Ap 16, 15 [1].
La rosa dei temi contenuti nell’esegesi di Ap 3, 2-3 percorre il poema con multiformi variazioni. Smarrirsi (“Ille enim dormit, qui in peccatis quiescit quasi sopitus … sic fuit otiosus et torpens, quod in mente non habuit qualiter acceperit et audierit statum et gratiam sue perfectionis, et quod ideo sic corruit”); non sapere («“et horam nescies qua veniam ad te” … qui se ipsum per negligentiam et torporem nescit»); tardare (“optat se diu in prosperitate victurum et Dei iudicium diu esse tardandum”); ripensare attentamente un primo, edenico stato di grazia, qual era («“In mente ergo habe”, id est attente recogita, “qualiter acceperis”, scilicet a Deo priorem gratiam … si digne recogitaveris gratiam tibi prius impensam et qualiter prius accepisti eandem»); udire (“illa que per predicationem audisti et per influxum gratie a Deo primitus accepisti”); vigilare (“Si ergo non vigilaveris … Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed vigilemus et sobrii simus”); conservare la fede acquisita per proprio consenso («Vel recogita qualiter per proprium consensum accepisti fidem et gratiam et statum eius … “Et serva”»): sono temi, portati dal lessico nel senso letterale, che fanno segno dell’esegesi; essi si ritrovano alternati, intrecciati e variati in più luoghi della Commedia.
È la situazione di Dante, tanto “pien di sonno” al momento di abbandonare la verace via smarrita da non saper ripetere come fosse entrato nella selva oscura, la cui immagine, tuttavia, ritornandogli alla memoria (cfr. il “si digne recogitaveris” detto al torpido e tardo vescovo di Sardi e l’inciso scritturale “et horam nescies qua veniam ad te”), “rinova la paura” (Inf. I, 3, 6, 10-12). Il tema del tardare è appropriato a Beatrice, la quale mossa da Lucia perché soccorra Dante, teme di essersi “tardi al soccorso levata”, “sì smarrito” (cfr. “sic fuit otiosus et torpens”) pare il suo amico (Inf. II, 64-66).
I temi si registrano nell’ascolto di Virgilio (Inf. V, 70-72; XIII, 20-24) o del “parlar … nemico” di Farinata (Inf. X, 121-129), o ancora di fronte al folgorante sguardo di Beatrice (Par. IV, 139-142) o nella visione finale di fronte al raggio divino, che nello smarrirsi e ricordare ripropone, variati, i motivi dell’inizio del poema (Par. XXXIII, 76-81). Sono appropriati a dannati antichi (Nembrot, Purg. XII, 34-36) e moderni (Vanni Fucci, Inf. XXIV, 112-117), ai purganti nella valletta dei principi (Purg. VIII, 58-63); sono presenti nell’appello ai lettori di Par. II, 1-15 e nell’elogio di Domenico fatto da Bonaventura (Par. XII, 61-69).
“Principio là onde si piglia / ragion di meritare in voi”, il libero arbitrio nelle parole di Virgilio è virtù innata “che consiglia, / e de l’assenso de’ tener la soglia”; è “nobile virtù” alla quale bisogna sempre ripensare affinché ogni atto volitivo “si raccoglia” alla “prima voglia”, innata per grazia divina (Purg. XVIII, 55-75). È dunque assimilato allo stato edenico da ricordare, e non a caso Virgilio, sulla soglia del Paradiso terrestre, dice a Dante: “libero, dritto e sano è tuo arbitrio, / e fallo fora non fare a suo senno” (Purg. XXVII, 140-141). Da confrontare quanto detto del libero arbitrio (“e de l’assenso de’ tener la soglia”) con l’assenso dato per Domenico dalla madrina in occasione del battesimo (Par. XII, 64): in entrambi i casi, della fede e della prima voglia, c’è una grazia data gratuitamente sulla quale deve esercitarsi il consenso (“Vel recogita qualiter per proprium consensum accepisti fidem et gratiam et statum eius”).
Ripensare con attenzione a un edenico ‘prima’ o all’originario stato di grazia è motivo che fascia Matelda e Piccarda.
L’apparizione di Matelda nell’Eden fa ricordare a Dante quale era Proserpina allorché, rapita da Plutone, perdette la “primavera”, cioè i fiori raccolti assimilati alla prima grazia (Purg. XXVIII, 49-51; da notare la corrispondenza tra “qualiter” e “qual era”). È questo un uso della parola “primavera” che Dante ha già proposto nella Vita Nova, applicandola a Monna Vanna, la donna del suo “primo amico” Guido Cavalcanti, la quale nell’incedere viene prima della sua donna, Monna Bice, come Giovanni Battista venne prima di Cristo. Nella figura di Matelda la presenza del “perpetuum ver” del bosco di Enna di cui canta Ovidio nelle Metamorfosi (V, 391) è innegabile ma, come sempre nel poema, qualunque ricordo classico si armonizza con la teologia che lo consacra. Notabile è che i versi “Quelli ch’anticamente poetaro / l’età de l’oro e suo stato felice” (vv. 139-141), di cui dice Matelda, corrispondano nella prosa a “fidem et gratiam et statum eius, prout a me et a ceteris tibi predicantibus audivisti”: gli antichi poeti, antesignani dei predicatori della fede e di un prossimo novum saeculum nella storia della Chiesa, sono forse l’espressione più alta raggiunta da Dante nello sforzo di conciliare la “felicitas” aristotelica con il cristianesimo.
Ricordare un ‘prima’ bello che non si ritrova più perché mutato in meglio si verifica nel riconoscimento di Piccarda. Nel rivelarsi, la donna invita il poeta a ricordare con mente attenta i “primi concetti” che ebbe di lei, cioè la prima immagine conosciuta in terra, e Dante replica che questi “primi” sono tanto trasfigurati dallo splendore divino da non avergli consentito un immediato riconoscimento senza l’aiuto delle parole del suo interlocutore (Par. III, 47-49, 58-63).
Quando Beatrice argomenta la resurrezione dei corpi, le parole sulla creazione della carne umana variano il tema dello stato di grazia e di perfezione da ben riguardare con la mente già utilizzato da Virgilio per descrivere l’origine del libero arbitrio: “se tu ripensi / come l’umana carne fessi allora / che li primi parenti intrambo fensi (Par. VII, 146-148).
Ancora sullo stesso panno è cucito il ricordo dei pastori che per primi ascoltarono il Gloria in excelsis Deo cantato dagli angeli sulla stalla di Betlemme – “come i pastor che prima udir quel canto” (Purg. XX, 140) -, canto che si rinnova al momento in cui Virgilio e Dante lasciano il quinto girone della montagna, in cammino verso il sesto, grido che accompagna il forte terremoto, anch’esso ripetizione della sconvolgente predicazione di Cristo e segno dell’apertura del sesto sigillo, del libero ascendere interiore e, politicamente, del ritorno del seme di Federico II, vittorioso sul regno di Francia.
Dalla stessa Beatrice, il torpore o smarrimento del vescovo di Sardi è invece appropriato a Dio in senso negativo: “né prima quasi torpente si giacque”, né ebbe un “prima” o un poi, nel suo “discorrer … sovra quest’ acque” (Par. XXIX, 19-21).
[1] Cfr. Il sesto sigillo, cap. 1d.
Tab. 33
[LSA, Ap 3, 2-3 (Ia visio, Va ecclesia)] “Esto vigilans” (Ap 3, 2), id est non torpens vel dormiens, sed attente sollicitus de salute tua. Ille enim dormit, qui in peccatis quiescit quasi sopitus et negligit curare de salute anime sue. Quia vero iste, tamquam episcopus, tenebatur sollicite curare non solum de sua salute sed etiam subditorum suorum, ideo pro utroque monetur ut vigilet. […]
|
||
Inf. I, 1-6, 10-12; II, 64-66Nel mezzo del cammin di nostra vita
|
Purg. VIII, 58-63“Oh!”, diss’ io lui, “per entro i luoghi tristi
|
|
e per sonare un poco in questi versi … Omai sarà più corta mia favella … Oh quanto è corto il dire e come fioco / al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi, / è tanto, che non basta a dicer ‘poco’ (Par. XXXIII, 74, 106, 121-123; Tab. 34)
Nell’esegesi della terza e quarta guerra si dice che la donna, volata nel luogo per lei preparato, venne ivi nutrita “per un tempo, tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente” (Ap 12, 14; cfr. supra). L’espressione “per un tempo, tempi e la metà di un tempo” indica un periodo di tre anni e mezzo, formati da quarantadue mesi (12 x 3 + 6) nei quali i trenta giorni corrispondono a trenta anni: si ha così un periodo di permanenza della donna nel deserto di 1260 anni. “Tempus” sta per un anno, “tempora” per due anni e “dimidium temporis” per sei mesi.
■ Questo numero mistico, che nel poema subisce numerose metamorfosi, ha vari significati. I tre anni e mezzo designano in primo luogo il mistero della trinità di Dio unitamente alla perfezione delle sue opere, che rispetto al loro artefice sono qualcosa di dimidiato, imperfetto, parziale e quasi nulla: le opere furono infatti compiute in sei giorni, che corrispondono alle sei età del mondo e ai sei mesi del mezzo anno.
Così nella visione finale il poeta vede “tre giri / di tre colori e d’una contenenza”, ma il suo dire è “corto” e “fioco”, inadeguato rispetto al concetto, a quanto cioè la mente ha ritenuto della visione, concetto che a sua volta è “poco”: il corto, il fioco, il poco esprimono il significato contenuto nella “metà di un tempo” (Par. XXXIII, 115-123).
■ La vicinanza del verbo “pertractare”, riferito nell’esegesi di Ap 12, 6 al quinto libro della Concordia di Gioacchino da Fiore, con il numero mistico “per tempus et tempora et dimidium temporis” (da Daniele, 12, 6-7; cfr. gli incisi “… sub uno quam brevi coart[ar]emus sermone … nisi hoc quod sonat versiculus iste …” con Par. XXXIII, 74, 106 : “e per sonare un poco in questi versi … Omai sarà più corta mia favella”) conduce a Inf. XI, 79-84, dove Virgilio ricorda al discepolo le tre disposizioni peccaminose odiate da Dio – “incontenenza, malizia e la matta bestialitade” – esposte ampiamente (‘pertrattate’) dall’Etica di Aristotele. Una di queste tre disposizioni, l’incontinenza, offende meno Dio e suscita minor biasimo, e pertanto gli incontinenti stanno fuori della città di Dite meno martellati nelle pene dalla divina vendetta. All’incontinenza è applicato il tema della “metà di un tempo”, mentre la malizia sembra corrispondere a “tempi” (il duale greco), considerato che ai vv. 22-24 si dice che il fine di ogni malizia, che consiste nell’ “ingiuria”, cioè nell’infrazione delle leggi divine o naturali, si consegue in due modi, con la forza (i violenti) o con l’inganno (i fraudolenti); quest’ultimo, a sua volta, si distingue nella frode verso chi si fida e in quella verso chi non si fida, con andamento bipartito riscontrabile in principio di Inf. XXVIII (Inf. XI, 52-66: “Questo modo di retro … Per l’altro modo …”). La “matta bestialitade” corrisponderebbe pertanto a “(un) tempo”. Da notare che i violenti hanno un andamento ternario, per non dire trinitario: “ma perché si fa forza a tre persone … a Dio, a sé, al prossimo” (Inf. XI, 28-33).
L’esame completo dell’espressione “per un tempo, tempi e la metà di un tempo” e dei confronti proposti nella sottostante tabella è stato condotto altrove.
Tab. 34
[LSA, cap. XII, Ap 12, 14 (IVa visio, III-IVum prelium)] Dicit autem “per tempus et tempora et dimidium temporis”, id est per tres annos et dimidium ex quadraginta duobus mensibus triginta annorum, id est mille ducentis sexaginta annis constantes. Eundem enim numerum sub aliis verbis intendit hic ponere, quem posuit paulo ante (cfr. Ap 12, 6). Per “tempus” enim intelligitur unus annus, et per “tempora” duo ann[i]. Nam Greci, in quorum lingua iste liber est editus, habent tres numeros in suis articulis, scilicet singularem et dualem et pluralem. Quod autem “tempus et tempora et dimidium temporis” sumatur alibi pro tribus annis et dimidio, patet quia Danielis VII° dicitur quod rex undecimus, designatus per undecimum cornu, “sanctos Altissimi conteret et tradentur in manu eius usque ad tempus et tempora et dimidium temporis” (Dn 7, 25). In hoc autem libro et infra, XIII° capitulo, dicitur quod “data est illi potestas facere malum per menses quadraginta duos” (Ap 13, 5) et idem dicitur supra, XI° (Ap 11, 2.9.11). Quod autem “tempus et tempora”, id est tres anni, non sumantur hic pro annis dierum seu mensium ex solis triginta diebus constantium, se[d] potius pro annis duodecim mensium ex triginta annis quasi ex triginta diebus constantium, patet non solum ex supradictis, sed etiam quia in tertio et quarto statu ecclesie non apparuit talis persecutio vel mansio in deserto per solos tres annos dierum perdurans. Preterea hic non dicit ‘ubi aletur per tempus et tempora’, sed “ubi alitur”, tamquam monstrans se loqui de toto tempore pastus eius, de quo supra dixerat quod “habet” in deserto “locum paratum a Deo, ut ibi pascat eam mille ducentis sexaginta diebus” (Ap 12, 6).
|
||
Inf. XXXIV, 22-24, 37-45, 55-67Com’ io divenni allor gelato e fioco,
|
Inf. XXVIII, 7-24S’el s’aunasse ancor tutta la gente
|
|
Par. XXXIII, 73-75, 106-108, 115-123ché, per tornare alquanto a mia memoria
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio, III-IVum prelium)] Notandum autem quod Ioachim totum librum suum Concordie veteris et novi testamenti fundavit super numero hic posito. Unde libro V° Concordie, circa finem pertractans verba illa angeli dicta Danieli, quod “in tempus et tempora et dimidium temporis” erit “finis horum mirabilium” (Dn 12, 6-7), dicit: «Verba hec Danielis ita a lectore huius operis pensari debere vellem, ut quicquid a principio huius operis usque huc late et diffuse contulimus sub uno quam brevi coart[ar]emus sermone. Nichil enim aliud nos intimasse credimus, nisi hoc quod sonat versiculus iste: ‘in tempus et tempora et dimidium temporis omnium istorum mirabilium esse finem’. Quia sicut iam per multas vices nos dixisse meminimus, in hiis quadraginta duabus generationibus septem signacula continentur, nichilque aliud est dicere “in tempus et tempora et dimidium temporis” complebuntur quam illud quod, sub sexto angelo tuba canente, alter angelus aut forte unus et idem ait: “tempus iam non erit amplius, sed in voce septimi angeli, cum ceperit tuba canere” (Ap 10, 6-7)»*.
* Concordia, V 6, c. 4 § 8; Patschovsky 3, pp. 1009, 10-17–1010, 1-6.
III.4 Il “punto” (Tab. 35, 36)
Il sesto stato – iniziato con Francesco e non ancora terminato (si tratta dell’età contemporanea a Olivi e Dante) – è, insieme al successivo e breve settimo stato, il “punto” da cui dipendono gli altri stati, perché appare nel testo dell’Apocalisse in modo più evidente degli altri, che da esso assumono chiarezza quanto alla loro manifestazione nella storia, come l’intelligenza delle cose ordinate ad un fine dipende dal fine (prologo, Notabile VIII). A conclusione del processo, la luce della luna sarà come quella del sole, e il sole della sapienza cristiana luminoso della luce dei sette giorni, secondo l’espressione di Isaia 30, 26 con cui si apre il prologo della Lectura. Come il solenne inizio del Nuovo Testamento ebbe luogo nella sesta età del mondo, illuminando le cinque età precedenti e l’intelligenza profetica relativa al primo avvento di Cristo, così il solenne inizio del sesto stato della Chiesa, preceduto dai primi cinque, chiarisce l’intelligenza del libro dell’Apocalisse e delle altre scritture profetiche quanto al triplice avvento di Cristo – nella carne (primo stato), nello Spirito (sesto stato) e nel giudizio (la parusia) – e ai tempi che precedono sia il primo come il secondo avvento.
Nel Primo Mobile Dante vede “un punto … che raggiava lume / acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca / chiuder conviensi per lo forte acume” (Par. XXVIII, 16-18). Intorno al punto, che designa la semplicità e indivisibilità di Dio, girano nove cerchi concentrici di fuoco via via meno veloci quanto più se ne allontanano, che rappresentano le gerarchie angeliche. Come afferma Beatrice, “da quel punto / depende il cielo e tutta la natura” (vv. 41-42). A Dio è dunque appropriato il tema del sesto stato come “punto”, fine da cui dipendono gli stati ad esso ordinati (è da notare la presenza del verbo ‘dipendere’ nel Notabile VIII e nei versi). È “punto che mi vinse” (Par. XXX, 11). Un punto luminoso non solo matematico o metafisico, ma anche storico-provvidenziale e spirituale, che riassume cioè tutti e sette i doni che lo Spirito increato, uno semplicissimo e molteplice, distribuisce e tutte le illuminazioni del libro progressivamente aperto agli uomini. La Metafisica di Aristotele e il relativo commento di Tommaso d’Aquino, fonti della frase detta da Beatrice, concordano con la Lectura dell’Olivi, il ragionamento umano con la manifestazione dei segni provvidenziali nella storia.
Il tema del “punto” è presente anche, in forma diversa, ad Ap 11, 6 (terza visione, sesta tromba), dove si dice che i due testimoni, Enoch ed Elia, chiuderanno il cielo affinché non piova, ossia nasconderanno agli indegni la sapienza cristiana e la grazia al modo con cui un’aquila volando in alto si sottrae alla nostra vista o con cui una mole grossa si attenua riducendosi a un punto invisibile.
I due significati del “punto” – come passaggio al sesto stato (prologo, Notabile VIII) e come il ridursi della sapienza cristiana da una mole grossa a un punto invisibile (Ap 11, 6) -, si ritrovano in Inf. XXXIV, 70-93, nel volgersi di Virgilio sull’anca di Lucifero. Con Dante avvinghiato al collo, il poeta pagano, quando le sei ali di Lucifero sono bene aperte (variazione di un tema del terzo e quarto stato, allorché alla donna sono date due grandi ali d’aquila per vincere la guerra (cfr. supra); in questo caso le ali di Lucifero sono di aiuto), si appiglia alle costole e scende giù di vello in vello (sono temi del condescensivo quinto stato sia il discendere sia l’avere una ‘costa’ cui aggrapparsi). Arrivato là ove la coscia di Lucifero “si volge, a punto in sul grosso de l’anche” (i due opposti motivi, del punto e della grossezza, sono congiunti poiché la testa del femore costituisce il punto medio del corpo di Dite), Virgilio volge la testa e si aggrappa al pelo per risalire lungo le gambe di Lucifero. Il punto in cui Virgilio si volge coincide con il centro della terra, punto che la “gente grossa” non vede nella sua ignoranza: sono qui presenti i motivi, da Ap 11, 6, della sapienza che si sottrae alla vista e della “moles grossa ” che si riduce, quest’ultimo tema già anticipato all’inizio del canto con la similitudine della “grossa nebbia” e dell’apparire “di lungi un molin che ’l vento gira”, che è in realtà Lucifero (vv. 4-7). Il contrasto tra l’umile semplicità degli uomini spirituali e la grossezza degli inferiori è anche uno dei temi della sesta vittoria (Ap 3, 12). Il volgersi di Virgilio nel “punto / al qual si traggon d’ogne parte i pesi” (vv. 110-111) segna il passaggio dall’ “emisperio nostro”, delle terre emerse, a quello dov’è la montagna del purgatorio. Come gli dice Virgilio, Dante è rimasto nel primo emisfero finché è durata la discesa (tema del quinto stato). Il “punto” segna il passaggio, con l’uscita dall’inferno, ad uno stato migliore, verso il secondo regno. È terminato il viaggio nelle prime cinque età del mondo (l’Antico Testamento); ora la seconda cantica narrerà il viaggio dei due poeti nella sesta età, quella della Chiesa di Cristo.
La luce divina, che tanto si leva dai concetti mortali, per cui la sua espressione sembra essere chiusa alla lingua del poeta, è “punto” nell’ultima visione: “Un punto solo m’è maggior letargo / che venticinque secoli a la ’mpresa / che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo” (Par. XXXIII, 94-96). Il “letargo” è l’oblio che induce la visione suprema esposta ad Ap 1, 16-17, quando il sublime “splendor faciei” di Cristo imprime negli inferiori un sentimento di annullamento e di umiliazione, di tremore e di adorazione. Il “punto” che è causa di oblio si contrappone, sul piano temporale, ai “venticinque secoli” che sono trascorsi, non ponendola in dimenticanza, dall’impresa degli Argonauti. Si contrappone ancora, sul piano spaziale, a qualcosa di ‘grosso’, cioè all’ombra della grande nave che Nettuno meravigliato guarda dal basso solcare il mare: un accostamento, quello del “punto” e dell’ “ombra”, che è proprio anche del cono d’ombra proiettato dalla terra (la ‘mole grossa’ del “vostro mondo”) che “s’appunta”, cioè termina, sul terzo cielo di Venere (Par. IX, 118-119).
È da notare che tra i dodici esercizi di ascesi alle virtù, proposti nell’esegesi di Ap 7, 5-8 come interpretazione dei nomi delle dodici tribù d’Israele da cui proverranno i 144.000 segnati all’apertura del sesto sigillo, la quinta tribù, Nèftali, rappresenta la virtù che sa trasferirsi dal sensibile allo spirituale e all’eterno, di modo che il sensibile e il temporale appaiano segno e specchio dell’intellettuale e dall’innumerevole multiformità del sensibile ci si dilati nella contemplazione dell’intellettuale. Per questo Nèftali (Ap 7, 6) viene interpretato come “comparatio” o “conversio translativa” o “latitudo”. Poi si esige la dimenticanza dello stesso sensibile; per passare infatti dal segno relativo e dallo specchio all’intellettuale bisogna spogliarsi del sensibile come di veli tenebrosi. Questo il significato della sesta tribù, Manasse, nome interpretato come “oblivio”. Nell’ordine degli esercizi viene dunque prima la dilatazione o la larghezza, poi l’oblio. Così la terzina che concerne il “letargo” (Par. XXXIII, 94-96) segue quella (vv. 91-93) in cui il poeta dichiara di aver visto “la forma universal di questo nodo” – cioè l’amoroso legame “in un volume” di “ciò che per l’universo si squaderna: / sustanze e accidenti e lor costume / quasi conflati insieme …” (vv. 85-90) -, e crede che sia così “perché più di largo, / dicendo questo, mi sento ch’i’ godo”. Conseguita la dilatazione contemplando in Dio la forma universale dell’innumerevole multiformità del sensibile, al poeta tocca l’oblio che si libera dai veli tenebrosi, figurati dall’ombra della nave degli Argonauti, antico precorrimento, con reminiscenze ovidiane (Am., II, 11, 1-2) e virgiliane (Aen., I, 124-128; VIII, 91), del viaggio “in pelago” del suo “legno che cantando varca” (cfr. Par. II, 1-18). Nella Lectura “ombra” e “velo” sono termini di significato equivalenti; l’“umbra velaminis” viene compiutamente tolta dalla gloria di Cristo per la quale, nel sesto e nel settimo stato, la luce della luna (il Vecchio Testamento) sarà come quella del sole (il Nuovo Testamento) e risplenderà della luce di sette giorni, cioè di tutte le illuminazioni verificatesi nella storia, secondo quanto scritto in Isaia 30, 26, il già ricordato passo assunto dall’Olivi come incipit del commento all’Apocalisse. I veli, o l’ombra, designano la poesia stessa, che spira da Dio e ombreggia con segni e con figure, cioè con immagini, verità superiori, come i sacramenti ombreggiano la verità divina (ad Ap 22, 2). Il “letargo” determinato dal “punto” divino è annullamento dell’ombra: l’intelletto tanto si profonda nella visione di Dio, che nessuna immagine si ritrova per esprimerla.
Il tema dell’intimo mutarsi di colui che contempla un’ardua visione, da Ap 1, 17 (lo “splendor faciei” di Cristo nel sesto stato), si ritrova nella contemplazione finale della luce divina, semplice e immutabile sembiante che tuttavia si trasforma – “a me si travagliava” – nel mutarsi del soggetto vedente, “per la vista che s’avvalorava / in me guardando” (Par. XXXIII, 109-114): sul piano teologico è così offerta la giustificazione al succedersi di figure diverse con cui la poesia descrive la visione, che è una, dei misteri della Trinità e dell’Incarnazione. Una delle spiegazioni dell’esistenza dei sette sigilli e delle loro chiusure sul libro sta nella passione di Cristo, che per sette motivi appare abietta al senso umano, il quale trova nella morte in croce impotenza, angustia, stoltezza, inopia, ignominia, inimicizia e sevizia (ad Ap 5, 1). Il terzo motivo è l’apparente stoltezza, per cui Dio si è fatto uomo ed è morto per dare soddisfazione alle ingiurie a Lui stesso arrecate e ha redento con tale prezzo coloro che avrebbe potuto salvare col solo suo potere. Contro l’apparente stoltezza sta il “valore”, di incomparabile lucro, che deriva dal commercio della dottrina di Cristo. In cambio di un solo denaro – la fede unica e semplice – si ottengono infatti beni senza prezzo, cioè il grano, l’orzo, il vino e l’olio di cui si dice nella terza apertura e che corrispondono ai quattro sensi della Scrittura (Ap 6, 6). Il commercio della sapienza tramite lo studio dello Scritture si contrappone alla bilancia dolosa ed erronea degli eretici, che vacilla dal retto equilibrio della verità. Il tema del valore incomparabile ottenuto in cambio di un solo denaro e di una fede unica e semplice viene utilizzato dal poeta per esprimere l’avvalorarsi della propria vista che, nella visione finale della Trinità e dell’Incarnazione, subiva crescenti mutazioni di aspetti pur rimanendo la luce divina, oggetto della contemplazione, “un semplice sembiante” e “una sola parvenza”. Da notare che il valore senza prezzo, nell’esegesi oliviana, si contrappone all’apparente stoltezza per cui Cristo si è fatto uomo.
L’intimo mutarsi, che per Olivi è segno della vera visione, è già stato proprio di Beatrice nell’Eden, nei cui occhi il grifone-Cristo, che pur sta fermo (nella sua unità e semplicità), raggia la sua immagine (il suo “idolo”) “come in lo specchio il sol (et facies eius sicut sol … debet preclarius radiare) … or con altri, or con altri reggimenti”, cioè come duplice natura, umana-leone e divina-aquila (Purg. XXXI, 121-126).
Nel sesto stato ci si dedicherà più al gusto senza misura della contemplazione che alle forti opere della vita attiva, e per questo non sarà data a questo periodo tanta forza e virtù per forti opere, come è stata data agli stati precedenti, e in particolare agli anacoreti del quarto, opere che gli uomini sensuali ammirano, stimano e, da esse mossi, sono tratti a imitare e desiderare più di quelle intellettuali e interne. Per compensare il difetto di virtù, al sesto stato è data la porta aperta, cioè l’illuminazione che detta interiormente; il sesto periodo non registra miracoli corporali, ma intellettuali (Ap 3, 7).
All’inizio del viaggio, Dante dubita della propria virtù – “Poeta che mi guidi, / guarda la mia virtù s’ell’è possente”, Inf. II, 10-12 -, perché “ad immortale secolo” andarono solo Enea e san Paolo. Il primo a causa dell’“alto effetto” che doveva uscire dalla sua vittoria: il “victoriosus effectus” è il conseguimento della quarta vittoria, degli operosi anacoreti (Ap 2, 26-27). Il secondo per recare conforto alla fede. Dante non è Enea né Paolo, non ha virtù per opere forti, non vive in un momento in cui la conversione si opera per i miracoli. Ha scarsa virtù, ma in compenso la porta gli è aperta. Glielo dirà Cacciaguida: “sicut tibi cui / bis unquam celi ianüa reclusa?” (Par. XV, 29-30).
Al termine del viaggio, san Bernardo chiede per Dante alla Vergine di dargli virtù possente: “supplica a te, per grazia, di virtute / tanto, che possa con li occhi levarsi / più alto verso l’ultima salute” (Par. XXXIII, 25-27).
Forte fu l’impresa degli Argonauti, ammirata da Nettuno e ricordata ancora dopo venticinque secoli; essa è assimilabile alla possente virtù data al quarto stato, tempo per eccellenza delle res gestae (gli stati sono al contempo periodi storici e modi di essere delle persone, habitus). Le si contrappone il “punto”, non sensibile ma intellettuale, vero simbolo del sesto stato, causa finale della storia umana.
Tab. 35
[LSA, prologus, Notabile VIII] Rursus quinque membra sic distincte et interscalariter currunt inter radicem visionum et inter sextum membrum, quod ex hoc ipso aperte insinuatur per ipsa designari quinque sollempnia tempora cum suis sollempnibus statibus et operibus ordinate percurrentibus ab initio ecclesie usque ad sextum tempus ipsius. Que autem essent illa tempora vel opera, aut in quo puncto inchoarentur et finirentur, non potuit a nobis communiter sciri vel investigari nisi per realem et manifestum adventum ipsorum ac per preclaram et sollempnem initiationem status sexti. Et ideo sicut sollempnis initiatio novi testamenti facta in sexta mundi etate cum precursione quinque etatum elucidat intellectum prophetarum quoad primum Christi adventum et quoad tempora ipsum precurrentia, sic sollempnis initiatio sexti status ecclesie cum precursione quinque priorum elucidat intelligentiam huius libri et ceterorum prophetalium quoad trinum Christi adventum et quoad tempora precurrentia tam primum quam secundum adventum, propter quod in ipso sexto tempore erit sol sapientie christiane septempliciter lucens sicut lux septem dierum (cfr. Is 30, 26). […] Ex predictis autem patet quod principalis intelligentia sexti et septimi membri visionum huius libri fortius probatur et probari potest quam intelligentia membrorum intermediorum inter primum et sextum seu inter radicem et sextum, unde et clara intelligentia ipsorum dependet ab intelligentia sexti, sicut et ratio eorum que sunt ad finem dependet a fine.[LSA, cap. XI, Ap 11, 6 (IIIa visio, VIa tuba)] Abscondent etiam eis celestem sapientiam et gratiam eo modo quo aquila per summam evolationem in altum abscondit se visui nostro, et eo modo quo molem grossam attenuando et minuendo fere redigit in invisibilem punctum. |
||
Par. IX, 118-120Da questo cielo, in cui l’ombra s’appunta
|
Inf. XXXIV, 4-6, 76-77, 91-93Come quando una grossa nebbia spira,
|
|
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 6 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Quinto exigitur virtus sciens ex omnibus sensibilibus se comparative transferre ad spiritualia et eterna, ita quod numquam assumit sensibilia et temporalia nisi ut signa et specula intellectualium, et ex innumera multiformitate sensibilium se multiformiter dilatat in contemplatione intellectualium. Hec autem desi-gnatur per Neptalim, qui interpretatur comparatio vel conversio, scilicet translativa, vel latitudo.
|
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1; IIIum sigillum] Deum autem humanari ac sperni et mori, ut Deomet satisfiat de iniuriis sibi ab alio factis, et ut illos tali pretio redimeret, qui simpliciter erant sub dominio suo et quos per solam potentiam salvare poterat, pretendit summam stultitiam. […] Contra stultitiam vero, est mercationum doctrine Christi lucrosus et incomparabilis valor. Nam pro denario unius et simplicis fidei habetur impretiabile triticum et ordeum et vinum et oleum, prout in tertia apertione monstratur (cfr. Ap 6, 6).[LSA, cap. I, Ap 1, 17 (radix Ie visionis)] Undecima est ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum quod cecidit in faciem prostratus, quia talis competit actui adorandi; casus vero resupinus est signum desperationis et desperate destitutionis. Huius casus sumitur ratio partim ex intolerabili superexcessu obiecti, partim ex terrifico et immutativo influxu assistentis Dei vel angeli, partim ex materiali fragilitate subiecti seu organi ipsius videntis. Est etiam huius ratio ex causa finali, tum quia huiusmodi immutatio intimius et certius facit ipsum videntem experiri visionem esse arduam et divinam et a causis supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi annichilatus humilius et timoratius visiones suscipit divinas, tum quia valet ad significandum quod sanctorum excessiva virtus et perfectio tremefacit et humiliat et sibi subicit animos subditorum et etiam ceterorum intuentium. Significat etiam quod in divine contemplationis superexcessum non ascenditur nisi per sui oblivionem et abnegationem et mortificationem et per omnium privationem. |
||
[LSA, cap. III, Ap 3, 7 (Ia visio, VIa ecclesia)] Nota etiam quod quia tunc amplius vacabitur excessibus et gustibus contemplationis quam fortibus active operibus, ideo non dabitur ei tantum robur virtutis ad fortia opera sicut datum est primis statibus et specialiter quarto, quod fiet non solum propter causam predictam, sed etiam ut unusquisque status habeat unde alteri humilietur et debeat humiliari, propter quod habent se sicut excedentia et excessa.
|
Inf. II, 10-12Io cominciai: “Poeta che mi guidi,
|
|
Par. XXXIII, 22-27, 94-96Or questi, che da l’infima lacuna
|
Tab. 36
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (III-IVum sigillum)] Secunda causa seu ratio septem sigillorum libri est quia in Christo crucifixo fuerunt septem secundum humanum sensum et estimationem abiecta, que claudunt hominibus sapientiam libri eius.
|
||
Par. XXIX, 142-145Vedi l’eccelso omai e la larghezza
|
||
Par. XXXIII, 79-81, 109-114E’ mi ricorda ch’io fui più ardito
|
Purg. XXII, 145-150
E le Romane antiche, per lor bere,
contente furon d’acqua; e Danïello
dispregiò cibo e acquistò savere.
Lo secol primo, quant’ oro fu bello,
fé savorose con fame le ghiande,
e nettare con sete ogne ruscello.
Inf. XVI, 67-76
“cortesia e valor dì se dimora
ne la nostra città sì come suole,
o se del tutto se n’è gita fora;
ché Guiglielmo Borsiere, il qual si duole
con noi per poco e va là coi compagni,
assai ne cruccia con le sue parole”.
“La gente nuova e i sùbiti guadagni
orgoglio e dismisura han generata,
Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni”.
Così gridai con la faccia levata
Par. IV, 136-138; V, 19-27, 61-63
Io vo’ saper se l’uom può sodisfarvi
ai voti manchi sì con altri beni,
ch’a la vostra statera non sien parvi.
Lo maggior don che Dio per sua larghezza
fesse creando, e a la sua bontate
più conformato, e quel ch’e’ più apprezza,
fu de la volontà la libertate;
di che le creature intelligenti,
e tutte e sole, fuoro e son dotate.
Or ti parrà, se tu quinci argomenti,
l’alto valor del voto, s’è sì fatto
che Dio consenta quando tu consenti
Però qualunque cosa tanto pesa
per suo valor che tragga ogne bilancia,
sodisfar non si può con altra spesa.
Par. XIII, 37-48
Tu credi che nel petto onde la costa
si trasse per formar la bella guancia
il cui palato a tutto ’l mondo costa,
e in quel che, forato da la lancia,
e prima e poscia tanto sodisfece,
che d’ogne colpa vince la bilancia,
quantunque a la natura umana lece
aver di lume, tutto fosse infuso
da quel valor che l’uno e l’altro fece;
e però miri a ciò ch’io dissi suso,
quando narrai che non ebbe ’l secondo
lo ben che ne la quinta luce è chiuso.
Nota alla Tabella 36
Nel quinto capitolo, la cui esegesi costituisce con il quarto una sorta di prologo alla seconda visione, Olivi definisce le cause della chiusura del libro, i cui sigilli stanno per essere aperti (ad Ap 5, 1). La seconda causa della presenza dei sette sigilli sta nella passione di Cristo, che per sette motivi appare abietta al senso umano, il quale trova nella morte in croce impotenza, angustia, stoltezza, inopia, ignominia, inimicizia e sevizia (ad Ap 5, 1). Il terzo motivo (corrispondente al terzo periodo della Chiesa) è l’apparente stoltezza, per cui Dio si è fatto uomo ed è morto per dare soddisfazione alle ingiurie a Lui stesso arrecate e ha redento con tale prezzo coloro che avrebbe potuto salvare col solo suo potere. Contro l’apparente stoltezza sta il “valore”, di incomparabile lucro, che deriva dal commercio della dottrina di Cristo. In cambio di un solo denaro – la fede unica e semplice – si ottengono infatti beni senza prezzo, cioè il grano, l’orzo, il vino e l’olio di cui si dice nella terza apertura e che corrispondono ai quattro sensi della Scrittura (Ap 6, 6). Il commercio della sapienza tramite lo studio dello Scrittura si contrappone alla bilancia dolosa ed erronea degli eretici, che vacilla dal retto equilibrio della verità.
Il tema del valore senza prezzo è nella spiegazione che Beatrice dà de “l’alto valor del voto”, che si fonda sulla libertà della volontà, il maggiore dono, proprio delle sole creature intelligenti, creato dalla liberalità di Dio, quello più conforme alla sua bontà e quello da lui più apprezzato [1]. Sia nella domanda del poeta (Par. IV, 136-138) come nella risposta della donna (Par. V, 19-27, 61-63) sono contenuti molti elementi semantici propri del terzo stato: “l’uom”, “le creature intelligenti” (il terzo stato è proprio dell’uomo razionale: prologo, Notabile I); “sodisfarvi / sodisfar”, “statera” (hapax), “più apprezza”, “pesa”, “bilancia”, “valor” (due volte), tutti dall’apertura del terzo sigillo (Ap 5, 1) [2].
Il tema del valore incomparabile ottenuto in cambio di un solo denaro e di una fede unica e semplice viene utilizzato dal poeta per esprimere l’avvalorarsi della propria vista che, congiunta “col valore infinito” nella visione finale della Trinità e dell’Incarnazione, subiva crescenti mutazioni di aspetti pur rimanendo la luce divina, oggetto della contemplazione, “un semplice sembiante” e “una sola parvenza” (Par. XXXIII, 109-114). Lo si ritrova nei tanti specchi (gli angeli) nei quali “si spezza”, “per tanti modi” per il diverso fervere d’amore, l’eterno valore, “uno manendo in sé come davanti” (Par. XXIX, 142-145). Da notare che il valore senza prezzo, nell’esegesi oliviana, si contrappone all’apparente stoltezza per cui Cristo si è fatto uomo.
Tace l’elemento ‘valore’, ma il cibo e il sapore della sapienza che deriva dall’acquisto della dottrina di Cristo percorrono la voce la quale da dentro le fronde dell’albero posto sul limitare del sesto girone del purgatorio, dove sono i golosi, dice di Daniele che “dispregiò cibo e acquistò savere” e dell’età dell’oro che “fé savorose (hapax) con fame le ghiande” (Purg. XXII, 146-150).
Da rilevare come il termine “valor” si accompagni a elementi semantici propri dell’esegesi di Ap 5, 1 in luoghi distanti come Inf. XVI, 67, 73-74 (“guadagni”, “dismisura”) e Par. XIII, 41-42 (“sodisfece”, “bilancia”).
[1] I temi provenienti dalla Lectura si combinano con quelli dalla quaestio oliviana sul voto evangelico.
[2] L’espressione di Beatrice «Avete il novo e ’l vecchio Testamento» (Par. V, 76) deriva dall’esegesi della quarta chiesa, alla quale è detto: «“Tantum id quod habetis” (Ap 2, 25), scilicet evangelium meum et meam evangelicam legem, “tenete donec veniam”».
III.5 La visione della sede divina (Tab. 37-40)
(Tab. 37)
La sede divina descritta nella seconda visione apocalittica – i cui temi sono appropriati agli “spiriti magni”, che stanno nel nobile castello del Limbo – è circondata dall’iride, simile allo smeraldo, cioè alla gemma incomparabilmente più verde (Ap 4, 3). In essa il colore verde supera in intensità quello delle erbe e delle fronde e impregna l’aria ripercossa, riempie gli occhi al solo sguardo e non lo sazia, tanto è grazioso a vedersi. Per quanto il colore verde sia più appariscente e grazioso, l’iride ha vari colori, secondo la densità o rarità della nube acquosa percossa dai raggi del sole: nella densa è rosso, nella più densa ceruleo (verde e nero, è il colore del mare profondo) oppure di colore livido oppure purpureo (commisto di nero e rosso), nella densissima nero; nella rara verde, nella più rara croceo, nella rarissima bianco. L’iride designa la grazia che preesiste causalmente ed esemplarmente in Dio e che si diffonde in giro a ornamento della sede della Chiesa celeste e subceleste: essa ha il colore della fiamma per la carità, il nero o il livido per l’umiltà, il verde per la sobrietà, il bianco per la chiarezza che proviene dalla sapienza.
Il tema dello smeraldo che impregna l’aria intorno di color verde fa parte della spiegazione che Matelda dà sull’origine del vento che spira nel Paradiso terrestre (Purg. XXVIII, 103-120). L’aria si muove in cerchio con il Primo Mobile (la “prima volta”, che corrisponde all’essere “in circuitu”) e percuote l’alta selva (l’“alta eminentia” della sede) facendone stormire le fronde, cosicché le piante impregnano del loro seme l’aria che lo diffonde nell’altra terra, cioè nel mondo abitato dagli uomini, il quale, secondo disposizione, concepisce e produce da diversi semi diverse piante. Anche se nessun colore viene indicato, non è difficile scorgere in questo circuire dell’aria a percuotere la selva e nel suo secondo girare, impregnata di riflesso dai semi delle piante percosse che essa diffonde, un valore assai simile a quello dell’iride, multiforme grazia che preesiste in Dio causa ed esempio e da lui emana su tutta la sede celeste e subceleste attorno alla quale gira.
Una variazione dei temi dell’iride è nella spiegazione che Stazio dà dei corpi aerei, per cui l’aria che circonda l’anima assume la figura in essa impressa dalla virtù formativa che raggia intorno, come l’aria pregna di umidità, riflettendo i raggi del sole, si adorna dei colori dell’iride (Purg. XXV, 88-96). Non sazia la vista, come il verde dello smeraldo, l’immagine (la “sembianza”, che corrisponde all’“aspectus” di Colui che siede sul trono ad Ap 4, 3) della Veronica in figura di san Bernardo (Par. XXXI, 103-108).
L’iride, del quale dice Matelda senza nominarlo, è esplicitato nel corso della successiva processione, allorché le sette fiammelle dei candelabri, quasi “tratti pennelli”, lasciano “dietro a sé l’aere dipinto … sì che lì sopra rimanea distinto / di sette liste, tutte in quei colori / onde fa l’arco il Sole e Delia il cinto”, colori che designano, come nell’esegesi della sede divina, i sette doni dello Spirito (Purg. XXIX, 73-78).
Sempre nel Paradiso terrestre, di smeraldo sembrano fatte le carni e le ossa della speranza, seconda delle tre donne che vengono danzando dalla destra ruota del carro, simboleggianti le virtù teologali (Purg. XXIX, 124-125). “Li smeraldi / ond’ Amor già ti trasse le sue armi” sono gli occhi di Beatrice, ai quali viene condotto il poeta dalle quattro virtù cardinali (Purg. XXXI, 115-117). In questo caso il significato dello smeraldo proprio dell’iride (saziare lo sguardo con il grazioso verdeggiare) si accompagna ai motivi che appartengono al diaspro, sia ad Ap 4, 3 (riferiti a colui che siede) come nei passi simmetrici ad Ap 21, 11-12 (riferiti al lume della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione). Il diaspro incorpora in modo fermo e incancellabile, al modo di uno specchio, la luce, come la città celeste e i cuori dei beati incorporano la luce che è gloriosa forma e immagine di Dio (Ap 21, 11). Così gli “occhi rilucenti” di Beatrice stanno saldi sul grifone-Cristo che li irradia e lo riflettono “come in lo specchio il sol” (Purg. XXXI, 119-123). Il diaspro sta a indicare la solida virtù dei santi che difendono la Chiesa contro i nemici (sono il muro della città celeste, Ap 21, 12), ed è a questo tipo di armi, promotrici di virtù, che alludono gli strali di Amore.
Il colore livido della pietra compare nel secondo girone del purgatorio, dove gli invidiosi ‘siedono’ con manti anch’essi color pietra (il manto è tema della terza perfezione di Cristo come sommo pastore, Ap 1, 13). La durezza, che è motivo appropriato alla pietra, si stempera nella compassione del poeta allorché si rende conto della pena che li affligge (Purg. XIII, 8-9, 47-48, 52-54).
Nella bolgia dei ladri, “livido e nero (altro colore dell’iride) come gran di pepe” è il serpentello (Francesco dei Cavalcanti) che trafigge Buoso (Inf. XXV, 84).
I colori dell’iride si ritrovano pure nei tre gradini che precedono la porta del purgatorio: bianco il primo come marmo pulito e terso da specchiarvisi (cfr. Ap 21, 11), il secondo nero di pietra “ruvida e arsiccia”, di porfido fiammeggiante come sangue il terzo. L’angelo che siede “in su la soglia” sembrava a Dante “pietra di diamante”, come Colui che siede “quasi sub specie regis sedentis super solium” sembrava a Giovanni pietra di diaspro (Purg. IX, 94-105).
Tab. 37
Purg. XXVIII, 103-114Or perché in circuito tutto quanto
|
Purg. XXV, 88-93Tosto che loco lì la circunscrive,
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 2-4 (radix IIe visionis)] Dicit ergo (Ap 4, 2): “Et ecce sedes posita erat in celo, et supra sedem sedens”, scilicet erat. Deus enim Pater apparebat ei quasi sub specie regis sedentis super solium. […] “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id est aspectibili seu visibili forme, “lapidis iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dicitur similis, quia Deus est per naturam firmus et immutabilis et in sua iustitia solidus et stabilis, et firmiter regit et statuit omnia per potentiam infrangibilem proprie virtutis.
|
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 11 (VIIa visio)] Formam autem tangit tam quoad eius splendorem quam quoad partium eius dispositionem et dimensionem, unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et sub igne et ab igne caloratur et ignis speciem sumit, non autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar speculi polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide incorporata et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter representans et omnium virtutum temperie virens. Est etiam perspicua et transparens non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim lune humilitatem celestium men-tium designat. |
[LSA, Ap 21, 12 (VIIa visio)] Dicit ergo: “Et habebat murum magnum et altum” (Ap 21, 12). Per magnum intelligit longum et latum, seu totum eius circuitum. Sicut autem murus opponitur exterioribus et defendit et abscondit interiora, sic sancti martires et zelativi doctores et pugiles, qui opposuerunt se hostibus et eorum impugnationibus in defensionem fidei et ecclesie, fuerunt murus ecclesie magnus et altus. Virtutes etiam hiis officiis dedicate sunt murus animarum sanctarum, qui quidem murus est ex lapide propter solidam virtutem sanctorum, et “ex lapide iaspide” (cfr. Ap 21, 18) propter virorem vive fidei, propter quam sunt zelati et passi et fortes effecti.
|
Purg. IX, 94-105Là ne venimmo; e lo scaglion primaio
|
Purg. XXIX, 73-78, 124-125; XXXI, 115-123e vidi le fiammelle andar davante,
|
(Tab. 38, 39)
Gli “spiriti magni” del nobile castello del Limbo vengono mostrati a Dante su un “prato di fresca verdura … sovra ’l verde smalto” (Inf. IV, 111, 118-119). Altrove è stato mostrato come questa zona del poema sia cucita sul panno della sede divina (Ap 4, 2-3). Ma solo con alcuni dei possibili fili, relativi ai sette punti in cui si distende l’ordito: l’altezza (I), l’assistenza dei seniori attorno a chi siede (IV), al quale viene reso onore (VII). Il verde è “verde smalto”, cioè impetrato; l’iride (III) non si dispiega nei suoi vari colori: i doni dello Spirito non sono mancati agli “spiriti magni”, ma non si sono storicamente sviluppati. Dei tre elementi che emanano dalla sede (V), nel Limbo non ci sono né folgori né tuoni, ma le voci umane e razionali, proprie del senso morale. Tale sviluppo è l’oggetto del viaggio di Dante; nell’Eden i temi dell’iride si mostrano compiutamente, e ancor più nell’Empireo e nella visione finale.
I temi propri della sede trovano infatti collocazione nella visione finale della Trinità, della “luce etterna che sola in te sidi” (Par. XXXIII, 124; Dio Padre appare a Giovanni come un re che siede sul trono: antiche figure in terra sono, a Inf. IV, 125-126, 132, il re Latino e Aristotele). In quattro versi (115-118) si ritrovano almeno sei elementi semantici che nella Lectura designano altrettanti attributi della sede: la “sussistenza” (che corrisponde alla “stabilitas essentie” della maestà divina; cfr. “subsisto” a Par. XXIX, 15) dell’“alto” lume è “profonda” e “chiara” (essere alto e profondo è proprio del contenuto del libro, la chiarezza appartiene al mare trasparente che sta dinanzi alla sede); in essa Dante vede “tre giri / di tre colori e d’una contenenza” (di una medesima dimensione, che corrisponde alla “continentia” del libro; anche i tre “giri” hanno un riferimento allo stare “in circuitu” dei seniori) e il secondo dei tre giri (il Figlio) che pareva riflesso dall’altro (il Padre) “come iri da iri” (la sede rifulge nell’arco dell’iride). Le parole “e l’un da l’altro come iri da iri / parea reflesso” sono sviluppo del tema dell’aria che gira con il Primo Mobile ed è ripercossa dalla folta selva dell’Eden verso la terra abitata dall’uomo, appunto “come iri da iri”. Lo ‘spirare’ come fuoco del terzo giro (lo Spirito Santo) in modo uguale dal primo e dal secondo (vv. 119-120) è pure tema connesso alla sede e al libro, come appare dall’esegesi delle coppe spiranti d’amore ad Ap 5, 8. Il verso 120 – “che quinci e quindi igualmente si spiri” – fa riferimento alla somma concordia (“equalitas”) della Gerusalemme celeste, i cui quattro lati hanno uguale misura in lunghezza, altezza e profondità (Ap 21, 16; cfr. infra).
Descrivendo l’invisibile, Dante figurava concetti teologici contenuti nell’esegesi della sede divina in principio del capitolo IV dell’Apocalisse. Non aveva bisogno di ispirarsi ai cerchi trinitari del Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore, come sostenuto da Leone Tondelli, questione che sembra essere ancora aperta [1]. Il rapporto fra Dante e Gioacchino è ben altro. L’abate è presente nella Commedia in modo diffuso, perché le numerose sue citazioni nella Lectura sono inserite nella generale metamorfosi di questa.
[1] Cfr. E. FUMAGALLI, Gioacchino da Fiore, Dante e i cerchi trinitari: una questione aperta?, in Pensare per figure. Diagrammi e simboli in Gioacchino da Fiore. Atti del 7° Congresso internazionale di studi gioachimiti. San Giovanni in Fiore – 24-26 settembre 2009, a cura di A. GHISALBERTI, Roma 2010, pp. 295-309.
Tab. 38
[LSA, cap. IV, Ap 4, 2-3 (radix IIe visionis)] Quoniam autem presentatio seu descriptio summe magnificentie et reverentie et sapientie maiestatis Dei et assistentium sibi plurimum confert ad advertendum profundam et altam et gloriosam continentiam huius libri a Dei dextera tenti, idcirco in prima parte magnificatur Dei maiestas ex septem.
|
|
Inf. IV, 106-132Venimmo al piè d’un nobile castello,
|
Purg. XXVIII, 7-12, 25-27, 61-63, 103-111Un’aura dolce, sanza mutamento
|
Tab. 39
[LSA, cap. IV, Ap 4, 2-3 (radix IIe visionis)] Quoniam autem presentatio seu descriptio summe magnificentie et reverentie et sapientie maiestatis Dei et assistentium sibi plurimum confert ad advertendum profundam et altam et gloriosam continentiam huius libri a Dei dextera tenti, idcirco in prima parte magnificatur Dei maiestas ex septem.
|
||
|
Par. XXIX, 13-15Non per aver a sé di bene acquisto,
|
|
[*] (v. 130) La variante fulgore, che ha un suo grado di ammissibilità, cede a colore, in quanto il colore è attributo della sede divina (Ap 4, 2-5), alla quale rinviano i versi 109, 111, 115-119, 124, 127, 128. |
||
Tab. 39 bis
[Ap 5, 8; radix IIe visionis] Phiale [igitur] iste sunt corda sanctorum per sapientiam lucida, per caritatem dilatata, et per contemplationem splendidam et flammeam aurea, et per devotarum orationum redundantiam odoramentis plena. Sicut enim odoramenta per ignem elicata sursum ascendunt totamque domum replent suo odore, sic devote orationes ad Dei presentiam ascendunt et pertingunt, eique suavissime placent et etiam toti curie celesti et subcelesti. Sicut [etiam] diffusio odoris spiratur invisibiliter ab odoramentis, sic devote affectiones orantium spirantur invisibiliter et latissime diffunduntur ad varias rationes dilecti et ad varias rationes sancti amoris, prout patet ex multiformi varietate sanctorum affectuum qui exprimuntur et exercentur in psalmis. Patet autem, secundum modum Ricardi, quare citharas premisit ante phialas, quia activa communiter precedit contemplativam. Sequendo etiam alterum modum, premittit convenienter citharas, quia nisi corde virtutum sint in cithara mentis disposite prout congruit laudi Dei, non potest haberi phiala cordis plena devotis desideriis et suspiriis et meditationibus ignitis et odoriferis, sicut nec iubilatio laudis potest perfecte exerceri nisi preeat plenitudo odoramentorum. Patet autem, secundum modum Ricardi, quare citharas premisit ante phialas, quia activa communiter precedit contemplativam. Sequendo etiam alterum modum, premittit convenienter citharas, quia nisi corde virtutum sint in cithara mentis disposite prout congruit laudi Dei, non potest haberi phiala cordis plena devotis desideriis et suspiriis et meditationibus ignitis et odoriferis, sicut nec iubilatio laudis potest perfecte exerceri nisi preeat plenitudo odoramentorum. |
||
Par. XXXI, 124-129E come quivi ove s’aspetta il temo
|
Par. II, 124-129Riguarda bene omai sì com’ io vado
|
Par. XIV, 127-129Ïo m’innamorava tanto quinci,
|
Par. XXIV, 28-33, 82-83“O santa suora mia che sì ne prieghe
|
Par. XXIII, 103-111 “Io sono amore angelico, che giro
|
Par. XXXII, 103-105qual è quell’ angel che con tanto gioco
|
Par. X, 1-3Guardando nel suo Figlio con l’Amore
|
Par. XV, 1-3Benigna volontade in che si liqua
|
Par. XXXI, 94-96E ’l santo sene: “Acciò che tu assommi
|
Par. XIX, 22-25Ond’ io appresso: “O perpetüi fiori
|
Inf. X, 16-21“Però a la dimanda che mi faci
|
|
Ad Ap 5, 8 le coppe auree e fiammeggianti (“phiale”), che i ventiquattro seniori (angeli o santi uomini) offrono prostrati dinanzi all’Agnello, ricolme di profumi che si diffondono come gli odori “ad varias rationes dilecti et ad varias rationes sancti amoris”, designano le preghiere dei santi, spirano di devoti affetti e di desideri dei cuori, con menti già disposte alla lode di Dio. I signacula, che rinviano a questo luogo esegetico, compongono una vera sinfonia dell’amor sacro che il poeta con libertà diffonde variamente combinandone i motivi.
|
||
(Tab. 40)
Nel capitolo quarto dell’Apocalisse, dopo la descrizione della sede divina, subentra il canto di lode rivolto dai quattro esseri viventi e dai ventiquattro seniori a Colui che siede sul trono e ha nella destra il libro segnato da sette sigilli (Ap 4, 8-11). Nel capitolo successivo, la lode viene tributata a Cristo, che ha ricevuto dal Padre il libro e si appresta ad aprirlo (Ap 5, 8-14; il “canticum novum”). All’esegesi di questi versetti rinviano i luoghi del Paradiso che celebrano la Trinità. Si noti in particolare Par. XIV, 28-33:
«(Ap 4, 8) laudant Deum trinum et unum de summa sanctitate et omnipotentia et eternitate omnium preteritorum et presentium et futurorum comprehensiva et gubernativa. … Dicunt (quattuor animalia) autem ter “sanctus” subdendo in singulari “Dominus Deus”, tamquam laudantes Deum trinum et unum … (Ap 4, 9-10) “Et cum darent illa quattuor animalia gloriam et honorem et benedictionem sedenti super tronum, viventi in secula seculorum, procidebant viginti quattuor seniores ante sedentem in trono”. … (Ap 5, 10) “Et fecisti nos Deo nostro regnum et sacerdotes”. “Regnum” scilicet ut Deus regnet super nos per gratiam et tandem per gloriam …
Quell’ uno e due e tre che sempre vive / e regna sempre in tre e ’n due e ’n uno, / non circunscritto, e tutto circunscrive, / tre volte era cantato da ciascuno / di quelli spirti con tal melodia, / ch’ad ogne merto saria giusto muno».
(Tab. 40 bis)
■ Dire tre volte “santo” e “dare benedizione”, come fanno i quattro esseri viventi e i ventiquattro seniori ad Ap 4, 8-11, si ritrovano, diversamente appropriati, nei canti dell’Eden. I seniori cantano “Benedicta tue / ne le figlie d’Adamo, e benedette / sieno in etterno le bellezze tue!” (Purg. XXIX, 85-87: da notare che altri possibili riferimenti scritturali, come Giudici 5, 24, Giuditta 13, 18; 15, 10, nonché la salutazione angelica di Luca 1, 28, sono contaminati, o meglio concordati, con l’Apocalisse). Prima dell’apparizione di Beatrice (Purg. XXX, 10-21), uno dei seniori, “quasi da ciel messo”, grida tre volte “Veni, sponsa, de Libano” (Cantico dei Cantici, 4, 8), seguito da tutti gli altri. Intervengono qui i temi da Ap 19, 6, dove il festivo gaudio – il canto di alleluia – per le nozze di Cristo con la Chiesa è interpretato come “voce di molte acque”. Olivi riporta l’opinione di Gioacchino da Fiore, secondo il quale “inchoante hanc laudem aliquo magno sancto, quasi magna tuba Dei, statim resonabit laus in ore multorum”. La contaminazione tra Ap 4, 8-10 e 19, 6 si mostra nella successiva similitudine della moltitudine di angeli, che si levano sul carro “ad vocem tanti senis”, con i beati che “al novissimo bando / surgeran presti ognun di sua caverna, / la revestita voce alleluiando”. Il bando e l’alleluia sono ad Ap 19, 6; la lode dei beati dopo la resurrezione dei corpi, accostata a quella delle intelligenze angeliche, ad Ap 4, 8-11. Le prime tre terzine del canto sono invece da riferire ad Ap 1, 4, “et a septem spiritibus” (“il settentrïon del primo cielo”), cioè ai doni dello Spirito increato (“che né occaso mai seppe né orto”), i quali fanno stare coloro che ne sono pieni al cospetto di Dio e della sua sede (“e che faceva lì ciascuno accorto / di suo dover”).
■ La fine tragica del viaggio di Ulisse (Inf. XXVI, 136-142), con il turbine che percuote il “legno”, ha anch’essa un senso spirituale, e fra i più inaspettati. La materia è fornita dal canto in lode di Cristo che ha aperto il libro, lode resa dai ventiquattro seniori e dai quattro esseri viventi ad Ap 5, 8-9. Il “canto” di costoro è “canticum novum” perché tutto quello che si canta di Cristo è nuovo, non invecchia né è caduco o destinato a rapida fine, ma è canto di ciò che è eterno, che rinnova i suoi cantori e li conserva nel nuovo (cfr. supra). Ulisse e i suoi compagni, vista la “nova terra”, si rallegrano ma la loro letizia subito si volge al pianto, perché un turbine percuote la prora della nave, detta “primo canto” con espressione equivoca, che significa prora e nello stesso tempo allude al primo rallegrarsi. Per il greco, vago ed estraniato, sembra che risuonino le parole del Salmo: “Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?” (Ps 136, 4). È giunto sulla soglia della sesta età, che inizia con Cristo; vede da lontano la montagna che designa la storia della Chiesa, e che ha in sé un futuro gravido di sviluppi fino al sesto e al settimo stato, cioè ai momenti segnati dalla più ampia illuminazione spirituale, corrispondenti all’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Ma il sesto sigillo, come tutti i precedenti che segnano il libro, resta chiuso.
I seniori e i quattro esseri viventi cantano la loro lode “in tre o, secondo Riccardo [di San Vittore], in quattro atti” (Ap 5, 9). Si tratta di un motivo che compare nelle “accoglienze oneste e liete” di Sordello nei confronti di Virgilio ripetute “tre e quattro volte” (Purg. VII, 1-2; cfr. la variante nella salmodia “Deus, venerunt gentes”, cantata dalle sette virtù “alternando / or tre or quattro”, a Purg. XXXIII, 1-3). La reiterazione non deriva solo dal valore indeterminato dell’espressione latina “ter quaterque” (nel senso che la festa viene ripetuta più volte), ma anche dal canto di lode delle quattro creature e dei seniori (perciò risulta di grande interesse la variante “tre o quattro volte”) [1].
Il primo atto della lode consiste nel ringraziare umilmente adorando, il secondo nell’orazione devota e profumata (le coppe o la vita contemplativa), il terzo nelle buone opere (le cetre o la vita attiva), il quarto nel canto nuovo. Nel capitolo precedente, i quattro esseri viventi (“animalia”) dicono tre volte santo, lodando Dio trino e uno (Ap 4, 8) e assegnano a Dio gloria, onore e benedizione (Ap 4, 9). Animali e seniori sono attorno al trono di Dio, “in circuitu”, ossia girano (Ap 4, 4.6). Davanti al trono sta il mare, cioè il pelago della Scrittura (Ap 4, 6). Le preghiere rappresentate dalle coppe si levano su verso Dio e a lui piacciono (Ap 5, 8). Il turbine fa girare la nave di Ulisse tre volte insieme con le “acque”, alla quarta la poppa si leva in su e la prora va in basso, “com’altrui piacque”. Scrive il Gorni:
… si tratta di una fine altamente simbolica. Nel triplice gorgo concentrico che rapina il “legno” di Ulisse, “Tre volte il fé girar con tutte l’acque” … non posso fare a meno di riconoscere un segno trinitario. Non è forse in “tre giri” (Par. XXXIII, 116) che Dio si manifesta a Dante nell’ultimo canto del Paradiso? [2].
Il libro che solo Cristo può aprire, chiuso da sette sigilli, è la prescienza divina e la predestinazione a riparare l’universo per mezzo di Cristo. In esso si trova scritta tutta la sapienza espressa dal Padre nel generare il Verbo. È la Scrittura, e soprattutto il Vecchio Testamento, nel quale il Nuovo è racchiuso e prefigurato sotto i veli profetici. Ulisse, anticipando i tempi stabiliti da Dio, non poteva da solo, con la ragione senza la fede, aprire il libro, che si richiude come il mare sopra di lui: il suo naufragio è la versione tragica del canto di giubilo a Cristo che apre i sigilli e rivela tutte le illuminazioni fatte nella storia della Chiesa dall’inizio fino alla visione beatifica di Dio. La versione giocosa, che è poi quella del testo dell’Apocalisse, verrà cantata da san Pietro nel girare tre volte la fronte di Dante dopo l’esame sulla fede nel quale il poeta gli è tanto piaciuto (Par. XXIV, 151-154).
Scriveva di Raffaello il critico Bernard Berenson: “compié questo miracolo: che anche quando leggiamo i classici ebrei, li accompagnamo d’immagini elleniche. Che influsso ha così esercitato sulla cultura moderna, ellenizzando l’unico elemento capace di opporsi all’ellenismo!” [3]. Due secoli prima, Dante aveva cristianizzato le immagini classiche, nei versi in cui risuonano concordi testi antitetici come l’Eneide e l’Apocalisse.
Tre volte girano cantando intorno a Beatrice e a Dante, nel cielo del Sole, gli spiriti sapienti che formano la prima corona, poi si arrestano taciti, come donne che non sospendono la danza ma ascoltano in attesa di raccogliere le nuove note (Par. X, 76-81): il silenzio precedente il canto, proprio anche del cantare di san Pietro dopo che il poeta ha cessato di parlare (Par. XXIV, 150-152), corrisponde al silenzio che caratterizza il settimo sigillo, che conclude la seconda visione, cui fa seguito l’inizio della terza con lo sgorgare del canto delle trombe (prologo, Notabile V; altri esempi a Purg. XXX, 82-83 e Par. XXVI, 67-68).
L’espressione “com’ altrui piacque” può essere riferita, oltre che ad Ap 5, 8, anche all’esegesi di Ap 15, 8-16, 1, al termine del capitolo che descrive la radice della quinta visione delle coppe. Ivi si afferma che “nessuno potrà entrare nel tempio finché non saranno consumate le sette piaghe dei sette angeli”, cioè, secondo una delle varie interpretazioni proposte, non si potrà entrare nella serena pace dell’arcana contemplazione fino al compimento delle sette piaghe, designate dal versamento delle sette coppe. Ciò significa anche che il libro, contenente i misteri divini, non potrà essere aperto se non al termine dei sette stati della Chiesa, cioè alla fine della storia umana. Viene poi detto che gli angeli che versano le coppe operano per comando di Dio, da lui ispirati, e muovono come ministri del giudizio divino, non per propria volontà o animosità ma per beneplacito e mandato altrui. Il tempio – la Chiesa dei contemplativi, quella degli ultimi tempi – è pieno di fumo, che designa l’ira e lo zelo che “turba”: questo turbamento è da porre in relazione con il “turbo” che percuote la nave di Ulisse, entrata senza decreto “ne l’alto passo”.
[1] Cfr. la sinossi tra Inf. XXVI, 136-142 e Aen. I, 92-117 (la tempesta che sconvolge la flotta di Enea, con l’onda che fa girare tre volte la nave di Oronte; da notare anche l’apostrofe di Enea – “O terque quaterque beati” – a quelli che morirono sotto le mura di Troia). Il ‘calco’ virgiliano appare assai meno vistoso se si vede la fonte classica fasciata dalle maglie della Lectura super Apocalipsim, che la colloca, come le altre, in una teologia della storia segnata da una progressiva apertura della conoscenza del divino.
[2] Cfr. G. GORNI, Lettera nome numero. L’ordine delle cose in Dante, Bologna 1990, p. 184.
[3] B. BERENSON, The Italian Painters of the Renaissance, Oxford 1930, trad. it. di E. Cecchi, Milano 19483, p. 163.
Tab. 40
[LSA, cap. IV, Ap 4, 8-11 (IIa visio, radix)] “Et requiem non habebant die ac nocte”, id est numquam cessabant a subscripta Dei laude, “dicentia: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus omnipotens, qui est et qui erat et qui venturus est”, id est semper et in prosperis et in adversis laudant Deum trinum et unum de summa sanctitate et omnipotentia et eternitate omnium preteritorum et presentium et futurorum comprehensiva et gubernativa. […]
|
|
Par. XIII, 25-27Lì si cantò non Bacco, non Peana,
|
Par. XV, 37-48Indi, a udire e a veder giocondo,
|
Tab. 40 bis
Aen. I, 92-96, 113-117Extemplo Aeneae solvontur frigore membra;
|
Purg. VII, 1-3: Mad Rb tre o quattro voltePoscia che l’accoglienze oneste e liete
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 8-10 (IIa visio, radix)] Dicunt (quattuor animalia) autem ter “sanctus” subdendo in singulari “Dominus Deus”, tamquam laudantes Deum trinum et unum. Sicut autem prima petitio quam docuit nos petere Christus est “sanctificetur nomen tuum”, sic summus actus laudis Dei est affectualiter et iubilatorie dicere “sanctus” et cetera. Nulla enim perfectio in Deo vel in nobis consideratur ut summe perfecta nisi consideretur ut virtuosa et sancta, quod in Deo prehabundat in tantum ut tota sua essentia sit virtus et sanctitas, vel equitas et caritas et e contrario. Nota etiam quod dicendo “sanctus” non solum ascribunt sanctitatem essentialem, sed etiam omnem aliam sibi tamquam summe cause ascribunt.
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 9 (IIa visio, radix)] Et ideo tertius vel, secundum Ricardum, quartus actus est decantatio laudis*. Unde subditur (Ap 5, 9): “Et cantabant canticum novum”. Novum quidem, tum quia omnia que de Christo cantantur sunt nova, est enim novus homo et nova eius lex et vita et familia et gloria; tum quia numquam veterascit nec est de aliquo veteri et caduco et cito interituro, sed de eternis aut ad eternitatem ordinatis; tum quia renovat et in novitate divina conservat suos cantatores.
|
Inf. XXVI, 136-142Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;
|
Par. XXIV, 148-154Come ’l segnor ch’ascolta quel che i piace,
|
[LSA, prologus, Notabile V] Item finis secunde visionis est quod aperto septimo sigillo “factum est silentium in celo quasi media hora” (Ap 8, 1), et tunc immediate subditur initium tertie visionis, scilicet: “Vidi septem angelos, et date sunt illis septem tube” (Ap 8, 2), ac si post silentium medie hore premissum prosiliret cantus septem tubarum, et certe de archano contemplationis silentio prosiliit perfecta et alta predicatio divinorum. |
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 8-11 (IIa visio, radix)] “Et requiem non habebant die ac nocte”, id est numquam cessabant a subscripta Dei laude, “dicentia: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus omnipotens, qui est et qui erat et qui venturus est”, id est semper et in prosperis et in adversis laudant Deum trinum et unum de summa sanctitate et omnipotentia et eternitate omnium preteritorum et presentium et futurorum comprehensiva et gubernativa. […]
|
|
Purg. XXX, 1-21Quando il settentrïon del primo cielo,
|
Purg. XXIX, 82-87Sotto così bel ciel com’ io diviso,
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 4 (salutatio)] Deinde subdit a quo optat eam dari, insinuans trinam habitudinem esse dantis. Prima est Deus, ut in se ipso absolute et eternaliter existens. Secunda est eius spiritualis virtus, prout est ad varios influxus donorum spiritualium indistantissime ordinata et in ipsis participata et quasi multiplicata. […] Pro secundo dicit: “Et a septem spiritibus”. Hoc non potest hic stare pro spiritibus angelorum creatis, quia gratia non dicitur dari nobis a creatura vel ab angelis, sed solum quod ministerialiter cooperantur ad hoc ut nobis detur a Deo. Non etiam potest stare pro donis gratie creatis, quia tunc esset sermo nugatorius et ridiculosus, scilicet quod ab ipsis donis creatis darentur nobis ipsamet dona creata. Stat ergo pro increato Spiritu. Unde et Ricardus exponit: “a septem spiritibus”, id est a septiformi Spiritu, qui simplex est per naturam et septiformis per gratiam. Dividit enim dona singulis prout vult. Dicit etiam hoc appropriate referri ad personam Spiritus Sancti. Significavit autem sic Spiritum increatum, tum ut insinuet eius causalem multiformitatem, tum ut ostendat eius multiformem et presentialem participationem in variis donis ac si in eis partiretur et multiplicaretur, tum ut ostendat eius originalem radicem et rationem et exemplarem formam septem statuum ecclesie de quibus in hoc libro est intentio principalis. “Qui in conspectu troni eius sunt”, id est qui eos quos replent faciunt in conspectu Dei et sue sedis stare, iuxta quod ad Romanos VIII° (Rm 8, 26) dicitur quod “ipse Spiritus pro nobis postulat”, quia facit nos postulare. Pro quanto etiam est quasi idem cum donis a se influxis, dicitur stare ante Deum quia eius dona stant ante Deum et ad cultum scilicet eius. Ricardus tamen legit quod ipsi spiritus semper conspiciuntur per contemplationem a sanctis angelis et hominibus, qui sunt tronus Dei quia residet in eis sicut rex in suo trono. |
|
Inf. X, 22-24, 73-75O Tosco che per la città del foco
|
Purg. XXIX, 70-72Quand’ io da la mia riva ebbi tal posta,
|
III.6 La vittoria dei contemplativi (Tab. 41, 42, 43)
Nella prima visione apocalittica, a ciascuna delle sette chiese d’Asia è data una vittoria (le sette vittorie sono trattate in principio del cap. II della LSA, anche se, per la quinta, la sesta e la settima chiesa, si riferiscono formalmente al cap. III). La più importante è quella conseguita da Filadelfia, la sesta chiesa, perché la visione è maggiore; essa porta a consumazione la vittoria conseguita da Tiàtira, la quarta chiesa, che rappresenta per antonomasia lo stato dei contemplativi.
La sesta vittoria (Ap 3, 12) per Olivi è l’ingresso in Cristo, che si consegue con una perfetta configurazione e trasformazione della mente in lui. Del vincitore si dice: “lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà più; scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo dal mio Dio, insieme al mio nome nuovo”. Chi entra in Dio riceve Dio dentro sé e Dio entra in lui. L’ingresso avviene in due modi. Il primo con l’essere stabilito nella Chiesa o nella vita religiosa per mezzo della professione; il secondo con la contemplazione, che apprende Dio e le sue opere.
Il primo ingresso è reso con l’immagine della colonna che sta all’interno del tempio, immobile, lunga, eretta, solida, densa, rotonda o quadrata, ferma, fissa, sostentativa e decorativa: così sta, nella Chiesa, nella vita religiosa, o nella curia celeste, un uomo evangelico configurato a Cristo. Sostiene, in quanto superiore, gli inferiori; si contrappone, con la sua semplicità e spiritualità, alla grossezza degli altri, per i quali si pone come il centro della sfera: la colonna, infatti, occupa meno spazio del tempio che sostiene. Stare fisso nel tempio indica il divieto di qualsiasi apostasia, negozio o distrazione temporale.
Il secondo ingresso viene indicato con lo scrivere nella mente il nome di Dio, il nome della nuova Gerusalemme che discende dal cielo e il nuovo nome di Cristo.
In primo luogo, viene inscritta la visione e la contemplazione della divinità delle tre persone. In secondo luogo, la visione della città, ossia del collegio dei santi, che si dice discendere dal cielo sia perché da Dio deriva, sia perché inferiore all’immensità divina designata con il cielo, sia per l’umiltà con cui si reputa indegna non solo di Dio ma anche del proprio celeste luogo, sia in quanto Chiesa militante che riceve le grazie da Dio e dalla gerarchia dei beati. Viene chiamata “nuova” per la novità della grazia e della gloria; è la Chiesa dei beati ma anche quella che, in questo mondo, è stata finora nei primi cinque stati dopo la venuta di Cristo e il ripudio della vecchia legge, e sarà nel sesto (nei tempi ‘moderni’) e settimo stato. Viene chiamata “Gerusalemme”, ossia “visione della pace”, perché di essa gusta o ad essa sospira.
In terzo luogo, viene inscritta la visione di Cristo uomo, nostro redentore e mediatore. Il suo nome viene definito “nuovo” sia per la novità della resurrezione e della gloria, sia perché l’unione personale della divinità e dell’umanità e in generale quanto si trova in lui contengono e palesano una mirabile novità.
E come la città discende da Dio e poi a lui ritorna, così la contemplazione, formando un circolo glorioso, inizia da Dio e per la città di Dio ascende in Cristo suo re, da dove ritorna e rientra in Dio.
Il nome di Dio padre viene inscritto quando l’immagine paterna si imprime come quella di un padre spirituale nella prole, di un abate nella propria religione.
Il nome della nuova Gerusalemme si inscrive allorché la mente, per la soavità dell’amore, è degna di essere definita sposa di Cristo e pia madre e nutrice di prole spirituale.
Il nuovo nome di Cristo viene inscritto intendendo “cristiano” come “unto del Signore”, nel senso del Salmo 104, 15: “Non toccate i miei consacrati”.
I temi della sesta vittoria forniscono molto panno ai versi, che ad essi rinviano con parole-chiave che costituiscono imagines agentes sulla memoria del lettore spirituale.
Nel primo momento della visione finale, in cui vede l’unità dell’universo in Dio, Dante sta come una colonna nel tempio, con la mente “fissa, immobile e attenta” (Par. XXXIII, 97-98), di fronte a una luce che non consente di “volgersi da lei per altro aspetto”, come lo stare fisso nel tempio non consente distrazioni (vv. 100-105). Si tratta di motivi connessi nell’esegesi con la totale configurazione e trasformazione in Cristo dell’uomo evangelico.
Stare “tutto fisso” nella contemplazione è tema presente anche ad Ap 19, 17, proprio dell’angelo che, con gli occhi fissi al sole, invita al convivio spirituale. Ne è esempio Beatrice la quale, nell’attesa che le schiere del trionfo di Cristo discendano al cielo delle stelle fisse, “stava eretta e attenta”, “sospesa e vaga” (l’essere ‘sospesi’ designa pure il contemplare: è appropriato all’aquila ad Ap 4, 7-8) verso il meridiano, cioè verso quella parte del cielo dov’è il sole a mezzodì, come sta l’uccello che con ardente affetto attende la luce del sole (Par. XXIII, 1-15: l’attendere è tema del quinto sigillo, ad Ap 6, 11; il meriggio è proprio del sesto stato, allorché la faccia di Cristo luce come il sole in tutta la sua virtù, ad Ap 1, 16). Ne è ulteriore esempio il pellegrino che, pervenuto all’Empireo, “si ricrea / nel tempio del suo voto riguardando” e comprende con lo sguardo la forma generale del paradiso “in nulla parte ancor fermato fiso”, per cui si rivolge a Beatrice desideroso di domandare “di cose / di che la mente mia era sospesa” (Par. XXXI, 43-57). Nel cielo Stellato, degli apostoli Pietro e Giacomo il poeta dice che “tacito coram me ciascun s’affisse”; di Giacomo è proprio lo scrivere sulla speranza (star fisso e scrivere sono i due elementi della sesta vittoria, e tra l’altro in rima; la speranza, ad Ap 21, 16 corrisponde all’altezza della città celeste), anzi il suo ‘figurarla’ tante volte quante Cristo mostrò la sua predilezione ai tre maggiori apostoli (Par. XXV, 25-33). Nel meriggio dell’Eden, le sette donne “s’affisser” dinanzi alla sorgente del Lete e dell’Eunoè (Purg. XXXIII, 103-111). Il tema della colonna interviene nel riconoscimento del ruffiano Venedico Caccianemico: “Per ch’ ïo a figurarlo i piedi affissi” (Inf. XVIII, 43; i dannati sono immagini ‘torte’ di Cristo). Ha poi un’applicazione più letterale ai superbi purganti i quali, curvi sotto il peso di grossi macigni, paiono mensole che sostengono tetti (Purg. X, 130-132).
Nella visione finale di Dio, il poeta vede prima l’unità dell’universo in Dio (Par. XXXIII, 85-93), poi contempla il mistero della Trinità (vv. 115-120), infine quello dell’Incarnazione (vv. 127-145). La contemplazione dell’unità dell’universo in Dio è assimilata all’interno del libro segnato da sette sigilli (i temi provengono dalla parte proemiale o radicale della seconda visione; cfr. supra). La contemplazione della Trinità e quella di Cristo in quanto uomo si conseguono con la sesta vittoria: “In huius[modi] autem mente tria inscribuntur, scilicet excessiva visio vel contemplatio deitatis trium personarum – parvermi tre giri / di tre colori e d’una contenenza … Tertium quod sibi [in]scribitur est contemplatio Christi secundum quod homo et secundum quod redemptor noster et mediator – mi parve pinta de la nostra effige”. “Qual è ’l geomètra che tutto s’affige / per misurar lo cerchio” (nel “tutto s’affige” è il tema della colonna), Dante si trova di fronte “a quella vista nova” – il “nomen novum” di Cristo uomo, redentore e mediatore -, incapace di comprendere come l’effigie umana si adatti e si collochi nel cerchio (tema del “circulus gloriosus”; Par. XXXIII, 133-138).
Il tema della “visio pacis” e della contemplazione come circolo appare nella rosa celeste, che ha la sua pace solo nel vedere Dio, distendendosi “in circular figura” (Par. XXX, 102-103). Da notare che la ‘circolarità’ è propria sia della rosa, cioè della città – “Vedi nostra città quant’ ella gira” dice Beatrice (v. 130) -, da cui le schiere del trionfo di Cristo, insieme a questi e sua madre, sono in precedenza discese al cielo delle stelle fisse per poi risalire all’Empireo (Par. XXIII; XXVII, 67-72); sia del Figlio fattosi uomo nella visione finale – “Quella circulazion che sì concetta / pareva in te come lume reflesso” (Par. XXXIII, 127-132). Contemplare e gustare la pace in questo mondo sono appropriati a san Bernardo (Par. XXXI, 110-111): l’esegesi della sesta vittoria è da collazionare con un passo del notabile VIII del prologo della Lectura, relativo al settimo stato, nel quale si potrà pregustare in questa vita, poco prima della fine del mondo, la vita eterna.
L’ingresso (in Cristo) e il ritorno (appropriato alla contemplazione, che ritorna in Dio), insieme combinati (“intrammo a ritornar”), sono motivi della salita di Dante e Virgilio per il “cammino ascoso” attraverso il quale escono “a riveder le stelle” (Inf. XXXIV, 133-134). L’ascesa al cielo del poeta è un tornare al proprio sito (Par. I, 92-93); il suo “trasumanar” avviene fissando gli occhi al sole, atto che si genera da quello di Beatrice come il raggio riflesso suole generarsi dal raggio di incidenza “e risalire in suso, / pur come pelegrin che tornar vuole” (vv. 49-51). Nella candida rosa, i beati – “quanto di noi là sù fatto ha ritorno” – stanno “intorno intorno” e sopra la luce divina (Par. XXX, 112-114, dove la circolarità è in rima col tornare; cfr. Par. IX, 107-108: “… e discernesi ’l bene / per che ’l mondo di sù quel di giù torna”, cioè lo circuisce ma anche lo trae col desiderio di ‘tornare’ a lui; e Par. XI, 13-15: “Poi che ciascuno fu tornato ne lo / punto del cerchio in che avanti s’era”). Discendere e risalire, prerogativa della città dei contemplativi, appartiene agli angeli che s’infiorano come api, partecipando ai beati la pace e l’ardore, e poi ritornano “là dove ’l süo amor sempre soggiorna” (Par. XXXI, 4-18).
Il discendere dal cielo della città è appropriato a Beatrice, donna scesa dal cielo, come dice Virgilio a Catone (Purg. I, 53): il “nome nuovo” di Gerusalemme è d’altronde assimilato a una madre pia e nutrice di prole spirituale. La donna discende al Limbo da Virgilio ma arde di tornare all’Empireo (Inf. II, 82-84).
L’ingresso in Cristo e la pace sono congiunti nel parlare di Casella, secondo il quale l’angelo nocchiero, che porta le anime dalla foce del Tevere alla riva del purgatorio, “veramente da tre mesi”, ossia dall’indizione del Giubileo il 22 febbraio 1300 (con effetto retroattivo al Natale 1299), “elli ha tolto / chi ha voluto intrar, con tutta pace” (Purg. II, 98-99).
Nella profezia fatta dal goloso Bonagiunta, una donna di nome Gentucca farà piacere al poeta Lucca, città altrove ripresa a motivo dei barattieri: più oltre, l’angelo della temperanza – il sesto angelo dei gironi della montagna – indica ai tre poeti che “quinci si va chi vuole andar per pace” (Purg. XXIV, 43-45, 141).
Il tema dell’iscrizione del nome di Dio padre, immagine paterna che si imprime come quella di un padre spirituale nella prole, di un abate nella propria religione, tocca la mente di Dante nella quale è fitta “la cara e buona imagine paterna” di Brunetto Latini, che gli insegnava “come l’uom s’etterna”, immagine che ora l’“accora” per “lo cotto aspetto” e “’l viso abbrusciato” (Inf. XV, 82-85). Anche nell’inferno esistono momenti di apertura all’imitazione di Cristo, per quanto solo nel ricordo della vita passata. Come pure sono presenti momenti di quiete e di silenzio, tipici del settimo stato (Francesca parla e ascolta “mentre che ’l vento, come fa, ci tace”, Inf. V, 94-96). Brunetto, poco prima, ammonisce i fiorentini a ‘non toccare’ la pianta in cui rivive il santo seme dei Romani, trasponendo su Dante, unto di Dio, quanto scritto nel Salmo 104, 15 sul popolo di Israele (Inf. XV, 73-78). Lo stesso tema della “paternitatis imago”, unito a quello della soavità d’amore per cui si inscrive il nome della nuova Gerusalemme, ritorna con Guido Guinizzelli, “il padre / mio e de li altri miei miglior che mai / rime d’amor usar dolci e leggiadre”, il quale parla di Cristo come “abate del collegio” per chiedere a Dante di recitare “un paternostro” (Purg. XXVI, 97-101, 127-130; da notare, qui e nel caso di Brunetto, l’uso di “quando”). Il termine “imago”, nella visione finale di Cristo incarnato, è appropriata al Figlio: “veder voleva come si convenne / l’imago al cerchio e come vi s’indova” (Par. XXXIII, 137-138).
Il tema del ritorno, unito a quello della soavità d’amore espressa nel nome della nuova Gerusalemme, è nelle parole dello scomunicato Manfredi, che conosce come la maledizione dei pastori (la quale appartiene alla vecchia legge) non impedisce “che non possa tornar, l’etterno amore, / mentre che la speranza ha fior del verde” (Purg. III, 133-135; da notare i motivi del ritorno e dell’ingresso nelle parole delle anime purganti, vv. 100-102: «“Tornate”, disse, “intrate innanzi dunque”»).
Sposa e Pia – altri due motivi propri del nome della nuova Gerusalemme inscritto nella mente – è colei che chiede al poeta di ricordarla ai vivi: “Deh, quando tu sarai tornato al mondo / e riposato de la lunga via …” (Purg. V, 130-136). Tornare al mondo, dopo tanto viaggio, è come conseguire la sesta vittoria, dopo la piena contemplazione, propria dell’uomo evangelico; riposarsi equivale a trionfare nello stadio. La misura della città celeste, descritta nella settima visione (Ap 21, 16), è di 12.000 stadi (i lati della città sono uguali). Lo stadio è lo spazio al cui termine si sosta o “si posa” per respirare e lungo il quale si corre per conseguire il premio. Esso designa il percorso del merito che ottiene il premio in modo trionfale, secondo quanto scrive san Paolo ai Corinzi: “Non sapete che tutti corrono nello stadio, ma di costoro uno solo prende il premio?” (1 Cor 9, 24). Ciò concorda con il fatto che lo stadio è l’ottava parte del miglio, e in questo senso designa l’ottavo giorno di resurrezione. L’ottava parte del miglio corrisponde a 125 passi, che rappresentano lo stato di perfezione apostolica adempiente i precetti del decalogo (12 apostoli x 10 comandamenti), cui si aggiunge la pienezza dei cinque sensi e delle cinque chiese patriarcali. Dicendo “e riposato de la lunga via”, la Pia identifica il viaggio del suo interlocutore con lo stadio paolino, al termine della corsa che conquista trionfalmente il premio. Della città misurata dallo ‘stadio’, chiamata anche ‘visione di pace’, partecipa la Pia, la quale sta nel gruppo di spiriti “ben nati” e usciti di vita “a Dio pacificati” ai quali si rivolge il poeta proprio in nome della pace (Purg. V, 56, 58-63). Per lei certamente la morte violenta subìta è sentita come «un ricordo di dolce speranza femminile: quella speranza fu illusoria quanto al suo oggetto, ma ben autentica nel soggetto, e vive ancora come sentimento del bene, e si conserva come “gemma” preziosa» [1]. Ma il sentimento realistico, la dolce speranza femminile illusa, è rivissuto da un’anima che spera di diventare “cittadina d’una vera città”, come dirà Sapia senese (Purg. XIII, 94-96). Di questa città chiamata, ad Ap 21, 2, “sposa”, fa segno la Pia. Le fondamenta della città sono ornate con dodici pietre preziose: diaspro, zaffiro, calcedonio, smeraldo, sardonice, cornalina, crisòlito, berillo, topazio, crisopazio, giacinto, ametista (Ap 21, 19-20). Queste gemme sono virtù. Nel “poema sacro” si impersonano nei beati, come nella “luculenta e cara gioia” (Folchetto di Marsiglia, Par. IX, 37) o nelle “molte gioie care e belle” dei solari spiriti sapienti, tanto ineffabili che si trovano solo nella “corte del cielo” e da essa non si possono sottrarre (Par. X, 70-72). Oppure può trattarsi effettivamente di virtù, come nel caso della fede – “questa cara gioia / sopra la quale ogne virtù si fonda” (corrisponde al verde diaspro, prima pietra fondante; cfr. il passo simmetrico di Ap 21, 12, relativo al muro della città, di verde diaspro per viva fede) – dal poeta professata a san Pietro (Par. XXIV, 89-91). Può essere una vera “gemma”, come quella con cui la Pia fu “ ’nnanellata pria / disposando”, che fa però segno di altro.
[1] Cfr. G. INGLESE, in Dante Alighieri, Commedia. Revisione del testo e commento. Purgatorio, Roma 2011, p. 89 (V, 135-136).
Tab. 41
[LSA, cap. II, Ap 3, 12 (Ia visio, VIa victoria)] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et transformationem mentis in ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. Hiis autem promittitur premium de quo sexte ecclesie dicitur: “Qui vicerit, faciam illum columpnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius; et scribam super illum nomen Dei mei et nomen civitatis Dei mei, nove Iherusalem, que descendit de celo a Deo meo et nomen meum novum” (Ap 3, 12). Quod Christus hic vel alibi dicit “Dei mei” vel “a Deo meo”, non dicit nisi tantum ratione sue humanitatis, secundum quam est subiectus Patri et toti Trinitati tamquam Deo suo. Quantum autem ad hoc premium, nota quod quia intrans in Deum recipit intra se Deum, ita quod et Deus intrat in ipsum, ideo hunc duplicem intrandi respectum hic ponit. Primum enim ponit sub typo columpne intra templum existentis et inde non egressure; secundum vero sub typo scripture per quam nomen Dei et sue civitatis inscribitur menti. Et secundum hoc templum significat Deum, prout infra XX[I°] dicitur: “Dominus Deus templum illius est”, scilicet civitatis Dei (Ap 21, 22). Sumendo tamen templum pro ecclesia sustentata a perfectis quasi a columpnis eius, tunc sub alio respectu significatur duplex ingressus. Quia enim et Deum et eius cultum intramus primo per professionis statum, per quem quis in Dei ecclesia et religione statuitur; secundo per contemplationis actum, per quem Deus cum suis operibus apprehenditur, idcirco primum significat per immobilem statum columpne in templo; secundum vero per inscriptionem divinorum in animo.
|
||
Par. XXXI, 43-45, 52-57E quasi peregrin che si ricrea
|
Par. XXIII, 1-15Come l’augello, intra l’amate fronde,
|
|
Tab. 42
[LSA, cap. II, Ap 3, 12 (Ia visio, VIa victoria)] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et transformationem mentis in ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. […] Columpna autem, sic stans, est longa et a fundo usque ad tectum erecta et solida ac sufficienter densa, et rotunda communiter vel quadrata, et firmiter fixa templique sustentativa et decorativa. Sic autem stat in Dei ecclesia vel religione vir evangelicus Christo totus configuratus, sic etiam suo modo stat in celesti curia. […](*sequitur) In huius[modi] autem mente tria inscribuntur, scilicet excessiva visio vel contemplatio deitatis trium personarum, et totius civitatis seu collegii sanctorum, quam dicit descendere de celo a Deo tum quia tota a Deo oritur et sic quod est inferior eo et sua immensitate per celum designata, tum quia per humilitatem non solum Deo sed etiam suo proprio ac celesti loco reputat se indignam, tum quia prout Iherusalem sumitur pro militanti ecclesia descendunt eius gratie a Deo et a hierarchia beatorum.
|
||
Par. XXX, 100-103, 112-114, 130Lume è là sù che visibile face
|
Par. XXXI, 1-12, 16-18, 109-111In forma dunque di candida rosa
|
|
Tab. 43
[LSA, cap. II, Ap 3, 12 (Ia visio, VIa victoria)] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et transformationem mentis in ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. Hiis autem promittitur premium de quo sexte ecclesie dicitur: “Qui vicerit, faciam illum columpnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius; et scribam super illum nomen Dei mei et nomen civitatis Dei mei, nove Iherusalem, que descendit de celo a Deo meo et nomen meum novum” (Ap 3, 12). Quod Christus hic vel alibi dicit “Dei mei” vel “a Deo meo”, non dicit nisi tantum ratione sue humanitatis, secundum quam est subiectus Patri et toti Trinitati tamquam Deo suo. Quantum autem ad hoc premium, nota quod quia intrans in Deum recipit intra se Deum, ita quod et Deus intrat in ipsum, ideo hunc duplicem intrandi respectum hic ponit. Primum enim ponit sub typo columpne intra templum existentis et inde non egressure; secundum vero sub typo scripture per quam nomen Dei et sue civitatis inscribitur menti. Et secundum hoc templum significat Deum, prout infra XX[I°] dicitur: “Dominus Deus templum illius est”, scilicet civitatis Dei (Ap 21, 22). Sumendo tamen templum pro ecclesia sustentata a perfectis quasi a columpnis eius, tunc sub alio respectu significatur duplex ingressus. Quia enim et Deum et eius cultum intramus primo per professionis statum, per quem quis in Dei ecclesia et religione statuitur; secundo per contemplationis actum, per quem Deus cum suis operibus apprehenditur, idcirco primum significat per immobilem statum columpne in templo; secundum vero per inscriptionem divinorum in animo.
|
||
Inf. XV, 82-85ché ’n la mente m’è fitta, e or m’accora,
|
Purg. XXVI, 97-101, 127-132quand’ io odo nomar sé stesso il padre
|
|
Par. XXXIII, 136-138tal era io a quella vista nova:
|
Purg. III, 100-102, 133-135
Così ’l maestro; e quella gente degna
“Tornate”, disse, “intrate innanzi dunque”,
coi dossi de le man faccendo insegna.
Per lor maladizion sì non si perde,
che non possa tornar, l’etterno amore,
mentre che la speranza ha fior del verde.
Tab. 43 bis (cfr. nota)
[LSA, cap. II, Ap 3, 12 (Ia visio, VIa victoria)] […] Et attende quomodo a Deo incipiens et in eius civitatem descendens, reascendit et finit in se ipsum, quia contemplatio incipit in Deo et per Dei civitatem ascendit in Christum eius regem, in quo et per quem consumatissime redit et reintrat in Deum, et sic fit circulus gloriosus. |
|
Par. XXIII, 103-111, 118-120“Io sono amore angelico, che giro
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 4 (IVa visio)] Unde et sextum preconium prerogative ipsorum est indivisibilis et indistans ipsorum ad Christum familiaritas, propter quod subditur: “Et sequuntur Agnum quocumque ierit”. Quantum unusquisque Deum imitatur et participat, in tantum sequitur eum. Qui ergo pluribus et altioribus seu maioribus perfectionibus ipsum imitantur et possident altius et multo fortius ipsum sequuntur. Qui ergo secundum omnes sublimes et supererogativas perfectiones mandatorum et consiliorum Christi ipsum prout est hominibus huius vite possibile participant, “hii sequuntur Agnum quocumque ierit”, id est ad omnes actus perfectionum et meritorum ac premiorum eis correspondentium, ad quos Christus tamquam dux et exemplator itineris ipsos deducit.
|
* Cfr. Ioachim, Expositio, pars VI, distinctio II, f. 203rb-vb.* S. Hieronymi Presbyteri Liber interpretationis hebraicorum nominum, cura et studio P. De Lagarde, Turnholti 1959 (Corpus Christianorum. Series Latina, LXXII), p. 159. La citazione è mediata tramite Isidoro di Siviglia, Etymologiarum, VI, xix, 19-21 (Lindsay, vol. I).* Sancti Aurelii Augustini De doctrina christiana, cura et studio I. Martin, Turnholti 1962 (Corpus Christianorum. Series Latina, XXXII), lib. II, xi, p. 42.* In Ap VI, iii (PL 196, col. 845 D).
|
|
[LSA, cap. XIX, Ap 19, 1.6 (VIa visio)] “Post hoc audivi” (Ap 19, 1). Descripta Babilonis dampnatione, subditur hic festivale gaudium sancte ecclesie quod erit post dampnationem Babilonis. Sicut enim Vasti regina a regno et coniugio regis Assueri abiecta, electa est Hester humilis et sancta ad eiusdem regis conubium et regnum, fecitque ex hoc rex magnificum convivium cunctis principibus et servis suis (cfr. Est 2, 18), sic reiecta sinagoga electa est ecclesia plenitudinis gentium, sicque in sexto statu ecclesie reiecta Babilone adultera oportet spiritalem ecclesiam exaltari et celebre ac spiritale convivium pro eius nuptiis celebrari. In hac igitur parte primo narratur gaudium ex iusta dampnatione Babilonis et ex liberatione sanctorum a servitute ipsius proveniens. Secundo subditur gaudium de exaltatione et clarificatione regni Christi et ex nuptiis Christi et spiritalis ecclesie procedens, ibi: “Et audivi quasi vocem tube magne” (Ap 19, 6). Pro primo dicit: “Post hoc”, id est post dampnationem Babilonis, “audivi vocem magnam quasi tubarum multarum in celo dicentium: Alleluia” (Ap 19, 1). Quot sancti erunt tunc tot erunt et tube, que per Spiritus Sancti vehementem flatum ex intimis visceribus usque ad celum et in totum orbem divinas iubilationes et laudes altissime et effusive resonabunt.
|
|
Par. XXIII, 97-111Qualunque melodia più dolce suona
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 2 (IVa visio, VIum prelium)] Quarto erat suavissima et iocundissima et artificiose et proportionaliter modulata, unde subdit: “et vocem, quam audivi, sicut citharedorum citharizantium cum citharis suis”. […] Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi et sub debitis circumstantiis unam virtutem et eius actus aliis virtutibus et earum actibus pro-portionaliter concordare et concorditer coherere, ita quod rigor iustitie non excludat nec perturbet dulcorem misericordie nec e contrario, nec mititatis lenitas impediat debitum zelum sancte correctionis et ire nec e contrario, et sic de aliis. Cithara etiam est ipse Deus, cuius quelibet perfectio, per affectuales considerationes contemplantis tacta et pulsata, reddit cum aliis resonantiam mire iocunditatis. Cithara etiam est totum universum operum Dei, cuius quelibet pars sollempnis est corda una a contemplatore et laudatore divinorum operum pulsata.[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 22-23 (VIa visio)] Deinde ostendit quomodo omni iocundo cantico seu gaudio, et omni utili et etiam curioso opere et artificio, et iocunda luce et nuptiis erit ex tunc omnino et in eternum privata, unde subdit (Ap 18, 22-23): “Et vox citharedorum” et cetera; “et vox”, id est sonus, “mole”, molentis scilicet triticum vel alia utilia, et cetera; “et vox sponsi et sponse”, id est letitia nuptiarum, “non audietur adhuc”, id est amplius seu de cetero, “in te”.
|
Nota su Par. XXIII, 79-87, 97-111, 118-120 (tab. 43 bis)
■ “E girerommi, donna del ciel, mentre / che seguirai tuo figlio” (Par. XXIII, 106-107). Corrisponde al seguire l’Agnello dovunque vada da parte dei santi contemplativi che stanno con lui sul monte Sion (Ap 14, 4). Il girare deriva dal tema dell’essere “in circuitu sedis”, che più volte appare nella descrizione della sede divina ai capitoli IV e V. Per esempio, i quattro esseri viventi e i ventiquattro seniori che hanno le cetre e le fiale (Ap 5, 8) e che cantano il canto nuovo (Ap 5, 9) stanno “in circuitu” (Ap 4, 4.6); gli esseri viventi sono “in circuitu ambulantes” (Ap 4, 6).
L’accenno dell’angelo all’ingresso di Maria nell’Empireo – “e farai dia / più la spera supprema perché lì entre” (Par. XXIII, 107-108) – introduce il tema dell’ingresso in Cristo proprio della sesta vittoria (Ap 3, 12). L’ingresso in Cristo, che avviene con la contemplazione, è indicato con lo scrivere nella mente il nome di Dio, il nome della nuova Gerusalemme che discende dal cielo e il nuovo nome di Cristo. In primo luogo, viene inscritta la visione e la contemplazione della divinità delle tre persone. In secondo luogo, la visione della città, ossia del collegio dei santi, che discende dal cielo. In terzo luogo, viene inscritta la visione di Cristo uomo, nostro redentore e mediatore. E come la città discende da Dio e poi a lui ritorna, così la contemplazione, formando un circolo glorioso, inizia da Dio e per la città di Dio ascende in Cristo suo re, da dove ritorna e rientra in Dio. Il motivo del “circulus gloriosus”, che si ritrova nella “circulata melodia” dell’“amore angelico” (Par. XXIII, 109), si realizza nel discendere delle schiere del trionfo di Cristo, con Cristo nella sua umanità e con Maria, al cielo Stellato dall’Empireo per poi risalirvi, prima Cristo (Par. XXIII, 85-87), poi Maria (vv. 118-120), infine i beati (Par. XXVII, 67-72). Così nell’ottavo cielo si verifica la visione della Gerusalemme che discende. La visione della Trinità, insieme a quella dell’umanità di Cristo, avverrà nell’Empireo (Par. XXXIII, 115-145). Poiché è proprio del sesto stato imprimere con il sigillo, come affermato nel notabile III del prologo, “la circulata melodia / si sigillava” (cfr. Par. VII, 67-69; XXIV, 142-144).
Si noterà come i signacula relativi alla sesta vittoria, già presenti nell’ottavo cielo (giro, entre, circulata: Par. XXIII, 103, 108-109), si ripropongano più intensamente nell’Empireo (dove, appunto, Maria ‘entra’), prima nella sua descrizione (vedere, pace, circular, fatto ha ritorno, città, gira: Par. XXX, 102-103, 114, 130), poi nella visione finale dell’Incarnazione (circulazion, vista nova: Par. XXXIII, 127, 136). Il poeta appropria a sé, ma in senso negativo, il motivo del seguire l’Agnello che fa parte della lode angelica: “[…] prout est hominibus huius vite possibile participant, “hii sequuntur Agnum quocumque ierit” […] – però non ebber li occhi miei potenza / di seguitar la coronata fiamma / che si levò appresso sua semenza” (Par. XXIII, 118-120).
■ “E farai dia / più la spera supprema perché lì entre” (Par. XXIII, 107-108). Si mostra qui, con due parole-chiave (dia, supprema), l’esegesi della gloria del volto di Cristo sommo pastore (Ap 1, 16-17: “virtus sue divinitatis […] huiusmodi immutatio intimius et certius facit ipsum videntem experiri visionem esse arduam et divinam et a causis supremis”), la cui virtù riluce tutta nella chiarezza meridiana incomparabilmente più del sole (decima perfezione). Ma questa sublime virtù di Cristo trasfigurato, impressa nei sottoposti, rende tremante chi la guarda (undicesima perfezione). Questi motivi, propri anche di Beatrice a Par. XXVI, 10, 12 (dia, la virtù), si manifestano nell’argomentare di Tommaso d’Aquino circa la suprema perfezione della natura umana conseguita in Adamo e in Cristo (Par. XIII, 73-78). La luce dell’idea divina, afferma l’Aquinate, parrebbe tutta se la natura fosse perfettamente disposta e il cielo fosse nella sua virtù suprema (“in tota virtute sua lucet […] et divinam et a causis supremis – e fosse il cielo in sua virtù supprema, / la luce del suggel parrebbe tutta”). Ma la natura rende sempre il sigillo della luce divina in maniera imperfetta, come l’artista a cui trema la mano; cioè, come scritto nell’esegesi, questa sublime virtù di Cristo trasfigurato, impressa nei sottoposti (che corrispondono alla cera o alla materia), rende tremante chi la guarda (“[…] ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio […] – Se fosse a punto la cera dedutta […] ch’a l’abito de l’arte ha man che trema”; si inserisce il tema dell’artista inesperto, da Ap 14, 2, mentre numerosi altri punteggiano il parlare di Tommaso).
■ I temi presenti nell’esegesi di Ap 19, 1 offrono materia per numerosi sviluppi. Ivi viene descritto il festoso gaudio della Chiesa che segue la dannazione di Babylon. Come, allorché venne ripudiata la regina Vasti dal regno e dal connubio del re Assuero e fu eletta l’umile e santa Ester quale sposa e regina, il re fece un grande banchetto con tutti i suoi principi e servi (Est 2, 18), e lo stesso avvenne in occasione del ripudio della Sinagoga quando fu eletta la Chiesa della pienezza delle genti, così nel sesto stato, ripudiata l’adultera nuova Babilonia, conviene sia esaltata la Chiesa spirituale e celebrato un convivio per le sue nozze. Dapprima si narra pertanto la gioia per la giusta dannazione di Babylon e per la liberazione dei santi dalla servitù: “Dopo ciò”, cioè dopo la dannazione, “udii una gran voce come di molte trombe in cielo che dicevano: alleluia”. Quanti saranno allora i santi altrettante saranno le trombe risonanti, per mezzo del veemente soffio dello Spirito Santo, dalle viscere più profonde fino al cielo e in tutto l’universo, lodi altissime e diffuse di gioia divina. E poiché un gran numero di Giudei e di Gentili, Greci e Latini, allora entrerà in Cristo con spirito grande e alto, molte saranno le trombe risonanti per le grandi voci degli intelletti spirituali e degli affetti, al modo con cui si celebra annualmente la solennità delle Palme, nella quale Cristo venne glorificato da molti popoli. Le turbe che precedono designano i Greci, quelle che seguono i Latini, quelle che vengono incontro alla discesa del monte degli Ulivi i Giudei, tra i quali sono i fanciulli. Tutti costoro cantavano “Osanna al Figlio di Davide”, e gloria, lode e onore sia a te, Cristo redentore (Mt 21, 9). Poiché allora l’intelletto spirituale del terzo stato generale, insieme con tutti gli altri, verrà aperto in modo chiarissimo, esso procederà dalle trombe delle diverse storie, figure e misteri risonanti con mirabile concordia e provocanti i santi all’ineffabile lode di Dio designata con “alleluia”, parola ebrea che significa lodare Dio. Secondo Girolamo, infatti, “Ya” è in ebraico uno dei dieci nomi di Dio e viene cantato comunemente nella Chiesa con grande melodia (neuma) per indicare quell’ineffabile e gioiosa lode di Dio che non può essere espressa con parole. E secondo Agostino, “amen” e “alleluia” sono rimaste senza traduzione per riverenza. Secondo Riccardo di San Vittore, ad “alleluia”, che è ignoto, aggiunge ciò che è noto dicendo: “lode e gloria e virtù al nostro Dio”, cioè è o sia e venga resa o attribuita da noi. Dice “lode” rispetto a noi che lo dobbiamo lodare; “gloria” per la sua essenziale e immensa beatitudine allora resa chiara ai suoi santi in modo singolare; “virtù” a motivo della sua onnipotenza per cui ha atterrato Babilonia e ha mirabilmente esaltato gli eletti.
Ap 19, 1 è luogo di riferimento importante (sempre in collazione con altri passi), dalla gaudiosa festa di Par. XII, 22-24 alla “gran cena del benedetto Agnello” di Par. XXIV, 1ss., ai vari modi di cantare Osanna; ma anche dagli “spiriti magni” del Limbo (Inf. IV, 118-120) agli “spiriti … di gran voce” del cielo di Marte (Par. XVIII, 31-33). Ad esso riconduce anche la lode dell’“amore angelico”. Alcuni motivi – la virtù, la potenza e l’esaltare – si trovano con diversa appropriazione in Par. XXIII, 85-87, nell’esaltarsi della divina virtù di Cristo, cioè nel suo sollevarsi in alto verso l’Empireo, per dare agli occhi del poeta, che non erano possenti, la possibilità di guardare (il “largirmi loco”, che proviene dall’inciso “tuncque congrue instituta est vita condescensiva, ut nequeuntibus in arduis perdurare daretur locus gratie in mediocri statu” del notabile V del prologo, è una forma di “condescensio” che Cristo opera innalzandosi). Da notare che exaltavit electos, nell’ottavo cielo attribuito alla virtù di Cristo (“sù t’essaltasti”), nel Limbo appartiene a Dante: “mi fuor mostrati li spiriti magni, / che del vedere in me stesso m’essalto” (Inf. IV, 119-120).
Il tema della tromba che risuona nel festoso gaudio si precisa, ad Ap 19, 6, come “voce di molte acque”. Secondo Gioacchino da Fiore, a iniziare la lode è un santo quasi fosse la grande tromba di Dio, alla cui voce la lode subito risuona su molte bocche come la voce di molte acque, la quale, fatta più ampia nel suo estremo quasi quella di grandi tuoni, perviene fino ai confini della terra. Alla triplice specie della voce corrisponde una triplice proprietà o perfezione della lode: è efficace nell’ammonire come la voce di una grande tromba, irriga con la multiforme devozione e compunzione come la voce di molte acque, aliena nello stupore estatico quasi assorbendo la mente e scuotendo nell’intimo come la voce di grandi tuoni. Fra le tante variazioni dei passi simmetrici relativi alla “vox aquarum multarum” (Ap 1, 15; 14, 2; 19, 6) vi è quella nell’Eden, allorché uno dei vegliardi, quasi messo del cielo, grida cantando per tre volte le parole del Cantico dei Cantici 4, 8 “Veni, sponsa, de Libano”, seguito da tutti gli altri, “cento” angeli i quali, “ad vocem tanti senis”, si levano sul carro come i beati al suono della tromba del giudizio finale risorgeranno ciascuno dalla propria tomba cantando alleluia con la voce rivestita degli organi corporei (Purg. XXX, 10-18). Nella melodia dell’amore angelico (Par. XXIII, 97-102) prevale, fra i motivi offerti dalla voce di Ap 19, 6, lo stupore estatico che assorbe la mente: “Qualunque melodia più dolce suona / qua giù e più a sé l’anima tira (la dolcezza e il tirare sono motivi connessi al suonare la cetra da Ap 14, 2, che è pure “voce di molte acque”), / parrebbe nube che squarciata tona (il tema della “vox tonitruorum magnorum” serve da contrasto alla dolcezza della voce), / comparata al sonar di quella lira (la cetra di Ap 14, 2) / onde si coronava il bel zaffiro / del qual il ciel più chiaro s’inzaffira” (si introduce il tema dello zaffiro da Ap 21, 19, una delle dodici pietre preziose che adornano le fondamenta della città celeste la quale, simile al cielo sereno, quando è colpita dai raggi del sole risplende di ardente fulgore e per questo significa la certa e fervida speranza delle cose celesti: i motivi sono presenti anche ai versi 82-84, nelle “… più turbe di splendori, / folgorate di sù da raggi ardenti”; il verbo “mei” e il sostantivo “ombra”, rispettivamente ai vv. 79 e 81, rinviano invece ad Ap 22, 1-2). Mentre l’amore angelico gira “l’alta letizia” finché entrerà nella sfera suprema (ad Ap 18, 22-23 la letizia nuziale è accostata alla «“vox”, id est sonus, “mole” molentis», cioè al suono di una ruota che gira; le parole “melodia” e “nome” sono accostate ad Ap 19, 1), “tutti li altri lumi / facean sonare il nome di Maria”, rispondendo alla lode espressa nella “circulata melodia”, come gli angeli nell’Eden si levano “ad vocem tanti senis” (“statim resonabit laus in ore multorum”: Ap 19, 6).
Non è senza significato il fatto che a Par. XXIII, 111 “Maria” rima con melodia (v. 109). “Il nome del bel fior” racchiude nelle due lettere finali un altro nome, di lode non traducibile: “Nam, secundum Ieronimum, ia est in hebreo unum de decem nominibus Dei, cantaturque communiter in ecclesia cum grandi melodia et neupmate ad designandum illum ineffabilem iubilum laudis Dei qui verbis exprimi non potest. – Così la circulata melodia / si sigillava, e tutti li altri lumi / facean sonare il nome di Maria». “Apocalipsis”, “alleluia”, “amen” sono i nomi intraducibili dei quali è vestita Beatrice.
III.7 “La prima equalità” (Tab. 44)
I quattro lati delle mura della Gerusalemme celeste, descritta nella settima visione, formano un quadrilatero (Ap 21, 16), che designa la solida quadratura delle virtù (a Cacciaguida il poeta dice di sentirsi “ben tetragono ai colpi di ventura”, Par. XVII, 23-24). I quattro lati sono uguali in lunghezza e in larghezza. La città dei beati quanto vede di Dio e dei suoi beni tanto ama, quanto è lunga nella visione tanto si dilata nella carità, quanto si prolunga nell’eterno tanto si dilata nel gaudio giocoso e glorioso. Lo stesso può dirsi di coloro che in questa vita raggiungono la perfezione, i quali quanto conoscono o credono tanto amano, quanto per la speranza si protendono nei beni eterni tanto si dilatano nel gaudio. Nei beati le quattro virtù cardinali – prudenza, fortezza, giustizia e temperanza -, designate dai quattro lati della città, hanno uguale misura. Anche l’altezza è uguale alla lunghezza e alla larghezza, poiché quanto i beati per la visione e per l’amore si protendono in lungo e si dilatano in largo, tanto si elevano nell’alta lode e nella reverenza verso Dio e nell’alto apprendimento e degustazione della sua sublime maestà. Tuttavia in questa vita l’altezza, proporzionata alla misura della carità e del tendere in Dio, sta comunemente solo nel desiderio e nella speranza di raggiungere la compiuta misura della patria celeste. Un edificio si pone infatti diversamente nel suo inizio e nella perfezione del fine.
Anche un sommario esame rivela quanto siano importanti questi temi nel Paradiso. La citazione di Gioacchino da Fiore sottolinea come l’uguaglianza dei lati della città designi la somma concordia dei beati nel regno di Dio. Beatrice, spiegando la differenza tra l’ordine celeste e quello del mondo, definisce il Primo Mobile come la sfera corporea corrispondente al primo dei cerchi angelici, i Serafini, “che più ama e che più sape” (la larghezza e la lunghezza si equivalgono), invitando Dante ad applicare la sua misura (il misurare la città) al criterio della virtù (i lati della città designano le virtù) e non a quello della grandezza apparente dei cerchi (Par. XXVIII, 70-78). Più avanti la donna dice che tutte le intelligenze “hanno diletto” (il godere giocoso proprio della larghezza e anche la degustazione propria dell’altezza) quanto è profonda la visione di Dio (la lunghezza; vv. 106-108). Soggiunge che l’essere beato si fonda nell’atto della visione, non nell’atto dell’amore, il quale consegue dal primo (Par. XXVIII, 109-111; cfr. Par. XXIX, 139-140). Secondo molti interpreti qui Dante accoglie la tesi tomista che fa precedere nella beatitudine l’atto dell’intelletto a quello della volontà se non nel tempo, almeno nella natura e nell’origine. Ernesto Buonaiuti notò una contraddizione tra la terzina di Par. XXVIII, 109-111 e la definizione del Primo Mobile come corrispondente “al cerchio che più ama e che più sape” (v. 72), dove invece prevarrebbe la tesi volontaristica francescana in quanto, in questo caso, l’amare è posto prima del sapere [1]. La questione viene affrontata dallo stesso Olivi ad Ap 21, 22, dove i due atti – la “visio” e il “beatificus actus caritatis” – sono considerati tanto compenetrati che nessuno dei due può ritenersi perfetto senza l’altro. Lo stesso Olivi, però, nel Notabile X del prologo della Lectura, afferma che non si può amare se non quello che si conosce, e che quindi la “notitia” precede l’amore come il terzo stato dei dottori (l’intelletto) precede storicamente il quarto stato degli anacoreti (l’affetto). La stessa questione viene posta nella domanda che Dante fa a Francesca: “Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, / a che e come concedette amore / che conosceste i dubbiosi disiri?”, e riecheggiata nella risposta: “Ma s’a conoscer la prima radice / del nostro amor tu hai cotanto affetto, / dirò come colui che piange e dice” (Inf. V, 118-120, 124-126).
Nei beati, come sa Dante che si rivolge a Cacciaguida, “l’affetto e ’l senno” (la larghezza e la lunghezza) sono di pari peso dal momento in cui essi hanno cominciato a contemplare Dio (definito, per restare nel medesimo ambito tematico, “la prima equalità ”, il sole uguale nel calore della carità e nella luce della visione), diversamente dai mortali, nei quali “voglia e argomento” (corrispondenti all’affetto e al senno) hanno ali disuguali (Par. XV, 73-84).
Al termine del viaggio, la lunghezza (“il mio disio”, che esprime anche l’altezza, “secundum mensuram sue tensionis”, e dunque la “sete natural” di cui a Purg. XXI, 1-4) e la larghezza (“’l velle”) saranno in Dante “sì come rota ch’igualmente è mossa” (Par. XXXIII, 143-145). Lo Spirito di Cristo, nell’invitare alla gloriosa cena delle nozze dell’Agnello, dice: “Et qui sitit veniat. Et qui vult accipiat aquam vite gratis”, perché, aggiunge Olivi, “nullus cogitur nec potest venire nisi per desiderium et voluntarium consensum” (ad Ap 22, 17).
Nella descrizione dell’empirea rosa, la fiumana luminosa, che prima appariva in lunghezza, successivamente diviene tonda distendendosi in figura circolare, con una circonferenza che sarebbe cintura “troppo larga” per il sole (Par. XXX, 88-90, 103-105). La rosa sempiterna “si digrada” (si allunga nel senso di protendersi), “e dilata” (si allarga) “e redole / odor di lode al sol che sempre verna” (l’elevarsi dell’altezza; vv. 124-126). Il digradare fa comunque riferimento ai “gradi”, che nella misura della città sono uguali per ciascun lato: secondo Gioacchino da Fiore, ovunque si ritrova il numero 6, in quanto il senario, riflesso su sé stesso ed elevato in alto, dà 36, e 36.000 (6 volte 6000) si ottiene dividendo 144.000 (dodici volte la misura della città, che è di 12.000 stadi) per i 4 lati.
Nel riferire l’ultima visione, Dante prima ricorda “l’abbondante grazia ond’ io presunsi / ficcar lo viso per la luce etterna” (la visione corrisponde alla lunghezza), poi afferma di aver visto la forma universale del nodo che unisce tutte le cose perché, dicendo ciò, prova un godimento più largo (i perfetti, i quali “in gaudio dilatantur” in questa vita, designano la larghezza; Par. XXXIII, 82-93). Il vedere del poeta è tanto più sincero quanto più entra nel raggio dell’alta luce (vv. 52-54), che tanto si eleva sui concetti mortali (vv. 67-68: l’altezza).
Pier Damiani ‘pareggia’, cioè rende uguale, la chiarezza della visione di Dio (“la vista mia, quant’ ella è chiara”) con “l’allegrezza ond’ io fiammeggio” – in lui sono pertanto uguali la lunghezza della visione e la larghezza del gaudio che deriva dalla carità – e, grazie alla virtù della luce divina che si congiunge con il suo vedere, può levarsi tanto sopra di sé (uguaglianza dell’altezza) nell’intelligenza della somma essenza (Par. XXI, 82-90).
I temi di Ap 21, 16 (l’uguaglianza dei lati della Gerusalemme celeste) si intrecciano, in diverse appropriazioni, con quelli di Ap 1, 16-17 (il chiaro splendore del volto di Cristo che più riluce nel meriggio del sesto stato): è il caso della larghezza-allegrezza e dell’altezza-speranza rispettivamente in Par. XXXII, 85-90 (la festa degli angeli sopra Maria) e XXV, 25-33 (Beatrice, ridendo, si rivolge a san Giacomo; il ridere rende lo “splendor faciei” di Cristo; cfr. infra; da rilevare la variante chiarezza, che rinvia ad Ap 1, 16, rispetto a carezza).
[Per più ampio esame cfr. La settima visione, I.3].
[1] E. BUONAIUTI, Storia del Cristianesimo, II, Milano 19472, pp. 537-538: “Ma come nell’animo di Dante l’intellettualismo tomistico e il volontarismo cistercense-francescano si mantenessero giustapposti, senza elidersi né sopraffarsi, appare dalla contraddizione in cui è lasciata cadere Beatrice, quando, nel canto XXVIII del Paradiso, spiegando il movimento dei cerchi angelici, afferma una volta tomisticamente che l’amore poggia sul conoscere […] e afferma un’altra volta, francescanamente, che il conoscere poggia sull’amare”.
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 16 (VIIa visio)] “Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum.
|
||
Par. XV, 73-84Poi cominciai così: “L’affetto e ’l senno,
|
Par. XXX, 88-90, 100-105, 115-120, 124-126e sì come di lei bevve la gronda
|
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (Ia visio)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
||
III.8 Il volto di Cristo sorridente (Tab. 45-50)
Fra le tante appropriazioni agli individui, registrabili nella Commedia, delle prerogative di Cristo descritte nella Lectura super Apocalipsim, eccellono quelle proposte ad Ap 1, 16-17. Si tratta della decima e undecima perfezione di Cristo sommo pastore, premesse alla prima visione. Queste perfezioni, afferma l’Olivi, possono adattarsi ai prelati, ma anche agli eletti, membra del corpo mistico di Cristo:
Notandum autem quod perfectiones predicte possunt anologice coaptari perfectis prelatis sub Christo, ita quod eorum perfectiones ascribantur Christo sicut cause efficienti et exemplari. Possunt sibi etiam ascribi tamquam capiti corporis mistici, et tunc per membra Christi hic posita possunt significari diversi electi, qui sunt mistica membra Christi, puta per oculos contemplativi, per pedes activi, per os autem seu per vocem doctores et iudices seu correctores.
La decima perfezione consiste nell’incomprensibile gloria che deriva a Cristo dalla chiarezza e dalla virtù, per cui si dice: “e la sua faccia riluce come il sole in tutta la sua virtù” (Ap 1, 16). Il sole riluce in tutta la sua virtù nel mezzogiorno, quando l’aere è sereno, fugata ogni nebbia o vapore grosso. Allora il viso corporeo di Cristo ha incomparabilmente più luce e vigore, e ciò designa l’ineffabile chiarezza e virtù della sua divinità e della sua mente. Lo splendore del volto indica l’aperta e fulgida conoscenza della Sacra Scrittura, che deve raggiare in modo più chiaro nel sesto stato, prefigurata dalla trasfigurazione sul monte avvenuta dopo sei giorni e designata dall’angelo che, al suono della sesta tromba, ha la faccia come il sole (cfr. Ap 10, 1).
L’undecima perfezione sta nell’imprimere negli inferiori, di fronte a tante sublimità, un sentimento di umiliazione, di tremore e di adorazione, per cui si dice: “e vedendolo”, cioè tanto e tale, “caddi ai suoi piedi come morto” (Ap 1, 17). Il cadere (è da intendere che Giovanni cadde col viso a terra in atto di adorazione, perché il cadere supino è segno di disperazione) è causato sia dall’intollerabile eccesso dell’oggetto visto, sia dall’influsso dell’angelo o dell’assistente divino che incute terrore e provoca un sentimento di mutazione, sia dalla materiale fragilità del soggetto o dell’organo visivo. Proprio il senso di intimo mutare rende colui che vede esperto del fatto che si tratta di una visione ardua, divina e derivata da cause supreme. Sentirsi annullato predispone a ricevere le visioni divine in modo più umile e timorato, e significa che la virtù e la perfezione dei santi provoca tremore e umiliazione negli inferiori. Significa anche che l’ascesa alla contemplazione divina avviene unicamente tramite l’oblio, la negazione, la mortificazione di sé stessi e la privazione di ogni cosa.
I signacula di questa esegesi del volto di Cristo che irradia, nel sesto stato, più luce e più rivelazione della Scrittura, percorrono tutta la terza cantica a partire dal principio, con la gloria della divina virtù che risplende, con l’essere il poeta disceso dal “ciel che più de la sua luce prende” (Par. I, 1-2, 4, 22). Lo splendor faciei di Cristo, che si incarna nel sorriso di Beatrice, discorre per tutto il Paradiso, con variazioni della rosa semantica che lo costella: l’essere più lucente, la troppa luce, il mettere in oblio, l’intimo accorgersi di più ardua visione. All’esegesi di queste due perfezioni di Cristo sommo pastore rimandano le parole incastonate nei versi come pietre miliari, a ricordare una dottrina poeticamente rivestita. Le variazioni, compiutamente mostrate in altra sede, non sono solo interne al ristretto passo esegetico (Ap 1, 16-17), ma coinvolgono altri luoghi della Lectura. Un lettore ‘spirituale’, di fronte al ridere di Beatrice, avrebbe senz’altro rammentato l’esegesi del volto solare di Cristo. Non nel senso di una reale identificazione, ma della conformità che nasce dal seguirlo.
(Tab. 45)
■ Beatrice, nell’attesa che le schiere del trionfo di Cristo discendano dall’Empireo al cielo Stellato, “stava eretta / e attenta, rivolta inver’ la plaga / sotto la quale il sol mostra men fretta” (Par. XXIII, 10-12), cioè verso mezzoggiorno quando, secondo l’esegesi di Ap 1, 16, il volto di Cristo si mostra, come il sole, di più luminoso splendore in tutta la sua virtù e chiarezza. È un sole che accende “migliaia di lucerne”, “quale ne’ plenilunïi sereni / Trivïa ride tra le ninfe etterne / che dipingon lo ciel per tutti i seni” (vv. 25-30). La luna che ride e accende le stelle appare con lo stesso splendore del sole-Cristo che illumina i beati; la similitudine raffigura il passo di Isaia 30, 26 “Erit lux lune sicut lux solis”, incipit della Lectura super Apocalipsim.
All’arrivo delle schiere, Beatrice dice a Dante di guardarla – “Apri li occhi e riguarda qual son io” -, perché egli ha veduto tali cose – “la lucente sustanza tanto chiara / nel viso mio, che non la sostenea”, cioè Cristo, che “è virtù da cui nulla si ripara” – che hanno reso la sua facoltà visiva disposta a sostenere il proprio sorriso (Par. XXIII, 31-36, 46-48). Il poeta è “come quei che si risente / di visïone oblita e che s’ingegna / indarno di ridurlasi a la mente” (vv. 49-51), deve rinunciare a cantare “il santo riso” (il sacro poema lo ‘salta’ nel descrivere il paradiso) perché il suo è omero mortale che si fa carico del “ponderoso tema”, e chi questo pensasse “nol biasmerebbe se sott’ esso trema” (vv. 55-69). Nei versi si ritrovano motivi da Ap 1, 16-17: la “claritas” e la “virtus” di Cristo, sole che accende migliaia di lucerne, cioè di anime luminose; l’“aperta et superfulgida notitia scripture sacre” raggiante nel sesto stato della Chiesa, che corrisponde all’invito di Beatrice al poeta di aprire gli occhi; lo “splendor faciei”, che è lo stesso sorriso della donna, come nella similitudine di Trivia; la fragilità dell’organo visivo; l’“oblivio sui”, sperimentato da Dante alle parole di Beatrice che lo richiamano dalla visione di Cristo che lo aveva fatto uscir di mente; la “tremefactio intuentium”, per cui il poeta trema nel tentativo, cui dice di rinunciare, di cantare l’aspetto della sua donna; l’arditezza della visione, che si traspone nell’ “ardita prora” del poema sacro.
La “lucente sustanza”, che “per la viva luce trasparea” (Par. XXIII, 31-32), deriva da Ap 22, 1, dall’esegesi del fiume che scorre nel mezzo della Gerusalemme celeste, il quale indica la sostanza della grazia e della gloria della somma Trinità che viene comunicata a tutti i beati e che procede ed è dispensata dal Cristo uomo e fa trasparire nelle sue acque vive, come in un cristallo solido e perspicuo, la luce della somma sapienza.
In Par. XXIII fanno da contrappunto ad Ap 1, 16-17 anche le proprietà di almeno quattro delle dodici tribù d’Israele da cui proverranno i segnati all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 6-8), quasi a voler significare una graduale ascesa alla perfezione “ad perfectum … nexum amoris”: la quarta tribù, Aser (“amor ad superna elavatus”): beatus, pinguis → Bëatrice, più pingue; la quinta, Neptalim (“amor ad fraterna dilatatus”: la virtù per cui ci si dilata all’eterno da ciò che è temporale, cosicché questo sia specchio dell’altro): se … dilatat → per dilatarsi; la sesta, Manasse (“amor inferiorum oblitus”: una volta passati all’intellettuale dal sensibile, sopravviene l’oblio di questo come una liberazione da veli tenebrosi): oblitus → oblita (hapax nella Commedia). Si aggiunge anche Isachar, la nona tribù rappresentante l’assiduo e fervido sospirare verso la ricompensa dell’eterna gloria che per essa si sottopone a ogni servizio di Dio e dei suoi: omni servituti Dei et suorum se subiciens … subposuit humerum suum ad portandum → in che gravi labor li sono aggrati … e l’omero mortal che se ne carca.
■ La stessa materia offerta da Ap 1, 16-17 e da Ap 22, 1, appropriata nell’ottavo cielo a Cristo e al riso di Beatrice, è stata già utilizzata, nell’Eden, per lo svelamento della donna “ne l’aere aperto” e, ancor prima, per descrivere il riflettersi del grifone-Cristo nei suoi occhi (Purg. XXXI, 121-126, 139-145). Nell’Eden, che sta in terra, Beatrice è “luce” e “gloria de la gente umana” (Purg. XXXIII, 115), prerogative del sommo pastore nella sua decima perfezione. Di esse partecipa anche Matelda, nel ridere paragonato al lume che risplendeva “sotto le ciglia a Venere, trafitta / dal figlio fuor di tutto suo costume” (Purg. XXVIII, 64-69).
■ I temi da Ap 1, 16-17 fasciano ancora il senso di annullamento e di oblio provato da Dante, sulla soglia dell’Empireo, di fronte alla bellezza di Beatrice, alla quale egli è tornato con gli occhi dopo l’estinguersi alla sua vista del trionfo dei cori angelici attorno al punto luminoso “che mi vinse”. Il solo ricordo “del dolce riso” – il ridere rende lo “spendor faciei” di Ap 1, 16 – annulla le facoltà della sua mente: “ché, come sole in viso che più trema, / così lo rimembrar del dolce riso / la mente mia da me medesmo scema” (Par. XXX, 25-27). L’espressione “come sole in viso che più trema” cuce i temi della decima perfezione di Cristo (“sicut sol”) e dell’undecima (la “tremefactio intuentium”), con il “più” trasferito dalla luce dell’una al rendere tremanti dell’altra. È da notare il riferimento all’ora sesta, cioè meridana, che “ferve” (vv. 1-2) e al trasmodare della bellezza della donna (vv. 19-21, “si trasmoda” è hapax nel poema), che corrispondono al sesto stato e alla trasfigurazione avvenuta dopo sei giorni. Il poeta si dichiara vinto: “Da questo passo vinto mi concedo / più che già mai da punto di suo tema / soprato fosse comico o tragedo” (vv. 22-24).
Tab. 45
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. XXIII, 4-6, 10-12, 25-72 (cfr. incipit)
|
Par. XXX, 1-2, 10-15, 19-21, 25-27Forse semilia miglia di lontano
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 6-7 (IIa visio, apertio VIi sigilli)][IV-Aser] Quarto exigitur patientia glorians et gaudens in tribulationibus, quam designat Aser, qui interpretatur beatus et de quo dicitur: “Aser pinguis panis eius, tingat in oleo pedem suum” (Gn 49, 20; Dt 33, 24). Quid enim beatius et pinguius aut magis fortificativum cordis quam sic se habere in adversis ac si suavi oleo inungeretur?[V-Neptalim] Quinto exigitur virtus sciens ex omnibus sensibilibus se comparative transferre ad spiritualia et eterna, ita quod numquam assumit sensibilia et temporalia nisi ut signa et specula intellectualium, et ex innumera multiformitate sensibilium se multiformiter dilatat in contemplatione intellectualium. Hec autem designatur per Neptalim, qui interpretatur comparatio vel conversio, scilicet translativa, vel latitudo.[VI-Manasse] Sexto exigitur oblivio ipsorum sensibilium. Postquam enim ex eis tamquam ex relativis signis et speculis ascendimus ad intellectualia, debemus oblivisci ipsorum ut denudemur ab eis tamquam a velaminibus tenebrosis, et hoc designatur per Manasse, qui interpretatur oblivio. […] Ad perfectum autem nexum amoris exiguntur tria, scilicet amor ad superna elavatus et ad fraterna dilatatus et inferiorum oblitus.[IX – Isachar] Nono exigitur assidua et fervens suspiratio ad mercedem eterne glorie omni servituti Dei et suorum se subiciens pro illa, et hanc designat Isachar, qui interpretatur merces, de quo dicit Iacob: “Isachar asinus fortis; vidit requiem quod esset bona, et terram quod optima, et subposuit humerum suum ad portandum”, scilicet omne honus propter illam, “factusque est tributis serviens” (Gn 49, 14-15). |
|
(Tab. 46)
Quanto è riferito alla decima e undecima perfezione di Cristo sommo pastore può congiungersi con altre perfezioni della stessa serie: ad esempio in Par. XV, 71, dove l’espressione “e arrisemi un cenno”, riferita a Beatrice, cuce lo splendore nel sorridere con quello che deriva dallo zelante guardare con occhi di fuoco ogni atto, intenzione, cenno altrui (Ap 1, 14; quinta perfezione). La contaminazione dei due passi si registra ancora nell’incontro fra Stazio e Virgilio (Purg. XXI, 109-114; XXII, 25-27).
San Bernardo invita Dante a riguardare “ne la faccia che a Cristo / più si somiglia, ché la sua chiarezza / sola ti può disporre a veder Cristo” (Par. XXXII, 85-87): « … sue claritatis … “et facies eius …”». Maria, nella preghiera, è “meridïana face / di caritate” (Par. XXXIII, 10-11) – «“et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie» (si noti la concordia fonica tra “facies”-faccia e “face”-fiaccola). Dopo, Bernardo accenna e sorride affinché il poeta si volga all’alta luce (vv. 49-50).
Nella visione finale dell’Incarnazione, il sorriso appartiene alla “… luce etterna che sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente te ami e arridi”, mentre il vedere con occhi di fuoco è trasferito sul poeta che contempla: “Quella circulazion che sì concetta / pareva in te come lume reflesso, / da li occhi miei alquanto circunspetta” (Par. XXXIII, 124-129).
Così, a Par. XX, 13-15, nel primo verso – “O dolce amor che di riso t’ammanti” -, il sorridere (decima perfezione) e l’ammantarsi (terza, Ap 1, 13: la santità del manto sacerdotale) si riflettono “in que’ flailli, / ch’avieno spirto sol di pensier santi”, cioè nelle luci che formano l’aquila. L’esegesi del manto (“vestitum podere”) è tela su cui il poeta sovrappone numerosi ricami.
Tab. 46
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
||
Par. XV, 70-72Io mi volsi a Beatrice, e quella udio
|
||
Par. XXXIII, 10-12, 49- 51, 124-129
|
Purg. XXI, 109-114; XXII, 25-27
Io pur sorrisi come l’uom ch’ammicca;
per che l’ombra si tacque, e riguardommi
ne li occhi ove ’l sembiante più si ficca;
e “Se tanto labore in bene assommi”,
disse, “perché la tua faccia testeso
un lampeggiar di riso dimostrommi?”.
Queste parole Stazio mover fenno
un poco a riso pria; poscia rispuose:
“Ogne tuo dir d’amor m’è caro cenno”.
Par. XXXII, 85-87
Riguarda omai ne la faccia che a Cristo
più si somiglia, ché la sua chiarezza
sola ti può disporre a veder Cristo.
[LSA, cap. I, Ap 1, 13-14 (radix Ie visionis)] Tertia (perfectio summo pastori condecens) est sacerdotalis et pontificalis ordinis et integre castitatis et honestatis sanctitudo, unde subdit: “vestitum podere” (Ap 1, 13). Poderis enim erat vestis sacerdotalis et linea pertingens usque ad pedes, propter quod dicta est poderis, id est pedalis: pos enim grece, id est pes latine. Poderis enim, secundum aliquos, erat tunica iacinctina pertingens usque ad pedes, in cuius fimbriis erant tintinabula aurea, et de hac videtur dici illud Sapientie XVI[II]° (Sap 18, 24): “In veste poderis, quam habebat, totus erat orbis terrarum, et parentum magnalia in quattuor ordinibus lapidum erant sculpta”. […]
Quinta (perfectio summo pastori condecens) est contemplationis speculative et practice zelativus et perspicax fervor et splendor, omnes actus et intentiones et nutus ecclesiarum circumspiciens, unde subdit: “et oculi eius velut flamma ignis” (Ap 1, 14).
(Tab. 47-50)
L’arte della memoria per parole-chiave non serviva soltanto ai religiosi. Il fatto che gruppi di terzine numericamente corrispondenti, a diversi stadi della Commedia, contengano parole-chiave che conducono alla medesima pagina esegetica sembra indicare che queste parole, se dovevano essere per il lettore spirituale signacula mnemonici di un altro testo, erano per il poeta anche segni del numero dei versi, ‘luogo’ dove collocare i medesimi signacula in forma e contesto diversi. Proprio in questa ars memorativa, e nella sua chiave, sta quello che Alberto Asor Rosa ha definito “l’unico ma grandioso mistero, con cui ha a che fare ogni lettore di Dante (incomparabile con quei misteriucci da quattro soldi, con cui si sono misurati gli Aroux e i Guénon): il mistero del segno, o di quel sistema di segni, che ha racchiuso un mondo intero in un insieme d’immagini plurisense” [1].
Esempi sono proposti qui di seguito nelle Tabelle 47 (Ap 1, 16-17), 48–49 (Ap 3, 12), 50 (Ap 3, 14-15). Altri esempi in « In mensura et numero et pondere ». Nella fucina della Commedia: storia, poesia e arte della memoria (PDF, 2014), cap. 3.
[1] A. ASOR ROSA, postfazione a L’idea deforme. Interpretazioni esoteriche di Dante, a cura di M. P. Pozzato, Milano, 1989, p. 316.
Tab. 47
[Ap 1, 16-17; radix Ie visionis] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
||
Purg. VI, 46-48 (16)Non so se ’ntendi: io dico di Beatrice;
|
Purg. XXX, 46-48per dicere a Virgilio: ‘Men che dramma
|
|
Par. XXIII, 46-51 (16-17) |
Par. XXXI, 49-51 (17) |
Par. XXXIII, 49-51 (17) |
“Apri li occhi e riguarda qual son io;
|
|
|
Par. II, 52-54 (18)Ella sorrise alquanto, e poi: “S’elli erra
|
|
|
Purg. XXVII, 58-60(20); XXVIII, 64-69(22-23) |
Par. X, 58-69 (20-23) |
Par. XXIII, 58-72 (20-24) |
‘Venite, benedicti Patris mei’,
|
come a quelle parole mi fec’ io;
|
per aiutarmi, al millesmo del vero
|
Tab. 48
[LSA, cap. III, Ap 3, 12 (VIa victoria)] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et transformationem mentis in ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. Hiis autem promittitur premium de quo sexte ecclesie dicitur: “Qui vicerit, faciam illum columpnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius; et scribam super illum nomen Dei mei et nomen civitatis Dei mei, nove Iherusalem, que descendit de celo a Deo meo et nomen meum novum” (Ap 3, 12). […] Quantum autem ad hoc premium, nota quod quia intrans in Deum recipit intra se Deum, ita quod et Deus intrat in ipsum, ideo hunc duplicem intrandi respectum hic ponit. Primum enim ponit sub typo columpne intra templum existentis et inde non egressure; secundum vero sub typo scripture per quam nomen Dei et sue civitatis inscribitur menti. Et secundum hoc templum significat Deum, prout infra XX[I°] dicitur: “Dominus Deus templum illius est”, scilicet civitatis Dei (Ap 21, 22). Sumendo tamen templum pro ecclesia sustentata a perfectis quasi a columpnis eius, tunc sub alio respectu significatur duplex ingressus. Quia enim et Deum et eius cultum intramus primo per professionis statum, per quem quis in Dei ecclesia et religione statuitur; secundo per contemplationis actum, per quem Deus cum suis operibus apprehenditur, idcirco primum significat per immobilem statum columpne in templo; secundum vero per inscriptionem divinorum in animo. Columpna autem, sic stans, est longa et a fundo usque ad tectum erecta et solida ac sufficienter densa, et rotunda communiter vel quadrata, et firmiter fixa templique sustentativa et decorativa. Sic autem stat in Dei ecclesia vel religione vir evangelicus Christo totus configuratus, sic etiam suo modo stat in celesti curia. Nam superiores ordines sunt sustentativi universitatis inferiorum, ipsorumque humilis simplicitas et simplex spiritualitas se habet ad minorem simplicitatem et quasi ad grossiciem inferiorum sicut centrum ad speram aut sicut spiritus ad corpus. Et ideo templum occupat maius spatium quam columpna ipsum sustentans.
|
||
Purg. XXXIII, 103-108 (35-36) |
Par. XXX, 100-105 (34-35)
|
Par. XXXIII, 97-105 (33-35)Così la mente mia, tutta sospesa,
|
[LSA, cap. XIX, Ap 19, 17-18 (VIa visio)] “Et vidi unum angelum stantem in sole” (Ap 19, 17). Iste designat altissimos et preclarissimos contemplativos doctores illius temporis, quorum mens et vita et contemplatio erit tota infixa in solari luce Christi et scripturarum sanctarum, et secundum Ioachim inter ceteros precipue designat Heliam. “Et clamavit voce magna omnibus avibus que volabant per medium celi”, id est omnibus evangelicis et contemplativis illius temporis: “Venite, congregamini ad cenam Dei magnam”, id est ad spirituale et serotinum convivium Christi, in quo quidem devorabitur universitas moriture carnis, ut transeat quod carnale est et maneat quod spirituale est. |
||
Tab. 49
[LSA, cap. III, Ap 3, 12 (VIa victoria)] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et transformationem mentis in ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. Hiis autem promittitur premium de quo sexte ecclesie dicitur: “Qui vicerit, faciam illum columpnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius; et scribam super illum nomen Dei mei et nomen civitatis Dei mei, nove Iherusalem, que descendit de celo a Deo meo et nomen meum novum” (Ap 3, 12). […] Quantum autem ad hoc premium, nota quod quia intrans in Deum recipit intra se Deum, ita quod et Deus intrat in ipsum, ideo hunc duplicem intrandi respectum hic ponit. Primum enim ponit sub typo columpne intra templum existentis et inde non egressure; secundum vero sub typo scripture per quam nomen Dei et sue civitatis inscribitur menti. Et secundum hoc templum significat Deum, prout infra XX[I°] dicitur: “Dominus Deus templum illius est”, scilicet civitatis Dei (Ap 21, 22). Sumendo tamen templum pro ecclesia sustentata a perfectis quasi a columpnis eius, tunc sub alio respectu significatur duplex ingressus. Quia enim et Deum et eius cultum intramus primo per professionis statum, per quem quis in Dei ecclesia et religione statuitur; secundo per contemplationis actum, per quem Deus cum suis operibus apprehenditur, idcirco primum significat per immobilem statum columpne in templo; secundum vero per inscriptionem divinorum in animo. Columpna autem, sic stans, est longa et a fundo usque ad tectum erecta et solida ac sufficienter densa, et rotunda communiter vel quadrata, et firmiter fixa templique sustentativa et decorativa. Sic autem stat in Dei ecclesia vel religione vir evangelicus Christo totus configuratus, sic etiam suo modo stat in celesti curia. Nam superiores ordines sunt sustentativi universitatis inferiorum, ipsorumque humilis simplicitas et simplex spiritualitas se habet ad minorem simplicitatem et quasi ad grossiciem inferiorum sicut centrum ad speram aut sicut spiritus ad corpus. Et ideo templum occupat maius spatium quam columpna ipsum sustentans.
|
||
Purg. III, 133-135 (45)
|
Purg. V, 130-136 (44-45)
|
Purg. XXVI, 127-132 (43-44)Or se tu hai sì ampio privilegio,
|
Inf. XVI, 133-136 (45)sì come torna colui che va giuso
|
Inf. XXXIV, 133-139 (45-46)Lo duca e io per quel cammino ascoso
|
Par. XXXIII, 133-138 (45-46)Qual è ’l geomètra che tutto s’affige
|
Tab. 50
[LSA, cap. III, Ap 3, 14-15 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Hiis autem, sicut et in ceteris ecclesiis, premittit preceptum de istis scribendis ac deinde proponitur Christus loquens, ibi (Ap 3, 14): “Hec dicit amen”, id est verus seu veritas; vel “amen”, id est vere; “testis fidelis et verus, qui est principium”, id est prima causa, “creature Dei”, et hoc tam creando omnia de nichilo quam recreando electos per infusionem gratie. Sancti enim [anthonomasice] dicuntur creature Dei, secundum illud epistule Iacobi capitulo I° (Jc 1, 18): “Voluntarie genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creature eius”. Et ad Ephesios II° dicit Apostolus (Eph 2, 10): “Ipsius sumus factura, creati in Christo Ihesu in operibus bonis”.
|
||
Inf. III, 4-8 (2-3)Giustizia mosse il mio alto fattore;
|
Par. XXXIII, 4-6 (2)tu se’ colei che l’umana natura
|
|
Inf. XXXII, 13-15 (5)Oh sovra tutte mal creata plebe
|
Purg. IX, 13-15Ne l’ora che comincia i tristi lai
|
|
Inf. IV, 82-84 (28)Poi che la voce fu restata e queta,
|
Par. XXVI, 82-84E la mia donna: “Dentro da quei rai
|
|
III.9 La misura del cerchio (Tab. 51)
Un angelo ha la canna d’oro – «habens “mensuram arundineam auream”» – con la quale misura la Gerusalemme celeste (Ap 21, 15). Designa i rettori e i dottori, i quali nel loro reggere o insegnare possiedono la sapienza della Scrittura sacra che è come una canna per il suono della predicazione e per l’umile sentimento della propria fragilità, vacuità e nullità, ed è aurea per il folgorare della conoscenza divina. Con la canna essi misurano la città, le mura e le porte, sia perché insegnano la regolarità della misura, sia perché con discreta misura reggono tutta la Chiesa e regolano l’entrare e l’uscire.
Questi sono i fili di Par. XXXIII, 133-141. Dante, nel cercare di comprendere come nella sua “vista nova” l’immagine umana di Cristo si convenga e trovi luogo nel cerchio, si trova a essere come il geometra tutto preso inutilmente a risolvere il problema della quadratura del cerchio (più avanti, nell’esegesi della settima visione, si dice che la misura della città può avvenire anche utilizzando i “cubiti geometrici”). Le sue ali non sono capaci di tal volo, per cui egli riconosce umilmente la propria fragilità e nullità, ma un lampo percuote la sua mente facendole venire ciò che voleva, cioè la chiara visione del mistero dell’incarnazione. Il motivo del ritrovare proviene dal recuperare il grado di perfezione originario (l’aurea prima carità) al quale viene invitato il vescovo di Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia (Ap 2, 5; prima visione): il “non ritrova, pensando” del finale del poema corrisponde così al “mi ritrovai per una selva oscura … che nel pensier rinova la paura” dell’inizio.
Pensare attentamente a un principio perduto – “e non ritrova, / pensando, quel principio ond’ elli indige” (Par. XXXIII, 134-135) – è nell’invito fatto al vescovo di Sardi, la quinta chiesa, di avere in mente la prima grazia ricevuta e di vegliare (Ap 3, 3). Ricordare uno stato che venne prima, congiunto con il tema della bellezza dei suoi inizi poi corrottisi (la quinta chiesa, nei suoi primordi, è definita “principium pulchritudinis”), si trasforma, con le parole di Matelda, nel ricordo di quella che per i poeti antichi fu “l’età de l’oro e suo stato felice” (Purg. XXVIII, 139-144). Corrisponde al vegliare “a studio de la culla” della madre nella Firenze antica rimpianta da Cacciaguida, la quale “consolando, usava l’idïoma / che prima i padri e le madri trastulla” (Par. XV, 121-123). Si ritrova, ancora, nel ripensare “come l’umana carne fessi allora / che li primi parenti intrambo fensi”, come afferma Beatrice a Par. VII, 145-148, argomentando in favore della resurrezione dei corpi, creati immortali per loro natura.
Il verbo “indigere” conduce ad Ap 4, 2, all’inizio della seconda visione (cfr. supra), relativa all’apertura dei sette sigilli. Per questa Giovanni viene elevato a un nuovo e più alto modo di vedere, quasi il suo primo vedere in spirito non lo fosse stato realmente rispetto al secondo. La ripetizione di questo elevarsi indica che ogni visione ha un proprio essere arduo, che è nuovo rispetto alle visioni precedenti, e che ogni volta Giovanni “indigeva” di essere nuovamente elevato. La visione dell’incarnazione, l’intelligenza dell’umano e del divino in Cristo, di come possa convenire il diametro con la circonferenza, è per il poeta l’ultima “vista nova” alla quale “indige” essere elevato. È anche l’ultima metamorfosi della città della quale Cristo è re, posta “in quadro” (Ap 21, 16) e nello stesso tempo “circulus gloriosus” (Ap 3, 12).
Il tema del misurare l’entrata e l’uscita dalla città superna è nell’entrare e uscire dei “topazi”, cioè delle “faville vive” (gli angeli), dal fiume di luce che il poeta vede nell’Empireo (Par. XXX, 64-69, 76-78; i motivi del fiume e degli “umbriferi prefazi” provengono da Ap 22, 1-2, il topazio è una delle gemme che ad Ap 21, 20 adornano le fondamenta della città). La regolare misura dell’entrata e dell’uscita era data (Lana), nella “Fiorenza dentro da la cerchia antica”, dalla campana della chiesa di Badia, la quale suonando “e terza e nona” segnava l’entrata e l’uscita dal lavoro dei lavoranti delle arti (Par. XV, 97-98).
Non solo il “popol giusto e sano” dell’Empireo è fasciato con i temi della santa città, oppure la Firenze antica rimpianta da Cacciaguida. Lo è anche, nella profonda notte che avvolge la città dei veri morti, l’ultima delle trasformazioni dei ladri della settima bolgia, quella che avviene tra il Cavalcanti per cui piange Gaville (il serpente che diventa uomo) e Buoso (l’anima che diventa fiera). Nel corso dello scambiarsi delle due nature (Inf. XXV), l’entrare delle braccia nelle ascelle (v. 112) e l’uscire degli orecchi (v. 126) corrispondono al tema del misurare nella città l’ingresso e l’uscita in modo che entrambi siano regolari (Ap 21, 15). Così “i due piè de la fiera, ch’eran corti, / tanto allungar quanto accorciavan quelle (le braccia)” (vv. 113-114) appare una perversa appropriazione del tema della città dei beati che tanto si prolunga nella visione di Dio quanto si dilata nella carità, essendo in essa uguali lunghezza e larghezza (Ap 21, 16). Le braccia designano il retto operare (Ap 2, 5), i piedi la perfezione delle opere (Ap 1, 15; 2, 18). Rientra forse in questo gruppo di temi anche la scomparsa alla vista della “giuntura” delle gambe e delle cosce dell’anima di Buoso, da questi unite (vv. 106-108), che rammenta, in estranea diversità, gli angoli delle porte della città celeste, che congiungono le pareti rafforzandole (Ap 21, 12).
Tab. 51
[LSA, cap. II, Ap 2, 5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Subdit ergo (Ap 2, 4): “Sed habeo adversum te” (quidam addunt “pauca”, sed non est de textu nisi solum in tertia ecclesia [cfr. Ap 2, 14], non autem hic nec in quarta [cfr. Ap 2, 20]) “quod caritatem tuam primam reliquisti”. Ricardus: «id est, quia te in dilectione Dei et proximi minorasti. Non dicit absolute ‘quod caritatem reliquisti’, sed “quod caritatem primam”, ex quo animadvertere possumus quod in bono quidem fuit minoratus sed non omnino bono evacuatus. In gratia enim accepta nimis secure vixerat et quedam negligenter egerat, et ideo de culmine sue perfectionis ceciderat ad minorationem sue perfectionis. Sed Dominus eum consulendo admonet ut penitendo gradum amissum recuperet, dicens (Ap 2, 5): “Memor esto itaque unde excideris, et age penitentiam et prima opera fac”. Quasi dicat: attende quod de fastigio tue perfectionis excideris et ad infimum perfectionis decideris, et age penitentiam de negligentia, et prima opera faciendo recupera primam gratiam». Hec Ricardus*.[LSA, cap. III, Ap 3, 3 (Ia visio, Va ecclesia)] “In mente ergo habe” (Ap 3, 3), id est attente recogita, “qualiter acceperis”, scilicet a Deo priorem gratiam, “et audieris”, ab homine scilicet per predicationem evangelicam, “et serva”, scilicet illa que per predicationem audisti et per influxum gratie a Deo primitus accepisti. Vel recogita qualiter per proprium consensum accepisti fidem et gratiam et statum eius, prout a me et a ceteris tibi predicantibus audivisti. “Et serva” ea “et penitentiam age”, scilicet de tuis malis, quasi dicat: si digne recogitaveris gratiam tibi prius impensam et qualiter prius accepisti eandem, servabis eam et penitentiam ages. […] Deinde comminatur eidem iudicium sibi occulte et inopinate superventurum si non se correxerit, unde subdit: “Si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur” […]* In Ap I, v (PL 196, col. 716 C-D). |
|
Par. XXXIII, 133-141Qual è ’l geomètra che tutto s’affige
|
Inf. I, 1-6Nel mezzo del cammin di nostra vita
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 2 (IIa visio, radix)] “Et statim fui in spiritu” (Ap 4, 2), id est in spirituali excessu mentis. Nota ex istis haberi aut quod post primam visionem fuerat ab excessu mentis ad se reductus, et ideo nunc iterato sublevatur ad mentis excessum; aut quod a primo mentis excessu, sub quo primam visionem vidit, elevatur nunc ad multo altiorem excessum, ac si tunc esset infra celum, nunc autem supra celum ascendat, et ac si suum primum esse in spiritu fuerit quasi non esse in spiritu respectu istius, de quo hic dicit: “Et statim fui in spiritu”; aut per reiterationes huiusmodi sublevationum designat quamlibet visionum cum suis obiectis habere propriam et novam arduitatem, et quod ad quam-libet videndam indigebat superelevari a Deo ad illam. Sicut autem una illuminatio disponit mentem ad aliam altiorem, sic spiritualis visio apertionis celi et spiritualis auditus vocis sic grandis, sicut est vox tube, erant dispositiones et ex[c]itationes ad sequentes sublevationes spiritus sui.
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 15 (VIIa visio)] Angelus vero habens “mensuram arundineam auream” (Ap 21, 15) designat rectores et doctores, qui in exemplari opere et potestate regendi et docendi habent sapientiam scripture sacre, que per sonum predicationis et per humilem sensum proprie fragilitatis et vacuitatis sive nichilitatis est arundo, et per fulgorem divine cognitionis est aurea. Per hanc autem metiuntur civitatem et murum et portas, tum quia docent horum regularem et virtualem mensuram, tum quia sub certa discretionis regula et mensura regunt totam ecclesiam et eius introitus et exitus et mirabilem clausuram.
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 16 (VIIa visio)] “Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum.
|
|
Inf. XXV, 103-114, 124-129Insieme si rispuosero a tai norme,
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] In scripturis tamen sepe angulus sumitur pro fortitudine et ornatu, quia in angulis domorum, in quibus parietes coniunguntur, est fortitudo domus. Unde Christus dicitur esse factus in caput anguli et lapis angularis […]
|
III.10 “L’amor che move il sole e l’altre stelle” (Tab. 52)
Ad Ap 2, 7 Olivi spiega perché l’istruzione data al vescovo di Efeso, il metropolita delle sette chiese d’Asia, venga proposta come detta dapprima da Cristo e per ultimo dallo Spirito Santo. Ciò avviene per quattro motivi. Il primo è affinché essa sia intesa provenire da tutta la Trinità.
Il secondo è perché due sono i modi di questo insegnamento, uno per mezzo della voce esteriore, l’altro tramite l’ispirazione e la suggestione interiore: il primo spetta a Cristo in quanto uomo, il secondo alla sua divinità ed è appropriato allo Spirito Santo. Il primo modo predispone al secondo come al suo fine ed è inutile senza di esso. Di questi due modi parla Cristo in Giovanni 14, 25-26: “Queste cose vi ho detto rimanendo tra di voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi suggerirà tutto ciò che io vi ho detto”. A Cristo, in quanto Verbo e verbale sapienza del Padre, è appropriato anche il parlare interiore che avviene per mezzo della luce della semplice intelligenza. Il parlare che avviene tramite il gusto e il sentimento dell’amore è appropriato allo Spirito Santo. Il primo modo si pone rispetto al secondo come la disposizione materiale rispetto all’ultima forma.
Il terzo motivo, infatti, è perché il tempo da Cristo fino al sesto stato è appropriato a Cristo, a partire dal sesto stato è appropriato allo Spirito Santo.
Il quarto motivo è perché a muoverci sia una duplice autorità magistrale e una duplice solenne testimonianza: dapprima l’evidente esempio delle opere di Cristo mostrate nella sua umanità, poi la fiamma e l’efficacia dello Spirito.
Questa duplice autorità si ritrova in Inf. II, 94ss., nell’episodio delle “tre donne benedette” che curano del poeta nella corte del cielo. Nell’Empireo una “donna … gentil”, cioè la Vergine la quale, come detto nella quarta visione, partorisce di continuo il corpo mistico di Cristo (Ap 12, 2) e dunque “si compiange / di questo ’mpedimento”, cioè dell’ostacolo che impedisce il parto della buona prole (la salita del “dilettoso monte” impedita dalla lupa), ha chiamato Lucia, cioè la “lux simplicis intelligentie”, perché presti aiuto al poeta, suo devoto. Lucia, mossasi, si è recata da Beatrice, che siede “con l’antica Rachele” (la vita contemplativa), come l’ “interna locutio que fit per lucem simplicis intelligentie” predispone al suo fine e alla sua ultima forma, cioè al gusto e al sentimento dell’amore, che avviene per mezzo della fiamma e dell’efficacia dello Spirito Santo. Mossa da amore, Beatrice discende veloce all’“uscio d’i morti”, cioè al Limbo, per muovere Virgilio.
Dante è mosso da due maestri. Virgilio, da una parte, è “voce esteriore”, assimilato a Cristo uomo; partecipa tuttavia anche del secondo tipo di insegnamento, quello che avviene per ispirazione e suggestione interiore, in quanto “lux simplicis intelligentie”: “Quanto ragion qui vede, / dir ti poss’io” (Purg. XVIII, 46-47). Lucia, che di questa luce è la più alta figura (designa Cristo “in quantum est Verbum et verbalis sapientia Patris”), agevola la salita del poeta dormiente dalla valletta dei principi alla porta del Purgatorio e mostra a Virgilio l’“intrata aperta” verso di essa (Purg. IX, 52-63). Con la porta comincia il sesto stato dell’Olivi (contraddistinto, appunto, dalla ‘porta aperta’) ovvero l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Beatrice rappresenta il gusto e il sentimento dell’amore, appropriato allo Spirito Santo. Mossa da amore, fa muovere Virgilio alla salvezza del suo amico: “Or movi, e con la tua parola ornata … l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata … amor mi mosse, che mi fa parlare” (Inf. II, 67-72). Virgilio e Beatrice operano entrambi per mezzo della “locutio”, cioè della favella, il primo con la “parola ornata”, la seconda con il parlare dettato da amore che suggerisce all’altro ciò che debba fare in modo da esserne consolata (lo Spirito Santo è Paraclito, cioè ‘consolatore’). Come l’insegnamento del Cristo uomo, per mezzo della voce esteriore, lascia il posto al gusto interiore dettato dallo Spirito, così Virgilio lascia il campo nell’Eden all’arrivo di Beatrice (Purg. XXX, 49-51).
Ad Ap 22, 16 (ultimo capitolo del libro, nella sua conclusione) Cristo si definisce “stella splendida”, illuminatrice dei santi, e “matutina”, che promette, predica e mostra la luce futura dell’eterno giorno. È stella in quanto fu uomo mortale e sole in quanto Dio. Egli invita tutti alla gloria (Ap 22, 17). Lo “sposo”, che secondo Riccardo di San Vittore è Cristo (Olivi nota che alcuni correttori del testo hanno tuttavia ad Ap 22, 17 “spirito” al posto di “sposo”, intendendo che Cristo invita tanto per sé quanto per il suo Spirito e per ispirazione interiore), e la “sposa”, cioè la Chiesa generale, sia quella dei beati sia quella peregrinante come quella contemplativa, dicono “Vieni”, cioè alla gloriosa cena delle nozze dell’Agnello. “E chi ascolta”, ossia chi è a conoscenza dell’invito, oppure chi crede e opera in modo retto e con obbedienza, “dica: vieni” a quelli che sono da chiamare alla cena e alla città beata. Poi è Cristo stesso ad invitare con liberalità dicendo: “Chi ha sete venga, e chi vuole riceva gratuitamente l’acqua della vita”. Dice “chi ha sete e chi vuole” perché nessuno può venire senza che ci sia desiderio e volontario consenso. “Venire” equivale a ricevere l’acqua della vita, cioè la grazia che ristora, vivifica e conduce alla vita eterna. Essa è “gratuita” perché viene data dalla carità e dalla liberalità di Cristo e ricevuta senza l’intervento di alcun prezzo venale ed esteriore, ma anche perché la prima grazia viene data senza alcun merito precedente essendo principio e causa del merito stesso e del suo aumento.
Il tema del venire per desiderio e volontario consenso di “chi ha sete e chi vuole” si ritrova, nel terzultimo verso del poema (Par. XXXIII, 143), nel volgere da parte di Dio “il mio disio e ’l velle”, ribadito dall’“in che sua voglia venne” che precede di due versi, allorché la folgore della grazia percuote la mente del poeta rendendola in grado di comprendere il mistero del rapporto tra l’umano e il divino nel Verbo.
Fu la “femminetta samaritana” a domandare, e dunque a desiderare e a volere, la grazia dell’acqua che sazia eternamente (Purg. XXI, 1-3). Il riferimento dell’espressione “il mio disio e ’l velle” ad Ap 22, 17 (venire, su invito, con desiderio e con volontario consenso) sembra prestare argomento a quanti ritengono che i due termini siano da rapportare non all’intelletto (il desiderio di conoscere) e alla volontà (l’amore per il bene), come nel caso di Par. XV, 73-84 (“L’affetto e ’l senno … Ma voglia e argomento”), bensì all’uguaglianza del volere istintivo con il volere razionale [1] . Ciò sembra confermato dal caso di Francesca e Paolo: “Quali colombe dal disio chiamate … vegnon per l’aere, dal voler portate” (Inf. V, 82-84).
“Amor mi mosse … l’amor che move il sole e l’altre stelle”. Nell’uno e nell’altro caso si tratta del gusto e del sentimento proprio dello Spirito Santo, non preso come entità a sé, ma come lo Spirito di Cristo, persona mediana della Trinità. Cristo, in quanto Dio, è “sole”; è “stella” in quanto uomo; tiene nella sua destra le sette “stelle”, cioè i doni del settiforme Spirito moltiplicati per le “stelle”, che nell’esegesi sono le chiese con i loro vescovi (Ap 3, 1). La filigrana dell’ultimo verso del poema mostra dunque l’immagine di Cristo Dio e uomo con l’amore del quale il suo Spirito permea l’universo e gli uomini nella loro storia.
Lo Spirito fa muovere per intimo dettato: “ut ex duplici auctoritate duorum tam sollempnium testium et magistrorum fortius moveremur … secunda vero ulterius moveret per spiritualem flammam et efficaciam Spiritus Sancti”. Suscita desiderio di moto: “vegno del loco ove tornar disio / amor mi mosse …”, afferma Beatrice che fa muovere Virgilio (Inf. II, 71-72). Dio è desiderato dalle sfere celesti e dall’uomo: “… la rota che tu sempiterni / desiderato … m’accesero un disio …” (Par. I, 76-77, 83; cfr. Ap 7, 17). In questo l’esegesi concorda con l’aristotelico primo motore il quale “movet ut amatum” (Metaph. XII 7). Al moto cosmico dell’“etterne rote” si unisce quello del poeta, “sì come rota ch’igualmente è mossa”, realizzando l’auspicio di Boezio, che l’amore governi gli uomini come regge il cielo (Cons. II, m. VIII, vv. 28-30).
Nell’ultimo verso del poema non ci sono concetti teologici separati dalla realtà storica. Nell’“empireo ciel”, lì dove Enea “fu de l’alma Roma e di suo impero / … per padre eletto” (Inf. II, 20-21); in “quella Roma onde Cristo è romano” (Purg. XXXII, 102), dove la Roma terrena “fu stabilita per lo loco santo / u’ siede il successor del maggior Piero” (Inf. II, 22-24), si realizza la città del sole della profezia di Isaia (19, 18), regno dell’alto “imperador” (Inf. I, 124). “L’amor che move il sole e l’altre stelle” non governa solo le ruote celesti, ma anche la storia umana, con Cristo mediatore, suo centro, romano sole per divinità e stella che contiene le altre per umanità.
Un lettore ‘spirituale’ avrebbe così accostato l’ultimo verso del poema al primo – “Nel mezzo del cammin di nostra vita” -, nel quale, incardinato nel senso letterale riferito al trentacinquesimo anno dell’autore, avrebbe scorto il riferimento a Cristo mediatore, la cui vita deve essere dalla nostra perfettamente imitata e partecipata.
[1] Cfr. A. M. CHIAVACCI LEONARDI, Paradiso, Milano 2007 p. 929).
Tab. 52
[LSA, cap. II, Ap 2, 7 (Ia visio, Ia ecclesia)] Quadruplici enim ex causa hec informatio primo proponitur ut a Christo dicta et ultimo ut dicta a Sancto Spiritu.
|
|
Inf. II, 67-72, 100-102Or movi, e con la tua parola ornata
|
Par. XXXIII, 139-145ma non eran da ciò le proprie penne: 21, 15
|
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 16-17 (finalis conclusio totius libri)] “Sum” etiam “stella splendida” (Ap 22, 16), omnium scilicet sanctorum illuminatrix, “et matutina”, future scilicet et eterne diei immensam claritatem predicando et promittendo et tandem prebendo, et etiam prout fui homo mortalis ipsam precurrendo, ut ipse secundum quod homo sit stella et secundum quod Deus sit sol.
|
|