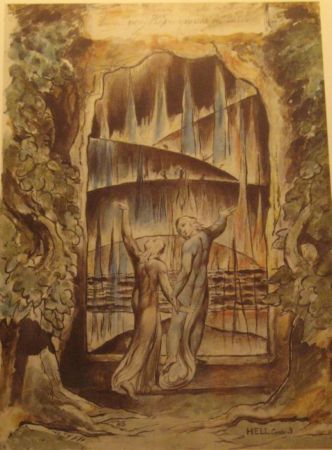INDICE GENERALE
Introduzione: I – II – III
I. La Gerusalemme celeste: una città ideale discesa in terra
I.1 La dolce vita differenziata (tab. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies). I.2 La luce della città. I.2.1 Come in uno specchio (tab. 2). I.2.2 Le vermiglie meschite (tab. 3). I.2.3 L’eterno femminino della Luna che patisce e riceve (tab. 4-5). I.2.4 Il gran trono e l’avvento del sole (tab. 6). I.2.5 Il nuovo sole e la primavera sempiterna / che notturno Arïete non dispoglia (tab. 7). I.3 Le due rive del nobile fiume (tab. 8-10). I.4 Tommaso d’Aquino con il saio francescano (tab. 11). I.5 Il muro tetragono (tab. 12). I.6 Luce intellettüal, piena d’amore (tab. 13). I.7 Roma e l’ardüa sua opra (tab. 14).
II. La preghiera di san Bernardo alla Vergine (tab. 15-27).
III. Il fine di tutti i desideri.
III.1 Visione e martirio (tab. 28). III.2 L’apertura del libro segnato da sette sigilli (tab. 29-31). III.3 Ricordo cessato e linguaggio imperfetto (tab. 32-34). III.4 Il punto (tab. 35-36). III.5 La visione della sede divina (tab. 37-40). III.6 La vittoria dei contemplativi (tab. 41-43). III.7 La prima equalità (tab. 44). III.8 Il volto di Cristo sorridente (tab. 45-50). III.9 La misura del cerchio (tab. 51). III.10 L’amor che move il sole e l’altre stelle (tab. 52).
[3] = numero dei versi. 12, 1-2 = collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]. Not. VII = collegamento ipertestuale all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura.Qui di seguito viene esposto Paradiso XXXIII con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (PDF; introduzione in html). |
Paradiso XXXIII |
« Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 12, 1-2; qu. de angelicis influentiis
|
Abbreviazioni e avvertenze
Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.
LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.
Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).
Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.
Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.
In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.
Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.
Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994.
Introduzione
Una lettura dei sensi spirituali semanticamente incardinati nel senso letterale dell’ultimo canto della Commedia richiede, in primo luogo, che vengano esaminati i luoghi della settima visione descritti nei capitoli XX-XXII della Lectura super Apocalipsim. Queste parti del “panno” costituiscono infatti il tessuto principale della “gonna” che riguarda l’Empireo. In secondo luogo sarà considerata la preghiera che san Bernardo rivolge alla Vergine (Par. XXXIII, 1-45). In terzo luogo si procederà all’esame dei cento versi seguenti, che narrano l’ultima, mutevole visione. Si potrà osservare come il tessuto fornito dall’esegesi apocalittica oliviana venga utilizzato, variandone i temi, anche in altri luoghi del poema, diversi da quelli principalmente considerati e spesso assai distanti fra loro.
Viene in luce quella che Benedetto Croce definiva “[…] una didascalica, di eccelso argomento, di grandioso movimento, di altissima intonazione, ma una didascalica con gli espedienti della didascalica” [*]. Questa didascalica consente tuttavia di avvicinarsi storicamente a Dante, nel suo tempo e nei suoi sentimenti, guardando alla poesia secondo la sua idea senza confronti con la nostra, come intendeva Croce. In tal modo è possibile registrare l’intima metamorfosi per la quale la storia sacra della Chiesa si travasa nello stato umano, sull’“aiuola che ci fa tanto feroci”. Quanto Olivi scrive della storia della Chiesa e della gloria di Cristo viene nella Commedia diffuso su tutte le persone e le forme, antiche e nuove, del nostro mondo con le sue passioni. Il saeculum humanum rivendica l’autonomia nell’uso del volgare, nella definizione del regime politico, nell’ambito della natura e della ragione, nella valorizzazione degli autori classici, in quelli che sarebbero stati gli ideali laici del Rinascimento. Delle due nature dell’anima di Dante, duplice come quella di Faust – per usare ancora una celebre definizione del Croce [**] -, “divisa tra Medioevo persistente e incipiente Rinascimento”, viene messa in luce la reciproca osmosi.
Il “panno” è stato scelto da Dante per mantenere l’unità del poema e, al tempo stesso, per dare al pubblico degli Spirituali francescani una versione aggiornata secondo i nuovi interessi dell’autore, poeticamente prestante “e piedi e mano”, nel volgare emulo del latino, ai concetti teologici contenuti nella loro opera-vessillo.
Nella sinossi dei testi si può avere concreta esperienza, attraverso l’esame di singole parole – infima, appropinquava, ripresta, conflati, sidi, indige, circunspetta, solo per citarne alcune – di quanto scrisse Mario Fubini:
“[…] diremmo che il volgare dantesco lasci qui, dove il poeta è giunto al vertice del suo mondo, trasparire così chiara e insistente, come forse in nessun altro luogo, dentro di sé del suo colore stesso, l’immagine del latino; quel latino a cui egli ha sempre tenuti fissi gli occhi come a modello ideale e che ora è come riassorto nel suo linguaggio” [***].
[*] B. CROCE, L’ultimo canto della «Commedia», in ID., Poesia antica e moderna. Interpretazioni, Bari 19432 (Scritti di storia letteraria e politica, XXXIV), pp. 151-161: p.156.
[**] B. CROCE, Ancora della lettura poetica di Dante (1948), in Letture di poeti e riflessioni sulla teoria e la critica della poesia, Bari 1950, pp. 3-20.
[***] M. FUBINI, L’ultimo canto del Paradiso, in Due studi danteschi, Firenze 1951 (Biblioteca del Leonardo, XLV), pp. 55-103: p. 59.
■ Chi intenda approfondire lo stato della ricerca può consultare su questo sito:
-
Pietro di Giovanni Olivi e Dante. Un progetto di ricerca, in “Collectanea Franciscana”, 82 (2012), pp. 87-156 – ENG
-
Petrus Iohannis Olivi in the Italian Peninsula. Images and Influences between Literature and History (Assisi 2015)
-
Amore e vita di poeta. La Vita Nova e l’imitazione di Cristo, dove si mostra come l’incontro fra Dante e le opere esegetiche dell’Olivi (in particolare l’Expositio in Canticum Canticorum e la Lectura super Lucam) risalga a prima dell’esilio, al tempo dell’uscita delle “nove rime”.
-
Quo vadis, Dantes?
LECTURA DANTIS
-
Inferno X (PDF)
-
Inferno XXVI (PDF)
-
Inferno XXXII, 124-139 – XXXIII, 1-90
-
Purgatorio III
-
Paradiso XI-XII
I
Allegoria e anagogia
La città superna, la Gerusalemme celeste, è ideale. Anche se descritta con similitudini materiali – fosse, muro, porte, case, piazza, angoli, misure dei lati, pietre preziose, fiume, rive, albero, frutti -, viene applicata agli uomini, che partecipano così delle sue divine qualità. Nell’esegesi essa è la Chiesa dei contemplativi, cioè dei beati; ma anche la Chiesa peregrinante e militante in terra ne può ben pregustare la pace. La vittoria del sesto stato, cioè degli uomini che in terra combattono contro Babylon – la Chiesa carnale – affinché si instauri un “novum saeculum”, consiste nell’aver iscritto nella mente il nuovo nome della Gerusalemme che discende dal cielo in terra, e che è detta essere visione di pace (Ap 3, 12). Di essa maggior gusto si potrà provare nel successivo settimo e ultimo stato. Il sesto periodo della Chiesa, iniziato con la conversione di san Francesco (1206), si estende fino alla completa distruzione di Babylon, con la sconfitta dell’Anticristo. È dunque il periodo nel quale Olivi scrive la Lectura (1290-1298) e nel quale Dante compie il suo viaggio (1300) narrato nella Commedia (iniziata nel 1307-1309).
San Giovanni descrive nell’Apocalisse la santa città dapprima sommariamente, poi in modo più compiuto per mezzo di un angelo. Ciò perché, secondo Riccardo di San Vittore, Giovanni prima vede in modo inferiore e poi in modo più alto. Secondo Gioacchino da Fiore, la prima descrizione è riferita alla gloria della Chiesa peregrinante in terra, la seconda alla gloria della Chiesa regnante nei cieli dopo il giudizio. Così Giovanni può vedere da solo nel primo caso, mentre nel secondo necessita dell’aiuto di un angelo. La Gerusalemme celeste non può essere veduta con gli occhi né si trova espressa nelle Scritture. Per essa si rende necessario un dottore spirituale che tragga i discepoli che hanno raggiunto la perfezione all’intelletto anagogico, in modo che da quel che è noto della città peregrinante in terra vengano rapiti alla visione spirituale della città che regna nei cieli. Il monte sul quale viene levato Giovanni (Ap 21, 10) è pertanto l’intelletto anagogico, grande e alto perché apprende cose grandi e sublimi, come la lettera apprende ciò che è transitorio e terreno e l’allegoria lo stato della Chiesa peregrinante che opera in un certo modo tra cielo e terra.
È san Bernardo a svolgere la funzione del dottore che mostra cose che non possono essere vedute o ascoltate traendo Dante, dal suo peregrinare, al senso anagogico invitandolo a levare gli occhi “quasi di valle andando a monte” cosicché veda la regina del cielo, perché “quest’ esser giocondo / … non ti sarà noto, / tenendo li occhi pur qua giù al fondo” (Par. XXXI, 112-123).
La narrazione dell’ineffabile
(I.1) La visione di Dante, come quella di Giovanni a Patmos, fu una sola: “tutta tua visïon fa manifesta”, gli dice Cacciaguida (Par. XVII, 128). Come avvenne all’Evangelista, non fu una fictio, ma una vera visione. Come l’autore dell’Apocalisse, scrivendo in seguito quanto visto, applicò in modo sempre più alto e arduo similitudini tratte prevalentemente dai fenomeni naturali, e ciò per rendere ai suoi lettori un vedere che, in quanto puramente intellettuale, sarebbe stato inesprimibile, così l’autore della Commedia e nuovo Giovanni rese con similitudini cose alte e forti, imitando il condiscendere della Scrittura verso gli ingegni umani, che si fondano sull’esperienza sensibile. Per questo, afferma Beatrice, la Scrittura “e piedi e mano / attribuisce a Dio e altro intende”, e la Chiesa rappresenta in figura umana gli arcangeli che sono pure intelligenze (Par. IV, 43-48).
Nell’Empireo il poeta, la cui memoria viene meno, ha visto “cose che ridire / né sa né può chi di là sù discende” (Par. I, 4-6). Nel descrivere l’ascesa al cielo ha dovuto pertanto “mantenere anche nella terza cantica quel ritmo e quella differenziazione di momenti narrativi, quella successione di episodi e di colloqui variamente ambientati, lo spazio e il tempo insomma richiesti da una rappresentazione poetica e che non potevano essergli offerti da una rigorosa adesione al concetto teologico” (Sapegno) [1]. Anche nella terza cantica ha portato le vicende e le passioni umane, ha dato valore universale a fatti di storia locale. La “dolce vita” differenziata, per cui i beati, tutti presenti nell’Empireo, si manifestano discendendo nei vari cieli facendo segno del loro diverso grado di beatitudine, è pertanto la base della struttura del Paradiso consentendo la soluzione “dei problemi che derivano dal narrare l’inenarrabile”, soprattutto di quello, fondamentale, “della temporalità del racconto” [2]. La teologia di Olivi gli offriva riscontri utili al mantenimento della differenziazione tanto necessaria sul piano poetico.
La “fabbrica della Chiesa”, afferma Olivi, è simile a un albero che non può mostrarsi compiuto nelle sue foglie fin dall’inizio come nel suo compimento. Così è per la gloria di Dio, che diversamente rifulge nelle parti della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione: “in eius partibus diversimode refulgentis et participate” (Ap 21, 12-13). Similmente Dante, che trasferisce sull’intero universo prerogative che nell’esegesi scritturale sono proprie della Chiesa e della sua evoluzione storica secondo sette stati, apre la terza cantica: “La gloria di colui che tutto move / per l’universo penetra, e risplende / in una parte più e meno altrove” (Par. I, 1-3). L’unità della città celeste è specchio dell’increato Spirito di Cristo, uno e semplice ma partito in sette doni, che sono anche i sette stati o periodi della Chiesa, cioè le categorie che segnano lo sviluppo della storia umana (Ap 1, 4; 5, 6-7).
I versi rivelano un linguaggio proprio dello Pseudo-Dionigi, adottato nella Lectura, come mostra il confronto con Ap 21, 18.21. Le intelligenze angeliche inferiori ricevono l’“habitus glorie” da quelle superiori, riflettendolo quali specchi, come le membra inferiori di un corpo sono radicate nelle virtù del cervello, del cuore o del fegato: “Questi ordini di sù tutti s’ammirano, / e di giù vincon sì, che verso Dio / tutti tirati sono e tutti tirano” (Par. XXVIII, 127-129). La medesima tesi dionisiana viene poi addotta nell’Epistola a Cangrande a commento della prima terzina del Paradiso (Ep. XIII, 60).
Ad Ap 21, 9 Olivi cita Riccardo di San Vittore, secondo il quale per quanto lo scopo della settima visione sia quello di descrivere lo stato superno della Gerusalemme beata, si trovano in essa molte cose che spettano più ai presenti meriti dei santi che ai futuri premi. Ciò, secondo Olivi, avviene perché le differenze della gloria dei beati non possono essere conosciute se non attraverso similitudini già sperimentate e familiari. Lo stato del premio può in altri termini essere descritto solo facendo riferimento, mediante le similitudini, allo stato del merito. Non diversamente lo Pseudo Dionigi, nel De angelica hierarchia, descrive le differenze degli ordini angelici con l’ausilio dei comuni doni della grazia a noi noti e posti nella Scrittura a denominazione delle gerarchie angeliche. Un terzo motivo sta nel fatto che, descrivendo la Chiesa sotto il duplice stato della grazia e della gloria, è possibile concepire la corrispondenza dei meriti con i premi e quindi che a meriti diversi corrispondono premi diversi.
Nell’Epistola a Cangrande (§§ 33-34) si distingue tra il soggetto letterale del Paradiso, cioè lo stato delle anime beate dopo la morte, e quello allegorico, cioè l’uomo che per i meriti ha conseguito il premio della giustizia divina. È distinzione molto vicina a quella proposta da Olivi, ad Ap 21, 9 (con le citazioni di Riccardo di San Vittore e dello Pseudo Dionigi), tra i premi futuri e i meriti presenti (senso allegorico), per cui nella settima visione si tratta più dei secondi che dei primi, in quanto in questa vita non è dato all’intelletto di vedere le differenze della gloria dei beati secondo le proprie specie e proprietà o mediante similitudini univoche, ma solo per mezzo di similitudini già note, cioè attraverso la rappresentazione allegorica. Naturalmente l’allegoria non è da intendere in senso strettamente poetico, cioè come una menzogna che nasconde la verità (cfr. Convivio, II, i, 2-15), bensì nel senso teologico, di qualcosa (personaggi e vicende storiche) che è prefigurazione di ciò che viene a compimento, della storia della Chiesa militante che si realizza nel “regno santo”.
Se la descrizione della Gerusalemme celeste si fonda più sui meriti che sui premi, cioè più sulla personale storia dei beati piuttosto che sulla loro mercede, il Paradiso è tanto tessuto di vicende terrene quanto della descrizione della “gloria di colui che tutto move”. Nell’Empireo, luogo al di fuori del tempo che tiene le sue radici nel sottostante Primo Mobile, Beatrice ha modo, indicando il trono dell’“alto Arrigo”, di profetizzare la condanna di Clemente V, il “prefetto nel foro divino” dal comportamento equivoco verso l’imperatore (Par. XXX, 142-144).
Alcuni, afferma Olivi, hanno sostenuto che la visione di Giovanni sarebbe stata puramente intellettuale, cioè senza immagini, e che poi egli avrebbe adattato le varie figure alla verità veduta senza di esse. Contrario a ciò sta il fatto che egli non accenna a una successiva composizione con figure ma a figure apparse in visione e mostrate da un altro soggetto. Inoltre, l’essere state le figure formate da Dio per mezzo di un angelo rende maggiore riverenza, stima e dignità alle visioni del libro che se esse fossero state aggiunte dopo da Giovanni. All’altezza della visione intellettuale nulla toglie l’aggiunta di immagini che siano di aiuto: l’intelligenza dei beati dopo la resurrezione dei corpi non sarà, con l’aggiunta della vista corporea, minore di quanto sia ora senza questa (Ap 1, 2).
Nella Commedia, le figure che vengono in ausilio della visione intellettuale non sono formate dall’angelo ma dal nuovo Giovanni. Lo sforzo del poeta è di chiedere il lume superiore affinché esse siano ben espresse “com’ io l’ho concette”. Dal suo petto spira il “buono Appollo” e si manifesta la “possa” della “diva Pegasëa” (Par. I, 13-21; XVIII, 82-87). L’“alta fantasia”, che alla fine viene meno perché non trova più figure (Par. XXXIII, 142), è tale non solo perché perviene fino alla visione divina, ma perché è mossa da un lume superiore. Essa è realizzazione della terza vittoria (la cui esegesi, ad Ap 2, 17, conclude l’istruzione data a Pergamo, la terza chiesa d’Asia), che consiste nella vittoriosa ascesa al di sopra della fantasia che muove dal senso, causa di errore e di eresia.
Nella “Città del Sole”
■ (I.2.1) Immagine di Dio, la città partecipa della sua luce, dal cui splendore assume forma, come il ferro, accalorandosi, prende la specie del fuoco. La luce della città è simile a una gemma, in essa incorporata come in uno specchio che riflette il divino: è verdeggiante come il diaspro, pulita come un cristallo, è acqua congelata e perspicua, trasparente, simile alla luna, che con le sue macchie oscure designa l’umiltà dei beati (Ap 21, 11). Anche il nobile fiume, che scorre nel mezzo della città con la sua acqua viva e di vita, fra due rive – l’umana e la divina, il merito e il premio – ugualmente ombreggiate dalle sacramentali foglie dell’albero designato da Cristo-lignum vite, è “splendido come cristallo” (Ap 22, 1-2). La piazza della città (lo spazio entro le mura) è detta “vetro perlucido” (Ap 21, 18.21): ivi infatti non è solo aureo fulgore, ma anche verità che senza macchia o polvere confessa umilmente i propri peccati. Questa città, secondo la dottrina dello Pseudo-Dionigi, è organizzata gerarchicamente, per cui gli inferiori si giovano dell’intermedia gloria dei superiori come fossero vetri o specchi più chiari.
Improntata dello splendore del lume divino nei tanti specchi che lo ricevono e lo trasmettono, la forma della città, di vetro trasparente per la verità che confessa, di cristallo e d’acqua congelata, di verde adornata, impregna tutto il Paradiso. Ma anche Dite si fregia perversamente delle qualità celesti, che permeano il tessuto di Cocito. La città di Dio, che da questi è illuminata e assume l’immagine come il ferro s’accalora al fuoco e ne prende la specie, che è come pietra di diaspro (Ap 21, 11), diventa, nella sua proiezione infernale, “la città del foco” dalle mura che “mi parean che ferro fosse”, “luogo … / tutto di pietra di color ferrigno” in Malebolge (Inf. VIII, 78; X, 22; XVIII, 1-3), dalle torri definite “meschite”, cioè moschee, rosse per l’arroventare del fuoco eterno (Inf. VIII, 70-74, 78 [I.2.2]).
■ (I.2.3) Nella descrizione dell’arrivo al primo cielo, quello della Luna che pure è pervaso dai motivi della trasparenza, fanno da contrappunto altri temi. “Per entro sé l’etterna margarita / ne ricevette … e qui non si concepe / com’ una dimensione altra patio, / ch’esser convien se corpo in corpo repe” (Par. II, 34-39): ricevere dentro di sé è tema proprio della sesta vittoria, con la quale si consegue l’ingresso in Cristo (Ap 3, 12). Nell’esegesi di Filadelfia, la sesta delle chiese d’Asia (Ap 3, 7), è detto che come nei contemplativi del quarto stato della Chiesa rifulse l’amore verso Cristo, così nei contemplativi del sesto rifulge il loro essere diletti da Cristo, non diversamente da quel che si dice di Pietro, che amò Cristo, e di Giovanni, che fu prediletto da Cristo. In tal modo prerogativa del sesto stato è di essere disposto a ricevere e a patire, e in ciò si differenzia dagli stati precedenti, disposti a fare e a dare: “quia potius prefertur eis in pati seu recipere quam in agere vel dare”. Al sesto periodo è attribuita più la felicità che deriva dalla speranza del premio che la fatica dell’attività per cui si acquistano meriti. Ricevendo più grazie e più segni di familiare amore da parte di Cristo, il sesto stato eccelle sugli altri precedenti, ma nello stesso tempo ad essi si deve maggiormente umiliare. I due verbi, “ricevere” e “patire” – “pati seu recipere” -, prerogative del sesto stato, sono appropriati al cielo della Luna, “etterna margarita” che ‘riceve’ dentro a sé il poeta come l’acqua riceve un raggio di luce senza dividersi, in modo che la sua dimensione ‘patisca’ un’altra, cioè il corpo di Dante, cosa inconcepibile sulla terra. Questo tema fondamentale si ritrova nella lezione che Stazio dà sull’umana generazione a Purg. XXV, 46-47, circa l’accogliersi “in natural vasello” dell’uno e dell’altro sangue, “l’un disposto a patire, e l’altro a fare”. Al sangue maschile corrisponde dunque il quarto stato, del quale è proprio il “victoriosus effectus” delle “res gestae”, l’“alto effetto” che uscì dal vittorioso Enea (secondo la quarta vittoria: Ap 2, 26-28; Inf. II, 17-18); al sangue femminile corrisponde il più alto e al tempo stesso il più umile degli stati, il sesto. Come non ricordare le parole di san Bernardo rivolte alla “Vergine Madre, figlia del tuo figlio, / umile e alta più che creatura”? L’età nella quale vivono Olivi e Dante, il sesto periodo della storia della Chiesa, che patisce e riceve, al quale è dato per grazia senza che debba dare (cfr. Inf. VIII, 105), nel quale lo stesso “Regnum celorum vïolenza pate” (Par. XX, 94), si fregia di prerogative che appartengono al sacro eterno femminino.
■ (I.2.4) Giovanni vede “un grande trono candido” (Ap 20, 11), che designa il potere e la dignità di Cristo giudice, ovvero, nella gloria, la regale divina maestà, e l’altezza e il candore della purezza della sua umanità sulla quale la sua divinità siede come sul proprio trono. I segni della duplice natura di Cristo – il trono divino e il candore umano – si mostrano, separati nell’appropriazione, nel “gran seggio” preparato nell’Empireo per l’anima “de l’alto Arrigo”, nella città dove i beati si mostrano “in forma … di candida rosa” (Par. XXX, 133-138; XXXI, 1-2).
La luce delle stelle si annulla all’avvento del fulgore della gloria di Cristo; così, a Par. XXX, 7-9, l’arrivo dell’aurora, “la chiarissima ancella / del sol”, fa sì che il cielo si chiuda “di vista in vista infino a la più bella”. Infatti, “dal cospetto di colui che siede (sul trono candido) fuggono la terra e il cielo e non c’è luogo da essi trovato”. Gli abitanti del cielo e della terra fuggono per il grande terrore del furore del giudice, o anche per la somma riverenza alla sua maestà si contraggono nella propria nullità. Questo motivo – il fuggire ritirandosi per paura, annullando il luogo dove prima si stava – è nella spiegazione cosmologica che Virgilio dà prima di lasciare l’inferno: caduto Lucifero nell’emisfero australe, la terra, che prima in questo emergeva, per paura di lui si ritrasse sotto il mare e venne all’altro emisfero e, sempre per fuggire Lucifero, la terra che ora forma la montagna in cima alla quale è l’Eden lasciò il suo luogo vuoto (la “natural burella” in cui si trovano al momento i due poeti) ricorrendo in su (Inf. XXXIV, 121-126).
■ (I.2.5) La solare luce che pervade la Gerusalemme celeste è storicamente pregustabile in questa vita. Il periodo è quello del sesto e del settimo stato. Ad Ap 21, 22-23 è citato Gregorio Magno. Questi, commentando nei Moralia Giobbe 9, 9 – “Egli che crea Arturo e Orione e le Pleiadi” – insegna espressamente come verso la fine del mondo la luce solare della sapienza di Cristo si renda più manifesta: per i singoli giorni la scienza celeste si mostra più e più come un lume a noi interno, si apre il tempo primaverile, il nuovo sole sfavilla alle nostre menti e, reso a noi noto per il verbo dei dottori, riluce ogni giorno più chiaramente. All’appressarsi della fine del mondo la scienza superna avanza e col tempo cresce più larga.
Nella città del “sol che sempre verna” (Par. XXX, 126), dove le porte non sono mai chiuse (Ap 21, 25; diversamente che per la Città di Dite, le cui porte vengono chiuse dai diavoli: Inf. VIII, 115-116), il pellegrino mena gli occhi “su per la viva luce passeggiando” (Par. XXXI, 46-48; cfr. Ap 21, 24: “Et ambulabunt gentes in lumine eius”).
Il tema del tempo primaverile, dalla citazione di Gregorio Magno, congiunto con quello dell’assenza della notte nella città che è sola luce, da Ap 21, 25 (“Nox enim non erit illic”), è contenuto nella terzina di Par. XXVIII, 115-117, riferita alla seconda terna della gerarchia angelica, “che così germoglia / in questa primavera sempiterna / che notturno Arïete non dispoglia”. L’Ariete è “notturno”, cioè visibile di notte, nell’autunno, mentre all’inizio della primavera sorge e tramonta col sole. L’espressione traduce pertanto in poesia il concetto che nella città dei beati non vi sarà più notte. Su questo tema principale si innesta, come contrappunto, la tematica del ‘ladro’, trattata nei due passi simmetrici di Ap 3, 3 e 16, 15.
■ (I.3) Il capitolo XXII dell’Apocalisse si apre con la visione del nobilissimo fiume che scorre nel mezzo della città celeste. È lo stesso Spirito Santo, ovvero la gloria che da Dio affluisce sui beati: fiume di acqua viva, o di vita eterna, da cui deriva tutta la sostanza della Trinità. Fiume di splendore e luce per sapienza, che ha due rive o due parti (destra e sinistra, superiore e inferiore), designanti le due nature, divina e umana, di Cristo-lignum vitae che dà perpetui frutti. Il lignum vitae, l’albero che sta nel mezzo della città, con le sue foglie getta un’ombra sacramentale, di verità superiori, su entrambe le rive, l’umana e la divina, perché non solo il cielo, ma anche la terra è ripiena della gloria di Dio.
L’esegesi di Ap 22, 1-2 offre una ricchezza tematica riaffiorante in numerosi luoghi della Commedia, primo fra tutti il luminoso fiume dell’Empireo: “fulvido di fulgore, intra due rive / dipinte di mirabil primavera”, dal quale escono “faville vive”, è “onda / che si deriva” da Dio; ma il fiume, le faville (“li topazi / ch’entrano ed escono”) e il verdeggiante “rider de l’erbe” sono “umbriferi prefazi”, cioè ombra sacramentale del vero, adombranti il primo una forma circolare e non lineare, le seconde gli angeli, il terzo i beati (Par. XXX, 61 sgg.). Le “due rive” dell’unico fiume celeste figurano in terra nei due fiumi dell’Eden (il Lete e l’Eunoè) che si dipartono da un’unica fontana (Purg. XXXIII, 112-117).
In questa esegesi del fiume di una città immateriale Dante poteva specchiare quanto la sua mente elaborava sulle due beatitudini, poste come fini all’uomo dalla Provvidenza: la beatitudine di questa vita (raffigurata nel paradiso terrestre), alla quale si perviene sotto il regime dell’Imperatore, attraverso la filosofia e la pratica delle virtù morali e intellettuali; la beatitudine della vita eterna (consistente nella visione di Dio), alla quale si perviene tramite le virtù teologali e sotto la guida del romano pontefice (cfr. Monarchia, III, xv, 7-10). Entrambe le beatitudini, come le loro guide, discendono senza intermediari dall’unico Fonte dell’universale autorità (ibid., xv, 15). Corrispondono alle due rive, umana e divina, dell’unico fiume della grazia e della gloria, all’umanità e alla divinità di Cristo. Beatrice, figura di Cristo, è nell’Eden cerniera: gli occhi partecipano sia dell’una come dell’altra, la bocca svelata adombra la visione di Dio.
Nel “poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra” (Par. XXV, 1-2), la Grazia che deriva da entrambe le rive dell’unico fiume celeste, secondo l’esegesi di Ap 22, 1-2, si estende anche al voto religioso e all’Impero, nel Paradiso trattati rispettivamente nei primi due cieli, entrambi, nelle “sacre bende” o nelle “sacre penne” (parole, rispettivamente, di Piccarda e di Giustiniano), “ombra” sacramentale di verità superiori che discendono dal fiume luminoso dell’Empireo, che ha due rive, una divina e l’altra umana (cfr. Par. III, 114; VI, 7). Non a caso alcuni fondamentali attributi del voto evangelico, così come delineati dall’Olivi, appaiono applicabili anche alla Monarchia: la stabilità, l’immutabilità, l’indissolubilità, il divieto assoluto di alienazione. Così lo stato di altissima povertà, a causa dell’immutabilità del voto, produce su chi lo professa gli stessi effetti della giurisdizione del Monarca: il non poter desiderare di più, la rimozione della cupidigia, la carità, la pace. Diventato consorte in cielo della Chiesa, l’Impero partecipa a pieno titolo dell’eterna generazione del Verbo e del suo farsi carne. Come Cristo fu soggetto al Padre per la sua mortale umanità, ma non per questo gli fu meno consustanziale ed eguale [3], così il romano Principe, assimilato al Figlio dell’uomo, avrebbe dovuto rendere reverenza al Padre e soggiacergli “in aliquo” (come sarebbe stato scritto al termine della Monarchia) senza per questo essere meno a Lui uguale [4].
Si direbbe che la stessa poesia derivi la sua linfa da quel fiume di grazia e di gloria (Ap 22, 1-2). Essa, nel descrivere il “regno santo”, è umbratile, sacramentale figurazione di verità superiori; si corona delle lauree foglie del “diletto legno” del “buono Appollo” utilizzando ambedue i gioghi di Parnaso, quello abitato dalle Muse e quello sede del dio, come su ambedue le rive, umana e divina, stanno le foglie di Cristo-lignum vitae con il loro sacro ombreggiare (Par. I, 16-18, 22-27).
■ (I.4) Nelle parole di Tommaso d’Aquino a Par. XIII, 52-87, la viva luce del Verbo che “sì mea”, cioè deriva, dalla sua fonte luminosa e raccoglie il suo radiare, quasi specchiandosi, nei nove cori angelici dai quali discende giù di atto in atto, cioè di cielo in cielo, fino alle ultime potenze tanto che da ultimo non produce più che creature contingenti e corruttibili, è la viva luce di ogni somma sapienza che ad Ap 22, 1 è rappresentata dal fiume per il quale deriva a tutti i beati la sostanza della Trinità. Il raccogliersi della luce nelle nove sussistenze angeliche, specchi della forma divina, è nell’essere deiforme della città, simile all’increata luce di Dio, sua idea e partecipazione di Lui (Ap 21, 11: “quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius … sic et sancta ecclesia accipit a Deo claritatem, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei”). La luce della grazia e della gloria è specchio del divino. Il discendere della luce di cielo in cielo corrisponde alla dottrina dello Pseudo Dionigi, contenuta nel De angelica hierarchia e citata ad Ap 21, 21, secondo la quale, sebbene la gloria di tutti i beati provenga da Dio, tuttavia coloro che hanno un grado inferiore si troveranno connessi alla gloria dei loro superiori e si gioveranno del loro aiuto entrando, attraverso la gloria intermedia di questi, quasi per specchi chiari e per vetri tersi e per porte, in un più chiaro e alto atto di contemplazione e di fruizione di Dio. Il permanere dell’unità della luce nel suo moltiplicarsi negli angelici specchi corrisponde al mantenersi unita della città (Ap 21, 18.21).
L’Aquinate recita in versi quanto da lui scritto nella Summa theologiae (I, q. xliv, 3) circa la presenza nella sapienza divina delle ragioni di tutte le cose, cioè delle forme esemplari esistenti nella mente di Dio, causa prima esemplare di tutte le cose. Ma le parole dell’Aquinate, anche ammesso che corrispondano al suo pensiero più che a quello di altri scolastici, sono tutte armate di significati spirituali che suoi non sono, tratti da una diversa teologia della storia.
■ (I.5) La città è cinta in quadrato da un grande e alto muro con dodici porte (Ap 21, 12-13). Nell’edificare una città prima si trova il luogo e si scavano i fossati, poi si gettano le fondamenta e si edificano le mura, infine si innalzano le porte e si costruiscono le case. Queste tre fasi corrispondono ai tre stati generali del mondo. In primo luogo venne infatti eletto il popolo di Israele per preparare in esso questa nobile città. Con l’avvento di Cristo, fondamento, porta e portinaio, muro e baluardo, furono eletti gli apostoli quali fondamenta e dopo di essi i Gentili perché passassero nella fede il muro. Gli apostoli furono pure porte, per le quali i fedeli entrarono nella fede e nella Chiesa di Cristo. Al momento della conversione finale di Israele e di tutto il mondo verranno nuovamente innalzate dodici porte, assimilabili ai dodici apostoli, per le quali entri l’universo popolo dei fedeli. Tuttavia in qualsivoglia stato della storia umana le parti della città possono essere adattate misticamente, né è da sorprendersi, perché come cose diverse possono essere designate in modo unitario, così quel che è uno può essere significato in modo molteplice.
Molteplici sono le variazioni sui temi offerti dall’esegesi del muro della Gerusalemme celeste. Ad esempio, il castello degli “spiriti magni” di Inf. IV, 106-108 è “nobile” come la città, ha “alte mura” da cui è “cerchiato”, ed è “difeso intorno d’un bel fiumicello”.
Difendere è precipuo tema dei ventiquattro seniori i quali, ad Ap 4, 4 (nella parte proemiale della seconda visione), circondano la sede divina come principi, dodici da sinistra e dodici da destra, ordinati come muro e come famuli alla difesa della Chiesa (designano la “plenitudo gentium” e la conversione finale delle Genti e di Israele). Con il panno della sede e dei seniori è tessuta la parte principale dell’ordito degli “spiriti magni”.
Il “bel fiumicello”, che circonda e difende il “nobile castello” degli “spiriti magni” che non conobbero Cristo, è preparazione del “lume in forma di rivera” che Dante vedrà nell’Empireo (Par. XXX, 61-63). Il castello è anch’esso, come la città celeste, illuminato, ma solo per metà (da “un foco / ch’emisperio di tenebre vincia” o “la lumera” di Inf. IV, 68-69, 103).
■ (I.7) In una città immateriale descritta con similitudini corporee, è possibile vedere prima una cosa e poi un’altra che nella realtà non può stare insieme alla prima, come accade nella visione delle quattro ruote di Ezechiele. Appaiono molte cose inconsuete che si mescolano con quelle consuete, e ciò serve a elevare il contemplante o il lettore in uno stato di stupore (Ap 21, 17). Questo stato è cantato dal poeta nell’Empireo, allorché definisce la propria meraviglia, di gran lunga superiore a quanto sentito dai barbari provenienti da settentrione “veggendo Roma e l’ardüa sua opra … quando Laterano / a le cose mortali andò di sopra” (Par. XXXI, 31-42), versi nei quali non può non colpire la concordanza fonica di Laterano, “u’ siede il successor del maggior Piero”, con i latera della Gerusalemme celeste.
La terzina di Par. XXXI, 37-39, con la triplice antitesi – “ïo, che al divino da l’umano, / a l’etterno dal tempo era venuto, / e di Fiorenza in popol giusto e sano” -, conduce ad altra opera dell’Olivi, la prima quaestio de domina (de consensu virginali pro Annuntiatione). Ivi il francescano spiega su un piano psicologico il passaggio della Vergine dallo stato precedente la maternità al nuovo stato iniziato con l’assenso dato alla divina concezione. Come nel venire a un alto stato religioso, o nell’ascendere dalla vita attiva al culmine della contemplazione, o nel passare all’altra vita da questo secolo, un fedele prova un’ardua trascendenza, un estraniarsi e un’inusitata novità che pervadono di stupore ogni sentimento, e per questo si sente come morire al suo stato precedente, tanto più Maria, nell’ora dell’assenso, provò un ineffabile passaggio a uno stato sovramondano e a una regione inusitata, nella quale doveva venire assorbita in modo radicale e irrevocabile dagli eccelsi abissi degli arcani divini. Sentimenti provati dall’Annunziata e fatti propri dal poeta, che perviene a ricrearsi “nel tempio del suo voto riguardando”.
II
■ Dante ha rinnovato, entrando nell’Empireo, lo stesso sentimento di stupore e di elevazione al divino provato dalla Vergine nel momento della salutazione angelica (I.7). Il viaggio del poeta è mosso dall’imitazione di Cristo, della quale partecipano, dissonanti o consonanti, le realistiche passioni umane espresse dai personaggi incontrati e dalle vicende narrate. La visione finale, l’“ultima salute”, riguarda la duplice natura, divina e umana, di Cristo: “veder voleva come si convenne / l’imago al cerchio e come vi s’indova”. Il “poema sacro, / al quale ha posto mano e cielo e terra” si chiude sul mistero dell’incarnazione di Cristo, Dio e centro del tempo. Cristo è mediatore fra Dio e uomo; la Vergine, “la faccia che a Cristo / più si somiglia”, la più nobile delle creature, media anch’essa pregando affinché Dante veda Cristo; Bernardo, che nella vita terrena ha gustato della pace paradisiaca, prega affinché la Vergine preghi. La storia della salvezza umana viene a coincidere con la salvezza dell’individuo Dante. Come nell’ultimo stadio dell’Apocalisse, della quale sono stati saliti tutti i gradini, cessano le storie, così nel poema. Finiscono anche le profezie. Lo spirito profetico, infatti, non solo prevede eventi futuri ma, soprattutto, trascorre dal particolare all’universale e viceversa. Ciò è palese fin dai primi versi: “Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai”. Ora questi due poli, il collettivo e l’individuale, il nostro e l’io, coincidono.
■ Le parole della preghiera di san Bernardo sono segni che racchiudono temi di una millenaria tradizione dottrinale. Notava Auerbach, comparando i versi danteschi con l’elogio di Venere che apre il De rerum natura di Lucrezio, dove l’immaginazione ha libero gioco:
L’immagine dantesca di Cristo, come amore incarnatosi nel seno della Vergine per la salvezza dell’umanità, è un simbolo d’un avvenimento storico insostituibile con un altro esempio, inseparabile dalla dottrina. La rigida coerenza di storia, simbolo e dottrina conferiscono alla composizione della preghiera dantesca un grado di rigidezza che un poeta antico non avrebbe potuto né voluto raggiungere [5].
Il confronto con la tradizione mariana non consente di determinare fonti sicure [6]. Bernardo stesso è il tipo del contemplativo, non una figura storica, non l’uomo d’azione, ideologo della seconda crociata e persecutore di Abelardo [7].
La memoria del lettore spirituale avrebbe tuttavia colto, oltre a quelli tradizionali percepibili nel vago colore bernardiano che percorre i versi, ulteriori significati in rapporto alla Lectura super Apocalipsim e ad altre opere di Olivi.
■ È stato osservato che la “santa orazione” segue lo schema tripartito adottato da Boezio: invocazione (epiklêseis: vv. 1-3), elogio (aretalogia: vv. 4-21), petizione (euchai: vv. 22-39) [8]. Nel De Consolatione Philosophiae (III, m. 9) la Filosofia, interlocutrice dell’autore, prega Dio (“O qui perpetua mundum ratione gubernas”) affinché si renda visibile alla mente (“Da, pater, augustam menti conscendere sedem /… in te conspicuos animi defigere visus”). Nella Commedia Bernardo prega la Vergine affinché preghi Dio: “tutti miei prieghi / ti porgo, … perché tu ogne nube li disleghi / di sua mortalità co’ prieghi tuoi, / sì che ’l sommo piacer li si dispieghi”. In Dante c’è una figura di mediatrice o avvocata presso Dio estranea a Boezio.
Ferma restando la suggestione boeziana, si può proporre anche un altro tipo di divisione. Nel capitolo X della Lectura super Apocalipsim viene descritto l’angelo dal volto solare (che Olivi identifica in Francesco) toccando tredici punti:
In hoc capitulo tanguntur per ordinem tredecim magnalia istius angeli, quorum prima septem describunt perfectionem in ipso existentem, sex vero sequentia monstrant perfectionem ab ipso in reliquos manantem.
Nella preghiera dantesca le prime sette terzine (vv. 1-21) descrivono la perfezione che è nella Vergine, le sei successive (vv. 22-39) mostrano come questa perfezione da lei promana sugli altri, nel caso specifico sul poeta. Potrebbe trattarsi di una generica forma retorica, se all’esegesi del capitolo X non rinviassero numerosi e importanti luoghi del poema. Qualcosa di simile è avvenuto nella divisione del sonetto Vede perfectamente ogne salute, che nella Vita Nova segue il Tanto gentile e tanto onesta pare: “Questo sonetto à tre parti. Nella prima dico tra che gente questa donna più mirabile parea; nella seconda dico sì come era gratiosa la sua compagnia; nella terza dico di quelle cose che virtuosamente operava in altrui” (Vita Nova, 17. 14, ed. a cura di G. Gorni, Torino 1996). Ancora, nella divisione della canzone Amor che nella mente mi ragiona come viene commentata nel terzo trattato del Convivio, nella parte dedicata alla speciale lode della donna secondo l’anima il poeta procede prima “secondo che ’l suo bene è grande in sé”, poi “secondo che ’l suo bene è grande in altrui e utile al mondo” (III, vii, 1).
■ Peter Dronke ha comparato il verso della preghiera boeziana – “Dissice terrenae nebulas et pondera molis” – con le parole di san Bernardo – “perché tu ogne nube li disleghi / di sua mortalità” [9]. Disleghi è tuttavia anche segno dell’incipit della Lectura, con la citazione di Isaia 30, 26: “Erit lux lune sicut lux solis, et lux solis erit septempliciter sicut lux septem dierum, in die qua alligaverit Dominus vulnus populi sui et percussuram plage eius sanaverit”. La luce della luna (il Vecchio Testamento) sarà pari alla luce del sole (il Nuovo) e questa sarà sette volte più intensa, come la luce di sette giorni, il giorno nel quale Dio fascerà la ferita del suo popolo e sanerà le sue piaghe. Il verbo dislegare è accostato, nell’incontro con Stazio, al risanare le piaghe: «ecco qui Stazio; e io lui chiamo e prego / che sia or sanator de le tue piage. / “Se la veduta etterna li dislego”, / rispuose Stazio …» (Purg. XXV, 29-32). Per quanto dislegare (qui nel senso di far palese) sia il contrario di fasciare (alligare nel passo di Isaia), Dante ha comunque elaborato in volgare la citazione del profeta inserendo il primo verbo al posto del secondo e collocando quest’ultimo al termine del canto: “con tal cura conviene e con tai pasti /che la piaga da sezzo si ricuscia” (vv. 138-139). L’effetto dei due verbi è affine, perché dislegare e alligare sanano le piaghe. Stazio illumina Dante circa la “veduta etterna” sull’anima umana come Maria, nella preghiera di san Bernardo, dislega, cioè dissipa, “ogne nube … di sua mortalità”, quella legata alla colpa originale, “la piaga che Maria richiuse e unse”, secondo quanto afferma lo stesso contemplante a Par. XXXII, 4. Il lettore spirituale, giunto a “disleghi”, non solo poteva rammentarsi di Boezio (dissice), se mai lo conosceva, ma avrebbe collegato la parola alla piaga del peccato originale chiusa da Maria. È questo esempio di come le parole che formano il senso letterale siano imagines agentes che sollecitano la memoria del lettore verso un’opera di ampia dottrina che già conosce, ma che rilegge mentalmente parafrasata in volgare, profondamente aggiornata secondo gli intenti propri del poeta, in versi che le prestano “e piedi e mano” e la dotano di exempla contemporanei e noti.
■ L’orazione è anche un cantico di lode. La voce cantante dei compagni dell’Agnello sul monte Sion è soave, giocosa, modulata e proporzionata (Ap 14, 2): “e la voce che udii era come quella dei citaristi che si accompagnano nel canto con le loro arpe”.
Le corde della cetra – afferma Olivi – sono le diverse virtù, che non suonano se non siano tese, e non concordano se non siano proporzionate l’una con l’altra e non vengano toccate in ugual proporzione. È infatti necessario che gli affetti virtuali siano protesi in modo fisso e attento verso i loro termini e oggetti (“Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi”) e che, secondo le dovute circostanze, una virtù e i suoi atti concordino in modo proporzionato con le altre virtù e i loro atti e che essi siano congiunti in modo concorde, cosicché il rigore della giustizia non escluda né venga a turbare la dolcezza della misericordia né al contrario. La cetra è Dio stesso, o l’universa sua opera, della quale ciascuna parte o perfezione è una corda che, toccata dall’affetto del contemplante o del lodatore, rende con le altre una risonanza mirabilmente giocosa. Citarista è solo colui che, da maestro, ha l’arte e il frequente uso (“magister artificiose citharizandi”).
“Fissi e attenti” sono gli occhi di Dante nel “caldo … caler” dell’ardente Bernardo, il contemplativo i cui affetti sono tutti protesi verso il suo oggetto – la Vergine – come le corde di una cetra compulsata “per affectuales considerationes contemplantis”: “Affetto al suo piacer, quel contemplante” (Par. XXXI, 139-142; XXXII, 1). I devoti affetti delle orazioni spirano amore dai cuori dei santi designati dalle coppe (“phiale”: Ap 5, 8, passo che subisce numerose variazioni).
La cetra è Dio stesso, l’artista ha teso le sue corde ab aeterno verso l’umana redenzione, per cui la Vergine madre è “termine fisso d’etterno consiglio”.
Ancora, ad Ap 5, 9 – “et cantabant canticum novum” – si tratta del canto dei seniori dopo che l’Agnello ha preso il libro dalla destra di Colui che siede sul trono per scioglierne i sigilli, nella parte ‘radicale’ della seconda visione. Questo canto è “nuovo” perché la sua materia riguarda Cristo in quanto degno di aprire il libro, come uomo nuovo che reca una vita e una legge nuova; né esso mai invecchia, conserva anzi nella novità le virtù affettive di coloro che cantano. Il tema del conservare i cantanti nella novità divina, unito al motivo degli affetti citato ad Ap 5, 9, conduce all’ultima parte della preghiera di san Bernardo alla Vergine: “quia renovat et in novitate divina conservat suos cantatores. Si pulsatio et resonantia cithare in hoc cantico includatur, tunc designat omnium virtutum affectus et actus pulsari et resonare cum iubilo huius laudis. – Ancor ti priego, regina, che puoi / ciò che tu vuoli, che conservi sani, / dopo tanto veder, li affetti suoi. / Vinca tua guardia i movimenti umani” (Par. XXXIII, 34-37).
■ È stato rilevato che i primi tre attributi riferiti a Maria sono “figure della totalità […] complesse, atte a sopprimere l’opposizione fra il tempo e l’eternità” [10]. Le rigide parole della “stilizzata orazione” (Croce) [11] fanno segno di un’ampia dottrina, quasi racchiudendo significati già palesati nel corso del viaggio. La “Vergine madre” è la donna vestita di sole di Ap 12, 1, coronata da dodici stelle, perché in vita sostenne dodici guerre riportando altrettante vittorie. Dante l’ha già veduta nel Cielo stellato come “coronata fiamma” dall’“amore angelico”; essa è “viva stella / che là sù vince come qua giù vinse” (Par. XXIII, 91-96, 119). Concepì nell’utero del corpo e della mente Cristo; portò anche nell’utero del cuore l’intero corpo mistico di Cristo, cioè la Chiesa, come fosse la sua prole. Costei chiama gridando e partorisce con grave angustia il corpo mistico di Cristo che sarà rigenerato nella grazia e nella gloria di Dio, che è anche il Cristo che si formerà e nascerà nei cuori. Nel girone degli avari e prodighi purganti, una voce (Ugo Capeto) ‘chiama’ nel pianto, “come fa donna che in parturir sia”, e loda la povertà di Maria, “unica sposa de lo Spirito Santo”, attributo che è proprio anche della Chiesa (Purg. XX, 19-24, 97-99). La Vergine Maria, “chiamata in alte grida”, assistette la madre di Cacciaguida nelle doglie del parto (Par. XV, 133).
La Vergine è al di sopra della gerarchia angelica. La sua mente vede e gusta il Verbo suo figlio, cosa che nessun angelo poté mai sperimentare in sé, ma che ora può sperimentare tramite essa. L’anima della Vergine ama e loda Dio in modo più alto e fervido di qualunque angelo; può e vuole pertanto infiammare, esortare e trarre gli angeli a più alto amore e lode. Fa ciò guardando gli angeli, che ama come suoi figli e figli del suo figlio (“quos diligit ut suos filios et ut filios filii sui”). Dante ha trasferito il legame fra la Vergine e gli angeli, ‘figli del suo figlio’, sulla stessa Vergine, “figlia del tuo figlio”, completando in tal modo la scala fra divino e umano ispirata dalla dottrina dello Pseudo Dionigi sulle gerarchie angeliche.
L’antitesi “umile e alta” è tradizionalmente applicata alla Vergine, fin dal Magnificat. Non sarà casuale che, in terra, il periodo storico più umile e al tempo stesso più alto sia il sesto stato, che patisce e riceve piuttosto che agire, che è diletto da Cristo anziché portato ad amare Cristo, designato con l’evangelista Giovanni in antitesi all’apostolo Pietro. È il tempo del viaggio di Dante, protetto in cielo da “tre donne benedette” (Inf. II, 124-125). Interpretando due passi di Isaia (7, 4.11), Olivi afferma che la Vergine si umiliò con il Figlio fin nel profondo inferno, senza essere toccata dalla minima scintilla di concupiscenza o superbia, per poi ascendere altamente in Dio. Non diversamente Beatrice discese all’“uscio d’i morti” per salvare l’amico senza inquinarsi e poi tornò all’Empireo (Inf. II, 91-93; Purg. XXX, 139).
Ad Ap 19, 10 l’angelo vieta a Giovanni di riverirlo come un servo fa col padrone. Questo perché la “dignitas humani generis” è stata esaltata dall’umanità di Cristo. A Laodicea, l’ultima delle sette chiese d’Asia, Cristo si presenta come l’“Amen”, cioè il vero “testimone fedele e verace, che è il principio”, cioè la prima causa, “della creazione di Dio”, che crea ogni cosa dal nulla e ricrea gli eletti infondendo la grazia (Ap 3, 14). I santi vengono chiamati “creature di Dio”, secondo quanto detto nella lettera di san Giacomo – “Di sua volontà egli ci ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo l’inizio delle sue creature” (Jc 1, 18) –, e nella lettera di san Paolo agli Efesini – “Siamo sua fattura, creati in Cristo Gesù per le opere buone” (“Ipsius sumus factura, creati in Christo Ihesu in operibus bonis”; Eph 2, 10). Questa esegesi si diffonde variamente nel poema fino a Maria , la quale nobilitò l’umana natura “sì, che ’l suo fattore / non disdegnò di farsi sua fattura”.
■ Nel ventre tuo si raccese l’amore, / per lo cui caldo ne l’etterna pace / così è germinato questo fiore (vv. 7-9). Nella terza età del mondo, appropriata allo Spirito Santo con il suo vitale caldo di carità, l’albero della Chiesa, che ha tenuto le radici nella prima età e il tronco nella seconda, produce fiori e frutti (prologo, Notabili VI e VII). Acque pluviali (“germinativorum imbrium”) fecondano la terra rendendola fertile (Ap 4, 6-7; 10, 1; “germinato” è hapax nel poema). I motivi sono già presenti in Francesco, “ch’el cominciò a far sentir la terra / de la sua gran virtute alcun conforto” (Par. XI, 56-57). Benedetto ha parlato “di quel caldo / che fa nascere i fiori e ’ frutti santi”, cioè i contemplativi quali Macario e Romualdo, “fuochi tutti contemplanti” come lo è Bernardo (Par. XXII, 46-51; fiorire è per antonomasia proprio dei contemplativi dal santo affetto: cfr. prologo, Notabile XII). Accendersi d’amore virtuoso è tipico dell’intelligenza morale della Scrittura (Ap 6, 6).
■ Qui se’ a noi meridïana face / di caritate (vv. 10-11). “Meridïana” non è solo reminiscenza del Cantico dei Cantici (1, 6) [12]. La decima perfezione di Cristo in quanto sommo pastore (prima visione) consiste nell’incomprensibile gloria che gli deriva dalla chiarezza e dalla virtù, per cui si dice: “e la sua faccia riluce come il sole in tutta la sua virtù” (Ap 1, 16). Il sole risplende in tutta la sua virtù nel mezzogiorno, quando l’aere è sereno, fugata ogni nebbia o vapore grosso. Allora il viso corporeo di Cristo ha incomparabilmente più luce e vigore, e ciò designa l’ineffabile chiarezza e virtù della sua divinità e della sua mente. Lo splendore del volto indica l’aperta e fulgida conoscenza della Sacra Scrittura, che deve raggiare in modo più chiaro nel sesto stato, prefigurata dalla trasfigurazione sul monte avvenuta dopo sei giorni e designata dall’angelo che, al suono della sesta tromba, ha la faccia come il sole (Ap 10, 1). Maria è “la faccia che a Cristo / più si somiglia” (Par. XXXII, 85-87); nella sua chiarezza meridiana, predispone, essa sola, a vedere il figlio. Lo “splendor faciei” del volto di Cristo equivale al sorriso, quel ridere che è “una corruscazione della dilettazione de l’anima, cioè uno lume apparente di fuori secondo sta dentro” (Convivio, III, viii, 11), che nell’ultimo canto del poema è proprio di san Bernardo (v. 49) e perfino della Trinità (v. 126).
■ Ad Ap 12, 14, nella trattazione congiunta della terza e della quarta guerra, si dice che alla donna (la Vergine, la Chiesa) vengono date due ali di una grande aquila le quali, nella concorrenza del terzo stato dei dottori e del quarto stato degli anacoreti, rappresentano il potere temporale e quello spirituale. La donna non è più fuggitiva dalla durezza giudaica come nella prima guerra (Ap 12, 6), bensì regina che vola in modo magnifico al luogo predestinato come suo, incorporando in sé i Gentili. Il motivo della donna signora e regina delle genti nel proprio regno si mostra nelle parole con cui san Bernardo invita Dante a guardare i cerchi di troni della rosa celeste “infino al più remoto, / tanto che veggi seder la regina / cui questo regno è suddito e devoto” (Par. XXXI, 97, 100, 115-117). Riaffiora nella preghiera che lo stesso Bernardo rivolge alla regina del cielo: «“Et date sunt mulieri due ale aquile magne” … tamquam gentium domina et regina magnifice volavit – Donna, se’ tanto grande e tanto vali, / che qual vuol grazia e a te non ricorre, / sua disïanza vuol volar sanz’ ali … in te magnificenza … Ancor ti priego, regina, che puoi / ciò che tu vuoli …» (Par. XXXIII, 13-15, 20, 34-35).
■ Nella Vergine si ritrovano congiunte le caratteristiche delle tribù di Simeone e di Levi (Ap 7, 7), due delle dodici tribù d’Israele dalle quali provengono i 144.000 “segnati” all’apertura del sesto sigillo: “Septimo exigitur devota oratio supernarum gratiarum impetrativa et exauditione digna, quam designat Simeon, qui interpretatur auditio vel exaudibilis. … Ad zelum etiam tria exiguntur. Primo scilicet benigne miserationis pia condescensio, et hoc est Simeon, id est audiens merorem. … Octavo exigitur spes de superfluentia pietatis et liberalitatis Dei supererogantis ultra omnia vota et merita et ultra quam presumamus, et hanc designat Levi, qui interpretatur superadditus. – La tua benignità non pur soccorre / a chi domanda, ma molte fïate / liberamente al dimandar precorre. / In te misericordia, in te pietate … (Par. XXXIII, 16-19)”. Anche la preghiera di san Bernardo rientra nella tematica propria della tribù di Simeone in quanto orazione che impetra grazia e, poiché devota, grata ed esaudita (Par. XXXII, 147-148; XXXIII, 40-42). Il motivo di Simeone, “pia condescensio … audiens merorem” è risuonato per la prima volta nel poema nelle parole rivolte da Lucia a Beatrice affinché scenda in terra a salvare l’amico: “Non odi tu la pieta del suo pianto … Oh pietosa colei che mi soccorse! (Inf. II, 106, 133)”.
■ Fra gli “spiriti magni” che albergano nel “nobile castello” del Limbo Dante ha visto Aristotele: “vidi ’l maestro di color che sanno / seder tra filosofica famiglia” (Inf. IV, 131-132). La figura del maestro dell’umana ragione è tessuta con i fili di Colui che siede sul trono più alto (Ap 4, 3-4), con il quale condivide i motivi della somma sapienza, del sedere, dell’essere circondato da “famuli” fra i quali, quasi consiglieri o assistenti a lui più propinqui, stanno Socrate e Platone (vv. 134-135, la vicinanza a Dio è designata dalle bianche stole dei seniori). L’onore fattogli da parte di tutti (v. 133) corrisponde a quello tributato al sedente sopra il trono nella successiva lode dei quattro animali (o esseri viventi) e dei seniori ad Ap 4, 9-11 e a quello reso ad Ap 5, 12 a Cristo che ha aperto il libro segnato da sette sigilli. Il “nobile castello” è ‘figura’ in terra della “candida rosa” dell’Empireo, che di quella ‘figura’ è il compimento. Socrate e Platone stanno più vicini degli altri sapienti ad Aristotele; Adamo e san Pietro nell’Empireo siedono l’uno a sinistra e l’altro a destra di Maria, “più felici / per esser propinquissimi ad Agusta” (Par. XXXII, 118-119). La curia celeste è proiettata su quella terrena, che deriva anch’essa dal fonte dell’universale sapienza. Ad Aristotele, come a Maria, spetta il seggio mediano.
Ad Ap 8, 3, nell’esegesi della “radice” della terza visione, a Cristo, angelo che sta dinanzi all’altare, “furono dati molti incensi”, cioè molte orazioni a Dio piacenti. Gli vengono dati da quanti pregando commettono sé e i propri voti a lui come nostro mediatore e avvocato e gli chiedono di offrirli a Dio. Gli sono pure dati dal Padre, come detto in Giovanni 17, 6.11: “Erano tuoi e li hai dati a me. Padre santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato”. E nel Salmo 67, 19 si afferma: “Sei salito in alto e hai ricevuto uomini in dono”. Egli riceve in noi, che siamo le sue membra, i doni della grazia che ci vengono dati. “Gli furono dati molti incensi perché offrisse le preghiere di tutti i santi sull’altare d’oro, posto davanti al trono di Dio”, cioè per offrirle a Dio sopra i meriti derivanti dalla propria umanità, oppure sopra la basilare ara della divina verità e maestà.
Pregare perché altri preghino, motivo appropriato a Cristo cui vengono offerti molti incensi affinché li offra sull’altare, è la radice semantico-tematica di molte situazioni nel poema, dai figli del conte Ugolino a Matelda; Dante stesso viene assediato dalla calca delle ombre “che pregar pur ch’altri prieghi”, che chiedono cioè suffragi per rendere più breve la loro permanenza fuori della porta del purgatorio (Purg. VI, 25-27).
Virgilio è l’altare su cui Marzia, la moglie di Catone passata a Ortensio e ritornata al primo marito nell’età estrema della vita, offre la sua preghiera. L’espressione di Virgilio, che sta nel Limbo con la donna dagli occhi casti, riecheggia la preghiera di Cristo al Padre in Giovanni 17, 6.11, citata ad Ap 8, 3: “Tui erant, et michi eos dedisti” – “ma son del cerchio ove son li occhi casti / di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega, / o santo petto, che per tua la tegni: / per lo suo amore adunque a noi ti piega” (Purg. I, 78-81; cfr. Convivio IV, xxviii, 17). È variante rispetto alle parole dette a Ugolino dai figli: “tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia”.
L’altare può essere anche interpretato come la solida verità di fede o come la maestà di Dio su cui debbono essere fondati e offerti i nostri voti e sacrifici. Davanti ad esso sta Cristo uomo che, come pontefice, offre sé e noi a Dio. Né bisogna meravigliarsi che Dio rivesta più ruoli, di altare e di colui al quale vengono presentate le offerte.
L’ultima e più alta variazione è in san Bernardo, avvocato che prega perché altri preghi. Negli occhi dell’oratore si fissano quelli, diletti e venerati da Dio, della Vergine per mostrare quanto le siano grate le devote preghiere che poi rivolge a Dio drizzando lo sguardo all’eterno lume (Par. XXXIII, 40-43). Maria, come Cristo, è insieme altare e pontefice, riceve le preghiere e le offre: “Tui erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi” – “… tutti miei prieghi / ti porgo … perché tu ogne nube li disleghi / di sua mortalità co’ prieghi tuoi … Ancor ti priego, regina, che puoi / ciò che tu vuoli, che conservi sani, / dopo tanto veder, li affetti suoi. / Vinca tua guardia i movimenti umani …” (vv. 29-37).
“E il fumo degli incensi” (Ap 8, 4), cioè la spirituale fragranza delle devozioni che emanava dalle preghiere dei santi, “salì dalla mano dell’angelo davanti a Dio”, in quanto per merito e intercessione di Cristo offerente furono rese accettabili e, accettate, elevate in alto, con la cooperazione dell’influsso e del ministero della grazia di Cristo operante nella mente dei santi. Così dice Bernardo: “vedi Beatrice con quanti beati / per li miei prieghi ti chiudon le mani!” (Par. XXXIII, 38-39). Il turibolo aureo (il corpo di Cristo purissimo o i santi oranti che offrono le preghiere degli eletti) è “omni gratia Deo gratum et incenso sacre et odorifere devotionis repletum”. Per “il suo fedel Bernardo” la regina del cielo “ne farà ogne grazia” (cfr. Par. XXXI, 100-102), lì dove Catone può parlare di Marzia solo al passato, “che quante grazie volse da me, fei” (Purg. I, 85-87). Il tema del fumo degli incensi che sale dalle mani dell’angelo si è già manifestato nella nuvola di fiori che sale dalle mani angeliche e ricade in giù dentro al carro e attorno, nella quale Beatrice appare nell’Eden (Purg. XXX, 28-30).
Gli ultimi due versi della preghiera – “vedi Beatrice con quanti beati / per li miei prieghi ti chiudon le mani!” -, che assai piacquero a Benedetto Croce al quale parvero “veramente una scena da affresco giottesco” [13], hanno anch’essi un riferimento teologico-didascalico. Un passo dalla prima quaestio de Domina di Olivi, quella sul consenso dato dalla Vergine all’umana redenzione, attesta che, nell’ora della salutazione angelica, tutta la gerarchia celeste pregava per l’accettazione di tanto compito da parte di Maria. L’arcangelo Gabriele non agiva da solo, aveva il mandato di tutta la città di Dio. San Bernardo, che prega sostenuto da Beatrice e dai beati affinché la Vergine preghi che Dante possa levarsi “verso l’ultima salute”, è vero legato “di quella Roma onde Cristo è romano” (cfr. Purg. XXXII, 102).
■ Nell’Apocalisse Giovanni viene elevato a visioni sempre nuove. La ripetizione di questo elevarsi indica che ogni visione è più ardua rispetto al modo delle visioni precedenti. Ogni illuminazione dispone infatti la mente a riceverne una più alta (Ap 4, 2). La visione dell’Incarnazione, l’intelligenza dell’umano e del divino in Cristo, di come possa convenire il diametro con la circonferenza, è per il poeta l’ultima “vista nova”, per cui “indige” (hapax nel poema) del principio geometrico che non ritrova, come Giovanni indigeva di essere elevato ogni volta a più alta visione (Par. XXXIII, 133-136). Per questo ha pregato Bernardo: “che possa con li occhi levarsi / più alto verso l’ultima salute (vv. 25-27)”.
■Come negli attivi anacoreti del quarto stato rifulse l’amore verso Cristo, così nei contemplativi del sesto rifulge il loro essere diletti da Cristo, non diversamente da quel che si dice di Pietro, che amò Cristo, e di Giovanni, che fu prediletto da Cristo. In tal modo prerogativa del sesto periodo, nel quale Dante vive, è di essere disposto a ricevere e a patire, e in ciò si differenzia dagli stati precedenti, e soprattutto dal quarto, disposti a fare e a dare (Ap 3, 7), come il sangue femminile è diverso da quello maschile (cfr. Purg. XXV, 46-47). Vertice di questo eterno femminino che trae verso l’alto, la Vergine è diletta da Dio: “Li occhi da Dio diletti e venerati” (Par. XXXIII, 40).
■ Ad Ap 22, 20-21 si indica il fine di ogni sacro desiderio e di tutta la Scrittura, cioè il beatifico avvento di Cristo, che Giovanni chiede tre volte, e il desiderio che la grazia venga data a tutti. Dante, il nuovo Giovanni, dice dunque a Beatrice nel nono cielo: “Onde, se ’l mio disir dee aver fine / in questo miro e angelico templo / che solo amore e luce ha per confine” (Par. XXVIII, 52-54). Più alta replica sarà data nel decimo cielo, dopo la preghiera alla Vergine di san Bernardo: “E io ch’al fine di tutt’ i disii / appropinquava, sì com’ io dovea, / l’ardor del desiderio in me finii” (Par. XXXIII, 46-48). Bernardo, come Giovanni a Cristo, ha ripetuto tre volte la richiesta alla Vergine: “tutti miei prieghi / ti porgo, e priego che non sieno scarsi / … Ancor ti priego ..” (vv. 29.30.34).
III
La Passione
(III.1) Le parole “che dopo ’l sogno la passione impressa / rimane” (Par. XXXIII, 59-60) non fanno riferimento solo a una generica emozione. La “passione” che Dante prova nella visione rinnova quella di Cristo. Ciò è dimostrato dalla presenza di altri temi che sono propri dello stato dei martiri (il secondo). Costoro, assimilati nella passione alla figura di Cristo, diedero testimonianza a lui e alla sua fede lasciando ai posteri un esempio di virtù per la sua maggior gloria (prologo, Notabile XII). Il poeta ‘soffre’ e ‘sostiene’ (due verbi appropriati ai martiri: vv. 76, 80) l’acume del vivo raggio, e invoca la somma luce affinché offra di nuovo (‘ripresti’) alla sua memoria un barlume di quel che ha visto e affinché renda la sua lingua tanto possente da essere in grado, esprimendosi, di lasciare ai posteri anche solo una favilla della gloria divina. Così gli uomini meglio comprenderanno la “vittoria” di Dio, cioè il suo infinito valore, ma anche il suo trionfo sulla passione (vv. 67-75).
(III.3) I mezzi espressivi vengono meno, lo smarrimento e il ricordare del principio del poema tornano, ma il primo è superato:
“Io credo, per l’acume ch’io soffersi / del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito, / se li occhi miei da lui fossero aversi. / E’ mi ricorda ch’io fui più ardito / per questo a sostener …” (vv. 76-80); cfr. Inf. I, 3, 6: “ché la diritta via era smarrita … che nel pensier rinova la paura”.
Il dire del poeta è “corto” e “fioco”, inadeguato rispetto al concetto, a quanto cioè la mente ha ritenuto della visione, concetto che a sua volta è “poco” (vv. 115-123). Queste parole sollecitano la memoria verso l’esegesi di Ap 12, 14, che verte sull’inciso “un tempo, due tempi e la metà di un tempo”, riferito alla permanenza della donna nel deserto. Corrisponde a tre anni e mezzo (42 mesi), ovvero a 1260 anni se si computano i 30 giorni mensili come anni. Questo numero mistico, che nel poema subisce numerose metamorfosi, ha vari significati. I tre anni e mezzo designano in primo luogo il mistero della trinità di Dio unitamente alla perfezione delle sue opere, che rispetto al loro artefice sono qualcosa di dimidiato, imperfetto, parziale e quasi nulla: le opere furono infatti compiute in sei giorni, che corrispondono alle sei età del mondo e ai sei mesi del mezzo anno. “Corto”, “fioco”, “poco”, dopo che il poeta ha figurato la visione della Trinità, esprimono il significato contenuto nella “metà di un tempo”.
Il libro segnato da sette sigilli (III.2)
Terminata la preghiera di san Bernardo e indirizzatisi gli occhi della Vergine all’“etterno lume”, Dante porta a compimento in sé “l’ardor del desiderio” e si predispone alla visione (Par. XXXIII, 46-51). La vista del poeta “e più e più intrava per lo raggio / de l’alta luce che da sé è vera” (vv. 52-54), due versi che rinviano a un passo dei Moralia di Gregorio Magno: “magis magisque scientia celestis ostenditur, quasi interni nobis luminis vernum tempus aperitur”. Entrare nella luce della sapienza divina e delle scritture per mezzo della contemplazione è inoltre proprio del sesto stato della Chiesa; a questa visione cooperano tutte le illuminazioni dei precedenti stati (Ap 3, 7): “oportet statum illius temporis elevari et intrare ad ipsa lumina suscipienda et contemplanda”.
La Commedia, sul piano dei significati spirituali, è la metafora del libro segnato da sette sigilli, nuova Apocalisse scritta dal nuovo Giovanni inviato da Dio, come l’antico evangelista, a convertire l’orbe.
Ad Ap 5, 1 Olivi espone i vari significati del libro: la prescienza divina, la predestinazione a riparare l’universo per opera di Cristo, il Verbo del Padre in quanto espressivo della sua sapienza, la scienza delle intelligenze angeliche o quella scritta da Dio nell’anima di Cristo, il volume della Sacra Scrittura e in particolare dell’Antico Testamento, nel quale il Nuovo venne rinchiuso, sigillato e velato sotto varie figure.
Il libro sta nella destra di Dio (Ap 5, 1), sia perché è nel suo pieno potere e facoltà, sia perché contiene le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo, e le elargizioni e preparazioni che spettano alla destra, come le avversità e le cose temporali alla sinistra.
Sta nella destra di Colui che siede sul trono, sia perché contiene le leggi e i precetti del sommo imperatore e le sentenze e i giudizi del sommo giudice, sia perché la sua intelligenza richiede una mente alta, stabile, matura, quieta e raccolta, come è proprio dell’intelligenza divina.
È un libro scritto dentro e fuori, poiché il libro della Sacra Scrittura ha un senso letterale di fuori, mentre dentro contiene il senso anagogico, quello allegorico e quello morale. Di fuori il senso letterale narra le storie, le gesta e gli esempi dei santi e le loro opere esteriori; dentro sono le più profonde sentenze dei divini precetti e degli insegnamenti sapienziali.
Su questi vari significati recati dal “panno” esegetico sono cucite molte parti della “gonna”, e ciò è stato mostrato altrove.
La prima delle due similitudini con le quali il poeta esprime il dissolversi della visione della somma luce – “Così la neve al sol si disigilla” (v. 64) – fa riferimento alla “solutio sigillorum” del libro da parte di Cristo. La neve designa la sapienza di Cristo rigida, congelata, astratta, punitiva, che si scioglie temperandosi pietosamente nel caldo della lana, secondo l’interpretazione dei due aspetti dei capelli di Cristo sommo pastore ad Ap 1, 14. Un precedente sono le superbe parole di Beatrice la quale, apparsa nell’Eden, rimprovera l’amico il cui cuore si stringe – “sì come neve tra le vive travi / per lo dosso d’Italia si congela” -; poi, al canto temperato degli angeli, si scioglie facendosi “spirito e acqua” (Purg. XXX, 70-99).
La seconda similitudine – “così al vento ne le foglie levi / si perdea la sentenza di Sibilla” (vv. 65-66) – accenna con immagine virgiliana al dissolversi di una sentenza, quella della Sibilla cumana scritta su foglie che il vento, penetrato nell’antro dalla porta, disperdeva. L’arcana profetessa è figura antica di una sentenza che si perde, quella per cui il libro della vita era chiuso da sette sigilli all’umana intelligenza prima che fosse pagato con la passione di Cristo il prezzo della colpa. Alle “foglie levi” agitate dal vento subentrano le foglie sacramentali del lignum vitae, l’albero che sta nel mezzo della Gerusalemme celeste, che ombreggiano entrambe le rive, la divina e l’umana, del fiume luminoso (Ap 22, 1-2). Vento e leggerezza sono propri dell’adolescenza agitata dall’errore (prologo, Notabile III), un accostamento già presente in “quei due che ’nsieme vanno, / e paion sì al vento esser leggeri” (Inf. V, 74-75).
Così le due similitudini, che letteralmente descrivono il dileguarsi dalla mente della visione divina, indirizzano la memoria del lettore spirituale sull’apertura dei sigilli apposti al libro.
La metafora del libro, che contiene al suo interno le più profonde sentenze divine e i documenti sapienziali, torna con la visione dell’unità del molteplice: “ciò che per l’universo si squaderna” – “sustanze e accidenti e lor costume”, che si mostrano in modo sparso e diviso -, “s’interna” nel profondo della luce eterna “legato con amore in un volume … quasi conflati insieme” (vv. 85-90). Dante vede “la forma universal di questo nodo”, che tiene unita in Dio la multiformità dell’universo, e crede che ciò sia vero “perché più di largo, / dicendo questo, mi sento ch’i’ godo” (vv. 91-93). Il tema dell’allargarsi della superna scienza, contenuto nel passo di Gregorio Magno, si congiunge con quello della larghezza della città celeste (Ap 21, 16), che si dilata nel gaudio, dopo che il poeta, con il suo “ficcar lo viso per la luce etterna”, ne ha designato la lunghezza (vv. 82-84).
La visione, all’interno del “volume”, della molteplicità fusa in unità – “sustanze e accidenti e lor costume / quasi conflati insieme” (vv. 88-89) – reca nel rarissimo latinismo conflati, che rinvia alla pace preconizzata in Isaia 2, 4 – “Conflabunt gladios suos in vomeres” (l’immagine opposta, delle falci rifuse in spade, è deplorata da Virgilio nelle Georgiche I, 508: “curvae rigidum falces conflantur in ensem”) -, l’immagine di una pacifica unità nella luce divina.
Visione intellettuale moderna e visione materiale antica
(III.4) La luce divina, che tanto si leva dai concetti mortali, per cui la sua espressione sembra essere chiusa alla lingua del poeta, è “punto” nell’ultima visione: “Un punto solo m’è maggior letargo / che venticinque secoli a la ’mpresa / che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo” (Par. XXXIII, 94-96).
Già nel Primo Mobile Dante ha visto “un punto … che raggiava lume / acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca / chiuder conviensi per lo forte acume” (Par. XXVIII, 16-18). Intorno al punto, che designa la semplicità e indivisibilità di Dio, girano nove cerchi concentrici di fuoco via via meno veloci quanto più se ne allontanano, che rappresentano le gerarchie angeliche. Come afferma Beatrice, “da quel punto / depende il cielo e tutta la natura” (vv. 41-42). A Dio viene appropriato il tema del sesto stato della Chiesa come “punto”, fine da cui dipende tutto il processo storico. È “punto che mi vinse” (Par. XXX, 11). Un punto luminoso non solo matematico o metafisico, ma anche storico-provvidenziale e spirituale, che riassume cioè tutti e sette i doni che lo Spirito increato, uno semplicissimo e molteplice, distribuisce e tutte le illuminazioni del libro progressivamente aperto agli uomini.
Il “letargo” indotto dalla visione del “punto” è l’oblio provocato dalla visione suprema esposta ad Ap 1, 16-17, quando il sublime “splendor faciei” di Cristo imprime negli inferiori un sentimento di annullamento e di umiliazione, di tremore e di adorazione. Il “punto” che è causa di oblio si contrappone, sul piano temporale, ai “venticinque secoli” che sono trascorsi, non ponendola in dimenticanza, dall’impresa degli Argonauti. Si contrappone ancora, sul piano spaziale, a qualcosa di ‘grosso’, cioè all’ombra della grande nave che Nettuno meravigliato guarda dal basso solcare il mare: un accostamento, quello del “punto” e dell’ “ombra”, che è proprio anche del cono d’ombra proiettato dalla terra (la ‘mole grossa’ del “vostro mondo”) che “s’appunta”, cioè termina, sul terzo cielo di Venere (Par. IX, 118-119).
Fra i dodici esercizi di ascesi alle virtù, proposti nell’esegesi di Ap 7, 5-8 come interpretazione dei nomi delle dodici tribù d’Israele da cui proverranno i 144.000 segnati all’apertura del sesto sigillo, la quinta tribù, Nèftali, rappresenta la virtù che sa trasferirsi dal sensibile allo spirituale e all’eterno, di modo che il sensibile e il temporale appaiano segno e specchio dell’intellettuale e dall’innumerevole multiformità del sensibile ci si dilati nella contemplazione dell’intellettuale. Per questo Nèftali (Ap 7, 6) viene interpretato come “comparatio” o “conversio translativa” o “latitudo”. Poi si esige la dimenticanza dello stesso sensibile; per passare infatti dal segno relativo e dallo specchio all’intellettuale bisogna spogliarsi del sensibile come di veli tenebrosi. Questo il significato della sesta tribù, Manasse, nome interpretato come “oblivio”. Nell’ordine degli esercizi viene dunque prima la dilatazione o la larghezza, poi l’oblio. Così la terzina che concerne il “letargo” (Par. XXXIII, 94-96) segue quella (vv. 91-93) in cui il poeta dichiara di aver visto “la forma universal di questo nodo” – cioè l’amoroso legame “in un volume” di “ciò che per l’universo si squaderna: / sustanze e accidenti e lor costume / quasi conflati insieme …” (vv. 85-90) -, e crede che sia così “perché più di largo, / dicendo questo, mi sento ch’i’ godo”. Conseguita la dilatazione contemplando in Dio la forma universale dell’innumerevole multiformità del sensibile, al poeta tocca l’oblio che si libera dai veli tenebrosi, figurati dall’ombra della nave degli Argonauti, antico precorrimento, con reminiscenze ovidiane (Am., II, 11, 1-2) e virgiliane (Aen., I, 124-128; VIII, 91), del viaggio “in pelago” del suo “legno che cantando varca” (cfr. Par. II, 1-18). Nella Lectura “ombra” e “velo” sono termini di significato equivalenti; l’“umbra velaminis” viene compiutamente tolta dalla gloria di Cristo per la quale, nel sesto e nel settimo stato, la luce della luna (il Vecchio Testamento) sarà come quella del sole (il Nuovo Testamento) e risplenderà della luce di sette giorni, cioè di tutte le illuminazioni verificatesi nella storia, secondo quanto scritto in Isaia 30, 26, passo assunto dall’Olivi come incipit del commento all’Apocalisse. I veli, o l’ombra, designano la poesia stessa, che spira da Dio e ombreggia con segni e con figure, cioè con immagini, verità superiori, come i sacramenti ombreggiano la verità divina (ad Ap 22, 2). Il “letargo” determinato dal “punto” divino è annullamento dell’ombra: l’intelletto tanto si profonda nella visione di Dio, che nessuna immagine si ritrova per esprimerla.
Nel sesto stato ci si dedicherà più al gusto della contemplazione che alle forti opere della vita attiva, e per questo non sarà data a questo periodo tanta forza e virtù per forti opere, come è stata data agli stati precedenti, e in particolare agli anacoreti del quarto, opere che gli uomini sensuali ammirano, stimano e, da esse mossi, sono tratti a imitare e desiderare più di quelle intellettuali e interne. Per compensare il difetto di virtù, al sesto stato è data la porta aperta, cioè l’illuminazione che detta interiormente; il sesto periodo non registra miracoli corporali, ma intellettuali (Ap 3, 7).
All’inizio del viaggio, Dante dubita della propria virtù – “Poeta che mi guidi, / guarda la mia virtù s’ell’è possente”, Inf. II, 10-12 -, perché “ad immortale secolo” andarono solo Enea e san Paolo. Il primo a causa dell’“alto effetto” che doveva uscire dalla sua vittoria: il “victoriosus effectus” è il conseguimento della quarta vittoria, degli operosi anacoreti (Ap 2, 26-27). Il secondo per recare conforto alla fede. Dante non è Enea né Paolo, non ha virtù per opere forti, non vive in un momento in cui la conversione si opera per i miracoli. Ha scarsa virtù, ma in compenso la porta gli è aperta. Glielo dirà Cacciaguida: “sicut tibi cui / bis unquam celi ianüa reclusa?” (Par. XV, 29-30).
Al termine del viaggio, san Bernardo chiede per Dante alla Vergine di dargli virtù possente: “supplica a te, per grazia, di virtute / tanto, che possa con li occhi levarsi / più alto verso l’ultima salute” (Par. XXXIII, 25-27).
Forte fu l’impresa degli Argonauti, ammirata da Nettuno e ricordata ancora dopo venticinque secoli; essa è assimilabile alla possente virtù data al quarto stato, tempo per eccellenza delle res gestae (gli stati sono al contempo periodi storici e modi di essere delle persone, habitus). Le si contrappone il “punto”, non sensibile ma intellettuale, vero simbolo del sesto stato, il tempo nel quale Dante vive, causa finale della storia umana.
La sesta vittoria (III.6)
Nella prima visione apocalittica, a ciascuna delle sette chiese d’Asia è data una vittoria. La più importante è quella conseguita da Filadelfia, la sesta chiesa, perché la visione è maggiore; essa porta a consumazione la vittoria conseguita da Tiàtira, la quarta chiesa, che rappresenta per antonomasia lo stato dei contemplativi.
La sesta vittoria (Ap 3, 12) per Olivi è l’ingresso in Cristo, che si consegue con una perfetta configurazione e trasformazione della mente in lui. Il vincitore sta come una colonna nel tempio di Dio e non ne uscirà più; ha iscritto nella mente il nome della nuova Gerusalemme, definita “visione di pace” che discende dal cielo, e il nuovo nome di Cristo. E come la città discende da Dio e poi a lui ritorna, così la contemplazione, formando un circolo glorioso, inizia da Dio e per la città di Dio ascende in Cristo suo re, da dove ritorna e rientra in Dio. Questa vittoria non è solo ottenuta dai beati: si consegue anche in terra, nella Chiesa militante del sesto e settimo stato.
Nel primo momento della visione finale, in cui vede l’unità dell’universo in Dio, Dante sta come una colonna nel tempio, con la mente “fissa, immobile e attenta” (Par. XXXIII, 97-98), di fronte a una luce che non consente di “volgersi da lei per altro aspetto”, come lo stare fisso nel tempio non consente distrazioni (vv. 100-105). La contemplazione dell’unità dell’universo in Dio è assimilata all’interno del libro segnato da sette sigilli.
Poi contempla il mistero della Trinità (vv. 115-120), infine quello dell’Incarnazione (vv. 127-145). La contemplazione della Trinità e quella di Cristo in quanto uomo si conseguono con la sesta vittoria: “In huiusmodi autem mente tria inscribuntur, scilicet excessiva visio vel contemplatio deitatis trium personarum – parvermi tre giri / di tre colori e d’una contenenza … Tertium quod sibi inscribitur est contemplatio Christi secundum quod homo et secundum quod redemptor noster et mediator – mi parve pinta de la nostra effige”. “Qual è ’l geomètra che tutto s’affige / per misurar lo cerchio” (nel “tutto s’affige” è il tema della colonna), Dante si trova di fronte “a quella vista nova” – il “nomen novum” di Cristo uomo, redentore e mediatore -, incapace di comprendere come l’effigie umana si adatti e si collochi nel cerchio (tema del “circulus gloriosus”; Par. XXXIII, 133-138).
Il tema della “visio pacis” e della contemplazione come circolo appare nella rosa celeste, che ha la sua pace solo nel vedere Dio, distendendosi “in circular figura” (Par. XXX, 102-103). Da notare che la ‘circolarità’ è propria sia della rosa, cioè della città – “Vedi nostra città quant’ ella gira” dice Beatrice (v. 130) -, da cui le schiere del trionfo di Cristo, insieme a questi e sua madre, sono in precedenza discese al cielo delle stelle fisse per poi risalire all’Empireo (Par. XXIII; XXVII, 67-72); sia del Figlio fattosi uomo nella visione finale – “Quella circulazion che sì concetta / pareva in te come lume reflesso” (Par. XXXIII, 127-132). Contemplare e gustare la pace in questo mondo sono appropriati a san Bernardo (Par. XXXI, 110-111): l’esegesi della sesta vittoria è da collazionare con un passo del notabile VIII del prologo della Lectura, relativo al settimo stato, nel quale si potrà pregustare in questa vita, poco prima della fine del mondo, la vita eterna.
Una visione travagliata
Colui che contempla un’ardua visione, come lo splendore del volto di Cristo nel meriggio del sesto stato (Ap 1, 16-17), prova un’intima mutazione. La luce divina, afferma il poeta, pur essendo semplice e immutabile sembiante, tuttavia si trasforma – “a me si travagliava” – nel mutarsi del soggetto vedente, “per la vista che s’avvalorava / in me guardando” (Par. XXXIII, 109-114): sul piano teologico è così offerta la giustificazione al succedersi di figure diverse con cui la poesia descrive la visione, che è una, dei misteri della Trinità e dell’Incarnazione.
L’intimo mutarsi, che per Olivi è segno della vera visione, è già stato proprio di Beatrice nell’Eden, nei cui occhi il grifone-Cristo, che pur sta fermo (nella sua unità e semplicità), raggia la sua immagine (il suo “idolo”) “come in lo specchio il sol (et facies eius sicut sol … debet preclarius radiare) … or con altri, or con altri reggimenti”, cioè come duplice natura, umana-leone e divina-aquila (Purg. XXXI, 121-126).
Contro l’apparente stoltezza, per la quale Dio si è fatto uomo ed è morto per dare soddisfazione alle ingiurie a lui stesso arrecate e ha redento con tale prezzo coloro che avrebbe potuto salvare con il solo suo potere, sta il “valore”, di incomparabile lucro, che deriva dal commercio della dottrina di Cristo. In cambio di un solo denaro – la fede unica e semplice – si ottengono infatti beni senza prezzo, cioè il grano, l’orzo, il vino e l’olio di cui si dice nell’apertura del terzo sigillo e che corrispondono ai quattro sensi della Scrittura (Ap 6, 6). Il commercio della sapienza tramite lo studio della Scrittura si contrappone alla bilancia dolosa ed erronea degli eretici, che vacilla dal retto equilibrio della verità. Il tema del valore incomparabile ottenuto in cambio di un solo denaro e di una fede unica e semplice viene utilizzato dal poeta per esprimere l’avvalorarsi della propria vista che, nella visione finale della Trinità e dell’Incarnazione, subiva crescenti mutazioni di aspetti pur rimanendo la luce divina, oggetto della contemplazione, “un semplice sembiante” e “una sola parvenza”.
La Trinità nella sede divina (III.5)
Par. XXXIII, 115-120, 124-132Ne la profonda e chiara sussistenza
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 2-5] Quoniam autem presentatio seu descriptio summe magnificentie et reverentie et sapientie maiestatis Dei et assistentium sibi plurimum confert ad advertendum profundam et altam et gloriosam continentiam huius libri a Dei dextera tenti, idcirco in prima parte magnificatur Dei maiestas ex septem. Primo scilicet ex sue sedis alta eminentia. […] Tertio ex sue sedis archuali refulgentia, ibi: “Iris erat”. […] Sexto ex septem lampadum et maris preclari obsequiosa seu adornatoria ante sedem coassistentia, ibi: “Et septem lampades”. […] Dicit ergo: “Et ecce sedes posita erat in celo, et supra sedem sedens”, scilicet erat. Deus enim Pater apparebat ei quasi sub specie regis sedentis super solium. Per hanc autem sedem significatur primo altissima stabilitas essentie Dei, in qua et per quam Deus maiestative existit. […] Quelibet etiam metropolitana ecclesia et precipue illa que est caput omnium, scilicet romana, dicitur sedes Dei. […]
“Et iris erat in circuitu sedis similis visioni [s]maragdine”, id est viridis coloris smaragdi. Smaragdus enim est gemma cui, secundum Isidorum et Papiam, nichil viridius comparatur. Nam virentes herbas et frondes exsuperat et intingit circa se viriditate repercussum aerem, soloque intuitu implet oculos nec satiat, est enim gratiosissima visui.
Nella visione finale della Trinità, della “luce etterna che sola in te sidi” (Par. XXXIII, 124), si rispecchiano i temi della sede divina nell’esegesi di Ap 4, 2-5, dove Dio Padre appare a Giovanni come un re che siede sul trono e tiene nella destra il libro segnato da sette sigilli, che poi l’Agnello aprirà. In quattro versi (115-118) si ritrovano almeno sei elementi semantici che nella Lectura designano altrettanti attributi della sede: la “sussistenza” (che corrisponde alla “stabilitas essentie” della maestà divina; cfr. “subsisto” a Par. XXIX, 15) dell’“alto” lume è “profonda” e “chiara” (essere alto e profondo è proprio del contenuto del libro, la chiarezza appartiene al mare trasparente che sta dinanzi alla sede); in essa Dante vede “tre giri / di tre colori e d’una contenenza” (di una medesima dimensione, che corrisponde alla “continentia” del libro) e il secondo dei tre giri (il Figlio) che pareva riflesso dall’altro (il Padre) “come iri da iri” (la sede rifulge nell’arco dell’iride, che sta “in circuitu”). Nell’esegesi sono specificati, sulla base del testo sacro, i colori che riguardano la sede. L’aspetto di colui che siede sul trono, è simile a pietra di diaspro e di sardonice, cioè di colore verde e rosso sangue (Ap 4, 3). Si dice che Dio è simile a una pietra poiché per sua natura è fermo e immutabile, solido e stabile nella giustizia, tutto governa e stabilisce con la potenza infrangibile della propria virtù. Il diaspro (“iaspis”) è di colore verde come l’erba, e rappresenta l’immarcescibile verdeggiare di Dio, assai dilettevole e grazioso agli eletti. La sardonice (“sardius”) è rossa sia per la carità e la pietà verso gli eletti come per l’ira e l’odio verso i reprobi. L’arrossare di Dio, inoltre, è perché per noi volle e fece il Figlio colorato nel rosso del suo sangue. L’iride è inizialmente verde, assume poi vari colori secondo l’intensità dei raggi solari. Dante, descrivendo la visione della Trinità e dell’Incarnazione, parla di “tre giri di tre colori” per la prima; della seconda dice che “dentro da sé, del suo colore stesso, / mi parve pinta de la nostra effige”, ma in entrambi i casi non definisce alcun colore. Dall’esegesi della sede trae gli elementi più astratti.
Contenenza è hapax nel poema; nell’unica occorrenza si mostra, caso non isolato, associata a parole – profonda, chiara, sussistenza, alto – che si rispecchiano nell’esegesi e che fanno segno di questa.
Le parole “e l’un da l’altro come iri da iri / parea reflesso” sono sviluppo del tema dell’aria che gira con il Primo Mobile ed è ripercossa dalla folta selva dell’Eden verso la terra abitata dall’uomo, appunto “come iri da iri”, secondo quanto spiegato da Matelda (Purg. XXVIII, 103-111).
Lo ‘spirare’ come fuoco del terzo giro (lo Spirito Santo) in modo uguale dal primo e dal secondo (vv. 119-120) è pure tema connesso alla sede e al libro, come appare dall’esegesi delle coppe spiranti d’amore ad Ap 5, 8.
Il verso 120 – “che quinci e quindi igualmente si spiri” – fa riferimento alla somma concordia (“equalitas”) della Gerusalemme celeste, i cui quattro lati hanno uguale misura in lunghezza, altezza e profondità (Ap 21, 16).
Antica prefigurazione in terra della sede divina è il “nobile castello” del Limbo dove, “sovra ’l verde smalto”, siedono il re Latino con sua figlia Lavinia e Aristotele circondati dagli “spiriti magni” (Inf. IV, 125-126, 132).
La sede divina, secondo Olivi, ha la sua proiezione terrena nella sede romana, capo di tutte le altre sedi metropolitane. Con la visione finale Dante è finalmente “cive / di quella Roma onde Cristo è romano” (Purg. XXXII, 101-102).
Il meriggio dell’Empireo (III.8)
I signacula dell’esegesi del volto di Cristo che irradia, nel meriggio del sesto stato, più luce e più rivelazione della Scrittura (Ap 1, 16-17) percorrono tutta la terza cantica a partire dal principio, con la gloria della divina virtù che risplende, con l’essere il poeta disceso dal “ciel che più de la sua luce prende” (Par. I, 1-2, 4, 22). Lo splendor faciei di Cristo, che si incarna nel sorriso di Beatrice, discorre per tutto il Paradiso, con variazioni della rosa semantica che lo costella.
San Bernardo invita Dante a riguardare “ne la faccia che a Cristo / più si somiglia, ché la sua chiarezza / sola ti può disporre a veder Cristo” (Par. XXXII, 85-87): « … sue claritatis … “et facies eius …”». Maria, nella preghiera, è “meridïana face / di caritate” (Par. XXXIII, 10-11) – «“et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie» (si noti la concordia fonica tra “facies / faccia” e “face / fiaccola”). Dopo, Bernardo accenna e sorride affinché il poeta si volga all’alta luce (vv. 49-50).
Nella visione finale dell’Incarnazione, il sorriso appartiene alla “… luce etterna che sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente te ami e arridi”.
La misura della città celeste
■ (III.7) I quattro lati delle mura della città formano un quadrilatero (Ap 21, 16), che designa la solida quadratura delle virtù (a Cacciaguida il poeta dice di sentirsi “ben tetragono ai colpi di ventura”: Par. XVII, 23-24). I quattro lati sono uguali in lunghezza e in larghezza. La città dei beati quanto vede di Dio e dei suoi beni tanto ama, quanto è lunga nella visione tanto si dilata nella carità, quanto si prolunga nell’eterno tanto si dilata nel gaudio giocoso e glorioso. Lo stesso può dirsi di coloro che in questa vita raggiungono la perfezione, i quali quanto conoscono o credono tanto amano, quanto per la speranza si protendono nei beni eterni tanto si dilatano nel gaudio. Nei beati le quattro virtù cardinali – prudenza, fortezza, giustizia e temperanza -, designate dai quattro lati della città, hanno uguale misura. Anche l’altezza è uguale alla lunghezza e alla larghezza, poiché quanto i beati per la visione e per l’amore si protendono in lungo e in largo, tanto si elevano nell’alta lode e nella reverenza verso Dio e nell’alto apprendimento e degustazione della sua sublime maestà. Tuttavia in questa vita l’altezza, proporzionata alla misura della carità e del tendere in Dio, sta comunemente solo nel desiderio e nella speranza di raggiungere la compiuta misura della patria celeste. Un edificio si pone infatti diversamente nel suo inizio e nella perfezione del fine.
Nella descrizione dell’empirea rosa, la fiumana luminosa, che prima appariva in lunghezza, successivamente diviene tonda distendendosi in figura circolare, con una circonferenza che sarebbe cintura “troppo larga” per il sole (Par. XXX, 88-90, 103-105). La rosa sempiterna “si digrada” (si allunga nel senso di protendersi), “e dilata” (si allarga) “e redole / odor di lode al sol che sempre verna” (l’elevarsi nell’altezza; vv. 124-126).
Nel riferire l’ultima visione, Dante prima ricorda “l’abbondante grazia ond’ io presunsi / ficcar lo viso per la luce etterna” (la visione corrisponde alla lunghezza), poi afferma di aver visto la forma universale del nodo che unisce tutte le cose perché, dicendo ciò, prova un godimento più largo (i perfetti, i quali “in gaudio dilatantur” in questa vita, designano la larghezza; Par. XXXIII, 82-93). Il vedere del poeta è tanto più sincero quanto più entra nel raggio dell’alta luce (vv. 52-54), che tanto si eleva sui concetti mortali (vv. 67-68: l’altezza).
Nei beati, come sa Dante che si rivolge a Cacciaguida, “l’affetto e ’l senno” (la larghezza e la lunghezza) sono di pari peso dal momento in cui essi hanno cominciato a contemplare Dio (definito, per restare nel medesimo ambito tematico, “la prima equalità ”, il sole uguale nel calore della carità e nella luce della visione), diversamente dai mortali, nei quali “voglia e argomento” (corrispondenti all’affetto e al senno) hanno ali disuguali (Par. XV, 73-84). Al termine del viaggio, la lunghezza (“il mio disio”, che esprime anche l’altezza, “secundum mensuram sue tensionis”, e dunque la “sete natural” di cui a Purg. XXI, 1-4) e la larghezza (“’l velle”) saranno in Dante “sì come rota ch’igualmente è mossa” (Par. XXXIII, 143-145). Lo Spirito di Cristo, nell’invitare alla gloriosa cena delle nozze dell’Agnello, dice: “Et qui sitit veniat. Et qui vult accipiat aquam vite gratis”, perché, aggiunge Olivi, “nullus cogitur nec potest venire nisi per desiderium et voluntarium consensum” (ad Ap 22, 17).
■ (III.9) Un angelo ha la canna d’oro – «habens “mensuram arundineam auream”» – con la quale misura la Gerusalemme celeste (Ap 21, 15). Designa i rettori e i dottori, i quali nel loro reggere o insegnare possiedono la sapienza della Scrittura sacra che è come una canna per il suono della predicazione e per l’umile sentimento della propria fragilità, vacuità e nullità, ed è aurea per il folgorare della conoscenza divina. Con la canna essi misurano la città, le mura e le porte, sia perché insegnano la regolarità della misura, sia perché con discreta misura reggono tutta la Chiesa e regolano l’entrare e l’uscire.
Il tema del misurare l’entrata e l’uscita della città superna è nell’entrare e uscire dei “topazi”, cioè delle “faville vive” (gli angeli), dal fiume di luce che il poeta vede nell’Empireo (Par. XXX, 64-69, 76-78; i motivi del fiume e degli “umbriferi prefazi” provengono da Ap 22, 1-2, il topazio è una delle gemme che ad Ap 21, 20 adornano le fondamenta della città). La regolare misura dell’entrata e dell’uscita era data (Lana), nella “Fiorenza dentro da la cerchia antica”, figura in terra della città celeste, dalla campana della chiesa di Badia, la quale suonando “e terza e nona” segnava l’entrata e l’uscita dal lavoro dei lavoranti delle arti (Par. XV, 97-98).
A questa esegesi rinviano precisi signacula incastonati nel senso letterale della visione finale:
Par. XXXIII, 133-141Qual è ’l geomètra che tutto s’affige
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 15] Angelus vero habens “mensuram arundineam auream” designat rectores et doctores, qui in exemplari opere et potestate regendi et docendi habent sapientiam scripture sacre, que per sonum predicationis et per humilem sensum proprie fragilitatis et vacuitatis sive nichilitatis est arundo, et per fulgorem divine cognitionis est aurea.
Dante, nel cercare di comprendere come nella sua “vista nova” l’immagine umana di Cristo si convenga e abbia luogo nel cerchio, si trova a essere come il matematico tutto preso inutilmente a risolvere il problema della quadratura del cerchio. Le sue ali non sono capaci di tal volo, per cui egli riconosce umilmente la propria fragilità e nullità, ma un lampo percuote la sua mente facendole venire ciò che voleva, cioè la chiara visione del mistero dell’incarnazione.
Il motivo del ritrovare proviene dal recuperare il grado di perfezione originario (l’aurea prima carità) al quale viene invitato il vescovo di Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia (Ap 2, 5; prima visione): il “non ritrova, pensando” del finale del poema corrisponde così al “mi ritrovai per una selva oscura … che nel pensier rinova la paura” dell’inizio.
Pensare attentamente a un principio perduto – “e non ritrova, / pensando, quel principio ond’ elli indige” – è nell’invito fatto al vescovo di Sardi, la quinta chiesa, di avere in mente la prima grazia ricevuta e di vegliare (Ap 3, 3). Ricordare uno stato che venne prima, congiunto con il tema della bellezza dei suoi inizi poi corrottisi (la quinta chiesa, nei suoi primordi, è definita “principium pulchritudinis”), si trasforma, con le parole di Matelda, nel ricordo di quella che per i poeti antichi fu “l’età de l’oro e suo stato felice” (Purg. XXVIII, 139-144). Corrisponde al vegliare “a studio de la culla” della madre nella Firenze antica rimpianta da Cacciaguida, la quale “consolando, usava l’idïoma / che prima i padri e le madri trastulla” (Par. XV, 121-123). Si ritrova, ancora, nel ripensare “come l’umana carne fessi allora / che li primi parenti intrambo fensi”, come afferma Beatrice a Par. VII, 145-148, argomentando in favore della resurrezione dei corpi, creati immortali per loro natura.
Il verbo “indigere” conduce ad Ap 4, 2, all’inizio della seconda visione, dove si afferma che ogni visione ha un proprio essere arduo, che è nuovo rispetto alle visioni precedenti, e che ogni volta Giovanni “indigeva” di essere nuovamente elevato. La visione dell’incarnazione, l’intelligenza dell’umano e del divino in Cristo, di come possa convenire il diametro con la circonferenza, è per il poeta l’ultima “vista nova” cui “indige” essere elevato. Indige è hapax nel poema, collegato a “quella vista nova”, come nell’esegesi si dice di Giovanni:
[LSA, cap. IV, Ap 4, 2] […] per reiterationes huiusmodi sublevationum designat quamlibet visionum cum suis obiectis habere propriam et novam arduitatem, et quod ad quamlibet videndam indigebat superelevari a Deo ad illam.
Lo Spirito motore (III.10)
Cristo, in quanto uomo, insegna con la voce esteriore e, in quanto Verbo, con la luce intellettuale; la sua divinità muove tramite il gusto d’amore proprio del suo Spirito (Ap 2, 7).
Dante è mosso da due maestri. Virgilio, da una parte, è “voce esteriore”, assimilato a Cristo uomo; partecipa tuttavia anche del secondo tipo di insegnamento, quello che avviene per ispirazione e suggestione interiore, in quanto “lux simplicis intelligentie”: “Quanto ragion qui vede, / dir ti poss’io” (Purg. XVIII, 46-47). Lucia, che di questa luce è la più alta figura (designa Cristo “in quantum est Verbum et verbalis sapientia Patris”), agevola la salita del poeta dormiente dalla valletta dei principi alla porta del purgatorio e mostra a Virgilio l’ “intrata aperta” verso di essa (Purg. IX, 52-63). Con la porta comincia il sesto stato dell’Olivi (contraddistinto, appunto, dalla ‘porta aperta’) ovvero l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Beatrice rappresenta il gusto e il sentimento dell’amore, appropriato allo Spirito Santo. Mossa da amore, fa muovere Virgilio alla salvezza del suo amico: “Or movi, e con la tua parola ornata … l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata … amor mi mosse, che mi fa parlare” (Inf. II, 67-72). Virgilio e Beatrice operano entrambi per mezzo della “locutio”, cioè della favella, il primo con la “parola ornata”, la seconda con il parlare dettato da amore che suggerisce all’altro ciò che debba fare in modo da esserne consolata (lo Spirito Santo è Paraclito, cioè ‘consolatore’). La parola esteriore predispone al gusto e al sentimento d’amore e questo le subentra, come Virgilio lascia il campo all’arrivo di Beatrice nell’Eden.
Ad Ap 22, 16 (ultimo capitolo del libro, nella sua conclusione) Cristo si definisce “stella splendida”, illuminatrice dei santi, e “matutina”, che promette, predica e mostra la luce futura dell’eterno giorno. È stella in quanto fu uomo mortale e sole in quanto Dio. Egli invita tutti alla gloria (Ap 22, 17). Lo “sposo”, che secondo Riccardo di San Vittore è Cristo (Olivi nota che alcuni correttori del testo hanno tuttavia ad Ap 22, 17 “spirito” al posto di “sposo”, intendendo che Cristo invita tanto per sé quanto per il suo Spirito e per ispirazione interiore), e la “sposa”, cioè la Chiesa generale, sia quella dei beati sia quella peregrinante come quella contemplativa, dicono “Vieni”, cioè alla gloriosa cena delle nozze dell’Agnello. “E chi ascolta”, ossia chi è a conoscenza dell’invito, oppure chi crede e opera in modo retto e con obbedienza, “dica: vieni” a quelli che sono da chiamare alla cena e alla città beata. Poi è Cristo stesso ad invitare con liberalità dicendo: “Chi ha sete venga, e chi vuole riceva gratuitamente l’acqua della vita”. Dice “chi ha sete e chi vuole” perché nessuno può venire senza che ci sia desiderio e volontario consenso. “Venire” equivale a ricevere l’acqua della vita, cioè la grazia che ristora, vivifica e conduce alla vita eterna. Essa è “gratuita” perché viene data dalla carità e dalla liberalità di Cristo e ricevuta senza l’intervento di alcun prezzo venale ed esteriore, ma anche perché la prima grazia viene data senza alcun merito precedente essendo principio e causa del merito stesso e del suo aumento.
Il tema del venire per desiderio e volontario consenso di “chi ha sete e chi vuole” si ritrova, nel terzultimo verso del poema (Par. XXXIII, 143), nel volgere da parte di Dio “il mio disio e ’l velle”, ribadito dall’“in che sua voglia venne” che precede di due versi, allorché la folgore della grazia percuote la mente del poeta rendendola in grado di comprendere il mistero del rapporto tra l’umano e il divino nel Verbo.
“Amor mi mosse che mi fa parlare … l’amor che move il sole e l’altre stelle”. Nell’uno e nell’altro caso si tratta del gusto e del sentimento proprio dello Spirito Santo, non preso come entità a sé, ma come lo Spirito di Cristo, persona mediana della Trinità. Cristo, in quanto Dio, è “sole”; è “stella” in quanto uomo; tiene nella sua destra le sette “stelle”, cioè i doni del settiforme Spirito moltiplicati per le “stelle”, che nell’esegesi sono le chiese con i loro vescovi (Ap 3, 1). La filigrana dell’ultimo verso del poema mostra dunque l’immagine di Cristo Dio e uomo con l’amore del quale il suo Spirito permea l’universo e gli uomini.
Lo Spirito fa muovere per intimo dettato: “ut ex duplici auctoritate duorum tam sollempnium testium et magistrorum fortius moveremur … secunda vero ulterius moveret per spiritualem flammam et efficaciam Spiritus Sancti”. Suscita desiderio di moto: “vegno del loco ove tornar disio / amor mi mosse …”, afferma Beatrice che fa muovere Virgilio (Inf. II, 71-72). Dio è desiderato dalle sfere celesti e dall’uomo: “… la rota che tu sempiterni / desiderato … m’accesero un disio …” (Par. I, 76-77, 83; cfr. Ap 7, 17). In questo l’esegesi concorda con l’aristotelico primo motore il quale “movet ut amatum” (Metaph. XII 7). Al moto cosmico dell’“etterne rote” si unisce quello del poeta, “sì come rota ch’igualmente è mossa”, realizzando l’auspicio di Boezio, che l’amore governi gli uomini come regge il cielo (Cons. II, m. VIII, vv. 28-30).
Nell’ultimo verso del poema non ci sono concetti teologici separati dalla realtà storica. Nell’“empireo ciel”, lì dove Enea “fu de l’alma Roma e di suo impero / … per padre eletto” (Inf. II, 20-21); in “quella Roma onde Cristo è romano” (Purg. XXXII, 102), dove la Roma terrena “fu stabilita per lo loco santo / u’ siede il successor del maggior Piero” (Inf. II, 22-24), si realizza la città del sole della profezia di Isaia (19, 18), regno dell’alto “imperador” (Inf. I, 124). “L’amor che move il sole e l’altre stelle” non governa solo le ruote celesti, ma anche la storia umana, con Cristo mediatore, suo centro, romano sole per divinità e stella che contiene le altre per umanità.
Un lettore ‘spirituale’ avrebbe così accostato l’ultimo verso del poema al primo – “Nel mezzo del cammin di nostra vita” -, nel quale, incardinato nel senso letterale riferito al trentacinquesimo anno dell’autore, avrebbe scorto il riferimento a Cristo mediatore, la cui vita deve essere dalla nostra perfettamente imitata e partecipata.
Gustare il Verbo (I.6)
Luce intellettüal, piena d’amore / amor di vero ben, pien di letizia, / letizia che trascende ogne dolzore (Par. XXX, 40-42) Questi versi, nei quali Bruno Nardi scorse il “lumen gloriae” della teologia [14], sono la messa in poesia di quanto affermato da Olivi sulla visione di Dio, possibile in questo mondo non solo per mezzo della luce intellettuale del Verbo, ma anche tramite il gusto d’amore indotto dallo Spirito Santo. Parole che generarono sospetto in Giovanni XXII, nel corso di una procedura (1317-1319) che portò nel 1326 alla condanna per eresia della Lectura super Apocalipsim.
Il primo verso della terzina, interconnessa per anadiplosi, riguarda Cristo, verbale sapienza del Padre ripiena del fuoco d’amore. Inizia con il Verbo e si conclude con lo Spirito Santo.
Il secondo verso inizia con lo Spirito Santo, primo amore del “vero bene”, cioè della somma sapienza (il Figlio) e della divina potestà (il Padre). Si conclude con la “letizia” della quale lo Spirito è pieno, uno degli effetti della fiamma d’amore.
Il terzo verso esprime il gusto della visione intellettuale, che si manifesta nella “letizia che trascende ogne dolzore”.
Il papa ‘caorsino’ poneva ai suoi teologi la domanda se davvero, come scritto dal frate ad Ap 3, 7, nel sesto e nel settimo stato della Chiesa si potesse pervenire a una “gustativa et palpativa experientia” della verità per suggerimento interiore dello Spirito. Che è proprio ciò a cui arriva Dante. Nel suo “trasumanar” ascendendo al cielo egli, come l’antico pescatore Glauco, ‘gusta’ interiormente guardando Beatrice fissa nel sole, figura dei dottori fissi per vita e contemplazione nella solare luce di Cristo (Par. I, 64-69). È “esperienza” che la grazia riserva anche ad altri (vv. 71-72). È “palpativa experientia” perché Dante mantiene il suo corpo: “S’i’ era sol di me quel che creasti / novellamente, amor che ’l ciel governi, / tu ’l sai, che col tuo lume mi levasti” (vv. 73-75), quasi non fosse in carne. La “gustativa et palpativa experientia” trascorre di bene in meglio a “viste” sempre più “superbe” nella loro arditezza. Dell’acqua del fiume luminoso dell’Empireo – quella che appaga “la sete natural che mai non sazia / se non con l’acqua onde la femminetta / samaritana domandò la grazia” (Purg. XXI, 1-3) – “bevve la gronda / de le palpebre mie” (Par. XXX, 88-89), afferma il poeta ormai al termine del viaggio. Che si tratti dei “fontes aquarum”, dolci e desiderabili, ai quali Cristo conduce (Ap 7, 17), o dell’acqua della vita, alla quale Cristo liberalmente invita e fa venire con desiderio e volontario consenso (Ap 22, 17), è sempre un termine raggiungibile, almeno in parte, in questa vita. Tutti gli elementi del gusto proprio dell’età dello Spirito, così come delineati dall’esegesi di Olivi, si ritrovano nei canti che descrivono l’Empireo. Così è stato per san Bernardo: “tal era io mirando la vivace / carità di colui che ’n questo mondo, / contemplando, gustò di quella pace” (Par. XXXI, 109-111; la pace è uno degli elementi del gustare il divino nel settimo stato della Chiesa: cfr. Ap 8, 1; 10, 5, 7). Il ‘doctor marianus’ – che potrebbe anche fregiarsi dell’appellativo di ‘doctor spiritualis’ o ‘anagogicus’ per il ruolo di ultima guida di Dante nella trionfante Gerusalemme celeste che non è visibile per la Chiesa militante – ha riassunto in sé, nonostante sia vissuto prima di questi due periodi, le prerogative del sesto e del settimo stato della Chiesa: “in sexto eminet fructus caritatis, in septimo vero esus seu gustus felicitatis. […] In septimo pregustatores glorie” (prologo, notabile I).
[1] DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di N. SAPEGNO, Milano-Napoli 1957, p. 824 a Par. IV, 28-33.
[2] Cfr. T. BAROLINI, The Undivine Comedy: Detheologizing Dante, Princeton 1992, trad. it., La “Commedia” senza Dio. Dante e la creazione di una realtà virtuale, Milano 2003, pp. 232-268: p. 232.
[3] Nella Lectura super Apocalipsim Olivi sottolinea in più luoghi la soggezione del Figlio al Padre, a motivo della sua mortale umanità: «(Ap 2, 7) Dicit autem “Dei mei” quia Christus in quantum homo minor est Deo Patre, ita quod in quantum homo habet Patrem pro Deo et Domino et etiam totam Trinitatem. […] (Ap 3, 12) Quod Christus hic vel alibi dicit “Dei mei” vel “a Deo meo”, non dicit nisi tantum ratione sue humanitatis, secundum quam est subiectus Patri et toti Trinitati tamquam Deo suo. […] (Ap 8, 3) Qui “venit”, per nature humane et mortalis assumptionem, “et stetit ante altare”, id est ante curiam seu hierarchiam celestem. Pro quanto enim, secundum carnis sue passibilitatem, minoratus est paulo minus ab angelis (cfr. Heb 2, 7; Ps 8, 6), habuit eos quasi ante se. […] (Ap 14, 18) Per illum vero angelum qui clamat ad alterum ut vindemiet dicit designari angelos bonos, qui non solum de templo sed etiam de altari exeunt quia non tantum ecclesiam electorum sed etiam Christum, qui est nostrum altare, respectu sue carnis transcendunt, secundum illud Psalmi (Ps 8, 6): “Minuisti eum paulo minus ab angelis”».
[4] G. VINAY, Interpretazione della “Monarchia” di Dante, Firenze 1962, p. 73, osserva: “Partito da una proposizione filosofica, inoltratosi tra i rovi di una disputa giuridica e teologica, Dante giunge alla conclusione senza accorgersi di essersi spostato sul piano della pura spiritualità, sul quale soltanto è possibile intendere il senso ultimo della Monarchia”.
[5] E. AUERBACH, La preghiera di Dante alla Vergine (Par. XXXIII) ed antecedenti elogi (1949), in IDEM, Studi su Dante, Milano 19744, pp. 263-292: p. 292.
[6] Cfr. A. VALLONE, La preghiera, in Studi su Dante medievale, Firenze 1965 (Biblioteca dell’“Archivum Romanicum”, Serie I, 80), pp. 83-109: p. 94.
[7] Cfr. P. DRONKE, The Conclusion of Dante’s Commedia, in Sources of Inspiration. Studies in Literaly Transformations, 400-1500, Roma 1997, pp. 131-159: pp. 132-134: “Many parallels have been proposed, yet few if any are verbally decisive, or are exclusively with Bernard” (p. 134).
[8] Ibid., pp. 135-137.
[9] Ibid., p. 137 nt.10.
[10] Cfr. G. GÜNTERT, Canto XXXIII, in Lectura Dantis Turicensis, a cura di G. GÜNTERT e M. PICONE, III, Paradiso, Firenze 2002, pp. 505-517: p. 514.
[11] Cfr. B. CROCE, L’ultimo canto della «Commedia», in ID., Poesia antica e moderna. Interpretazioni, Bari 19432 (Scritti di storia letteraria e politica, XXXIV), pp. 151-161: p. 159.
[12] Cfr. DRONKE, The Conclusion of Dante’s Commedia, pp. 138-139. Il passo del Cantico dei Cantici è citato ad Ap 21, 13, nell’esegesi delle tre porte meridionali della Gerusalemme celeste: «Sunt etiam tres a meridie, ad aperiendum ardentem Christi caritatem, et eius superexcessivam et incomprehensibilem claritatem, et ineffabilem et immensam iocunditatem et felicitatem et satietatem et ebrietatem. Hec enim sunt tria meridionalia, que Canticorum I° petit sponsa cum ait: “Indica michi ubi pascas, ubi cubes in meridie” (Cn 1, 6)».
[13] CROCE, L’ultimo canto, p. 159.
[14] B. NARDI, Studi di filosofia dantesca, Firenze 19672, pp. 167-214.
I
La Gerusalemme celeste: una città ideale discesa in terra.
La settima visione dell’Apocalisse, quella finale, descrive la Gerusalemme celeste. È trattata nei tre ultimi capitoli del libro (XX-XXII). Tuttavia il primo di questi (XX), nella parte in cui concerne la dannazione finale del drago e dei reprobi e la glorificazione degli eletti, può anche, secondo Olivi, far parte della sesta visione (che ha per oggetto la dannazione di Babylon), integralmente o nei suoi primi dieci versetti, per cui la settima visione comincerebbe da Ap 20, 11: “E vidi un grande trono”, oppure direttamente dal principio del capitolo XXI: “E vidi un cielo nuovo”. Inoltre, nell’ultimo capitolo dell’Apocalisse, il XXII, solo i primi cinque versetti appartengono effettivamente alla settima visione, mentre i successivi (6-21) si riferiscono alla conclusione finale del libro. Il XXI è dunque l’unico dei tre capitoli dedicato per intero all’ultima visione apocalittica.
I.1 La “dolce vita” differenziata (Tab. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies)
(Tab. 1)
■ La fabbrica della città, afferma Olivi, è simile a un albero che non può mostrarsi compiuto nelle sue foglie fin dall’inizio come nel suo compimento. Così è per la gloria di Dio, che diversamente rifulge nelle parti della città (Ap 21, 12-13). Similmente Dante, che trasferisce sull’intero universo prerogative che nell’esegesi scritturale sono proprie della Chiesa e della sua evoluzione storica, apre la terza cantica: “La gloria di colui che tutto move / per l’universo penetra, e risplende / in una parte più e meno altrove” (Par. I, 1-3).
L’unità della città celeste è specchio dell’increato Spirito di Cristo, uno e semplice ma partito in sette doni, che sono anche i sette stati o periodi della Chiesa, cioè le categorie che segnano lo sviluppo della storia umana (Ap 1, 4; 5, 6-7). Già nella natura angelica “la prima luce” è recepita “per tanti modi” quanti sono i singoli angeli, come pure “d’amar la dolcezza / diversamente in essa ferve e tepe”; l’eterno valore, infatti, “tanti / speculi fatti s’ha in che si spezza, / uno manendo in sé come davanti” (Par. XXIX, 136-145). Così la dolce vita è differenziata nei vari cieli (Par. IV, 34-36), nei quali la virtù del “corpo” (il Primo Mobile, che si gira nel quieto Empireo) viene ripartita (dall’ottavo cielo, delle stelle fisse) “per diverse essenze” (Par. II, 112-117); gli “organi del mondo” (i cieli) “così vanno … di grado in grado, / che di sù prendono e di sotto fanno” (vv. 121-123); i lumi dei beati vanno in circolo “più e men correnti, / al modo, credo, di lor viste interne” (Par. VIII, 19-21); “le cose generate” – le “brevi contingenze” di cui parla Tommaso d’Aquino a Par. XIII, 61-72 – non sempre concordano con la disposizione celeste che le impronta, per cui la loro materia “sotto ’l segno / idëale poi più e men traluce. / Ond’ elli avvien ch’un medesimo legno, / secondo specie, meglio e peggio frutta; / e voi nascete con diverso ingegno”. Versi che rivelano un linguaggio proprio dello Pseudo-Dionigi, come mostra il confronto con Ap 21, 18.21. Le intelligenze angeliche inferiori ricevono l’“habitus glorie” da quelle superiori, riflettendolo quali specchi, come le membra inferiori di un corpo sono radicate nelle virtù del cervello, del cuore o del fegato. La medesima tesi dionisiana viene addotta dall’Epistola a Cangrande a commento della prima terzina del Paradiso (Ep. XIII, 60) [1]. E la dottrina dell’Areopagita viene appunto in rilievo a proposito delle gerarchie angeliche “Questi ordini di sù tutti s’ammirano, / e di giù vincon sì, che verso Dio / tutti tirati sono e tutti tirano” (Par. XXVIII, 127-129).
■ Oltre ai temi, qui sopra considerati, dalla settima visione (Ap 21, 12-13: la similitudine dell’albero che cresce; il risplendere diversificato di Dio; il motivo dionisiano delle intelligenze angeliche che tirano e sono tratte verso l’alto), si noterà la presenza, nei primi versi del Paradiso, di altri riferimenti a passi della Lectura. In primo luogo ad Ap 1, 16-17, dove viene descritta la gloria e la divina virtù del volto di Cristo nel meriggio del sesto stato, che genera oblio in chi la guarda (prima visione: decima e undecima perfezione di Cristo come sommo pastore).
Questi temi si ripresentano nell’ultimo canto: «(Ap 1, 17) “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” … tum quia valet ad significandum quod sanctorum excessiva virtus et perfectio tremefacit et humiliat et sibi subicit animos subditorum et etiam ceterorum intuentium. Significat etiam quod in divine contemplationis superexcessum non ascenditur nisi per sui oblivionem – (Par. XXXIII, 55-57) Da quinci innanzi il mio veder fu maggio / che ’l parlar mostra, ch’a tal vista cede, / e cede la memoria a tanto oltraggio (cede, che deriva dal verbo cedere, fa segno, insieme agli altri signacula, del versetto scritturale in cui compare il verbo cadere)».
Il passo, esaminato compiutamente altrove, ha rilievo anche in Par. XXXIII, 49, 126 (cfr. qui di seguito).
■ Ad Ap 1, 4 e 5, 6 si tratta dello Spirito increato di Cristo, uno e semplice ma diviso (multiplicatus, partitus, particulatus) in sette doni. La tematica è presente in numerosi luoghi del poema, ad esempio in principio di Purg. XXX e a Inf. XXII, 97-105.
Il Flegetonte, il fiume di sangue che nel settimo cerchio infernale “spiccia / fuor de la selva” come “un picciol fiumicello”, esce nell’arena infuocata come ruscello dal Bulicame “che parton poi tra lor le peccatrici” (Inf. XIV, 76-81). Nella Città di Dite, questo tartareo fiume di virgiliana memoria è la raccapricciante immagine del fiume luminoso dell’Empireo (Ap 22, 1-2), e come questo designa lo Spirito increato che, restando semplice, si differenzia nei suoi doni, così quello viene partito fra i peccati che li deturpano (come fanno appunto le “peccatrici”, cioè le meretrici viterbesi).
Ancor prima che la Grazia gli concedesse di “veder li troni / del trïunfo etternal” (Par. V, 115-117), Dante aveva applicato questo concetto al volgare illustre, “simplicissima substantiarum, que Deus est” e “simplicissima quantitas, quod est unum” (De vulgari eloquentia, I, xvi, 5), dal quale si procede discendendo agli “inferiora vulgaria”. Affermazioni fondate, com’è noto, sulla Metafisica e sull’Etica Nicomachea di Aristotele, sui relativi commenti di Tommaso d’Aquino, sul Liber de causis e su altre fonti [2]. Idee che nella Commedia permangono come “conoscenza viva” (cfr. Par. XXVI, 61), ma che vengono concordate con quanto esposto nella Lectura super Apocalipsim di Olivi, incastonate “quasi rubin che oro circunscrive”.
Che nel caso del Flegetonte si tratti proprio dei doni dello Spirito, intesi in senso negativo, lo dimostra la presenza del verbo partire appropriato all’acqua del ruscello che esce dal Bulicame: come si può vedere ad Ap 5, 6 (passo simmetrico ad Ap 1, 4, dove il secondo modo del dare, ivi trattato, proviene dai sette spiriti che stanno dinanzi al trono), l’increato spirito di Cristo – che ha in sé la “plenitudo spiritualis fontalitatis”-, in sé uno e semplice, viene “partito”, cioè diviso, in sette doni [3].
Una variante del medesimo tema è l’uscita nell’Eden da una sola sorgente di un’unica acqua (“d’una fontana”) che poi da sé si ‘diparte’ nel Lete e nell’Eunoè, assimilati al Tigri e all’Eufrate di Genesi 2, 14 (Purg. XXXIII, 112-117). Immagine che si ripercuote nel finale della Monarchia (III, xv, 15), per attestare che l’autorità del Monarca temporale discende direttamente dall’unico fonte dell’universale autorità, che da semplice si fa molteplice “ex habundantia bonitatis”.
Così l’intelligenza che muove il cielo delle stelle fisse (“’l ciel cui tanti lumi fanno bello”) “sua bontate / multiplicata per le stelle spiega, / girando sé sovra sua unitate” (Par. II, 136-138).
Nella Commedia, il rapporto tra l’uno e il molteplice si risolve dando “e piedi e mano” a un concetto teologico (lo Spirito semplicissimo e però partito in modo settiforme) sul quale si fonda lo sviluppo storico che consiste, appunto, nella sua fenomenologia. Ciò è coerente con il fatto che il poema narra di un viaggio nella storia sacra, dall’umano al divino, dalla felicità civile alla contemplazione celestiale. L’applicazione all’intero creato degli status della Chiesa secondo Olivi, cioè delle categorie della storia della Chiesa le quali escono dall’angustia francescana per rendere universali personaggi ed episodi di storia locale, consente a Dante, nel Paradiso, la soluzione “dei problemi che derivano dal narrare l’inenarrabile”, soprattutto di quello, fondamentale, “della temporalità del racconto” [4].
(Tab. 1 bis)
Qui di seguito vengono considerate alcune elaborazioni dell’esegesi presenti nei primi due canti del Paradiso (non ne esaurisono, comunque, la complessa ricchezza). I motivi, semanticamente espressi, non si escludono a vicenda ma si intrecciano reciprocamente. Il testo dottrinale contenuto nella Lectura, prima di travasarsi semanticamente nella Commedia, subisce infatti una duplice riorganizzazione. La prima, sulla base delle indicazioni dello stesso Olivi, secondo il materiale esegetico attribuibile ai singoli stati. La seconda, seguendo il principio applicato nelle distinctiones ad uso dei predicatori, secondo lemmi analogicamente collazionati. La “mutua collatio” di parti della Lectura arricchisce il significato legato alle parole e consente uno sviluppo tematico amplificato. Si vedano, ad esempio, le variazioni eseguite sul tema della “voce” o sull’espressione “in medio”, temi più volte iterati nel sacro testo, oppure il modo con cui Ap 1, 16-17 (l’esegesi della decima e undecima prefezione di Cristo come sommo pastore) percorre i versi in collazione con altri passi.
■ (Par. II) La “virtus contentiva” di Cristo (prologo, notabile VI), che appartiene al Primo Mobile (“un corpo ne la cui virtute / l’esser di tutto suo contento giace”) e al cielo Stellato (“quell’ esser parte per diverse essenze, / da lui distratte e da lui contenute”; Par. II, 113-116)[5], si arricchisce di motivi provenienti da Ap 2, 1 (la bellezza della quinta chiesa d’Asia – Sardi – nel suo stellare principio, conformata nella sua unità per differenti membra), 5, 9 (il cantico nuovo e il risuonare della cetra) e 14, 2 (la voce, come quella della cetra, dei compagni dell’Agnello sul monte Sion, designante le opere del divino artista che trae e tende le corde-virtù indirizzandole ai loro fini).
Ad Ap 2, 1 l’esegesi interpreta il nome della quinta chiesa – “Sardis” – come “principium pulchritudinis”. Gli zelanti primi istitutori del quinto stato ordinarono le diverse membra e i diversi offici dei propri collegi con una regola ispirata all’unità ma anche condiscendente in modo proporzionato alle membra stesse, conseguendo una forma di mirabile bellezza che è propria della Chiesa, la quale è come una regina ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei vari doni e nelle varie grazie delle diverse membra.
Nel corso della confutazione della teoria averroista delle macchie lunari, creduta da Dante, Beatrice spiega nella ‘pars construens’ che, come l’anima nel corpo umano, pur rimanendo una, “per differenti membra e conformate / a diverse potenze si risolve”, cioè si dispiega nei vari organi conformati all’esercizio delle sue diverse facoltà (tema della quinta chiesa, ordinata con proporzione nelle diverse membra con vari doni e varie grazie), così l’intelligenza che muove il cielo delle stelle fisse (“’l ciel cui tanti lumi fanno bello”) “sua bontate / multiplicata per le stelle spiega, / girando sé sovra sua unitate”. L’unica virtù si moltiplica dunque e si fa diversa per ciascun cielo, legandosi in modo diverso alla loro preziosa materia. Tale virtù, che variamente risplende attraverso i corpi degli astri, è il “formal principio” (tema della quinta chiesa, “principium pulchritudinis … habet mire pulchritudinis formam toti generali ecclesie competentem”) della diversa luminosità di questi, che non dipende dal raro e denso della materia, come creduto, con Averroè, da Dante (Par. II, 133-148).
Il capitolo XIV dell’Apocalisse si apre con la descrizione della virtù e della gloria dei santi del sesto stato che hanno vinto le persecuzioni dell’Anticristo e stanno con l’Agnello sul monte Sion. La quarta delle sette prerogative attribuite a questi compagni dell’Agnello consiste nell’eccellenza del cantico di giubilo, a sua volta magnificato in sette modi. Il quarto modo, o proprietà, della voce cantante è di essere oltremodo soave, giocosa, modulata e proporzionata (Ap 14, 2): “e la voce che udii era come quella dei citaristi che si accompagnano nel canto con le loro arpe”. Secondo Gioacchino da Fiore, la parte vuota della cetra designa la povertà volontaria: come infatti un vaso musicale non suona bene se non sia concavo, così neppure la lode di Dio risuona bene se non proceda da una mente umile e svuotata delle cose terrene.
Le corde della cetra sono le diverse virtù, che non suonano se non siano tese, e non concordano se non siano proporzionate l’una con l’altra e non vengano toccate in ugual proporzione. È infatti necessario che gli affetti virtuali siano protesi in modo fisso e attento verso i loro termini e oggetti e che, secondo le dovute circostanze, una virtù e i suoi atti concordino in modo proporzionato con le altre virtù e i loro atti e che essi siano congiunti in modo concorde, cosicché il rigore della giustizia non escluda né venga a turbare la dolcezza della misericordia né al contrario, oppure una lieve mitezza impedisca il dovuto zelo della santa correzione e ira, o al contrario. La cetra è Dio stesso, o l’universa sua opera, della quale ciascuna parte o perfezione è una corda che, toccata dall’affetto del contemplante o del lodatore, rende con le altre una risonanza mirabilmente giocosa. Citarista è solo colui che, da maestro, ha l’arte e il frequente uso (il “magister artificiose citharizandi”). Gli altri suonano in modo discordante e rustico o senz’arte, e se talvolta compulsano bene, ciò è dovuto al caso piuttosto che alla prudenza dell’artista.
L’esegesi di Ap 14, 2 è soggetta a molte metamorfosi nel Paradiso. Nel discorso di Beatrice sulle macchie lunari la si trova intrecciata con il notabile VI del prologo, con Ap 2, 1 (l’interpretazione del nome “Sardis”) e con Ap 5, 9 (il “canticum novum”). La “virtus contentiva” (lo Spirito increato, uno e semplicissimo) si moltiplica diversamente per le stelle come le corde di una cetra sono variamente compulsate dal maestro citarista: “(14, 2) Corde vero cithare sunt diverse virtutes … Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi … citharedus non dicitur nisi per artem et frequentem usum, sicut magister artificiose citharizandi; (5, 9) Plena enim seu perfecta iubilatio pulsat omnes virtutes et ex omnibus trahit resonantiam laudis – (Par. II, 116-117, 120, 127-128, 139) … per diverse essenze, / da lui distratte … dispongono a lor fini … Lo moto e la virtù d’i santi giri, / come dal fabbro l’arte del martello … Virtù diversa …”. La rima “disiri/spiri” (vv. 125/129) è cucita su Ap 5, 8 – le coppe colme di desideri del cuore predisposto dalle corde della cetra, che piacciono alla curia celeste e subceleste -; si riscontrano questi motivi, propri del canto di lode dei seniori e degli animali che circondano la sede divina, nel colloquio tra Dante e Virgilio, prima dell’incontro con Farinata (Inf. X, 4-6, 16-24) e in molti altri luoghi.
Lo schema neoplatonico proveniente dallo Pseudo-Dionigi, che percorre tutta la seconda parte del discorso di Beatrice in Par. II, concorda con quanto, già sopra considerato, nella Lectura si afferma dell’increato spirito di Cristo che si parte e moltiplica (Ap 1, 4; 5, 6-7). Fra i versi di Par. II, 127-135 si riconosce un richiamo a Boezio e una sua parziale riscrittura; questa è però incastonata fra le maglie dell’armatura oliviana, e con essa concordata. Boezio (Cons., III, m. ix, vv. 13-17) parla dell’anima del mondo la quale, inserita da Dio nel suo centro, si dispiega dividendosi per le armoniose membra e poi torna in sé girando la mente profonda e facendo volgere il cielo secondo la propria immagine. Dante parla dell’intelligenza angelica che muove il cielo Stellato, la quale “de la mente profonda che lui volve / prende l’image e fassene suggello”. Questo cielo ha le caratteristiche del maestro citarista, che differentemente allenta e tira le corde (che sono virtù); possiede anche le prerogative della Chiesa generale, una per carità ma varia nei doni dello Spirito. La Chiesa, assimilata alla Gerusalemme celeste, “accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei” (Ap 21, 11; da notare come i temi della trasparenza della città, vitrea, perspicua come specchio, trascorrano nel discorso di Beatrice).
■ (Par. I) Beatrice, trattando nel canto precedente dell’ordine dell’universo, ha già rinviato un potenziale lettore ‘spirituale’ agli stessi passi dell’esegesi usati per spiegare come l’intelligenza che muove il cielo Stellato si parta diversamente per le stelle (Par. I, 103sgg.). Lo ha fatto però con importanti variazioni. Quegli zelanti istitutori della quinta chiesa, una e molteplice al tempo stesso, bella e monda nel suo principio, mirabilmente ordinata nelle diverse membra in modo condiscendente e consono secondo la loro proporzione, che in Par. II si trasferiscono nei panni delle intelligenze motrici dei cieli, e in particolare del cielo Stellato (la quinta chiesa d’Asia, Sardi, è quella dotata di pienezza stellare), nel primo canto sono riassunti da Dio stesso, “l’etterno valore”. Così “l’arte”, che “da’ beati motor convien che spiri” (Par. II, 128-129), è proprio l’arte del sommo maestro citarista: “(Par. I, 104, 111): … e questo è forma … più al principio loro e men vicine … (Par. II, 147): … essa è formal principio …; (Par. I, 107-108, 124): … il quale è fine / al quale è fatta la toccata norma … a sito decreto … (Par. II, 120): … dispongono a lor fini e lor semenze; (Par. I, 110, 112, 125): … per diverse sorti … a diversi porti … la virtù di quella corda … (Par. II, 70, 116, 139): … virtù diverse … per diverse essenze … virtù diversa …”.
“Corda”, che nell’esegesi è quella della cetra, nei versi diventa quella dell’arco (Par. I, 125); il suo essere “tacta et pulsata” (i contemplativi “tangunt et pulsant” le corde della cetra, che sono le opere di Dio) si rinviene ne “la toccata norma” (v. 108).
Mentre però nel secondo canto del Paradiso il movimento è dall’alto verso il basso (dal Primo mobile agli altri cieli attraverso quello Stellato), nel primo canto sono le creature a inclinare verso il creatore. “Ne l’ordine ch’io dico sono accline / tutte nature” (Par. I, 109-110): il verbo rende il declinans proprio del quinto stato (prologo, notabile V), in un contesto dove si conciliano l’unità del principio e il diverso (“per diverse sorti … a diversi porti”), come detto nell’esegesi di Sardi, assimilata alla Chiesa generale. “Sono accline”, sottintendendo: ‘secondo la proporzione di ciascuna natura’. Per questo sarà da considerare seriamente la variante “(son) decline” (nel senso di ‘tendenti verso’, ‘propendenti’), considerata dal Petrocchi equivalente, per quanto tarda.
“Onde si muovono a diversi porti / per lo gran mar de l’essere, e ciascuna / con istinto a lei dato che la porti” (vv. 112-114). Nella spiegazione dell’ordine dell’universo data da Beatrice in Par. I vengono ancora utilizzati i motivi del mare e del portare propri della seconda tromba (il secondo stato è proprio dei martiri), particolarmente dedicato ai “Gentili” (Ap 8, 8-9).
Delle metamorfosi di questa esegesi, per cui l’antica bellicosa turbolenza dei Gentili, tempestosi nel cuore come il mare, ridonda sulla moderna Romagna di Guido da Montefeltro e di Guido del Duca, sui “vivi” della “serva Italia”; del valore insito nei verbi ‘portare’ e ‘leggere’ (propri dei diaconi), che doveva essere ben chiaro a un lettore ‘spirituale’, per esempio nell’episodio di Francesca per gli insistiti signacula; dell’andar per mare, cioè nel portar fede o nel romperla; dell’essere nave per il gran mare dei cuori gentili, e del perire in esso, si è dato conto altrove.
La variazione di Par. I, 112-120, che avviene in un contesto lontanissimo dalla trama esegetica originaria, è appena percettibile in una sublimazione della Gentilità, bruta o razionale, nel macrocosmo: le specie naturali “si muovono a diversi porti / per lo gran mar de l’essere”, ciascuna portata dall’istinto datole, che porta il fuoco a salire verso la luna, che muove i “cor mortali”, cioè le creature irrazionali, che “la terra in sé stringe e aduna” con la legge di gravità. Ad essere indirizzate al proprio fine non sono solo le creature prive di ragione, ma anche quelle dotate di intelligenza e amore. Rimane, dell’esegesi di partenza, la distinzione tra il vivere di quanti hanno un’anima ‘animale’ (le “nature”) e quello di quanti agiscono razionalmente (le creature “c’hanno intelletto e amore”), nonché l’uso dell’immagine del mare per designare principalmente la vita delle creature “che son fore d’intelligenza”, degli animali bruti dall’anima solo sensitiva (che corrisponde al mare dei Gentili dall’amore brutale e dai cuori fluttuosi di Ap 8, 8). È da notare come ai motivi del mare e del portare si aggiunga quello dell’“istinto”, anch’esso presente ad Ap 8, 8 nell’empio suggerire del diavolo-gran monte messo nel mare: ad Ap 2, 9 (seconda chiesa) la “suggestio”, sempre diabolica, equivale a “instinctus” e si accompagna all’“adunare”, verbo che pure è presente nelle parole di Beatrice (l’istinto che “la terra in sé stringe e aduna”), la quale, parodiandoli, appropria all’ordine dato da Dio motivi che nel testo esegetico sono connessi con l’operare diabolico.
Tornando all’ordine delle cose secondo Beatrice, la donna afferma: “Vero è che, come forma non s’accorda / molte fïate a l’intenzion de l’arte, / perch’ a risponder la materia è sorda, / così da questo corso si diparte / talor la creatura, c’ha podere / di piegar, così pinta, in altra parte” (Par. I, 127-132). Nella perfetta armonia risuonante nell’universo per l’arte del maestro citarista che fa concordare le diverse corde – secondo l’esegesi di Ap 14, 2 -, la creatura, se vuole il male, assume la parte di chi non ha l’arte, di quanti “discordanter et rusticaliter seu inartificialiter citharizant”. Mentre il maestro allenta e tira le corde in modo proporzionato una con l’altra, la creatura piega “in altra parte” (cioè in una sola direzione).
(Tab. 1 ter)
Nell’esegesi della settima e ultima visione dell’Apocalisse, Olivi tratta delle differenze nella gloria dei beati (ad Ap 21, 9). Secondo Riccardo di San Vittore, per quanto lo scopo di questa visione sia quello di descrivere lo stato superno della Gerusalemme beata, si trovano in essa molte cose che spettano più ai presenti meriti dei santi che ai futuri premi. Ciò perché l’istruzione sulle magnifiche virtù e i meriti dei santi deve condurre ad ammirare in modo più sublime i loro celesti premi. Olivi propone un’altra spiegazione, fondata sulle differenze della gloria dei beati, le quali non possono essere conosciute se non attraverso similitudini già sperimentate e familiari. Lo stato del premio può in altri termini essere descritto solo facendo riferimento, mediante le similitudini, allo stato del merito. Non diversamente lo Pseudo Dionigi, nel De angelica hierarchia, descrive le differenze degli ordini angelici con l’ausilio dei comuni doni della grazia a noi noti e posti nella Scrittura a denominazione delle gerarchie angeliche. Un terzo motivo sta nel fatto che, descrivendo la Chiesa sotto il duplice stato della grazia e della gloria, è possibile concepire la corrispondenza dei meriti con i premi e quindi che a meriti diversi corrispondono premi diversi.
Le similitudini consentono di dare forme corporee a una visione intellettuale, di apprendere con i sensi quanto diviene poi degno di intelletto. Già fondamentale principio aristotelico, per cui “nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu”, è l’argomentazione con cui Beatrice, in Par. IV, 28-48, risolve il dubbio di Dante sull’effettiva sede dei beati nell’Empireo, essendogli le prime anime apparse nel cielo della Luna: Piccarda e Costanza, come gli altri, “tutti fanno bello il primo giro”, ma si sono lì mostrate, “rilegate per manco di voto”, “per far segno / de la spiritual [6] c’ha men salita”, mostrando cioè sotto figure sensibili il loro minore grado di beatitudine, ovvero consentendo ad un intelletto non ancora compiutamente allenato, nell’ascesi paradisiaca, di apprendere una visione puramente intellettuale. Le cose spirituali sono rappresentate sotto metafore sensibili. Per questo la Scrittura “condescende” alle possibilità dell’ingegno umano, “e piedi e mano / attribuisce a Dio e altro intende”, e la Chiesa rappresenta in figura umana gli arcangeli che sono pure intelligenze. La “dolce vita” differenziata nella salita all’Empireo è la base della struttura del Paradiso, perché permette a Dante “di mantenere anche nella terza cantica quel ritmo e quella differenziazione di momenti narrativi, quella successione di episodi e di colloqui variamente ambientati, lo spazio e il tempo insomma richiesti da una rappresentazione poetica e che non potevano essergli offerti da una rigorosa adesione al concetto teologico” (Sapegno). La teologia stessa gli offriva il destro al mantenimento della differenziazione tanto necessaria sul piano poetico.
Il ‘condescendere’ della Scrittura è tema proprio del quinto stato in cui, dopo l’altezza della contemplazione raggiunta dagli anacoreti nel quarto, viene proposta una pietosa “condescensio” verso i deboli e gli infermi, in modo proporzionato alle possibilità di ciascuno.
Se, come nota Riccardo di San Vittore, le similitudini che riempiono l’Apocalisse si riferiscono tutte a fenomeni naturali (cielo, sole, luna, nubi, pioggia, grandine, folgori, tuoni, venti, uccelli, pesci, bestie, serpenti, rettili, alberi, monti, colli, aria, mare, terra ecc.), anche le similitudini presenti nella Commedia per la maggior parte si riferiscono, come nota il Pagliaro [7], a dati sensitivi e reali legati con fenomeni della natura.
Se, ancora, la descrizione della Gerusalemme celeste si fonda più sui meriti che sui premi, cioè più sulla personale storia dei beati piuttosto che sulla loro mercede, il Paradiso è tanto tessuto di vicende terrene quanto della descrizione della “gloria di colui che tutto move” [8].
Nell’Epistola a Cangrande (§§ 33-34) si distingue tra il soggetto letterale del Paradiso, cioè lo stato delle anime beate dopo la morte, e quello allegorico, cioè l’uomo che per i meriti ha conseguito il premio della giustizia divina. È distinzione molto vicina a quella proposta da Olivi, ad Ap 21, 9 (con le citazioni di Riccardo di San Vittore e dello Pseudo Dionigi), tra i premi futuri e i meriti presenti (senso allegorico), per cui nella settima visione si tratta più dei secondi che dei primi, in quanto in questa vita non è dato all’intelletto di vedere le differenze della gloria dei beati secondo le proprie specie e proprietà o mediante similitudini univoche, ma solo per mezzo di similitudini già note, cioè attraverso la rappresentazione allegorica. Naturalmente l’allegoria non è da intendere in senso strettamente poetico, cioè come una menzogna che nasconde la verità (cfr. Convivio, II, i, 2-15), bensì nel senso teologico, di qualcosa (personaggi e vicende storiche) che è prefigurazione di ciò che viene a compimento, della storia della Chiesa militante che si realizza nel “regno santo”.
Nella medesima Epistola a Cangrande (§ 84) si afferma che con l’intelletto vediamo molte cose per esprimere le quali mancano i “signa vocalia”, cioè le parole, come dimostra Platone nelle sue opere quando si serve delle metafore. In Par. IV, 49-63, Beatrice, dopo aver spiegato a Dante perché le prime anime beate siano apparse nel cielo della Luna, scioglie il dubbio del poeta che possa essere vera la tesi svolta da Platone nel Timeo e condannata come eretica, secondo la quale le anime dopo la morte ritornano alle stelle in cui hanno dimorato prima di incarnarsi. Platone, argomenta la donna, ha forse espresso un’opinione diversa da quella che suona la sua sentenza presa letteralmente, forse perché intendeva dire che ai cieli torna l’onore o il biasimo degli influssi buoni o cattivi che essi esercitano all’inizio sulle anime. Potrebbe cioè aver parlato per metafora intendendo in “altra guisa”, come la Scrittura “altro intende” attribuendo a Dio “e piedi e mano”, o come Piccarda e Costanza si mostrano nel cielo della Luna per dare un segno sensibile di altra verità, cioè della differenza nella gloria dei beati, che non si apprende con una visione puramente intellettuale.
La situazione di Dante è simile a quella di Giovanni, la cui visione avviene per segni – cioè per oggetti che nella specie altro intendono -, e non essendo questi segni naturalmente appropriabili al secondo significato (come lo è, ad esempio, l’acqua al battesimo), gli vengono spiegati da un angelo, che ne è consapevole (Ap 1, 2). Questo secondo apprendimento non è più soltanto un percepire da parte dei sensi, è una “ratiocinatio seu argumentatio”. Così Beatrice (che svolge la funzione che l’angelo ha per Giovanni) spiega, nel cielo della Luna, che le anime “qui si mostraro, non perché sortita / sia questa spera lor, ma per far segno / de la spiritual c’ha men salita”. E poiché far segno comporta un secondo apprendimento razionale, la donna subito aggiunge che ciò avviene per il noto principio della logica aristotelica, che si trova in tal modo concordato con l’esegesi scritturale: “Così parlar conviensi al vostro ingegno, / però che solo da sensato apprende / ciò che fa poscia d’intelletto degno” (Par. IV, 37-42).
(Tab. 1 quater, quinquies)
Alcuni, afferma Olivi, hanno sostenuto che la visione di Giovanni sarebbe stata puramente intellettuale, cioè senza immagini, e che poi egli avrebbe adattato le varie figure alla verità veduta senza di esse. Contrario a ciò sta il fatto che egli non accenna ad una successiva composizione con figure ma a figure apparse in visione e mostrate da un altro soggetto. Inoltre, l’essere state le figure formate da Dio per mezzo di un angelo rende maggiore riverenza, stima e dignità alle visioni del libro che se esse fossero state aggiunte dopo da Giovanni. All’altezza della visione intellettuale nulla toglie l’aggiunta di immagini che siano di aiuto: l’intelligenza dei beati dopo la resurrezione dei corpi non sarà, con l’aggiunta della vista corporea, minore di quanto sia ora senza di questa (Ap 1, 2; l’esame dei primi tre versetti dell’Apocalisse è stato condotto altrove).
Nella Tab. 1 quater sono riportati alcuni passi del poema relativi al vedere per figure, con l’aiuto di queste, fino all’“alta fantasia” che alla fine ne difetta. Nell’Apocalisse, a differenza che nella Commedia, le figure sono formate dall’angelo e non da Giovanni. Ma lo sforzo del poeta è di chiedere il lume superiore affinché esse siano ben espresse “com’ io l’ho concette”. Dal suo petto spira il “buono Appollo” e si manifesta la “possa” della “diva Pegasëa”.
L’“alta fantasia” è tale non solo perché perviene fino alla visione divina, ma perché è mossa da un lume superiore. La terza vittoria (la cui esegesi conclude l’istruzione data a Pergamo, la terza chiesa d’Asia) consiste nella vittoriosa ascesa al di sopra della fantasia che muove dal senso, che è causa di errore e di eresia. Questa salita avviene tramite la prudenza che mette in fuga le nebbie, gli errori e gli impulsi precipitosi e temerari. È propria dei dottori i quali nel terzo periodo della Chiesa vincono gli errori della fantasia eretica; ad essi spetta il premio del singolare apprendimento e del gusto dell’arcana sapienza di Dio. Così alla terza chiesa d’Asia (Pergamo) viene detto: “Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza lucida sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve” (Ap 2, 17). La fantasia erronea è pure il difetto che rende chiuso il terzo sigillo (ad Ap 5, 1; tab. 1 quinquies).
I temi della fantasia e dell’errore, dalla terza vittoria, emergono con evidenza nel terzo girone del purgatorio. Cessate le visioni estatiche di mansuetudine, che precedono l’episodio di Marco Lombardo, il poeta, tornato con l’anima “di fori / a le cose che son fuor di lei vere”, riconosce che le cose da lui viste erano “non falsi errori”, errori in quanto non esistenti nella realtà, non falsi come esperienza di visione soggettiva (Purg. XV, 115-117). Dopo l’uscita dal fumo degli iracondi (momento in cui il poeta si appella all’immaginazione del lettore, Purg. XVII, 1-9), è la volta delle visioni di ira punita. La loro descrizione è preceduta da un’apostrofe all’“imaginativa”, cioè alla fantasia, la facoltà dell’anima che media tra il sensibile e l’intelletto: chi la fa operare, si chiede il poeta, se la materia non è fornita dalle percezioni sensibili? Essa, in questo caso, viene stimolata da un lume che prende forma nel cielo, o per influsso celeste o perché mandato da Dio (Purg. XVII, 13-18). Nel caso delle visioni estatiche, pertanto, il poeta consegue la terza vittoria, cioè ascende al di sopra della fantasia che muove dal senso, causa di errore e di eresia: il lume celeste che muove l’“imaginativa” corrisponde al lume dei dottori (prologo, Notabile X). È l’“alta fantasia” (Par. XXXIII, 142), cioè la visione intellettuale che, come quella dell’Apocalisse avuta da Giovanni, non viene sminuita dal fatto di essere aiutata da figure, che però alla fine vengono a mancare (Ap 1, 2). È da notare, nell’apostrofe all’“imaginativa”, la presenza di un altro tema del terzo stato (la tuba dottorale: prologo, Notabile I) nel riferimento al suonar delle “mille tube” che non potrebbero impedire il rapimento dell’anima dalle impressioni del mondo esterno (l’espressione “ch’om non s’accorge” contiene il motivo dell’uomo razionale, sempre dal Notabile I). Il rapporto equivoco tra immagine vera e quella erronea (le cose vere fuori dell’anima e i “non falsi errori” all’interno) continua nelle visioni di ira punita, nell’immaginazione di Aman crocifisso, tra Assuero, Ester e il giusto Mardocheo, la quale si rompe da sola, come una bolla d’aria che viene meno al rompersi del velo d’acqua che l’avvolge (Purg. XVII, 31-33): il tema del rompere l’errore (in questo caso non falso) è proprio della terza chiesa (Pergamo), alla quale Cristo si presenta come colui che ha la rumphea, cioè la spada acuta che scinde e divide (Ap 2, 12). La fine delle visioni (vv. 40-45) corrisponde al cader giù dell’immaginare del poeta percosso nel volto dal lume dell’angelo della pace, come il sonno “si frange” (altro motivo appropriato alla chiesa di Pergamo) guizzando allorché il viso è percosso da “nova luce” (la pietruzza lucida che contiene il nome nuovo, premio della terza vittoria ad Ap 2, 17).
[quanto esposto nella Tabella 1 quinquies è stato più diffusamente trattato altrove]
[1] Questa e altre coincidenze consentono nuove riflessioni sulla questione dell’autenticità dell’epistola.
[2] Cfr. i riferimenti nell’edizione del De vulgari eloquentia a cura di P. V. MENGALDO, Milano-Napoli 1979 (DANTE ALIGHIERI, Opere minori, II), pp. 126-131, e nel commento a cura di S. CECCHIN (Torino 1983), pp. 72-77. Il Cecchin, sul diverso modo con cui le creature ricevono la bontà divina, ritiene che oltre alla presenza della fonte più sicura (e cioè il Liber de causis in quanto citato in Convivio III, vii, 25), sia possibile cogliere un’eco dello Pseudo-Dionigi e del relativo commento dell’Aquinate.
[3] Ai sette doni dello Spirito vòlti in idolatria fa riferimento Inf. XIX, 109-111: “quella che con le sette teste nacque, / e da le diece corna ebbe argomento, / fin che virtute al suo marito piacque”.
[4] Cfr. T. BAROLINI, The Undivine Comedy: Detheologizing Dante, Princeton 1992, trad. it., La “Commedia” senza Dio. Dante e la creazione di una realtà virtuale, Milano 2003, pp. 232-268: 232.
[5] Nei versi: “un corpo ne la cui virtute / l’esser di tutto suo contento giace” (Par. II, 113-114) le parole virtute e contento avrebbero rinviato un accorto lettore alla virtus contentiva di Cristo (LSA, prologo, Notabile VI: nell’esegesi sono i periodi della Chiesa ad essere contenuti, nei versi il movimento dei cieli sottostanti, e dunque il tempo, che nel Primo Mobile o Cristallino tiene le sue radici e negli altri le fronde: cfr. Par. XXVII, 118-120); la parola corpo, se letta congiuntamente ad organi (v. 121) gli avrebbe rammentato la dottrina dionisiana secondo la quale le intelligenze angeliche inferiori ricevono l’“habitus glorie” da quelle superiori, riflettendolo al modo di specchi, come le membra inferiori di un corpo sono radicate nelle virtù del cervello, del cuore o del fegato (Ap 21, 18.21)
[6] PETROCCHI: celestïal. La lezione spiritual, recata da tradizione autorevole, per quanto minoritaria, è preferibile non solo perché l’Empireo è cielo di pura luce intellettuale (Chiavacci Leonardi), oppure per la citazione di Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, III, Suppl., q. 93 a. 2, secondo il quale uno è il luogo spirituale, diversi i gradi di avvicinamento ad esso (Parodi), ma perché i beati partecipano in modo diverso dello Spirito increato e dei suoi doni, il quale è uno e semplice nell’Empireo, è “partitus et particulatus” nel suo moltiplicarsi diversamente partecipato secondo i meriti.
[7] Cfr. A. PAGLIARO, Similitudine in Enciclopedia Dantesca, V, p. 256.
[8] Cfr. S. BATTAGLIA, L’umano e il divino nell’ultimo canto del Paradiso, in Esemplarità e antagonismo nel pensiero di Dante, Napoli 1975, I, pp. 201-221: p. 204: “Il canto XXXIII del Paradiso è sempre sul punto di abolirla, questa umanità, per abilitarla alla visione suprema; ma ogni volta la restaura dinanzi all’abisso della stessa infinità divina. Questa mediazione dell’umano, che è simultaneamente un tramite e un ostacolo, diventa il mito lirico del Paradiso e in particolare del suo episodio finale”.
Tab. 1
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. I, 1-12, 22La gloria di colui che tutto move
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (I sig.)] Nam in prima (apertione) triumphalis lux fidei, procedens a Christo quasi acuta sagitta ex archu, penetravit et illustravit cecos in tenebris sedentes.Par. XXXI, 22-24ché la luce divina è penetrante
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12-13 (VIIa visio)] Sciendum igitur quod, licet per apostolos et per alios sanctos secundi status generalis ecclesie intraverit multitudo populorum ad Christum tamquam per portas civitatis Dei, nichilominus magis appropriate competit hoc principalibus doctoribus tertii generalis status, per quos omnis Israel et iterum totus orbis intrabit ad Christum. Sicut enim apostolis magis competit esse cum Christo fundamenta totius ecclesie et fidei christiane, sic istis plus competet esse portas apertas et apertores seu explicatores sapientie christiane. Nam, sicut arbor dum est in sola radice non potest sic tota omnibus explicari seu explicite monstrari sicut quando est in ramis et foliis ac floribus et fructibus consumata, sic arbor seu fabrica ecclesie et divine providentie ac sapientie in eius partibus diversimode refulgentis et participate non sic potuit nec debuit ab initio explicari sicut in sua consumatione poterit et debebit. Et ideo sicut ab initio mundi usque ad Christum crevit successive illuminatio populi Dei et explicatio ordinis et processus totius veteris testamenti et providentie Dei in fabricatione et gubernatione ipsius, sic est et de illuminationibus et explicationibus christiane sapientie in statu novi testamenti.
|
|
Par. II, 112-123, 136-138Dentro dal ciel de la divina pace
|
Par. IV, 34-39ma tutti fanno bello il primo giro,
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 4 (prohemium, salutatio)] Pro secundo dicit: “Et a septem spiritibus”. Hoc non potest hic stare pro spiritibus angelorum creatis, quia gratia non dicitur dari nobis a creatura vel ab angelis, sed solum quod ministerialiter cooperantur ad hoc ut nobis detur a Deo. Non etiam potest stare pro donis gratie creatis, quia tunc esset sermo nugatorius et ridiculosus, scilicet quod ab ipsis donis creatis darentur nobis ipsamet dona creata. Stat ergo pro increato Spiritu. Unde et Ricardus exponit: “a septem spiritibus”, id est a septiformi Spiritu, qui simplex est per naturam et septiformis per gratiam. Dividit enim dona singulis prout vult*. Dicit etiam hoc appropriate referri ad personam Spiritus Sancti**. Significavit autem sic Spiritum increatum, tum ut insinuet eius causalem multiformitatem, tum ut ostendat eius multiformem et presentialem participationem in variis donis ac si in eis partiretur et multiplicaretur, tum ut ostendat eius originalem radicem et rationem et exemplarem formam septem statuum ecclesie de quibus in hoc libro est intentio principalis.* In Ap I, ii (PL 196, col. 696 C). ** Ibid., col. 696 B.[LSA, cap. V, Ap 5, 6-7 (radix IIe visionis)] Quarto ostenditur habere universalem plenitudinem sapientie et providentie et spiritualis fontalitatis omnis gratie ad universa regenda, cum subditur: “et oculos septem, qui sunt septem spiritus Dei missi in omnem terram”. “Oculi” vocantur propter intelligentiam omnium visivam, “spiritus” vero propter subtilem et spiritualem et agilem naturam et efficaciam. Licet autem increatus spiritus Christi sit in se unus et simplex, dicitur tamen esse “septem spiritus” propter septiformitatem septem donorum suorum et septem statuum, in quibus participatur et quibus secundum eorum partialem seu particularem proportionem assistit, ac si esset in eis partitus et particulatus.De vulgari eloquentia, I, xvi, 1, 4-6: (1) Postquam venati saltus et pascua sumus Ytalie, nec pantheram quam sequimur adinvenimus, ut ipsam reperire possimus rationabilius investigemus de illa ut, solerti studio, redolentem ubique et necubi apparentem nostris penitus irretiamus tenticulis. […] (4-6) Que quidem nobilissima sunt earum que Latinorum sunt actiones, hec nullius civitatis Ytalie propria sunt, et in omnibus comunia sunt: inter que nunc potest illud discerni vulgare quod superius venabamur, quod in qualibet redolet civitate nec cubat in ulla. Potest tamen magis in una quam in alia redolere, sicut simplicissima substantiarum, que Deus est, in homine magis redolet quam in bruto, in animali quam in planta, in hac quam in minera, in hac quam in elemento, in igne quam in terra; et simplicissima quantitas, quod est unum, in impari numero redolet magis quam in pari; et simplissimus color, qui albus est, magis in citrino quam in viride redolet. Itaque, adepti quod querebamus, dicimus illustre, cardinale, aulicum et curiale vulgare in Latio quod omnis latie civitatis est et nullius esse videtur, et quo municipalia vulgaria omnia Latinorum mensurantur et ponderantur et comparantur.Monarchia, III, xv, 15: Sic ergo patet quod auctoritas temporalis Monarche sine ullo medio in ipsum de Fonte universalis auctoritatis descendit: qui quidem Fons, in arce sue simplicitatis unitus, in multiplices alveos influit ex habundantia bonitatis. |
|
Tab. 1 bis
[LSA, prologus, Notabile VI] Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix visionum proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. Nunc tamen in generali breviter demonstretur. Constat enim quod totum imperium potestatis ecclesiastice (I), ac sacerdotale sacrificium martirizationis sue (II), et sapientiale magisterium sue doctrine (III), ac altivolum supercilium vite anachoritice (IV), et condescensivum contubernium vite domestice seu cenobitice (V), et nuptiale connubium seu familiare vinculum singularis amicitie (VI), ac beatificum convivium divine glorie (VII), sunt in Christo exemplariter et etiam contentive et effective. Contentive quidem, tum quia ab eterno est presens omnibus futuris, tum quia virtus, per quam unumquodque in suo tempore efficit et conservat et continet, est sibi essentialis et eternaliter presens.[LSA, cap. XIV, Ap 14, 2 (IVa visio)] Quarto erat suavissima et iocundissima et artificiose et proportionaliter modulata, unde subdit: “et vocem, quam audivi, sicut citharedorum citharizantium cum citharis suis”. Secundum Ioachim, vacuitas cithare significat voluntariam paupertatem. Sicut enim vas musicum non bene resonat nisi sit concavum, sic nec laus bene coram Deo resonat nisi a mente humili et a terrenis evacuata procedat. Corde vero cithare sunt diverse virtutes, que non sonant nisi sint extense, nec concorditer nisi sint ad invicem proportionate et nisi sub consimili proportione pulsentur. Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi et sub debitis circumstantiis unam virtutem et eius actus aliis virtutibus et earum actibus proportionaliter concordare et concorditer coherere, ita quod rigor iustitie non excludat nec perturbet dulcorem misericordie nec e contrario, nec mititatis lenitas impediat debitum zelum sancte correctionis et ire nec e contrario, et sic de aliis.
|
|
Par. II, 70-72, 112-120, 124-148Virtù diverse esser convegnon frutti
|
Par. I, 103-135e cominciò: “Le cose tutte quante
|
[LSA, prologus, Notabile III; de quinto dono (zelus severus in phialis designatus est septiformis)] Item est septiformis quia est contra initium mali intrinsecum (I) et extrinsecum (II); et contra medium terminum, scilicet ascendens (III) stans (IV) et declinans (V); et contra terminum intrinsecum (VI) et extrinsecum (VII).[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (Va ecclesia)] Vocatur autem congrue hec ecclesia Sardis, id est principium pulchritudinis, tum quia in suis paucis incoinquinatis habet singularem gloriam pulchritudinis, quia difficillimum et arduissimum est inter tot suorum luxuriantes se omnino servare mundum; tum quia primi institutores quinti status fuerunt in se et in suis omnis munditie singulares zelatores, suorumque collegiorum regularis institutio, diversa membra et officia conectens et secundum suas proportiones ordinans sub regula unitatis condescendente proportioni membrorum, habet mire pulchritudinis formam toti generali ecclesie competentem, que est sicut regina aurea veste unitive caritatis ornata et in variis donis et gratiis diversorum membrorum circumdata varietate.[LSA, cap. III, Ap 3, 1 (Va ecclesia)] Respectu vero quinti status ecclesiastici, talem se proponit quia quintus status est respectu quattuor statuum precedentium generalis, et ideo universitatem spirituum seu donorum et stellarum seu rectorum et officiorum se habere testatur, ut qualis debeat esse ipsius ordinis institutio tacite innotescat. Diciturque hec ei non quia dignus erat muneribus ipsis, sed quia ipsi et semini eius erant, si dignus esset, divinitus preparata. Unde et Ricardus dat aliam rationem quare hec ecclesia dicta est “Sardis”, id est principium pulchritudinis, quia scilicet sola initia boni non autem consumationem habuit, et solum nomen sanctitatis potius quam rem*. Supra vero fuit alia ratio data. Respectu etiam prave multitudinis tam huius quinte ecclesie quam quinti status, prefert se habere “septem spiritus Dei et septem stellas”, id est fontalem plenitudinem donorum et gratiarum Spiritus Sancti et continentiam omnium sanctorum episcoporum quasi stellarum, tum ut istos de predictorum carentia et de sua opposita immunditia plus confundat, tum ut ad eam rehabendam fortius attrahat.* In Ap I, xi (PL 196, col. 742 C). |
|
Tab. 1 ter
Tab. 1 quater
Tab. 1 quinquies
[LSA, cap. II, Ap 2, 12 (Ia visio, IIIa ecclesia)] Hiis autem premittuntur duo, scilicet preceptum de scribendo hec sibi et introductio Christi loquentis, cum subdit (Ap 2, 12): “Hec dicit qui habet rumpheam”, id est spatam, “ex utraque parte acutam”. Hec congruit ei, quod infra dicit: “pugnabo cum illis in gladio oris mei” (Ap 2, 16).
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 17 (IIIa victoria)] Tertia est victoriosus ascensus super phantasmata suorum sensuum, quorum sequela est causa errorum et heresum. Hic autem ascensus fit per prudentiam effugantem illorum nubila et errores ac impetus precipites et temerarios ac tempestuosos. Hoc autem competit doctoribus phantasticos hereticorum er-rores expugnantibus, quibus et competit premium singularis apprehensionis et degustationis archane sapientie Dei, de quo tertie ecclesie dicitur: “Vincenti dabo manna absconditum, et dabo ei calculum lucidum, et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo novit, nisi qui accipit” (Ap 2, 17).[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (III defectus] Tertius (defectus in nobis claudens intelligentiam huius libri) est nostre phantasie proterva et erronea cervicositas. |
Purg. IX, 32-33e sì lo ’ncendio imaginato cosse,
|
Purg. XV, 115-117Quando l’anima mia tornò di fori
|
I.2 La luce della città
I.2.1 Come in uno specchio (Tab. 2)
Immagine di Dio, la città partecipa della sua luce, dal cui splendore assume forma, come il ferro, accalorandosi, prende la specie del fuoco. La luce della città è simile a una gemma, in essa incorporata come in uno specchio che riflette il divino: è verdeggiante come il diaspro, pulita come un cristallo, è acqua congelata e perspicua, trasparente, simile alla luna, che con le sue macchie oscure designa l’umiltà dei beati (Ap 21, 11). Anche il nobile fiume, che scorre nel mezzo della città con la sua acqua viva e di vita, fra due rive – l’umana e la divina, il merito e il premio – ugualmente ombreggiate dalle sacramentali foglie dell’albero designato da Cristo-lignum vite, è “splendido come cristallo” (Ap 22, 1-2). La piazza della città (lo spazio entro le mura) è detta “vetro perlucido” (Ap 21, 18.21): ivi infatti non è solo aureo fulgore, ma anche verità che senza macchia o polvere confessa umilmente i propri peccati. Questa città, secondo la dottrina dello Pseudo-Dionigi, è organizzata gerarchicamente, per cui gli inferiori si giovano dell’intermedia gloria dei superiori come fossero vetri o specchi più chiari; al modo in cui gli organi secondari del corpo si radicano nella virtù del cervello, del cuore e del fegato.
Improntata dello splendore del lume divino nei tanti specchi che lo ricevono e lo trasmettono, la forma della città, di vetro trasparente per la verità che confessa, di cristallo e d’acqua congelata, di verde adornata, impregna tutto il paradiso. Dai primi beati, i quali nel cielo della Luna si manifestano “quali per vetri trasparenti e tersi, / o ver per acque nitide e tranquille”, quasi fossero “specchiati sembianti” (Par. III, 10-11, 20), all’istantanea creazione della pura forma, della pura materia e dei cieli da esse composti: “e come in vetro, in ambra o in cristallo / raggio resplende sì, che dal venire / a l’esser tutto non è intervallo” (Par. XXIX, 25-30), fino al fiume luminoso dell’Empireo nel quale si specchiano le anime: “e come clivo in acqua di suo imo / si specchia, quasi per vedersi addorno, / quando è nel verde e ne’ fioretti opimo” (Par. XXX, 109-114); si tratti di Adamo, “l’anima primaia” che “mi facea trasparer per la coverta / quant’ ella a compiacermi venìa gaia” (Par. XXVI, 100-102), o del volgersi del poeta “per veder se ’l vetro / li dice il vero” a proposito del lume che emanano i “belli occhi” di Beatrice, prima visto “come in lo specchio fiamma di doppiero” (Par. XXVIII, 1-12), la semantica propria di questa parte dell’esegesi della città superna marca costantemente i versi.
Anche in questo caso, Dite si fregia perversamente delle qualità celesti, che permeano il tessuto di Cocito, “… un lago che per gelo / avea di vetro e non d’acqua sembiante” (Inf. XXXII, 23-24), nei cui dannati ci si specchia (v. 54), dove “le ’nvetrïate lagrime” sono “sì come visiere di cristallo” (Inf. XXXIII, 97-99, 128) e l’ultime ombre “tutte eran coperte, / e trasparien come festuca in vetro” (Inf. XXXIV, 11-12).
I tre gradini sottostanti la porta del purgatorio, sulla cui soglia siede l’angelo portiere, sono proiezione sulla Chiesa peregrinante in terra di Colui che siede sul trono celeste (Purg. IX, 94-105). Il primo dei tre – “e lo scaglion primaio / bianco marmo era sì pulito e terso, / ch’io mi specchiai in esso qual io paio” – contiene il tema della superna vitrea Gerusalemme come “vera città”, cioè come unione di cittadini che confessano la pura verità senz’ombra o pulviscolo, riconoscendo umilmente i propri peccati (Ap 21, 18.21). Il primo gradino non designa dunque, come comunemente si intende, la “contritio cordis”, cioè la prima parte del sacramento della confessione secondo la teologia scolastica, bensì la “claritas”, vale a dire la coscienza dei propri peccati, che in quella città è collettiva, essendo i beati come specchi che si rendono mutuamente. Alla contrizione semmai è avvicinabile il secondo dei gradini, “tinto più che perso, / d’una petrina ruvida e arsiccia, / crepata per lo lungo e per traverso”; mentre il terzo, “sì fiammeggiante / come sangue che fuor di vena spiccia”, designa la carità. Il bianco, il livido o nero, il rosso sono colori dell’iride che circonda la sede divina ad Ap 4, 3, designanti rispettivamente la sapienza, l’umiltà e la carità.
Tab. 2
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 11 (VIIa visio)] Formam autem tangit tam quoad eius splendorem quam quoad partium eius dispositionem et dimensionem, unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et sub igne et ab igne caloratur et ignis speciem sumit, non autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar speculi polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide incorporata et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter representans et omnium virtutum temperie virens. Est etiam perspicua et transparens non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim lune humilitatem celestium men-tium designat. |
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 1-2 (VIIa visio)] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum.
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 18.21 (VIIa visio)] Postquam autem dixit quod materia muri erat ex iaspide, dicit (Ap 21, 18): “Ipsa vero civitas”, scilicet erat “aurum mundum simile vitro mundo”. Et infra, postquam egit de materia portarum, subdit (Ap 21, 21): “Et platea civitatis”, scilicet erat, “aurum mundum, tamquam vitrum perlucidum”. Et forte secundum litteram primum dixit de domibus ex quibus constabat civitas, ultimum vero de toto fundo seu planitie intra muros contenta. Per utrumque autem designatur generalis ecclesia et principaliter contemplativorum, sicut per muros militia martirum et pugilum seu defensorum interioris ecclesie, que est per unitatem concordie “civitas”, id est civium unitas, et per fulgorem divine caritatis et sapientie aurea, et per puram confessionem veritatis propria peccata clare et humiliter confitentis et nichil falso simulantis est “similis vitro mundo”, et per latitudinem caritatis et libertatem ac communitate[m] evangelice paupertatis est “platea” celis patula, non tectis clausa, nec domibus occupata, nec domorum distinctionibus divisa, nec isti vel illi instar domorum appropriata, sed omnibus communis et indivisa. Et quia in tertio generali statu, statutis duodecim portis eius, fulgebit singulariter evangelica paupertas et contemplatio, ideo non fit mentio de platea nisi post portas, et ubi mox subditur quod solus Deus est templum et sol huius civitatis (cfr. Ap 21, 22-23). Unde et platea non solum dicitur esse “aurum simile vitro mundo”, id est perspicuo et polito et nulla macula vel pulvere obumbrato, sed etiam dicitur esse sicut “vitrum perlucidum”, id est valde lucidum, quia tunc maior erit cordis et oris puritas et clarior veritas. In ecclesia vero beatorum erit tanta, ut omnia interiora cordium sint omnibus beatis mutuo pervia et aperta. Nota quod, secundum doctrinam Dionysii in libro de angelica hierarchia sane et subtiliter intellectam, hii qui fuerunt fundamenta vel porte in statu meriti seu gratie multo gloriosius hec erunt in statu premii et glorie. Quamvis enim totus habitus glorie inferiorum sit immediate a Deo, sic tamen erit connexus glorie suorum superiorum ac si in ipsa fundetur et conradicetur, sicut secundaria membra corporis quasi fundantur et radicantur in virtute cerebri, cordis et [e]patis. Inferiores etiam mi[ni]sterialiter iuvabuntur per intermediam gloriam superiorum, quasi per specula clara et quasi per vitrum perspicuum et quasi per portas intrent in clariorem et altiorem actum visionis et fruitionis Dei. Qualiter autem hoc sit et esse possit declaravi plenius in lectura super librum angelice hierarchie prefate. |
|
Inf. XXXII, 22-24, 52-54Per ch’io mi volsi, e vidimi davante
|
Par. III, 10-15, 20Quali per vetri trasparenti e tersi,
|
I.2.2 Le “vermiglie meschite” (Tab. 3)
La città di Dio, che da questi è illuminata e assume l’immagine come il ferro s’accalora al fuoco e ne prende la specie, che è come pietra di diaspro (Ap 21, 11), diventa, nella sua proiezione infernale, “la città del foco” dalle mura che “mi parean che ferro fosse”, “luogo … / tutto di pietra di color ferrigno” in Malebolge (Inf. VIII, 78; X, 22; XVIII, 1-3). Impetrarsi e rosseggiare sono propri della sede divina descritta in principio della seconda visione apocalittica (Ap 4, 2-3), quando Giovanni vede Dio seduto su un trono, con in mano il libro segnato dai sette sigilli, ancora chiuso prima della loro apertura da parte di Cristo. Colui che siede, immobile per giustizia nel suo stare, è simile nel sembiante al verde diaspro (per gli eletti) e alla rossa cornalina (per i reprobi).
La città di Dite dalle ferrigne mura ha torri definite “meschite”, cioè moschee, rosse per l’arroventare del fuoco eterno (Inf. VIII, 70-74, 78). Il termine presta “e piedi e mano” all’esegesi di Ap 13, 1-2, dove Olivi cita l’interpretazione data da Gioacchino da Fiore della statua vista da Nabucodonosor nel sogno spiegato da Daniele, secondo la quale con la quarta parte della statua, fatta di ferro mescolato con fango (è da ricordare che il Veglio di Creta ha il piede destro in terracotta), viene indicato il regno dei Saraceni indomabili come il ferro e correnti alla guerra. Ma si tratta di ferro misto, cioè di seme non più puro, indebolito perché mescolato ad altre genti. Meschite, dunque, concorda nel suono con mixtum (per cui è da prendere in considerazione la forma mischite), ed è segnale mnemonico che rinvia ai significati dell’esegesi esposta nella Lectura. Che poi le “meschite” siano “là entro certe ne la valle” (Inf. VIII, 71), sta ad indicare la certa e giusta misura del giudizio divino, che propina (mesce) il vino dell’ira, «“quod mixtum”, id est propinatum, “est mero”, id est purissimo supplicio» (Ap 14, 10).
I diavoli ostinati, che non vogliono fare entrare Virgilio e Dante nella città, corrono a gara entro le mura, che sembrano ferro, e si preparano alla guerra proprio come i Saraceni. L’arrivo del messo celeste dimostrerà poi, all’apertura della porta con una verghetta, la scarsa solidità di quelle mura, difese da una tracotanza usata già “a men segreta porta, / la qual sanza serrame ancor si trova”, cioè per difendere la porta dell’inferno (Inf. VIII, 124-126). La tematica della gente ‘mista’, che nell’esegesi è relativa ai Saraceni, è ben conosciuta da Cacciaguida (per altro morto come crociato), allorché lamenta l’attuale mistura della cittadinanza di Firenze con gente del contado, “di Campi, di Certaldo e di Fegghine” (Par. XVI, 49-51).
Tab. 3
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 11 (VIIa visio)] Formam (civitatis) autem tangit tam quoad eius splendorem quam quoad partium eius dispositionem et dimensionem, unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et sub igne et ab igne caloratur (a) et ignis speciem sumit, non autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar speculi polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide incorporata et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter representans et omnium virtutum temperie virens. Est etiam perspicua et transparens non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim lune humilitatem celestium mentium designat.(a) caloratur] coloratur B T[LSA, cap. IV, Ap 4, 3 (radix IIe visionis)] Lapidi vero pretioso dicitur similis, quia quicquid est in Deo est pretiosissimum super omnia. Sicut autem iaspis est viridis, sardius vero rubeus et coloris sanguinei, sic Deus habet in se immarcescibilem decorem et virorem delectabilissimum electis, gratioso virori gemmarum et herbarum assimilatum. Rubet etiam caritate et pietate ad electos et fervida iracundia seu odio ad reprobos. Rubet etiam in eo quod voluit et fecit suum Filium pro nobis sanguine rubificari. |
|
Inf. VIII, 67-78; X, 22-23Lo buon maestro disse: “Omai, figliuolo,
|
Inf. XVIII, 1-3Luogo è in inferno detto Malebolge,
|
[LSA, cap. XIII, Ap 13, 1 (IVa visio, VIum prelium)] Et huic sententie satis videtur concordare idem Ioachim, libro V° Concordie circa finem, ubi exponit aliqua de visionibus Danielis et ubi agit de quarta parte statue, scilicet de ferro luto et teste commixto (cfr. Dn 2, 33), per quod debet intelligi quartum regnum contra ecclesiam in quarto eius tempore suscitatum, scilicet regnum Sarracenorum indomabile quasi ferrum et ita currens ad gladium ac si curreret ad convivium. Ibi enim subdit: «Suscitabit autem Deus regnum istud ut percutiat Babilonem, sicut scribitur in Apocalipsi: “decem cornua in bestia odient fornicariam et ipsam igne cremabunt” (Ap 17, 16). Quod autem pedum ipsius statue pars una ferrea erat, altera fictilis, designat regnum novissimum quod erit tempore Antichristi, quod licet a gente ipsa ferrea originem trahat, ob mixturam tamen diversarum gentium, que erit in eo, non erit in ipso tanta soliditas quanta in precedenti, quia ex parte regnum erit solidum, ex parte contr[it]um propter mixturam humani seminis que erit in eo»*.
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 10 (IVa visio, VIum prelium)] “Hic bibet de vino ire Dei” (Ap 14, 10), id est de horrendo et infernali supplicio a Dei ira propinato, “quod mixtum”, id est propinatum, “est mero”, id est purissimo supplicio nulla refrigerante misericordia ad[a]quato. “Mixtum”, inquam, seu propinatum est “in calice ipsius”, id est in certa et iusta mensura iusti iudicii eius, quasi dicat: de infinito vino zelatricis et iracund[e]iustitie Dei contra scelera reproborum miscuit seu propinavit meram penam “in calice”, id est in mensura proportionata culpe illorum.
|
I.2.3 L’eterno femminino della Luna che patisce e riceve (Tab. 4-5)
(Tab. 4)
Nei versi si riscontra la collazione tra Ap 4, 2-3 (la sede divina circondata dall’iride, trattata nella “radice” della seconda visione prima dell’apertura dei singoli sette sigilli) e Ap 21, 11 (la forma luminosa della Gerusalemme celeste trattata nella settima e ultima visione), passi congiunti dal motivo della pietra di diaspro, attribuito nel primo caso a Colui che siede, nel secondo al lume divino. Ciò è particolarmente visibile nella descrizione del cielo della Luna (Par. II, 31ss.), in quell’acqua cristallizzata che a Sainte-Beuve parve esprimere compiutamente la rigenerazione alla “vita suprema” dell’anima, prima fluttuante come un fiume di Babilonia, per opera della Grazia:
Non essendo S. Giovanni a Patmos, bisognerebbe essere Dante nel suo Paradiso per poterla descrivere e dipingere: come all’ingresso delle nove sfere, bisognerebbe toccare insieme a lui quel magnifico insieme di viventi rubini, di luminosi vestiboli, di gemme che cantano, e far già sentire quell’atmosfera celeste dove lo accoglie, come nella nube più impalpabile, il diamante eterno ed indivisibile [1].
La Luna è “lucida” e “pulita”, cioè perspicua come il vetro, ma è anche “solida” per la verità che non traspare per vano fluire (cfr., ad Ap 4, 3, la solidità di Dio che siede sul trono). Ha le qualità del cristallo, che è simile alla luna o all’“acqua” congelata (cfr., ad Ap 4, 3, la nube acquosa). La Luna riceve Dante in sé stessa, cioè lo incorpora, come è incorporata la luce nelle gemme della città (Ap 21, 11). Il poeta si meraviglia dello stare simultaneo di due corpi nello stesso spazio, il suo e quello della stella, e usa il termine “dimensione”, che nell’esegesi scritturale è proprio della descrizione della forma della Gerusalemme celeste.
La Luna appare a Dante coperta da una nube. Olivi afferma (ad Ap 21, 11) che l’oscurità della Luna (“li segni bui”) designa l’umiltà delle menti celesti. Poiché ad Ap 10, 1 si dice che l’angelo dal volto solare è ricoperto da una nube, “amictus nube”, in quanto umile e povero, la nube designa anche l’umiltà della Luna. L’umiltà congiunge la nube con la “margarita”, perché questa, nel suo esser piccolo, è segno dell’umiltà e della povertà evangelica, come quelle incastonate sulle dodici porte della città (Ap 21, 21).
“Per entro sé l’etterna margarita / ne ricevette … e qui non si concepe / com’ una dimensione altra patio, / ch’esser convien se corpo in corpo repe” (Par. II, 34-39): il ricevere dentro di sé è tema proprio della sesta vittoria, con la quale si consegue l’ingresso in Cristo (Ap 3, 12). Nell’esegesi di Filadelfia, la sesta delle chiese d’Asia (Ap 3, 7), è detto che come negli attivi contemplativi del quarto stato rifulse l’amore verso Cristo, così nei contemplativi del sesto rifulge il loro essere diletti da Cristo, non diversamente da quel che si dice di Pietro, che amò Cristo, e di Giovanni, che fu prediletto da Cristo. In tal modo prerogativa del sesto stato è di essere disposto a ricevere e a patire, e in ciò si differenzia dagli stati precedenti, disposti a fare e a dare: “quia potius prefertur eis in pati seu recipere quam in agere vel dare”. Al sesto periodo è attribuita più la felicità che deriva dalla speranza del premio che la fatica dell’attività per cui si acquistano meriti. Ricevendo più grazie e più segni di familiare amore da parte di Cristo, il sesto stato eccelle sugli altri precedenti, ma nello stesso tempo ad essi si deve maggiormente umiliare. I due verbi, “ricevere” e “patire” – “pati seu recipere” -, prerogative del sesto stato, sono appropriati al cielo della Luna, “etterna margarita” che ‘riceve’ dentro a sé il poeta come l’acqua riceve un raggio di luce senza dividersi, in modo che la sua dimensione ‘patisca’ un’altra, cioè il corpo di Dante, cosa inconcepibile sulla terra. Questo tema fondamentale si ritrova nella lezione che Stazio dà sull’umana generazione a Purg. XXV, 46-47, circa l’accogliersi “in natural vasello” dell’uno e dell’altro sangue, “l’un disposto a patire, e l’altro a fare” [2]. Al sangue maschile corrisponde dunque il quarto stato, del quale è proprio il “victoriosus effectus” delle “res gestae”, l’“alto effetto” che uscì dal vittorioso Enea (secondo la quarta vittoria: Ap 2, 26-28; Inf. II, 17-18); al sangue femminile corrisponde il più alto e al tempo stesso il più umile degli stati, il sesto [3]. Come non ricordare le parole di san Bernardo rivolte alla “Vergine Madre, figlia del tuo figlio, / umile e alta più che creatura”? L’età nella quale vivono Olivi e Dante, il sesto periodo della storia della Chiesa, che patisce e riceve, al quale è dato per grazia senza che debba dare (cfr. Inf. VIII, 105), nel quale lo stesso “Regnum celorum vïolenza pate” (Par. XX, 94), si fregia di prerogative che appartengono al sacro eterno femminino.
(Tab. 5)
L’ingresso (in Cristo) e il ritorno (appropriato alla contemplazione e alla città che con “circulus gloriosus” risale e ritorna a Dio dopo essere discesa in terra), sono temi della sesta vittoria, quella propria dei contemplativi (Ap 3, 12; questa esegesi verrà esaminata per intero più avanti, per ora è solo accennata). Insieme combinati (“intrammo a ritornar”), si rinvengono già nella salita di Dante e Virgilio per il “cammino ascoso” attraverso il quale escono “a riveder le stelle” (Inf. XXXIV, 133-134). L’ascesa al cielo del poeta è un tornare al proprio sito (Par. I, 92-93); il suo “trasumanar” avviene fissando gli occhi al sole, atto che si genera da quello di Beatrice come il raggio riflesso suole generarsi dal raggio di incidenza “e risalire in suso, / pur come pelegrin che tornar vuole” (vv. 49-51). La sesta vittoria si intreccia frequentemente con la settima visione, e ciò è comprensibile in quanto entrambe concernono la città superna, con la differenza che quanto avviene nel sesto stato è nella storia – il sesto periodo della Chiesa, iniziato con la conversione di Francesco nel 1206, durerà fino alla sconfitta dell’Anticristo e alla distruzione di Babylon, la Chiesa carnale: è dunque il tempo in cui vivono Olivi e Dante -, lì dove invece con la settima visione cessano storia e profezia e si descrive il compimento nell’eterno. Nella candida rosa, i beati – “quanto di noi là sù fatto ha ritorno” – stanno “intorno intorno” (la circolarità della contemplazione, in rima col tornare) e sopra la luce divina (Par. XXX, 112-114). Discendere e risalire, sempre prerogative della città dei contemplativi, è proprio degli angeli che s’infiorano come api, partecipando ai beati la pace e l’ardore, e poi ritornano “là dove ’l süo amor sempre soggiorna” (Par. XXXI, 4-18). Come nell’Empireo, al termine del viaggio, così il tornare è appropriato ai primi beati che si manifestano nel cielo della Luna (“tornan d’i nostri visi le postille”, Par. III, 13).
Si può notare l’insinuarsi dei signacula da Ap 3, 12 (sesta vittoria) in quelli tratti dai passi relativi alla descrizione della Gerusalemme celeste (settima visione: Ap 21, 11.18.21; 22, 1). Questo è indice del fatto che il Paradiso, a suo modo, sia ancora nella storia. Letteralmente descrive la quiete delle anime in attesa della resurrezione dei corpi, è in ciò configura il settimo e ultimo stato della Chiesa secondo Olivi in quanto appartiene all’altra vita. Ma il settimo periodo è anche nel tempo, e consiste nel pregustare in questo mondo la pace e la gloria futura, come se la Gerusalemme celeste fosse scesa in terra, e questa discesa è anticipata nel periodo precedente con la sesta vittoria.
‘Tornare’, nella Lectura, assume un preciso valore storico nel celebre passo sulla “commutatio” del pontificato contenuto nel Notabile VII del prologo. Nell’Antico Testamento si registrò un continuo mutare delle stirpi sacerdotali, nonostante i patti stabiliti da Dio con alcune di esse. Qualcosa di simile si registra nel Nuovo. Con Pietro e con gli apostoli il sacerdozio fu infatti dato alla stirpe evangelica, quindi venne utilmente e ragionevolmente commutato a uno stato fondato sul possesso dei beni temporali, la cui durata va da Costantino al termine del quinto stato. In questo periodo, i pontefici che preferirono la povertà evangelica ai beni temporali segnarono di nuovo, e in modo raddoppiato, il prevalere del primo ordine, quello del sacerdozio apostolico. Alla fine di queste mutazioni, il pontificato dovrà ritornare al primo ordine, al quale spetta per diritto di primogenitura e per la maggiore perfezione derivante dalla conformità con Cristo. Questo ritorno sarà agevolato non solo dall’imperfezione insita nel possesso dei beni temporali, ma pure da quegli enormi difetti – superbia, lussuria, simonie, liti, frodi e rapine – da cui la Chiesa, divenuta alla fine del quinto stato quasi una nuova Babilonia, risulterà macchiata e confusa dai piedi al capo. Questo tornare è simmetrico, nel sesto stato, alla sesta vittoria (Ap 3, 12), allorché alla discesa della città in terra, nel secolo che si rinnova, corrisponderà un ritorno della medesima in Cristo suo re.
Un esempio tutto particolare di variazione dei temi offerti dal passo della “commutatio” è nell’argomentare di Beatrice contro la soluzione data da Averroè al problema delle macchie lunari, fondata sulle differenze materiali dei corpi celesti, sulla loro rarità e densità (Par. II, 73-90; da notare che il raro e denso, che il personaggio Dante ritiene qualità corporee, sono, nelle descrizione della sede divina ad Ap 4, 3 qualità spirituali, riferite alla nube acquosa entro cui, ai raggi del sole, si forma l’iride dai vari colori che circonda la sede). Se le macchie provenissero dal raro, cioè dalla minore densità – sostiene la donna -, o il pianeta sarebbe raro per tutto il suo spessore in quanto scarso (“digiuno”) di materia; ovvero alternerebbe nella sua massa strati densi e radi, come gli strati del grasso e del magro di un corpo o come carte in un volume. Nel primo caso, la rarità della materia lunare sarebbe manifesta nell’eclissi di sole per il trasparirvi della luce solare. Nel secondo caso, l’alternarsi degli strati rari e densi avrebbe comunque un termine al di là del quale il denso non lasci più passare il raro e che rifletta i raggi, come fa il piombo che sta dietro lo specchio da cui ‘tornano’ i raggi colorati che formano l’immagine degli oggetti. In questo presunto alternarsi di strati rari e densi si annida il tema della “commutatio” tra stato povero ed evangelico (il pianeta “di sua materia sì digiuno”) e stato dotato di beni temporali (“lo grasso” del corpo) cui è soggetto il pontificato, come, nel “termine da onde / lo suo contrario più passar non lassi”, da cui “l’altrui raggio si rifonde / così come color torna per vetro / lo qual di retro a sé piombo nasconde”, è presente il motivo del ritorno del pontificato, alla fine delle mutazioni, al primo ordine, allorché la densità della materia è tanta, come la corruzione della Chiesa al termine del quinto stato, da non lasciar più passare la luce.
Si può notare che sia l’immagine del lume che traspare (vv. 80-81) sia la similitudine con lo specchio (vv. 89-90) segnano un rinvio alla forma della città luminosa e vitrea descritta nella settima visione. Siffatta similitudine ha avuto un’anticipazione in Inf. XXIII, 25-30, con Virgilio il quale, più veloce di uno specchio (di un “piombato vetro”) che trae l’immagine esterna, incorpora come pietra (“dentro ’mpetro”) i pensieri di Dante (nella città celeste la pietra che incorpora il lume è cristallina, i cuori dei beati sono reciprocamente aperti e pervi; ‘impetrare’, in questo caso, non ha il significato di ottenere).
Beatrice, a Par. II, 91-105, previene quindi la possibile obiezione di Dante, per cui il raggio verrebbe riflesso, dagli strati più densi della Luna, in modo “tetro”, cioè non luminoso. Nel proporre un esperimento risolutivo secondo l’uso del tempo, la donna invita il poeta a ‘ritrovare’ con lo sguardo uno specchio posto più distante in mezzo ad altri due collocati a uguale distanza. La luce che illumina i tre specchi, riflettendosi, sarà nello specchio mediano quantitativamente meno estesa che negli altri due ma uguale nello splendere. Per quanto poco perspicuo nel passaggio dei significati spirituali, l’esperimento sembra da connettere con Ap 2, 5, nel senso della “prima gratia” che si estende senza perdersi del tutto fino al fondo della scala, fino “a l’ultime potenze” (cfr. Par. XIII, 61-63), e che può essere ritrovata risalendo i gradi. Ciò vale anche per la carità, che può ridursi dal suo aureo grado (corrispondente alla prima Grazia) senza estinguersi [4]. Ma, anche in questo caso, il lume che si specchia è quello che si diffonde per la città e le dà forma; per esso “ciò che non more e ciò che può morire / non è se non splendor di quella idea / che partorisce, amando, il nostro Sire” (Par. XIII, 52-54); infatti “la gloria di colui che tutto move / per l’universo penetra, e risplende / in una parte più e meno altrove” (Par. I, 1-3), e l’ottavo cielo (o delle stelle fisse), che pur “de la mente profonda che lui volve / prende l’image (cfr. Ap 21, 11: “sancta ecclesia accipit a Deo formam et imaginem Dei”) e fassene suggello”, poi “vi dimostra molti / lumi, li quali e nel quale e nel quanto / notar si posson di diversi volti” (Par. II, 64-66, 131-132). Che si tratti di signacula dalla settima visione apocalittica lo dimostrano anche espressioni come “Ben che nel quanto tanto non si stenda / la vista più lontana, lì vedrai / come convien ch’igualmente risplenda” (Par. II, 103-105), rinvianti alla misura dei lati della città, nei quali lunghezza (vista), larghezza (carità) e altezza (lode) sono uguali (Ap 21, 16), nel senso che in un cerchio corporeo come la Luna, dove si mostrano i beati che vedono meno, il lume divino risplende allo stesso modo, ma in quantità minore, come minore è la loro beatitudine e minori sono le uguali misure del quadrato della città celeste [5].
[1] CHARLES-AUGUSTIN de SAINTE-BEUVE, Port-Royal, I, 5; trad. it. di S. D’Arbela, Firenze 1964 (Classici della Storia Moderna), p. 75.
[2] Si noti il confronto di alcuni punti della lezione di Stazio sull’origine dell’anima umana (Purg. XXV, 46-57) con l’arrivo e la descrizione del cielo della Luna (Par. II, 28-39). Si registrano temi comuni: Ap 3, 7 (‘ricevere e patire’, cfr. supra, Tab. 4); Ap 21, 12 (‘congiungere’, proprio degli angoli della città celeste); Ap 21, 21 (la ‘margarita’, cioè la conchiglia – lo “spungo marino” che designa l’anima sensitiva – pura nel coagulo).
[3] Nella selva dell’Eden gli “augelletti” che operano le loro arti e al tempo stesso ricevono entro le foglie, cantando, le ore mattutine, uniscono la vita attiva con quella contemplativa (Purg. XXVIII, 13-18).
[4] Cfr. “Lectura super Apocalipsim” e “Commedia”. Le norme del rispondersi, cap. 2 (Scendere e risalire per gradi: l’istruzione al vescovo di Efeso (Ap 2, 2-7) secondo Riccardo di San Vittore e Pietro di Giovanni Olivi).
[5] Solo Dio, “verace speglio” nelle parole di Adamo, “fa di sé pareglio a l’altre cose” (Par. XXVI, 106-108), è cioè la “prima equalità” di cui dice Dante a Cacciaguida (Par. XV, 73-78). Dio è “pareglio”, esempio ideale delle creature: «sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei»; la città celeste è “similis (pareglio) increate luci Dei tamquam imago et participatio eius” (Ap 21, 11).
Tab. 4
[LSA, cap. IV, Ap 4, 2-4 (radix IIe visionis)] Dicit ergo (Ap 4, 2): “Et ecce sedes posita erat in celo, et supra sedem sedens”, scilicet erat. Deus enim Pater apparebat ei quasi sub specie regis sedentis super solium. […] “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id est aspectibili seu visibili forme, “lapidis iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dicitur similis, quia Deus est per naturam firmus et immutabilis et in sua iustitia solidus et stabilis, et firmiter regit et statuit omnia per potentiam infrangibilem proprie virtutis.
|
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 7 (Ia visio, VIa ecclesia)] Hinc etiam est quod Christus plus commendat promissiones suorum donorum factas angelo sexto quam merita ipsius sexti. Consurgitque ex hoc quoddam mirabile et valde notabile, videlicet quod status sextus quanto maior erit precedentibus in susceptione gratiarum et familiarium signorum amoris Christi ad eum, tanto habebit unde plus Christo et statibus precedentibus humilietur, quia potius prefertur eis in pati seu recipere quam in agere vel dare, et potius in felicitate hab[ente] speciem premii quam in laborioso opere habent[e] rationem meriti. Hec tamen per anthonomasiam et per quandam appropriationem sunt intelligenda, alias omnia in viris perfectis omnium statuum reperiuntur. Unde et ista sexta singulariter laudatur de patientia (cfr. Ap 3, 10). |
[LSA, cap. III, Ap 3, 12 (VIa victoria)] Quantum autem ad hoc premium, nota quod quia intrans in Deum recipit intra se Deum, ita quod et Deus intrat in ipsum […]
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 11 (VIIa visio)] Formam autem tangit tam quoad eius splendorem quam quoad partium eius dispositionem et dimensionem, unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et sub igne et ab igne caloratur et ignis speciem sumit, non autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar speculi polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide incorporata et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter representans et omnium virtutum temperie virens. Est etiam perspicua et transparens non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim lune humilitatem celestium mentium designat.
|
Par. II, 31-42, 49-51, 58-60Parev’ a me che nube ne coprisse
|
Purg. XXV, 46-57, 76-78Ivi s’accoglie l’uno e l’altro insieme,
|
Purg. XXVIII, 13-18non però dal loro esser dritto sparte
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 7 (Ia visio, VIa ecclesia)] Hinc etiam est quod Christus plus commendat promissiones suorum donorum factas angelo sexto quam merita ipsius sexti. Consurgitque ex hoc quoddam mirabile et valde notabile, videlicet quod status sextus quanto maior erit precedentibus in susceptione gratiarum et familiarium signorum amoris Christi ad eum, tanto habebit unde plus Christo et statibus precedentibus humilietur, quia potius prefertur eis in pati seu recipere quam in agere vel dare, et potius in felicitate hab[ente] speciem premii quam in laborioso opere habent[e] rationem meriti. Hec tamen per anthonomasiam et per quandam appropriationem sunt intelligenda, alias omnia in viris perfectis omnium statuum reperiuntur. Unde et ista sexta singulariter laudatur de patientia (cfr. Ap 3, 10).
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 21 (VIIa visio)] Quod autem hic per duodecim portas magis designentur illi per quos duodecim tribus Israel intrabunt ad Christum, patet ex hoc quod dicit nomina duodecim tribuum Israel esse scripta in hiis duodecim portis (Ap 21, 12), sicut nomina duodecim apostolorum et Agni sunt scripta in fundamentis (Ap 21, 14). Unde bene dicuntur esse margarite et ex margaritis, quia singulari cordis et corporis munditia et castimonia candescent tamquam ex rore celitus concepti et coagulati. Margarite enim dicuntur in conchilibus formari ex rore celesti eis imbibito. Sicut etiam margarite sunt parvule, sic ipsi erunt per evangelicam humilitatem et paupertatem parvuli.[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] In scripturis tamen sepe angulus sumitur pro fortitudine et ornatu, quia in angulis domorum, in quibus parietes coniunguntur, est fortitudo domus. Unde Christus dicitur esse factus in caput anguli et lapis angularis […] |
Tab. 5
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 11 (VIIa visio)] Formam autem tangit tam quoad eius splendorem quam quoad partium eius dispositionem et dimensionem, unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et sub igne et ab igne caloratur et ignis speciem sumit, non autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar speculi polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide incorporata et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter representans et omnium virtutum temperie virens. Est etiam perspicua et transparens non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim lune humilitatem celestium men-tium designat. |
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 18.21 (VIIa visio)] Postquam autem dixit quod materia muri erat ex iaspide, dicit (Ap 21, 18): “Ipsa vero civitas”, scilicet erat “aurum mundum simile vitro mundo”. Et infra, postquam egit de materia portarum, subdit (Ap 21, 21): “Et platea civitatis”, scilicet erat, “aurum mundum, tamquam vitrum perlucidum”. Et forte secundum litteram primum dixit de domibus ex quibus constabat civitas, ultimum vero de toto fundo seu planitie intra muros contenta. Per utrumque autem designatur generalis ecclesia et principaliter contem-plativorum, sicut per muros militia martirum et pugilum seu defensorum interioris ecclesie, que est per unitatem concordie “civitas”, id est civium unitas, et per fulgorem divine caritatis et sapientie aurea, et per puram confessionem veritatis propria peccata clare et humiliter confitentis et nichil falso simulantis est “similis vitro mundo” […]
|
Inf. XXIII, 25-30E quei: “S’i’ fossi di piombato vetro,
|
Par. II, 79-81, 88-90, 97-105, 130-132Se ’l primo fosse, fora manifesto
|
I.2.4 Il gran trono e l’avvento del sole (Tab. 6)
Al momento del giudizio generale (Ap 20, 11), Giovanni vede “un grande trono candido”, che designa il potere e la dignità di Cristo giudice, ovvero, nella gloria, la regale divina maestà, e l’altezza e il candore della purezza della sua umanità sulla quale la sua divinità siede come sul proprio trono. Il trono significa pure la gloria dei santi degli ordini superiori resa candida dalla luce, tramite i quali Dio giudica coloro che devono essere dannati. I segni della duplice natura di Cristo – il trono divino e il candore umano – si mostrano, separati nell’appropriazione, nel “gran seggio” preparato nell’Empireo per l’anima “de l’alto Arrigo”, nella città dove i beati si mostrano non su troni, ma “in forma … di candida rosa” (Par. XXX, 133-138; XXXI, 1-2). Altissimo e quasi ‘divino’ è pertanto il posto che spetta al Monarca che siederà su quel trono, speculare compimento dell’Aristotele visto, nel “nobile castello” del Limbo, “seder tra filosofica famiglia” fregiato delle prerogative di Colui che siede sul trono con in mano il libro ancora chiuso, segnato da sette sigilli. I versi contengono altri motivi da Ap 19, 1-9 (cenare alle nozze dell’Agnello) e da Ap 6, 12 (venire prima che l’Italia sia predisposta ad accettarlo).
Segue poi il versetto sacro: “Dal cospetto di colui che siede (sul trono candido) fuggono la terra e il cielo e non c’è luogo da essi trovato”. Gli abitanti del cielo e della terra fuggono per il grande terrore del furore del giudice, o anche per la somma riverenza alla sua maestà si contraggono nella propria nullità (il verbo ‘resilire’ ha il significato di ‘saltare all’indietro’). Non trovano luogo perché si annullano: come la luce delle candele e delle stelle sparisce all’avvento del sole, così rispetto al fulgore della gloria di Cristo tutte le altre cose saranno quasi nulla. Riccardo di San Vittore legge il passo come relativo al transito della prima specie della terra e del cielo. Anche san Paolo, citato da Agostino nel De civitate Dei XX, 14, dice ai Corinzi: “Passa la figura di questo mondo” (1 Cor 7, 31). Questo motivo – fuggire ritirandosi per paura, annullando il luogo dove prima si stava – è nella spiegazione cosmologica che Virgilio dà prima di lasciare l’inferno: caduto Lucifero nell’emisfero australe, la terra, che prima in questo emergeva, per paura di lui si ritrasse sotto il mare e venne all’altro emisfero e, sempre per fuggire Lucifero, la terra che ora forma la montagna in cima alla quale è il Paradiso terrestre lasciò il suo luogo vuoto (la “natural burella” in cui si trovano al momento i due poeti) ricorrendo in su (Inf. XXXIV, 121-126; cfr. l’uso di parte della medesima tematica a Inf. XXV, nel trasmutarsi reciproco delle due nature, dell’uomo e del serpente).
Il tema, da Ap 20, 11, dell’annullarsi della luce delle stelle all’avvento del fulgore della gloria di Cristo è in Par. XXX, 7-9, dove l’arrivo dell’aurora, “la chiarissima ancella / del sol”, fa sì che il cielo si chiuda “di vista in vista infino a la più bella”. All’arrivo nell’Empireo, Dante viene fasciato da una luce viva, tanto fulgida che null’altro gli appare. Beatrice spiega (utilizzando un ulteriore motivo tratto da Ap 16, 16, relativo all’essere sempre pronti a ricevere il salutifero avvento di Cristo giudice) che Dio, amore che quieta l’Empireo, sempre riceve le anime al loro ingresso con siffatto saluto, nel fulgore di luce, per rendere la candela disposta alla fiamma divina, cioè l’anima preparata alla contemplazione (vv. 46-54). Ancora nell’Empireo, il fulgore di Maria, “pacifica oriafiamma”, si avviva nel mezzo facendo diminuire l’intensità della fiamma ai lati, come al sorgere del sole (che nell’esegesi corrisponde all’avvento di Cristo) l’orizzonte si infiamma in un punto mentre da una parte e dall’altra il lume diminuisce (Par. XXXI, 124-129).
Così di fronte al riso di Beatrice si annulla la poesia di Dante e ‘non trova luogo’ il figurare il paradiso, che passa come la prima figura della terra e del cielo nella citazione di Agostino: “e così, figurando il paradiso, / convien saltar lo sacrato poema, / come chi trova suo cammin riciso” (Par. XXIII, 61-63). “Saltar … riciso”: due verbi che appartengono alle locuste le quali, al suono della quinta tromba (Ap 9, 3), escono dal pozzo dell’abisso privo di freno, pungono e traggono al male, saltano verso l’alto ma, impedite ad alto volo, ricadono a terra. Non deve stupire questa singolare metamorfosi in bonam partem di qualità tanto malvage (Ugo Capeto, in Purg. XX, le trasferisce sulla propria dinastia); esse sono appropriate, tre canti più avanti, addirittura a san Giovanni, emblema per eccellenza della carità (cfr. Par. XXVI, 49-57). D’altronde di metamorfosi e di parodia si tratta e non di riscrittura (si noti il ‘recidere ad terram’ da ‘cado’, proprio delle locuste, che viene sostituito con il ‘recidere’ da ‘caedo’, fonicamente identico).
La penna del poeta “salta” anche lo scrivere il divino canto di san Pietro che si volge tre volte intorno a Beatrice (Par. XXIV, 25-27). Si registra ancora il verso, riferito a Giovanni Battista, “e che per salti fu tratto al martiro”, che delle locuste contiene i temi, appropriati a Salomè, del saltare e del trarre (Par. XVIII, 135).
Tab. 6
Inf. XXXIV, 121-126Da questa parte cadde giù dal cielo;
|
Inf. XXV, 109-111, 124-129, 142-143Togliea la coda fessa la figura
|
[LSA, cap. XX, Ap 20, 11 (VIIa visio)] “Et vidi tronum” (Ap 20, 11). Habito de dampnatione diaboli, in quo intelligitur dampnatio omnium demonum, hic subditur de generali iudicio omnium mortuorum, id est omnium hominum, quamvis et per mortuos possint intelligi omnes spiritus per culpam mortui et morti eterne destinati.
|
|
Par. XXX, 7-9, 49-54, 133-138e come vien la chiarissima ancella
|
Par. XXXI, 1-3, 124-129In forma dunque di candida rosa
|
Par. XVIII, 133-136Ben puoi tu dire: “I’ ho fermo ’l disiro
|
Purg. XX, 64-66, 70-75, 79Lì cominciò con forza e con menzogna
|
[LSA, cap. IX, Ap 9, 3 (IIIa visio, Va tuba)] Tertio tangitur quedam spiritalis plaga quorundam pestiferorum de predicto fumo exeuntium, cum subdit: “et de fumo putei exierunt locuste in terram” (Ap 9, 3). Quamvis per has locustas possint designari omnes mali christiani quorum malitia est multa et publica et multorum lesiva et cruciativa, magis tamen proprie, quoad hunc primum sensum, designat pravam multitudinem clericorum et monachorum et iudicum et ceterorum curialium plurimos spiritaliter et temporaliter pungentium et cruciantium, qui omnes de fumo putei exeunt quia de pravo exemplo effrenationis prefate occasionem et inductivam causam sui mali traxerunt, et etiam quia quasi de puteo inferni cum predicto fumo exempli pessimi videntur exisse. Vocantur autem “locuste”, tum quia ad modum locuste alte saliunt per elationem, et hoc postremis cruribus quia vanam gloriam in omnibus finaliter intendunt, et ad terram recidunt per cupiditatem; tum quia instar locustarum postremis cruribus saliunt, proponendo scilicet in fine penitentiam agere et sic sperant ad gloriam eternam salire, pedibus vero anterioribus et toto ore terre adherent virentia cuncta rodentes; tum quia locusta est animal parvum et secundum legem mundum, habetque alas non ad altum et diuturnum volatum sed ad infimum et modicum. Et ideo partim designat ypocritas humilitatis et munditie et contemplativi volatus simulatores aliorum vitam detractionibus corrodentes et aliorum bona temporalia devorantes, sive per auctoritatem ecclesiasticam, sive per oblationem quasi sanctis factam, sive per questum quasi sub specie pietatis exactum, sive per symoniacam fraudem, sive per falsa et iniqua iudicia vel per alias impias exactiones; partim etiam designat leves et volatiles clericos et monachos carnalia sectantes et per [ea] multis nocentes. |
|
[LSA, cap. IX, Ap 9, 5.10 (IIIa visio, Va tuba)] (Ap 9, 5) Per cruciatum autem designatur hic pungitivus remorsus conscientie et timor gehenne, qui fidelibus in gravia peccata cadentibus non potest de facili deesse. Designat etiam iram et offensam quam temporaliter dampnificati et iniuriati a predictis locustis habent contra eas […].
|
|
Par. XXVI, 49-63“Ma dì ancor se tu senti altre corde
|
Purg. XXXI, 52-54, 85-90e se ’l sommo piacer sì ti fallio
|
San Giovanni, esaminando Dante sulla carità, gli chiede se senta “altre corde” tirarlo verso Dio, cioè, come spiega il Buti, “altri movimenti che ti tirino ad amare Iddio, come la corda tira chi vi è legato” (Par. XXVI, 49-51). L’Apostolo ha già ascoltato come il poeta si senta tratto a Dio per gli argomenti della ragione umana (Aristotele) e per l’autorità della Scrittura che con essa concorda (Mosè e lo stesso Giovanni). Questa ulteriore domanda di Giovanni è tessuta anche con motivi che sorprendono per la loro apparente distanza. L’ottava proprietà delle locuste, che al suono della quinta tromba escono dal pozzo dell’abisso aperto e privo di freno, è di avere le code aculeate simili a quelle degli scorpioni (Ap 9, 10). La coda designa l’intenzione finale e occulta, la coda dello scorpione incurvata verso l’alto e davanti indica la velenosa e fraudolenta intenzione di pungere quasi per stimolare verso i beni superiori e che stanno innanzi agli altri. Gli aculei della coda delle locuste penetrano sottili e acuti nel cuore lasciando la puntura del peccato e del rimorso. Questi motivi, propri di una piaga apocalittica, sono variati nelle parole dell’Evangelista: “Ma dì ancor se tu senti altre corde / tirarti verso lui, sì che tu suone / con quanti denti questo amor ti morde” (denti e mordere, nonché il suonare, sono altre proprietà delle locuste). A Dante “non fu latente la santa intenzione / de l’aguglia di Cristo”, cioè non fu occulta intenzione come quella velenosa delle locuste, e lo stimolare verso l’alto non fu fraudolento ma chiaro nell’indicare il fine al quale desiderava condurre la risposta del poeta (vv. 52-54; “latente” è hapax nel poema: cfr. il passo simmetrico di Ap 9, 19). La quale riprende il tema del morso per dichiarare ciò che ha concorso a formare la carità, e si tratta di “tutti quei morsi / che posson far lo cor volgere a Dio” (vv. 55-57). Anche la definizione di san Giovanni come “aguglia di Cristo”, se secondo il senso letterale deriva dal simbolo dell’aquila che gli è proprio, per fonetica spirituale concorda con gli “aculei” delle locuste i quali, privati della loro malefica efficacia, indirizzano all’amore del sommo bene. Non è questo l’unico luogo del poema che trasforma in senso positivo un passo che nel testo dell’Apocalisse è appropriato a figure o a situazioni negative, e di ciò altrove si è trattato.
|
|
I.2.5 Il nuovo sole e la “primavera sempiterna / che notturno Arïete non dispoglia” (Tab. 7)
La solare luce che pervade la Gerusalemme celeste è storicamente pregustabile in questa vita. Il periodo è quello del sesto e del settimo stato. Ad Ap 21, 22-23 è citato Gregorio Magno. Questi, commentando nei Moralia Giobbe 9, 9 – “Egli che crea Arturo e Orione e le Pleiadi” – insegna espressamente come verso la fine del mondo la luce solare della sapienza di Cristo si renda più manifesta: per i singoli giorni la scienza celeste si mostra più e più come un lume a noi interno, si apre il tempo primaverile, il nuovo sole sfavilla alle nostre menti e, reso a noi noto per il verbo dei dottori, riluce ogni giorno più chiaramente. All’appressarsi della fine del mondo la scienza superna avanza e col tempo cresce più larga.
Il tema gregoriano della scienza celeste che, alla fine dei tempi, è come lume che si interna sempre di più in noi è presente nelle visioni finali, che verranno in seguito esaminate.
Nella città del “sol che sempre verna” (Par. XXX, 126), dove le porte non sono mai chiuse (Ap 21, 25; diversamente che per la Città di Dite, le cui porte vengono chiuse dai diavoli: Inf. VIII, 115-116), il pellegrino mena gli occhi “su per la viva luce passeggiando” (Par. XXXI, 46-48; cfr. Ap 21, 24: “Et ambulabunt gentes in lumine eius”).
Il tema del nuovo sole, unito con quello dell’aprirsi e dell’entrare, si trova al momento del riprendere il cammino verso “l’aperta”, cioè il passaggio, che consente di ‘entrare’ nel quinto girone del purgatorio, dopo il torpore provocato dal sogno della “femmina balba”, quando “tutti eran già pieni / de l’alto dì i giron del sacro monte” (Purg. XIX, 34-39; l’espressione “sol novo” ricorre solo qui, dove inizia il terzo giorno di permanenza sulla montagna).
Il tema del tempo primaverile, dalla citazione di Gregorio Magno, congiunto con quello dell’assenza della notte nella città che è sola luce, da Ap 21, 25 (“Nox enim non erit illic”), è contenuto nella terzina di Par. XXVIII, 115-117, riferita alla seconda terna della gerarchia angelica, “che così germoglia / in questa primavera sempiterna / che notturno Arïete non dispoglia”. L’Ariete è “notturno”, cioè visibile di notte, nell’autunno, mentre all’inizio della primavera sorge e tramonta con il sole. L’espressione traduce pertanto in poesia il concetto che nella città dei beati non vi sarà più notte. Su questo tema principale si innesta, come contrappunto, la tematica del ‘ladro’, trattata nei due passi simmetrici di Ap 3, 3 e 16, 15 [1]. Il ladro viene di notte (Ap 3, 3), come il giorno del giudizio: così scrive san Paolo ai Tessalonicesi invitandoli a vegliare e ad essere “figli della luce e del giorno” (1 Th 5, 2-7). E ad Ap 16, 15 si aggiunge: “Beato chi vigila e custodisce le sue vesti”, cioè le virtù e le buone opere, “affinché non vada nudo”, cioè spogliato delle virtù in modo che tutti vedano i suoi turpi peccati e la pena che verrà inflitta a sua confusione nel giorno del giudizio. Il verbo ‘spogliare’ è lo stesso proprio del notturno e autunnale Ariete. La terzina può essere così accostata a quella, pregna di reminiscenze virgiliane, di Inf. III, 112-114: “Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie”, riferita al “mal seme d’Adamo” pronto a passare l’Acheronte, spronato dalla giustizia divina, “sì che la tema si volve in disio”. È da notare l’accostamento del vedere, appropriato al ramo, con lo spogliarsi, motivi non presenti nella reminiscenza virgiliana – “Quam multa in silvis autumni frigore primo / Lapsa cadunt folia …” (Aen. VI, 309-310) -, e che sono invece nell’esegesi di Ap 16, 15 (per altri esempi cfr. altrove).
[1] Cfr. Il sesto sigillo, cap. 1d, tab. VIII, 1-7.
Tab. 7
Par. XXX, 124-126Nel giallo de la rosa sempiterna,
|
Purg. XIX, 34-39Io mossi li occhi, e ’l buon maestro: “Almen tre
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 22-25 (VIIa visio)] Quod autem circa finem huius seculi amplius innotescat solaris lux sapientie Christi docet expresse Gregorius, libro IX° Moralium super illud Iob IX° (Jb 9, 9) “Qui facit Arturum et Orionem et Iadas”, dicens: «Dum, diebus singulis magis magisque scientia celestis ostenditur, quasi interni nobis luminis vernum tempus aperitur, ut novus sol nostris mentibus rutilet et doctorum verbis nobis cognitus se ipso cotidie clarior lucet. Urgente enim mundi fine superna scientia proficit et largius cum tempore excrescit. Hinc namque per Danielem dicitur: “Pertransibunt plurimi et multiplex erit scientia” (Dn 12, 4). Hinc Iohanni in priori parte revelationis angelus dicit: “Signa que locuta sunt septem tonitrua” (Ap 10, 4). Cui tamen in eiusdem revelationis termino precipit dicens: “Ne signaveris verba prophetie libri huius” (Ap 22, 10). Pars quippe revelationis anterior signari precipitur, terminus prohibetur, quia quicquid in sancte ecclesie initiis latuit, finis cotidie ostendit»*. Idem etiam docet libro IIII° Dialogorum, capitulo XLIII°**.
|
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 3; (Ia visio, Va ecclesia)] Deinde comminatur eidem iudicium sibi occulte et inopinate superventurum si non se correxerit, unde subdit: “Si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur”, qui scilicet venit latenter et ex improviso ut bona auferat et possessorem occidat. Unde subdit: “et horam nescies qua veniam ad te”. Iustum enim est ut qui se ipsum per negligentiam et torporem nescit, nesciat horam iudicii sui et exterminii. Talis etiam propter suas tenebras non videt lucem, ac erronee credit et optat se diu in prosperitate victurum et Dei iudicium diu esse tardandum, et etiam spe presumptuosa sperat se esse finaliter salvandum, propter quod Ia ad Thessalonicenses V° dicit Apostolus quod “dies Domini veniet in nocte sicut fur. Cum enim dixerint: pax et securitas, tunc superveniet eis repentinus interitus” (1 Th 5, 2-3). Quibus autem, scilicet sanctis, et quare non veniet sicut fur ostendit subdens: “Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos dies illa tamquam fur comprehendat; omnes enim vos estis filii lucis et diei. Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed vigilemus et sobrii simus. Qui enim dormiunt nocte dormiunt” et cetera (ibid., 5, 4-7). |
|
Par. XXVIII, 115-117L’altro ternaro, che così germoglia
|
Inf. III, 112-114Come d’autunno si levan le foglie
|
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 15 (Va visio, VIa phiala)] Quia vero Deus tunc ex improviso et subito faciet hec iudicia, ideo subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 15). Fur enim venit latenter ad furandum, ne advertat hoc dominus cuius sunt res quas furatur. Non autem dicit ‘veniam’ sed “venio”, et hoc cum adverbio demonstrandi, ut per hoc estimationem de sua mora nobis tollat et ad adventum suum nos attentiores et vigilantiores et timoratiores reddat. Ad quod etiam ultra hoc inducit per promissionem premii et comminationem sui oppositi, unde subdit: “Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus; “et videant”, scilicet omnes tam boni quam mali, “turpitudinem eius”, id est sua turpissima peccata et suam confusibilem penam in die iudicii sibi infligendam. |
|
Inf. XXXIII, 55-63Come un poco di raggio si fu messo
|
Inf. III, 113-114; XIII, 103-104; XXVII, 127-129; Purg. VII, 34-35; Par. XII, 47-48………………………..fin che ’l ramo
|
I.3 Le due rive del nobile fiume (Tab. 8-10)
Il capitolo XXII dell’Apocalisse si apre con la visione del nobilissimo fiume che scorre nel mezzo della città celeste. È lo stesso Spirito Santo, ovvero la gloria che da Dio affluisce sui beati: fiume di acqua viva, o di vita eterna, da cui deriva tutta la sostanza della Trinità. Fiume di splendore e luce per sapienza, che ha due rive o due parti (destra e sinistra, superiore e inferiore), designanti le due nature, divina e umana, di Cristo-lignum vitae che dà perpetui frutti. Il lignum vitae, l’albero che sta nel mezzo, con le sue foglie getta un’ombra sacramentale, di verità superiori, su entrambe le rive, l’umana e la divina, perché non solo il cielo, ma anche la terra è ripiena della gloria di Dio [1].
L’esegesi di Ap 22, 1-2 offre una ricchezza tematica riaffiorante in numerosi luoghi della Commedia. Può inoltre essere considerata in collazione con altri passi del testo sacro, come Ap 21, 11 (la forma della città, ‘idea’ dello splendore divino) e Ap 21, 18.21.
(Tab. 8, 8 bis)
Se riferita al fiume, l’esegesi conduce ai due fiumi dell’Eden (il Lete e l’Eunoè) che si dipartono da un’unica fontana, e al fiume di luce dell’Empireo (Ap 22, 1-2). Il tessuto dell’Eden è in parte segnato dai temi del fiume celeste, scomposti e assegnati a più immagini. Si dice in parte perché innumerevoli sono i segni che rinviano ad altri raggruppamenti tematici; qui se ne isola uno solo. Si noti la rima diriva / ravviva, per l’Eunoè (Purg. XXXIII, 127-129); ma viva è anche “la divina foresta”, in rima con riva intesa come margine in corrispondenza dell’ultimo gradino della scala (Purg. XXVIII, 1-3), quasi anticipazione della ripa verdeggiante e ombrata del Lete. Questo “rio, / che ’nver’ sinistra con sue picciole onde / piegava l’erba che ’n sua ripa uscìo” (vv. 25-27), la cui acqua toglie la memoria del peccato, costituisce la riva sinistra del fiume celeste, mentre l’Eunoè, il cui gusto “a tutti altri sapori … è di sopra” (v. 133), corrisponde all’altra riva, destra e superiore. Entrambi i fiumi nascono da un’unica sorgente, “al fin d’un’ombra smorta, / qual sotto foglie verdi e rami nigri / sovra suoi freddi rivi l’alpe porta” (Purg. XXXIII, 109-111). I signacula provengono tutti dalla medesima parte di esegesi, ma sono assegnati alcuni a un fiume altri all’altro, altri a entrambi: la ripa e la qualità di “fiume sacro” al Lete, il derivare e l’essere l’acqua viva all’Eunoè; è comune l’ombra delle foglie. Dalle singole parti così contrassegnate, come per sineddoche, l’esperto lettore può ricostruire il tutto, cioè la dottrina che proviene dall’esegesi del testo sacro. Certo questo ‘tutto’ egli già lo conosce in latino, ma è cosa diversa ritrovarselo in volgare, figurato in tante immagini, utile per l’edificazione personale e la predicazione.
Non sono solo i due fiumi dell’Eden ad essere fasciati dalla sacra pagina e dalla sua esposizione. Perfino Beatrice vi partecipa. Anche la donna ha due bellezze, gli occhi e la bocca. Alla prima si perviene con le virtù cardinali (le quali lì accompagnano Dante), ma si guarda nel suo profondo solo con le virtù teologali e per preghiera di queste, congiunta con la grazia gratuitamente data, si ottiene la seconda bellezza. Nel suo svelarsi, Beatrice è “isplendor di viva luce etterna” che sta fra cielo e terra, “là dove armonizzando il ciel t’adombra”. Per lei non si parla di ‘fiume’ o di ‘acqua’, ma assume alcune fondamentali prerogative di Cristo centro della Gerusalemme celeste, della sua irrigazione e dunque della storia umana (Purg. XXXI, 139-145). La donna ha anche nelle sue vesti una zona superiore (il velo candido, “sopra” il quale è “cinta d’uliva”) e una inferiore (“sotto verde manto”), cioè la veste rossa, indelebile memoria dell’umana Beatrice descritta con “vestimenta sanguigne” nella Vita Nova (1. 4, 15; 28. 1; Purg. XXX, 31-33). Il suo disvelarsi è una vera e propria messa in versi della parola “apocalisse”, rivelazione per grazia dell’arcano. L’ombra del velo verrà completamente tolta nella gloria di Cristo quando, nel sesto e nel settimo stato, la luce della luna sarà, come quella del sole, splendente della luce di sette giorni, secondo Isaia 30, 26 che è incipit della Lectura super Apocalipsim.
I due fiumi dell’Eden sono figura in terra dell’unico luminoso fiume dell’Empireo: “fulvido di fulgore, intra due rive / dipinte di mirabil primavera”, dal quale escono “faville vive”, è “onda / che si deriva” da Dio; ma il fiume, le faville (“li topazi / ch’entrano ed escono”) e il verdeggiante “rider de l’erbe” sono “umbriferi prefazi”, cioè ombra sacramentale del vero, adombranti il primo una forma circolare e non lineare, le seconde gli angeli, il terzo i beati (Par. XXX, 61sgg.). Non è detto, ma è facile deduzione dal confronto con gli elementi semantici che segnano l’esegesi scritturale e i versi, che il fiume di luce, come linearmente appare al poeta che non ha “viste ancor tanto superbe”, designi nelle sue due rive la doppia natura di Cristo, umana e divina, volta verso la terra e il cielo. Ma sono entrambe rive di un unico fiume di “luce intellettüal, piena d’amore” (lo Spirito Santo: Dante ne beve l’acqua con gli occhi), per cui dalla Trinità deriva ai beati, ad essi comunicata, tutta la sostanza della grazia e della gloria. Sazietà ed ebbrezza sono alla porta meridionale della città, che apre l’ardente carità di Cristo (Ap 21, 13); le “faville vive” sono “come inebrïate da li odori”, è opportuno che Dante “si sazi” dell’acqua del fiume (vv. 67, 74).
“Li topazi / ch’entrano ed escono” rinviano ad altri luoghi dell’esegesi della Gerusalemme celeste. L’entrata e l’uscita dalla città è misuratamente regolato da un angelo con la canna d’oro (Ap 21, 15; cfr. infra). Le fondamenta della città sono ornate con dodici pietre preziose: diaspro, zaffiro, calcedonio, smeraldo, sardonice, cornalina, crisòlito, berillo, topazio, crisopazio, giacinto, ametista (Ap 21, 19-20) [2]. Queste gemme sono virtù, le loro qualità sono variamente distribuite. Il topazio – che secondo Gregorio Magno deriva da “pan, quod est omne, pro eo quod omni colore resplendet” e designa la perfetta vita contemplativa – è impersonato in Cacciaguida (Par. XV, 85-86); pervade sia la scala d’oro vista nel cristallino cielo di Saturno (Par. XXI, 28-33) come il velo tanto ghiacciato di Cocito “che se Tambernicchi / vi fosse sù caduto, o Pietrapana (la Pania delle Alpi Apuane, in cui pan è come incastonato), / non avria pur da l’orlo fatto cricchi” (Inf. XXXII, 28-30).
All’estremo infernale dell’Empireo sta Cocito, nella cui Tolomea si registra uno stare dell’anima (superiore e ‘viva’) e del corpo (inferiore e terreno) distorto rispetto a quello di Cristo centro fra le due rive: ivi infatti i traditori degli ospiti stanno dannati con l’anima ancor prima della morte corporale, essendo il corpo governato da un demonio che lo fa apparire “vivo ancor di sopra” (Inf. XXXIII, 154-157).
Ma l’archetipo figurale del nobilissimo fiume di luce dell’Empireo è il “bel fiumicello” che ‘difende’ il “nobile castello” del Limbo (Inf. IV, 106-108) anch’esso, con gli “spiriti magni” che vi albergano, primo nucleo dell’edificio santo che tanto si svilupperà attraverso i sette stati della storia, antica e nuova.
In questa esegesi del fiume di una città immateriale, perché tale è la Gerusalemme celeste, Dante poteva specchiare quanto la sua mente aveva elaborato sulle due beatitudini, poste come fini all’uomo dalla Provvidenza: la beatitudine di questa vita (raffigurata nel paradiso terrestre), alla quale si perviene sotto il regime dell’imperatore, attraverso la filosofia e la pratica delle virtù morali e intellettuali; la beatitudine della vita eterna (consistente nella visione di Dio), alla quale si perviene tramite le virtù teologali e sotto la guida del romano pontefice (cfr. Monarchia, III, xv, 7-10). Entrambe le beatitudini, come le loro guide, discendono senza intermediari dall’unico Fonte dell’universale autorità (ibid., xv, 15). Corrispondono alle due rive, umana e divina, dell’unico fiume della grazia e della gloria, all’umanità e alla divinità di Cristo. Beatrice, figura di Cristo, è nell’Eden cerniera: gli occhi partecipano sia dell’una come dell’altra, la bocca svelata adombra la visione di Dio.
Nel “poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra” (Par. XXV, 1-2; cfr. l’esegesi di Ap 10, 5-7, considerata altrove), per il quale la Grazia deriva da entrambe le rive dell’unico fiume celeste, l’esegesi di Ap 22, 1-2 torna con insistenza, e in modo insospettabile. Ad esempio, voto religioso e impero sono nel Paradiso trattati rispettivamente nei primi due cieli, entrambi, nelle “sacre bende” o nelle “sacre penne”, “ombra” sacramentale di verità superiori che discendono dal fiume luminoso dell’Empireo, che ha due rive, una divina e l’altra umana (cfr. Par. III, 114; VI, 7; “sacramento” è “sacro segno” ad Ap 1, 20 e 17, 7). C’è una ragione precisa del tanto spazio dato alla questione dell’alienabilità dei voti. Alcuni fondamentali attributi del voto evangelico, così come delineati dall’Olivi, appaiono infatti applicabili anche alla Monarchia: la stabilità, l’immutabilità, l’indissolubilità, il divieto assoluto di alienazione. Così lo stato di altissima povertà, a causa dell’immutabilità del voto, produce su chi lo professa gli stessi effetti della giurisdizione del Monarca: il non poter desiderare di più, la rimozione della cupidigia, la carità, la pace.
Si direbbe che la stessa poesia derivi la sua linfa da quel fiume di grazia e di gloria (Ap 22, 1-2). Essa, nel descrivere il “regno santo”, è umbratile, sacramentale figurazione di verità superiori; si corona delle lauree foglie del “diletto legno” del “buono Appollo” utilizzando ambedue i gioghi di Parnaso, quello abitato dalle Muse e quello sede di Apollo, come su ambedue le rive, umana e divina, stanno le foglie di Cristo-lignum vitae con il loro sacro ombreggiare (Par. I, 16-18, 22-27) [3].
(Tab. 9)
Come ogni parte della Lectura utilizzata alla stregua di “panno”, anche l’esegesi di Ap 22, 1-2 non è mai isolata. La ritroviamo collazionata con quella di altri luoghi. Ad esempio, i temi della sesta vittoria (il discendere della città da Dio, per poi risalirvi o tornarvi, tale che la contemplazione formi un “circulus gloriosus”; la pace: Ap 3, 12), sono incastonati, nella descrizione dell’acqua del fiume luminoso e dell’empirea candida rosa (Par. XXXI, 7-18), fra quelli della settima visione apocalittica (l’adornarsi del verde di tante foglie; la rima viva / arriva appropriata agli angeli; il sempre soggiornare del suo amore, che riprende l’eterna coabitazione di Dio con gli uomini da Ap 21, 3).
(Tab. 10)
Quanto sia diffusa nel poema l’esegesi di Ap 22, 1-2 è verificabile anche imperniando sul verbo derivare (con la variante meare) gli altri elementi semantici ad essa riferibili. I luoghi sono così numerosi da indurre a non dilungarsi nell’esplicarli singolarmente, lasciando all’ingegnoso lettore il compito di dedurne le conseguenze. Tuttavia alcuni punti assumono un significato particolare.
Come l’Eunoè, acqua dal gusto superiore alle altre, “diriva” dall’unica fontana dell’Eden e, per tramite di Matelda, “ravviva” la “tramortita … virtù” di Dante (Purg. XXXIII, 127-129), all’opposto nella valle infernale anche il Flegetonte “si diriva così dal nostro mondo” e “ci appar pur a questo vivagno” (Inf. XIV, 121-123). “Vivagno”, letteralmente, designa il bordo interno del settimo cerchio (il sabbione infuocato); spiritualmente, accenna al massimo estraniarsi del mondo umano dall’acqua che “ravviva”. La stessa forma “deriva” è appropriata al riversarsi da “una fonte … per un fossato” del “tristo ruscel” che va nella palude Stigia (Inf. VII, 100-108). Qui, nel passaggio dal quarto al quinto cerchio, Virgilio e Dante tagliano il quarto “a l’altra riva” (la rima con “deriva” corrisponde a due distinti elementi semantici dell’esegesi scritturale, ripa e dirivatur). Si ritrovano ancora gli elementi propri dell’irrigazione della città descritta nella settima visione: una fonte, due rive (anche se con queste sono da intendere i due bordi, superiore e inferiore, del quarto cerchio), e anche un fossato (che, come si vedrà più avanti, assume particolare significato nella formale costruzione delle parti della città celeste). È anche la prima volta che nel corso del viaggio si incontra una ‘fonte’. I due luoghi di Inf. VII e XIV sono tessuti sul medesimo panno esegetico, a testimoniare l’unicità dei fiumi infernali, che pur mutano nome in Acheronte, Stige, Flegetonte, Cocito.
In Par. IV Beatrice risolve due dubbi che spingono Dante “d’un modo”, ma che in realtà hanno valore diverso. L’uno infatti (che le anime beate paiano tornare alle stelle, “secondo la sentenza di Platone” data nel Timeo) concerne una questione filosofica, “che più ha di felle”, per il congiunto rischio di eresia; l’altro (che la giustizia divina possa sembrare ingiusta agli uomini) “è argomento / di fede e non d’eretica nequizia”. Tuttavia, afferma Beatrice, anche in quest’ultimo caso “puote vostro accorgimento / ben penetrare a questa veritate”, cioè su essa la ragione può intervenire nella materia teologica. Alla fine (vv. 115-120), l’argomentare della donna è descritto con i motivi del fiume della Gerusalemme celeste: è “parlar” che “inonda”, “ondeggiar del santo rio / ch’uscì del fonte ond’ ogne ver deriva; / tal puose in pace uno e altro disio”, due desideri incardinati su due diverse rive, umana e divina, filosofica e di fede. Le rime deriva, diva, m’avviva sono tre marcatori di concetti relativi al fiume di acqua vivificante (lo Spirito Santo) che deriva da Dio.
Estrema, ma significativa, variazione è la rima viva / riva a Par. XXVI, 61.63. Anche se non di fiume, ma di mare si tratta, a san Giovanni Dante parla di due vie che menano a Dio: una umana e razionale (additata da Aristotele, “colui che mi dimostra il primo amore / di tutte le sustanze sempiterne”, concorde con le Scritture), l’altra oggetto di fede che concorre alla carità (nei tre doni della creazione, redenzione e gloria). L’una e l’altra via, quella intellettuale e quella d’amore – prosegue il poeta – “tratto m’hanno del mar de l’amor torto, / e del diritto m’han posto a la riva”. Ma l’esegesi del nobilissimo fiume di acqua viva dalle due rive, umana e divina, entrambe sotto l’ombra del sacro proveniente da Cristo, è ben presente all’autore. Con il definire “conoscenza viva” la filosofia, Dante ha portato il “maestro di color che sanno” sulla riva, sinistra e umana, di quel fiume.
[1] Ad Ap 22, 2 Olivi si sofferma a lungo sul Lignum vitae di Bonaventura (cfr. l’edizione in rete della Lectura super Apocalipsim).
[2] Cfr. La settima visione, I.7.
[3] Da confronti con altri autori – Riccardo di San Vittore (Expositio in Apocalypsim) e il commento all’Apocalisse erroneamente attribuito a Tommaso d’Aquino – si evince l’originalità dell’Olivi. Lo pseudo-Tommaso dipende dal Vittorino con l’aggiunta di citazioni scritturali. Riccardo, che è fonte essenziale per la Lectura oliviana, dove viene affrontato con l’altra grande auctoritas costituita da Gioacchino da Fiore, è ben presente nel commento francescano, ma con profonde differenze. Non usa il termine ripa, non parla di “nobilissimo” fiume, non dà delle ‘foglie’ quell’interpretazione di ombra sacramentale (esse sono, genericamente, i “praecepta Christi”) che si è visto insinuarsi nei versi danteschi proprio con riferimento al valore della poesia. Cfr. La settima visione, 2.2.
Tab. 8
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 11 (VIIa visio)] Formam autem tangit tam quoad eius splendorem quam quoad partium eius dispositionem et dimensionem, unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et sub igne et ab igne caloratur et ignis speciem sumit, non autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar speculi polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide incorporata et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter representans et omnium virtutum temperie virens. Est etiam perspicua et transparens non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim lune humilitatem celestium mentium designat. |
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 18.21 (VIIa visio)] Postquam autem dixit quod materia muri erat ex iaspide, dicit (Ap 21, 18): “Ipsa vero civitas”, scilicet erat “aurum mundum simile vitro mundo”. Et infra, postquam egit de materia portarum, subdit (Ap 21, 21): “Et platea civitatis”, scilicet erat, “aurum mundum, tamquam vitrum perlucidum”. Et forte secundum litteram primum dixit de domibus ex quibus constabat civitas, ultimum vero de toto fundo seu planitie intra muros contenta. Per utrumque autem designatur generalis ecclesia et principaliter contemplativorum, sicut per muros militia martirum et pugilum seu defensorum interioris ecclesie, que est per unitatem concordie “civitas”, id est civium unitas, et per fulgorem divine caritatis et sapientie aurea, et per puram confessionem veritatis propria peccata clare et humiliter confitentis et nichil falso simulantis est “similis vitro mundo” […] Inferiores etiam mi[ni]sterialiter iuvabuntur per intermediam gloriam superiorum, quasi per specula clara et quasi per vitrum perspicuum et quasi per portas intrent in clariorem et altiorem actum visionis et fruitionis Dei. Qualiter autem hoc sit et esse possit declaravi plenius in lectura super librum angelice hierarchie prefate. |
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 1-2 (VIIa visio)] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit*. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum.
|
|
Par. XXX, 61-69, 73-78, 85-87e vidi lume in forma di rivera
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 15 (VIIa visio)] Per hanc autem metiuntur civitatem et murum et portas, tum quia docent horum regularem et virtualem mensuram, tum quia sub certa discretionis regula et mensura regunt totam ecclesiam et eius introitus et exitus et mirabilem clausuram.[LSA, cap. XXI, Ap 21, 20 (VIIa visio)] “Topazius”, qui similis est auro purissimo et serenissimo celo, et super ceteros lapides splendens maxime cum tangitur solis splendore, et qui secundum Gregorium dicitur a «pan», quod est omne, pro eo quod omni colore resplendet, designat perfectam contem-plativam.
|
Tab. 8 bis
Purg. XXXI, 1-3, 139-145“O tu che se’ di là dal fiume sacro”,
|
Par. I, 16-18, 22-27Infino a qui l’un giogo di Parnaso
|
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 1-2 (VIIa visio)] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum.
|
|
Purg. XXVIII, 1-4, 10-18, 25-33; XXXII, 43-45; XXXIII, 106-111, 127-129Vago già di cercar dentro e dintorno
|
Par. XXX, 61-66, 76-87e vidi lume in forma di rivera
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 20 (Ia visio)] Misterium dicitur omne signum figurale figurans aliquod grande secretum, et aliquando stat pro tali occulto significato.
|
|
Inf. III, 21; VIII, 86-87mi mise dentro a le segrete coseE ’l savio mio maestro fece segno
|
Par. VII, 55-57, 61-63Tu dici: “Ben discerno ciò ch’i’ odo;
|
Tab. 9
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 11 (VIIa visio)] Formam autem tangit tam quoad eius splendorem quam quoad partium eius dispositionem et dimensionem, unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et sub igne et ab igne caloratur et ignis speciem sumit, non autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar speculi polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide incorporata et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter representans et omnium virtutum temperie virens. Est etiam perspicua et transparens non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim lune humilitatem celestium mentium designat. |
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 18.21 (VIIa visio)] Postquam autem dixit quod materia muri erat ex iaspide, dicit (Ap 21, 18): “Ipsa vero civitas”, scilicet erat “aurum mundum simile vitro mundo”. Et infra, postquam egit de materia portarum, subdit (Ap 21, 21): “Et platea civitatis”, scilicet erat, “aurum mundum, tamquam vitrum perlucidum”. Et forte secundum litteram primum dixit de domibus ex quibus constabat civitas, ultimum vero de toto fundo seu planitie intra muros contenta. Per utrumque autem designatur generalis ecclesia et principaliter contemplativorum, sicut per muros militia martirum et pugilum seu defensorum interioris ecclesie, que est per unitatem concordie “civitas”, id est civium unitas, et per fulgorem divine caritatis et sapientie aurea, et per puram confessionem veritatis propria peccata clare et humiliter confitentis et nichil falso simulantis est “similis vitro mundo” […] Inferiores etiam mi[ni]sterialiter iuvabuntur per intermediam gloriam superiorum, quasi per specula clara et quasi per vitrum perspicuum et quasi per portas intrent in clariorem et altiorem actum visionis et fruitionis Dei. Qualiter autem hoc sit et esse possit declaravi plenius in lectura super librum angelice hierarchie prefate. |
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 1-2 (VIIa visio)] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum.
|
|
Par. XXX, 88-90, 100-105, 109-114e sì come di lei bevve la gronda
|
Par. XXXI, 7-18sì come schiera d’ape che s’infiora
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 12 (VIa victoria)] Vocat autem eam novam propter novitatem glorie vel gratie, unde et precipue significat hic civitatem beatorum, et post hoc illam que erit in sexto et septimo statu, et post hoc illam que reiecta vetustate legalium fuit in quinque primis statibus Christi, et post hoc totam universaliter ab initio mundi. Vocatur etiam Iherusalem, id est visio pacis, quia vel ipsa fruitur vel ad ipsam suspiratur.
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 3 (VIIa visio)] “Ecce tabernaculum Dei cum hominibus” (Ap 21, 3), id est, secundum Ricardum, manifestum deitatis con-tubernium cum salvatis. Et quia illa societas seu cohabitatio Dei cum eis non erit transitoria sed eterna, ideo subdit: “et habitabit in eis”, id est cum eis semper. Cuius societatis vinculum magis declarat, cum subdit: “Et ipsi populus eius erunt”, sibi scilicet fidelissime adherendo ipsumque colendo et semper laudando et sibi obediendo; “et ipse Deus cum eis erit eorum Deus”, suam scilicet presentiam et bea-titudinem ipsis ineffabiliter communicando et ipsos numquam deserendo. Nunc enim in hoc mundo quasi non est cum suis, quia non se presentat eis visibiliter et facialiter, sed speculariter quasi absens*.
|
Tab. 10
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 1-2 (VIIa visio)] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum.
|
|
Inf. VII, 100-102Noi ricidemmo il cerchio a l’altra riva
|
Par. II, 139-144Virtù diversa fa diversa lega
|
I.4 Tommaso d’Aquino con il saio francescano (Tab. 11)
Dalla collazione del Notabile VII, nel prologo della Lectura, con i passi della settima visione che descrivono la forma della città celeste (capp. XXI-XXII), nascono i versi con cui Tommaso d’Aquino in Par. XIII, 52-87 spiega non esserci contraddizione tra quanto creduto per fede da Dante, che la perfezione della sapienza umana sia stata infusa prima in Adamo e poi in Cristo uomo, e quanto affermato dallo stesso Aquinate, che Salomone sia stato il più sapiente degli uomini (Par. X, 109-114).
L’inizio del discorso di Tommaso è, come scrive il Sapegno, “uno degli esempi più alti della lirica metafisica di Dante, che traduce i grandi concetti della filosofia medievale in lucentezza cristallina di immagini” [1]. Tommaso recita in versi quanto da lui scritto nella Summa theologiae (I, q. xliv, 3) circa la presenza nella sapienza divina delle ragioni di tutte le cose, cioè delle forme esemplari esistenti nella mente di Dio, causa prima esemplare di tutte le cose. Ma le parole dell’Aquinate, anche ammesso che corrispondano al suo pensiero più che a quello di altri scolastici, sono tutte armate di significati spirituali che suoi non sono, tratti da una diversa teologia della storia. D’altronde anche per Olivi Cristo “verbalis sapientia Patris”, che cioè esprime la sapienza del Padre, è “causa exemplaris” (prologo, Notabile VI; Ap 2, 7; 5, 1).
La viva luce del Verbo che “sì mea”, cioè deriva, dalla sua fonte luminosa e raccoglie il suo radiare, quasi specchiandosi, nei nove cori angelici dai quali discende giù di atto in atto, cioè di cielo in cielo, fino alle ultime potenze tanto che da ultimo non produce più che creature contingenti e corruttibili, è la viva luce di ogni somma sapienza che ad Ap 22, 1 è rappresentata dal fiume per il quale deriva a tutti i beati la sostanza della Trinità. Il raccogliersi della luce nelle nove sussistenze angeliche, specchi della forma divina, è nell’essere deiforme della città, simile all’increata luce di Dio, sua idea e partecipazione di Lui (Ap 21, 11: “quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius […] sic et sancta ecclesia accipit a Deo claritatem, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei”). La luce della grazia e della gloria è specchio del divino. Il discendere della luce di cielo in cielo corrisponde alla dottrina dello Pseudo Dionigi, contenuta nel De angelica hierarchia e citata ad Ap 21, 21, secondo la quale, sebbene la gloria di tutti i beati provenga da Dio, tuttavia coloro che hanno un grado inferiore si troveranno connessi alla gloria dei loro superiori e si gioveranno del loro aiuto entrando, attraverso la gloria intermedia di questi, quasi per specchi chiari e per vetri tersi e per porte, in un più chiaro e alto atto di contemplazione e di fruizione di Dio. Il permanere dell’unità della luce nel suo moltiplicarsi negli angelici specchi corrisponde al mantenersi unita della città (Ap 21, 18.21).
La luce è “imago”, cioè idea divina, e “substantia Trinitatis”. Nel Notabile VII del prologo, spiegando i motivi della preminenza del sesto stato, Olivi configura la storia umana come una rappresentazione della trinità e dell’unità divina. Il tempo che precede il primo avvento di Cristo ci mostra Dio padre fecondo e tutto ordinato alla generazione del Figlio, come la legge e le profezie e tutto il primo popolo di Dio furono ordinati a prefigurare, promettere, partorire Cristo. Cristo che redime e rinnova il mondo rappresenta nella sua persona il tempo del Figlio. Il tempo del rinnovamento del secolo per la celebrazione della vita di Cristo – il sesto stato, suo secondo avvento – è appropriato allo Spirito Santo, che procede dal Padre e dal Figlio ed entrambi chiarifica. In questa età il popolo giudaico, che già fu “imago Patris” e il popolo dei Gentili, che dopo aver ricevuto Cristo da lui si discostò, verranno riuniti dal calore vitale e dalla luce della vita di Cristo per mezzo dello Spirito. I temi di questa rappresentazione trinitaria della storia fasciano l’argomentare di Tommaso, soprattutto nell’essere il Verbo “quella idea / che partorisce, amando, il nostro Sire”, dove il partorire del Padre non appartiene al linguaggio dell’Aquinate. Un altro tema è il mantenersi unita la viva luce del Verbo con il Padre e con lo Spirito, che corrisponde alla riunificazione dei due popoli operata nel terzo stato dalla luce di Cristo per mezzo del suo Spirito, e anche alla concordia della città celeste, “civitas, id est civium unitas” (Ap 21, 18.21).
Sono, questi, temi che nella cantica precedente hanno già segnato la lezione di Stazio sull’umana generazione, dall’andamento trinitario (Purg. XXV, 34-78): una e indivisa è la luce divina che si diffonde nel creato, come l’anima dell’uomo è “un’alma sola” per la quale non è concepibile un intelletto disgiunto, come intese Averroè. Come nella generazione dell’uomo, di cui dice Stazio, vi è uno sviluppo trinitario reso uno dallo “spirito novo, di virtù repleto” che rende partecipe della propria sostanza di divino intelletto l’anima vegetativa e quella sensitiva, così nella luce creatrice, di cui dice Tommaso d’Aquino, vi è unità trinitaria che scende fino alle ultime potenze e alle brevi contingenze. In entrambi i casi, dell’anima e delle creature, ciò che è umano e corruttibile partecipa in misura diversa del divino, con la propria storia individuale.
Nel Notabile VII del prologo Olivi prosegue spiegando che nella storia della Chiesa diversi sono i gradi di perfezione, per cui si sale dall’infimo al supremo per gradi intermedi, come per precedenti predisposizioni verso l’ultima forma. Ad esempio, il popolo dei Gentili non fu subito perfettamente disposto a una perfetta intelligenza della fede e a una perfetta imitazione della vita di Cristo, e dovette pertanto essere illuminato attraverso un succedersi di più periodi (status) e di più guide. Ancora, trattando delle porte della Gerusalemme celeste (Ap 21, 12-13), il Francescano afferma che la divina sapienza e provvidenza, che risplende nelle parti della “fabrica ecclesie” in modo diversamente partecipato, si esplica tutta, dopo successive e crescenti illuminazioni del popolo di Dio, nel terzo stato del mondo, che corrisponde al sesto e settimo stato, come un albero si mostra compiutamente solo nelle foglie e nei frutti.
Così Tommaso continua (vv. 67-72) dicendo che la materia può essere disposta in modo diverso nel ricevere l’influsso celeste e nel riflettere l’impronta dell’idea divina, che cioè esistono diversi gradi di perfezione. Di qui deriva il fatto che alberi identici nella specie producano frutti migliori o peggiori: il “legno” e il “fruttare” sono motivi tratti da Ap 22, 2, dove il “lignum vitae”, cioè Cristo che sta nel mezzo della città celeste, produce frutti per dodici mesi.
La luce dell’idea divina parrebbe tutta se la natura fosse perfettamente disposta e il cielo fosse nella sua virtù suprema, ma la natura rende sempre il sigillo della luce divina in maniera imperfetta, come l’artista a cui trema la mano (vv. 73-78). Nelle due terzine si mostra il tema della gloria di Cristo, la cui virtù luce tutta nella chiarezza meridiana incomparabilmente più del sole (Ap 1, 16: decima perfezione di Cristo come sommo pastore), che corrisponde nei versi all’essere il cielo nella sua virtù suprema, all’apparire di tutta la luce. Ma questa sublime virtù di Cristo trasfigurato, impressa nei sottoposti (che corrispondono alla cera o alla materia), rende tremante chi la guarda (nei versi è l’artista cui trema la mano; si tratta, ad Ap 1, 17, dell’undicesima perfezione, tema intrecciato con quello dell’artista inesperto, da Ap 14, 2).
Però, conclude l’Aquinate (vv. 79-87), se lo Spirito Santo (“’l caldo amor”, dal Notabile VII del prologo) dispone il Verbo (“la chiara vista”, che corrisponde alla “claritas” di Ap 21, 11) che procede dal Padre (“la prima virtù”), allora la creatura aduna in sé il massimo della perfezione, come avvenne appunto in Adamo e nella Vergine.
Il procedere per gradi di successive illuminazioni dall’infimo al supremo è proprio del viaggio di Dante il quale, come dice san Bernardo nella preghiera alla Vergine, dopo aver visto “le vite spiritali ad una ad una” partendo “da l’infima lacuna / de l’universo”, ora supplica di ricevere tanta virtù per potersi levare “più alto verso l’ultima salute” (Par. XXXIII, 22-27).
Da notare, nel parlare di Tommaso (come nella lezione di Stazio sull’umana generazione), la presenza dei temi del rimanere e del seme, dalla quinta guerra (Ap 12, 17).
Nel suo alto parlare che diffonde sull’universo i temi della Gerusalemme celeste, Tommaso non dice cose che, da vivo, avrebbe smentito; da beato, tuttavia, la semantica che utilizza non è sua. Egli non è d’altronde la luce più fulgida, cioè la più sapiente, del cielo del Sole; più di lui splende, e quindi vede più profondo, l’equivoca “quinta luce”, prima innominata e che poi lo stesso Aquinate precisa, sempre con parole tessute sulla Lectura super Apocalipsim di Olivi, essere Salomone.
[1] DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di N. SAPEGNO, Milano-Napoli 1957, p. 951 a Par. XIII, 52.
Tab. 11
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. xliv, 3: Et ideo oportet dicere quod in divina sapientia sunt rationes omnium rerum: quas supra diximus ideas, id est formas exemplares in mente divina existentes.[LSA, cap. II, Ap 2, 7 (Ia visio, Ia ecclesia)] Item Christo, in quantum est Verbum et verbalis sapientia Patris, appropriatur interna locutio que fit per lucem simplicis intelligentie. Illa vero que fit per amoris gustum et sensum appropriatur Spiritui Sancto. Prima autem se habet ad istam sicut materialis dispositio ad ultimam formam.[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (radix IIe visionis)] “Et vidi in dextera sedentis super tronum librum scriptum intus et foris, signatum sigillis septem” (Ap 5, 1). Preostensa gloria et magnificentia maiestatis Dei, hic accedit ad ostendendum profunditatem incomprehensibilem libri sui. Qui quidem liber est primo idem quod Dei essentialis prescientia et totius reparationis universe fiende per Christum predestinatio, et per appropriationem est ipsum Verbum Patris prout est expressivum sapientie eius et prout Pater, ipsum generando, scripsit in eo omnem sapientiam suam.Secundo modo est idem quod scientia mentium angelicarum ipsis a Deo data et in eis scripta, prout est de totali gratia et gloria electorum et totius cultus Dei consumandi per Christum, et multo magis est scientia universorum scripta a Deo in anima Christi. Tertio est idem quod totum volumen scripture sacre et specialiter veteris testamenti, in quo novum fuit inclusum et sub figuris variis signatum et velatum. […][LSA, prologus, Notabile VI] Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix visionum proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. |
||
[LSA, prologus, Notabile VII] Ex hoc autem consurgit sollempnissima et preclarissima representatio summe trinitatis et unitatis Dei. Nam, secundum hoc, tempus patrum Christi expresse representat Deum patrem ut fecundum et totaliter ordinatum ad Filium generandum. Sic enim tota lex et prophetia et totus prior Dei populus fuit a Deo virtualiter fecundatus et totaliter ordinatus ad Christum prefigurandum et promittendum et parturiendum.
|
||
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 11 (VIIa visio)] Formam autem tangit tam quoad eius splendorem quam quoad partium eius dispo-sitionem et dimensionem, unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et sub igne et ab igne caloratur et ignis speciem sumit, non autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar speculi polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gra-tiosa. Iaspis vero est coloris viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide incorporata et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter representans et omnium virtu-tum temperie virens. Est etiam perspicua et transparens non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim lune humilitatem celestium mentium desi-gnat. |
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 18.21 (VIIa visio)] Postquam autem dixit quod materia muri erat ex iaspide, dicit (Ap 21, 18): “Ipsa vero civitas”, scilicet erat “aurum mundum simile vitro mundo”. Et infra, postquam egit de materia portarum, subdit (Ap 21, 21): “Et platea civitatis”, scilicet erat, “aurum mundum, tamquam vitrum perlucidum”. Et forte secundum litteram primum dixit de domibus ex quibus constabat civitas, ultimum vero de toto fundo seu planitie intra muros contenta. Per utrumque autem designatur generalis ecclesia et principaliter contemplativorum, sicut per muros militia martirum et pugilum seu defensorum interioris ecclesie, que est per unitatem concordie “civitas”, id est civium unitas, et per fulgorem divine caritatis et sapientie aurea, et per puram confessionem veritatis propria peccata clare et humiliter confitentis et nichil falso simulantis est “similis vitro mundo” […] Inferiores etiam mi[ni]sterialiter iuvabuntur per intermediam gloriam superiorum, quasi per specula clara et quasi per vitrum perspicuum et quasi per portas intrent in clariorem et altiorem actum visionis et fruitionis Dei. Qualiter autem hoc sit et esse possit declaravi plenius in lectura super librum angelice hierarchie prefate. |
|
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 1-2 (VIIa visio)] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum. […]
|
||
Par. XIII, 52-72, 79-81Ciò che non more e ciò che può morire
|
||
Par. XXXIII, 22-27Or questi, che da l’infima lacuna
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12-13 (VIIa visio)] Sciendum igitur quod, licet per apostolos et per alios sanctos secundi status generalis ecclesie intraverit multitudo populorum ad Christum tamquam per portas civitatis Dei, nichilominus magis appropriate competit hoc principalibus doctoribus tertii generalis status, per quos omnis Israel et iterum totus orbis intrabit ad Christum. Sicut enim apostolis magis competit esse cum Christo fundamenta totius ecclesie et fidei christiane, sic istis plus competet esse portas apertas et apertores seu explicatores sapientie christiane. Nam, sicut arbor dum est in sola radice non potest sic tota omnibus explicari seu explicite monstrari sicut quando est in ramis et foliis ac floribus et fructibus consumata, sic arbor seu fabrica ecclesie et divine providentie ac sapientie in eius partibus diversimode refulgentis et participate non sic potuit nec debuit ab initio explicari sicut in sua consumatione poterit et debebit. Et ideo sicut ab initio mundi usque ad Christum crevit successive illuminatio populi Dei et explicatio ordinis et processus totius veteris testamenti et providentie Dei in fabricatione et gu-bernatione ipsius, sic est et de illuminationibus et explicationibus christiane sapientie in statu novi testamenti.
Purg. XXVIII, 112-114
e l’altra terra, secondo ch’è degna
per sé e per suo ciel, concepe e figlia
di diverse virtù diverse legna.
[LSA, prologus, Notabile VII (segue)] Secunda ratio est ex parte diversarum perfectionum seu diversorum graduum eiusdem perfectionis in Christi ecclesia distincte et ordinate introducendorum. Sicut enim multi sunt gradus perfectionum inter infimum et supremum, sic decuit quod ecclesia ab infimo ad supremum ascenderet per gradus intermedios tamquam per preambulas dispositiones precurrentes ultimam formam. Et ideo ut finis ecclesie concordaret fini sinagoge seu prioris seculi, in cuius sexta etate Christus tamquam finis prioris seculi venit, elegit Deus sextum tempus ecclesie ad suam formam et vitam in ipso perfectius exprimendam. […]
Secundum argumentum est quia populus gentilis sic fuit per idolatriam cecatus et moribus rudis et incompositus quod mox cum ad Christi fidem intravit non fuit sufficienter aptus et dispositus ad perfectam intelligentiam fidei et ad perfectam imitationem vite Christi, et ideo per diversa curricula temporum debuit magis ac magis illuminari ad intelligentiam fidei, et per diversa exemplaria statuum et sanctorum ducum debuit successive sublevari ad perfectam vitam Christi.
I.5 Il muro tetragono (Tab. 12)
La città è cinta in quadrato da un grande e alto muro con dodici porte. Nella descrizione della formale disposizione delle parti si comincia dal muro per poi passare alle porte e alle fondamenta, cioè si procede dall’ultimo al medio e da questo al primo (Ap 21, 12). Più avanti, trattando della materia, si procede invece dal muro alle fondamenta e alle porte, quasi venendo dagli estremi al mezzo (Ap 21, 18-21); in entrambi i casi si parte dal muro come da ciò che all’osservatore si presenta per primo.
Nell’edificare una città prima si trova il luogo e si scavano i fossati, poi si gettano le fondamenta e si edificano le mura, infine si innalzano le porte e si costruiscono le case. Queste tre fasi corrispondono ai tre stati generali del mondo. In primo luogo venne infatti eletto il popolo di Israele per preparare in esso questa nobile città. Con l’avvento di Cristo, fondamento, porta e portinaio, muro e baluardo, furono eletti gli apostoli quali fondamenta e dopo di essi i Gentili perché passassero nella fede il muro. Gli apostoli furono pure porte, per le quali i fedeli entrarono nella fede e nella Chiesa di Cristo. Al momento della conversione finale di Israele e di tutto il mondo verranno nuovamente innalzate dodici porte, assimilabili ai dodici apostoli, per le quali entri l’universo popolo dei fedeli. Tuttavia in qualsivoglia periodo della storia umana le parti della città possono essere adattate misticamente, né è da sorprendersi, perché come cose diverse possono essere designate in modo unitario, così quel che è uno può essere significato in modo molteplice.
Il muro della città è detto “grande e alto” intendendo la lunghezza e larghezza, ovvero l’intero suo circuito. Esso designa i martiri e i ‘pugilatori’ campioni della fede. Come infatti il muro si oppone agli esterni e difende e nasconde ciò che è dentro, così i santi martiri e i dottori zelanti si opposero all’assalto dei nemici in difesa della fede e della Chiesa. Il muro è di pietra, e ciò designa la solida virtù dei santi; la pietra è il diaspro, e ciò designa il verde della viva fede per la quale hanno zelato, patito e che li ha resi forti.
La santa ideale città, fatta di mura che sono martiri difensori della fede, di porte che sono popoli che entrano e vengono incorporati in Cristo, di pietre che sono virtù, si adatta nel “poema sacro” alle più diverse situazioni: l’uno al molteplice, secondo quanto sostenuto da Olivi.
Il castello degli “spiriti magni” di Inf. IV è in parte definito, ai versi 106-108, anche dai temi della Gerusalemme celeste. È “nobile” come la città, ha “alte mura” dalle quali è “cerchiato”, ed è “difeso intorno d’un bel fiumicello”.
Difendere è precipuo tema dei ventiquattro seniori i quali, ad Ap 4, 4 (nella parte proemiale della seconda visione), circondano la sede divina come principi, dodici da sinistra e dodici da destra, ordinati come muro e come famuli alla difesa della Chiesa (designano la “plenitudo gentium” e la conversione finale delle Genti e di Israele). Con il panno della sede e dei seniori è tessuta la parte principale dell’ordito degli “spiriti magni”.
Il “bel fiumicello” certamente rappresenta un ostacolo che si frappone all’ingresso nel castello; non può però essere inteso in senso negativo, come ad esempio da Iacopo Alighieri (le “mondane e viziose delettazioni”), in quanto positivamente (è “bel”) difende il castello avverso gli estranei (assumerebbe altrimenti due significati opposti). È probabile che intervenga in qualche modo il tema del fiume che apre il capitolo XXII, il quale scorre in mezzo alla Gerusalemme celeste ed è solido come cristallo, per la luce e la sapienza divina in esso incorporata. In questo senso, il “bel fiumicello”, che circonda e difende il “nobile castello” degli “spiriti magni” che non conobbero Cristo, è preparazione del “lume in forma di rivera” che Dante vedrà nell’Empireo (Par. XXX, 61-63). Il nobile castello è anch’esso, come la città celeste, illuminato, ma solo per metà (da “un foco / ch’emisperio di tenebre vincia” o “la lumera” di Inf. IV, 68-69, 103).
L’espressione “Questo passammo come terra dura” (Inf. IV, 109) è da riferire alla Giudea, che venne separata dal mare e resa abitabile affinché potesse rendere erbe verdeggianti e alberi fruttuosi e vi si potesse in quiete adorare Dio, ma che fu resa dura dalla pertinacia dei Giudei (Ap 8, 7). Nel Limbo, come dice Virgilio a Sordello, sono, coi pargoli innocenti, coloro che non conobbero le tre virtù teologali ma conobbero e seguirono senza vizio tutte le altre (Purg. VII, 31-36). A costoro, non battezzati, non bastano mercedi, “e s’e’ furon dinanzi al cristianesmo, / non adorar debitamente a Dio” (Inf. IV, 37-38). Se nel “bel fiumicello” è in nuce il fiume folgorante di luce dell’Empireo, l’essersi fatto “terra dura” significa che esso è secco senza la luce di Cristo, come la Giudea, fattasi da giardino selva, si è inaridita (altrove la Giudea è figura dell’Italia).
Il ‘passare’ da parte dei sei poeti non indica soltanto un generico attraversare ma, come spesso accade nel poema, un patire [1]. Lo stesso viaggio di Dante è “alto passo” al quale il poeta sente la sua virtù inadeguata (Inf. II, 10-12). I poeti ‘entrano’ per sette porte (prefigurazione dei sette stati della Chiesa) e giungono “in prato di fresca verdura”, il “verde smalto” (Inf. IV, 110-111, 118) che riprende il motivo del verde contenuto nella pietra del diaspro (motivo trattato simmetricamente ad Ap 4, 3 e 21, 11).
L’ingresso nella fede è avvenuto attraverso le porte di Cristo e degli apostoli; avverrà ancora attraverso i dottori del sesto stato della Chiesa: “Sicut enim apostolis magis competit esse cum Christo fundamenta totius ecclesie et fidei christiane, sic istis plus competet esse portas apertas et apertores seu explicatores sapientie christiane” (Ap 21, 21). Questo tipo di ingresso vale per Dante, che ha ripetuto nel sesto stato il battesimo, sacramento speculare al primo stato di fondazione della Chiesa: “e in sul fonte / del mio battesmo prenderò ’l cappello; / però che ne la fede, che fa conte / l’anime a Dio, quivi intra’ io, e poi / Pietro per lei sì mi girò la fronte” (Par. XXV, 8-12). Il rinnovato battesimo reca le vestigia della “signatio” sulla fronte, che avviene in apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3).
Ma la fede, come la Chiesa, ha un suo sviluppo secondo i periodi della storia (status). Ciascun dono dello Spirito può essere distinto in sette parti. Il terzo dono, la “tuba magistralis”, espone la fede secondo sette parti (prologo, Notabile III). La prima parte, volta a seminare la fede, corrisponde al sacramento del battesimo: si ricordino, a Inf. IV, 36, le parole di Virgilio sul battesimo “ch’è parte de la fede che tu credi” (dove tutti i codici, salvo il Cortonese nell’edizione dell’antica vulgata del Petrocchi, recano “parte” e non “porta”, come reca invece lo stesso editore). “Parte” è da intendere come ‘prerogativa’, ‘qualità’, propria dei singoli sette doni dello Spirito increato, uno semplicissimo ma ‘partito’ nella storia della Chiesa divisa secondo sette stati.
Il travaglio di Ulisse e dei suoi compagni, che è un entrare e un patire, è racchiuso nel verso “poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo” (Inf. XXVI, 132). L’“alto muro” della città celeste sta ad indicare i santi martiri, i dottori e gli atleti che si opposero ai nemici in difesa della fede e per essa patirono. Ma l’ingresso nel muro della città celeste, e quindi “ne l’alto passo”, è entrata che il greco ha anticipato, prima che vi passassero gli infedeli entrando nella fede, in Cristo e negli apostoli, fondamento e porta della nobile città; prima del sesto stato della Chiesa allorché tutto l’universo si sarebbe ancora convertito. L’Altissimo non ha costruito l’edificio della Chiesa in un solo tempo, né fin dall’inizio l’albero dallo stretto stipite o tronco si è espanso nei rami, nelle foglie, nei frutti.
Si è detto che l’edificio santo fu costruito per gradi: prima i fossati, poi le fondamenta, quindi le mura, infine porte e case. Gli Ebrei prepararono la costruzione; con il primo avvento di Cristo i Gentili passarono nella fede il muro, per le porte degli apostoli. La fiamma che nell’ottava bolgia “martira” Ulisse e Diomede “si move … per la gola / del fosso” (Inf. XXVI, 40-41), e dentro ad essa “si geme / l’agguato del caval che fé la porta / onde uscì de’ Romani il gentil seme” (vv. 58-60; da notare che nell’esegesi scritturale il popolo gentile ‘entra’ per la porta, mentre nei versi ‘esce’ a causa della frode del cavallo, che pure preparò l’entrata in Cristo). Lucciola che percorre il fossato della città di Dio: tale fu la parte nella costruzione del santo edificio, con la corrispondente illuminazione, concessa a Ulisse, che però, andando verso il futuro, volle precorrere i tempi, prima di Enea, dei Romani, del primo avvento di Cristo e del suo secondo avvento nel sesto stato della Chiesa [2].
Parodia della struttura formale della Gerusalemme celeste, la città di Dite si presenta al poeta nella sequenza ternaria: prima “l’alte fosse”, poi “le mura”, quindi “l’intrata”, ovvero le “porte” alle quali la barchetta di Flegiàs perviene “non sanza prima far grande aggirata”, cioè dopo aver costeggiato il circuito grande delle mura (Inf. VIII, 76-83; da notare l’espressione “venimmo in parte”, simile al ‘venire alle parti’ di cui è formata la città). I diavoli chiudono a Virgilio le porte e gli negano “le dolenti case” (vv. 115-123). Il maestro è adirato, ma rassicura il discepolo che vincerà la prova nonostante dentro le mura ci si dia da fare per difendersi. L’espressione “qual ch’a la difension dentro s’aggiri” fa intervenire il passo sulla difesa, simmetrico a quello relativo al grande e alto muro della città da Ap 21, 12, tratto da Ap 4, 4 e appropriato ai seniori che circondano, difensori e famuli, il trono di Dio.
I motivi proseguono nel canto seguente. Virgilio assicura di essere già entrato “dentr’ a quel muro” in virtù degli scongiuri di “Eritón cruda” (Inf. IX, 22-27). La palude Stigia “cinge dintorno la città dolente” (vv. 31-32): il cingere la città rientra nell’esegesi di Ap 20, 8, allorché Gog e Magog, l’ultima delle tribolazioni, cingono d’assedio l’accampamento dei santi e la città diletta, la quale, secondo Agostino (De civitate Dei, XX, 11), non si trova in un solo luogo ma è diffusa in tutto il mondo e fra tutte le genti.
Infine, entrati nella città di Dite grazie all’arrivo del messo celeste, i due poeti passano (il ‘passare’, come ad Inf. IV, 109, contiene in sé il motivo del patire) tra le alte mura (“li alti spaldi”) e i “martìri” degli eresiarchi (Inf. IX, 133; X, 1-2). Nel testo di esegesi scritturale le alte mura sono i màrtiri e i dottori che difendono la città e la fede; nei versi ci sono gli “alti spaldi” e i “martìri”, cioè i tormenti degli eretici seppelliti nelle arche roventi. Ma il tema del difendere rimane in Farinata, che difese la sua città “a viso aperto” (Inf. X, 93).
Fossati a difesa delle mura, come quelli che cingono i castelli, sono recati ad esempio dei fossi di Malebolge, il cui “fondo” (che corrisponde ai “fundamenta” della città) è distinto in dieci bolge (Inf. XVIII, 1-18; il “pozzo assai largo e profondo” deriva dall’esegesi della quinta tromba, ad Ap 9, 1-2). Le parole “cingon li castelli” derivano da Ap 20, 8, dove la città diletta e i “castra sanctorum” sono stretti dai nemici e chiusi nelle angustie della tribolazione.
Il tema del muro si ripropone nel fondo dell’inferno, dove Anteo ha posato i due poeti: “e io mirava ancora a l’alto muro”, cioè alla scarpata che corre lungo la parete esterna del pozzo (Inf. XXXII, 16-18).
Nella terza bolgia, dei simoniaci, il poeta vede “per le coste e per lo fondo / piena la pietra livida di fóri” (“fodiuntur fossata”), simili ai luoghi deputati a fonti battesimali “nel mio bel San Giovanni” (Inf. XIX, 13-18). Dal Notabile XIII del prologo si deduce che il battesimo è sacramento proprio dello stato di ‘fondazione’ della Chiesa. Oltre a essere “foracchiato”, il “fondo” della bolgia è “arto”, cioè angusto (vv. 40-42): l’aggettivo, come pure il “venire” sul quarto argine, deriva sempre dall’esegesi agostiniana di Ap 20, 8, riferita alle angustie della città diletta: “ibique a suis inimicis cingetur, id est in angustias tribulationis artabitur et concludetur”.
Ad Ap 20, 8 si dice che la città, oltre che sposa diletta, è “unice recollecta” («“civitas”, id est civium unitas») e dotata di castrense forza. Così nel compianto sulla condizione dell’Italia, dove “l’un l’altro si rode / di quei ch’un muro e una fossa serra” (Purg. VI, 83-84).
Il passaggio nel fuoco descritto a Purg. XXVII è anch’esso percorso dalla tematica dell’entrare, del muro, e anche del fossato: l’angelo invita a entrare nel fuoco (v. 11: “intrate in esso”), Dante si mostra renitente e si sente “qual è colui che ne la fossa è messo” (v. 15), Virgilio gli ricorda che il fuoco è “muro” fra lui e Beatrice (vv. 35-36). L’episodio, che contiene altri temi della settima visione (il riferimento ai mille anni da Ap 20, 2 e tutti i motivi tratti dall’apertura del libro della vita da Ap 20, 12), è esempio di metamorfosi psicologica di un tema materiale. Il fossato si pone quale elemento della città estremo rispetto alla porta, sottolineando la massima alienazione dell’animo del poeta dall’effettuare il passaggio.
Nella rosa celeste le donne Ebree formano una sorta di muro che divide i beati dell’Antico e del Nuovo Testamento secondo la fede in Cristo venturo o in Cristo venuto (Par. XXXII, 16-21).
Una porta senza muro è quella dell’inferno. Ad Ap 21, 12 si cita Giovanni 10, 9 per indicare che Cristo è porta: “Ego sum ostium. Per me, si quis introierit, salvabitur et ingredietur et egredietur et pascua inveniet”. Con “per me” iniziano i primi tre versi che riportano le oscure parole scritte al sommo della porta infernale.
[1] È da ricordare che alla “schiera” dei poeti sono appropriati temi dalla “signatio” nell’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3), ai quali non è estraneo il patire.
[2] Cfr. Ulisse perduto. Un viaggio nel futuro (PDF), cap. 5.
Tab. 12
Inf. IV, 106-111Venimmo al piè d’un nobile castello,
|
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7 (IIIa visio, Ia tuba)] Per “terram” autem significatur hic Iudea, quia sicut terra habitabilis fuit segregata a mari et discooperta aquis, ut posset homo habitare in ea et ut ipsa ad usum hominis posset fructificare et herbas et arbores fructiferas ferre, sic Deus mare infidelium nationum et gentium separaverat a terra et plebe Iudeorum, ut quiete colerent Deum et facerent fructum bonorum operum, et ut essent ibi simplices in bono virentes ut herbe, et perfecti essent ut arbores grandes [et] solide et fructuose. […] “Grando” significat duritiam et pertinaciam Iudeorum, que ad predica-tionem Christi et apostolorum fuit fortius congelata et indurata, sicut ad Moysi verba et signa Pharao fortius induravit cor suum.
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] Deinde subdit de dispositione partium eius: “Et habebat murum” et cetera (Ap 21, 12). Ubi nota quod in describendo formalem dispositionem partium, incipit ab ultimo per medium ad primum, id est a muro per eius portas ad fundamentum; ubi vero agit de materia, incipit a muro ac deinde agit de fundamento et postmodum de portis, tamquam ab extremis veniens ad medium (cfr. Ap 21, 18-21); utrobique autem incipit a muro, tamquam ab eo quod intrantibus vel extra aspicientibus occurrit primo. Deinde vero agit de tota interiori civitate.
|
|
Inf. VII, 100-102; VIII, 76-83, 115-123; IX, 25-27, 31-32
|
Inf. XII, 1-3, 52-55
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] Nota etiam quod ad hedificandam urbem primo invenitur locus et fodiuntur fossata, secundo ibi ponuntur fundamenta et hedificantur muri, tertio statuuntur porte et hedificantur domus. Primum autem horum pertinet ad primum statum, qui fuit ante Christum humanatum; secundum vero ad secundum, tertium autem ad tertium. Primo enim electus est populus Israel, ut fieret in eo preparatio huius nobilis civitatis. Secundo in adventu Domini electi sunt duodecim apostoli, ut essent in fundamentis civitatis, et post ipsos filii in fide de populo gentili, ut transirent in muros civitatis. Cum autem venerit tempus conversionis Israel et iterum totius orbis, tunc statuentur duodecim porte duodecim apostolis similes, per quas universus populus fidelis intret civitatem. Attamen in quolibet statu possunt omnes partes civitatis mistice adaptari, nec mirum, quia sicut diversa possunt significari per idem, sic unum et idem potest per plura significari. Nam Christus est fundamentum secundum Apostolum, Ia ad Corinthios III° (1 Cor 3, 10-11); et porta seu hostium et etiam hostiarius, prout dicitur Iohannis X° (Jo 10, 3.9); et murus et antemurale, prout dicitur Isaie XXVI° (Is 26, 1). Apostoli etiam fuerunt fundamenta ecclesie, prout dicitur ad Ephesios II° (Eph 2, 20); fuerunt etiam porte per quas infideles intraverunt ad fidem et ecclesiam Christi. Sed ad presens sufficit predictum modum tamquam principaliorem breviter exponere. |
|
Inf. IV, 34-36; Par. XXV, 8-11; XXXII, 16-21ch’ei non peccaro; e s’elli hanno mercedi,
|
[LSA, prologus, Notabile III] Quarta ratio est quia quodlibet predictorum septem donorum potest subdistingui in septem partes sive proprietates, ita quod prima a proprietate correspondet primo statui et secunda secundo et sic de aliis, ut sic sint septies septem. […] De tertio (dono) etiam patet. Nam magistralis tuba seu expositio intendit fidei et eius scientie seminande (I), et deinde radicande seu roborande (II), deinde explicande (III), deinde amplexande (IV), deinde contemperande, unicuique scilicet secundum suam proportionem (V); intendit etiam finaliter eam imprimere et sigillare (VI) et tandem glorificare seu glorificatam exhibere (VII). Et patet correspondentia primi ad primum statum et secundi ad secundum et sic de aliis.[LSA, prologus, Notabile XIII] Quia primus status fundationis ecclesie conformatur baptismali rege-nerationi.
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12-13 (VIIa visio]] In scripturis tamen sepe angulus sumitur pro fortitudine et ornatu, quia in angulis domorum, in quibus parietes coniunguntur, est fortitudo domus. Unde Christus dicitur esse factus in caput anguli et lapis angularis […]
|
|
I.6 “Luce intellettüal, piena d’amore” (Par. XXX, 40-42; Tab. 13)
■ Due sono le principali perfezioni di Dio, sommo bene e somma luce, alle quali le altre possono essere ricondotte: amore (“amor superoptimus”) e sapienza (“sapientia summe lucens”). Gli angeli, i seniori e i quattro esseri viventi, che ad Ap 7, 11-12 rendono lode a Colui che siede sul trono, attestano queste due perfezioni dicendo “benedictio” in quanto sommo bene e “claritas” in quanto somma luce.
■ Cristo, in quanto uomo, insegna e muove con la voce esteriore. In quanto Verbo ed espressione della sapienza del Padre (“verbalis sapientia Patris”), gli è proprio il parlare interiore attraverso la pura luce intellettuale (“interna locutio que fit per lucem simplicis intelligentie”) [Ap 2, 7]. La sapienza di Cristo è piena d’amore (“Christi sapientia plena igne caritatis”) [Ap 15, 2, dove viene designata con il “mare”].
■ Lo Spirito Santo (si tratta non di un’entità a sé, ma dello Spirito di Cristo) insegna e muove interiormente attraverso il gusto e il sentimento d’amore (“interna locutio que fit per amoris gustum et sensum”) [Ap 2, 7; il passo è rilevante nel rapporto tra Virgilio e Beatrice]
-
Nel terzo stato generale del mondo lo Spirito Santo si mostra come fiamma e fornace dell’amore divino (“exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris”), con gli effetti che esso comporta: ebbrezza (“ut cellarium spiritualis ebrietatis”), profumi (“ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum”), tripudio (“ut tripudium spiritualium iubilationum et iocunditatum”). Per questi effetti sarà posssibile vedere la verità, cioè la sapienza del Verbo incarnato e la potenza di Dio Padre, non solo con la luce della semplice intelligenza, ma anche con l’esperienza del gusto e del sentimento (“per que non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris”). [Ap 3, 7]
-
Il terzo stato generale, appropriato allo Spirito Santo, comprende il sesto e il settimo stato della Chiesa. Nell’ultimo periodo della storia umana, il settimo, la mente separata dalle operazioni inferiori riposa in Dio e gioconda gusta in questo mondo il dolce e soave della pace e della letizia che supera ogni sentimento (“me et meam dulcedinem et bonitatem iocunde gustando et comedendo ac bibendo et incorporando” [Ap 3, 20: settima vittoria]; “in quo mens separata et requiescens in Deo gustat ipsius ineffabilem suavitatem et pacem que exsuperat omnem sensum” [Ap 8, 1: settimo sigillo]; “tempus utique septimi angeli, cui benedicet Dominus dans in eo pacem et letitiam sustinentibus se” [Ap 10, 5-7: settima tromba]).
Il primo verso della terzina, interconnessa per anadiplosi, riguarda Cristo, verbale sapienza del Padre ripiena del fuoco d’amore. Inizia con il Verbo e si conclude con lo Spirito Santo.
Il secondo verso inizia con lo Spirito Santo, primo amore del “vero bene”, cioè della somma sapienza (il Figlio) e della divina potestà (il Padre). Si conclude con la “letizia” della quale lo Spirito è pieno, uno degli effetti della fiamma d’amore.
Il terzo verso esprime il gusto della visione intellettuale, che si manifesta nella “letizia che trascende ogne dolzore”.
Questi versi, nei quali Bruno Nardi scorse il “lumen gloriae” della teologia [1], sono la messa in poesia di quanto affermato da Olivi sulla visione di Dio, possibile in questo mondo non solo per mezzo della luce intellettuale del Verbo, ma anche tramite il gusto d’amore indotto dallo Spirito Santo. Parole che generarono sospetto in Giovanni XXII, nel corso di una procedura (1317-1319) che portò nel 1326 alla condanna per eresia della Lectura super Apocalipsim [2].
Il papa ‘caorsino’, che negava la possibilità che i beati, compresa Maria, potessero vedere l’essenza divina fino al giudizio universale, poneva ai suoi teologi la domanda se davvero, come scritto dal frate ad Ap 3, 7, nel sesto e nel settimo stato della Chiesa si potesse pervenire a una “gustativa et palpativa experientia” della verità per suggerimento interiore dello Spirito. Che è proprio ciò a cui arriva Dante. Nel suo “trasumanar” ascendendo al cielo egli ‘gusta’ interiormente guardando Beatrice fissa nel sole, figura dei dottori fissi per vita e contemplazione nella solare luce di Cristo (Par. I, 64-69). È “esperienza” che la grazia riserva anche ad altri (vv. 71-72). È “palpativa experientia” perché Dante mantiene il suo corpo: “S’i’ era sol di me quel che creasti / novellamente, amor che ’l ciel governi, / tu ’l sai, che col tuo lume mi levasti” (vv. 73-75), quasi non fosse in carne. La “gustativa et palpativa experientia” trascorre di bene in meglio a “viste” sempre più “superbe” nella loro arditezza. Dell’acqua del fiume luminoso dell’Empireo – quella che appaga “la sete natural che mai non sazia / se non con l’acqua onde la femminetta / samaritana domandò la grazia” (Purg. XXI, 1-3) – “bevve la gronda / de le palpebre mie” (Par. XXX, 88-89), afferma il poeta ormai al termine del viaggio [3]. Che si tratti dei “fontes aquarum”, dolci e desiderabili, ai quali Cristo conduce (Ap 7, 17), o dell’acqua della vita, alla quale Cristo liberalmente invita e fa venire con desiderio e volontario consenso (Ap 22, 17), è sempre un termine raggiungibile, almeno in parte, in questa vita. Così è stato per san Bernardo: “tal era io mirando la vivace / carità di colui che ’n questo mondo, / contemplando, gustò di quella pace” (Par. XXXI, 109-111; la pace è uno degli elementi del gustare il divino nel settimo stato della Chiesa: cfr. Ap 8, 1; 10, 5, 7). Il ‘doctor marianus’ – che potrebbe anche fregiarsi dell’appellativo di ‘doctor spiritualis’ o ‘anagogicus’ per il ruolo di ultima guida di Dante nella trionfante Gerusalemme celeste che non è visibile per la Chiesa militante – ha riassunto in sé, nonostante sia vissuto prima di questi due periodi, le prerogative del sesto e del settimo stato della Chiesa: “in sexto eminet fructus caritatis, in septimo vero esus seu gustus felicitatis. […] In septimo pregustatores glorie” (prologo, notabile I).
Tutti gli elementi del gusto proprio dell’età dello Spirito, così come delineati dall’esegesi di Olivi, si ritrovano nei canti che descrivono l’Empireo (con l’unica eccezione della suavitas, semanticamente legata alle voces; cfr. Par. XVI, 32; Ap 11, 19):
gustus |
XXXI, 111 (gustò)XXXII, 122 (gusto), 123 (gusta) |
pax |
XXX, 102 (pace)XXXI, 16, 111XXXIII, 8 |
ebrietas |
XXX, 67 (inebrïate) |
letitia |
XXX, 41, 42 (letizia)XXXI, 62, 134 |
iocunditas |
XXXI, 112 (giocondo), 133 (giochi)XXXII, 103 (gioco) |
dulcedo |
XXX, 26 (dolce)XXXII, 101XXXIII, 63 |
suavitas |
—— |
aromata |
XXX, 67 (odori), 126 (odor) |
unctiones |
XXXII, 4 (unse) |
■ La terzina può anche essere letta in altro modo, confrontando i tre versi con l’esegesi dei quattro lati della Gerusalemme celeste, di uguale misura nella lunghezza, larghezza e altezza (Ap 2, 16; cfr. infra). La lunghezza, cioè la visione di Dio sommo bene (“luce intellettüal”) è pari alla larghezza, cioè al giocondo, gaudioso e dilatato amore (“piena d’amore; / amor di vero ben, pien di letizia”). L’altezza consiste nella trascendenza che apprende e gusta la visione di Dio (“in altum superexcessum apprehensionis et degustationis sublimis maiestatis Dei” – “letizia che trascende ogne dolzore”).
[1] B. NARDI, Studi di filosofia dantesca, Firenze 19672, pp. 167-214.
[2] Cfr. A. FORNI – P. VIAN, Un codice curiale nella storia della condanna della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi: il Parigino latino 713, in “Collectanea Franciscana”, 81 (2011), pp. 479-558; 82 (2012), pp. 563-677.
[3] Nelle Derivationes di UGUCCIONE da PISA, “palpo -as”, («a palim quod est motus») indica l’anelare, cioè un movimento dell’anima («anelare sicut qui animam trahit»). Di qui “palpebra -e, idest sinus oculorum, quia palpebre semper moventur” [Edizione critica princeps a cura di E. Cecchini …., II, Firenze 2004 (Edizione nazionale dei testi mediolatini II, Serie I, 6, P 7 (11-13), p. 890].
Tab. 13
[LSA, cap. VII, Ap 7, 11-12 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Vel potest dici quod quia in Deo sunt due principales perfectiones ad quas cetere reducuntur, tamquam generales ad suas specificas aut tamquam ipsarum duarum efficaciam vel efficientiam vel precellentiam exprimentes, ille autem due sunt amor superoptimus et sapientia summe lucens, ideo primo attrib[uunt] ei generaliter rationem summi boni ab omnibus benedicibilis, cum dicunt “benedictio”; secundo generalem rationem summe lucis, cum dicunt “et claritas”; tertio specificam rationem huius secundi, cum dicunt “et sapientia” […] |
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 7 (Ia visio, Ia ecclesia)] Item Christo, in quantum est Verbum et verbalis sapientia Patris, appropriatur interna locutio que fit per lucem simplicis intelligentie. Illa vero que fit per amoris gustum et sensum appropriatur Spiritui Sancto. Prima autem se habet ad istam sicut materialis dispositio ad ultimam formam.[LSA, cap. XV, Ap 15, 2 (Va visio, radix)] “Et vidi tamquam mare”. […] Item per hoc mare principalius designatur immensa Christi sapientia plena igne caritatis et zelatricis iustitie, et amara et immensa passio Christi igne caritatis plena et exsequens vitia nostra et ad viscera Christi contemplanda mediatrix et pervia quasi vitrum. |
Par. XXX, 40-42luce intellettüal, piena d’amore;
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 7 (Ia visio, VIa ecclesia)] Sicut etiam in primo tempore exhibuit se Deus Pater ut terribilem et metuendum, unde tunc claruit eius timor, sic in secundo exhibuit se Deus Filius ut magistrum et reseratorem et ut Verbum expressivum sapientie sui Patris, sic in tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum et ut tripudium spiritualium iubilationum et iocunditatum, per que non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris. Christus enim promisit quod “cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem” et “ille me clarificabit” et cetera (Jo 16, 13-14). |
|
[LSA, cap. X, Ap 10, 5-7 (IIIa visio, VIa tuba)] Sumendo vero tubicinium septimi angeli respectu pacis que erit in ecclesia post mortem Antichristi, tunc est sensus quod tempus afflictionis et laboris sex priorum statuum, quasi sex dierum quibus laborare et operari oportet, cessabit in sabbato et requie septimi status, tuncque “consumabitur misterium” per prophetas [pre]nuntiatum quantum in hac vita consumari debet. Et sic exponit hoc Ioachim, subdens quod post tempus sex apertionum huius sexte etatis manet «tempus, ut ait angelus Danieli, quale non fuit ex eo tempore quo ceperunt homines esse in terra (cfr. Dn 12, 1), tempus utique septimi angeli, cui benedicet Dominus dans in eo pacem et letitiam sustinentibus se».
|
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 1 (apertio VIIi sigilli)] […] factus est a[s]census ad exta[tice] contemplationis excessum, in quo silent omnes cogitationes et operationes inferiores et in quo mens separata et requiescens in Deo gustat ipsius ineffabilem suavitatem et pacem que exsuperat omnem sensum.[LSA, cap. III, Ap 3, 20 (Ia visio, VIIa ecclesia] “Si quis audierit”, id est cordaliter seu obedienter receperit, “vocem meam”, scilicet monitionum mearum predictarum, “et aperuerit michi ianuam”, id est viscerales consensus et affectus cordis sui, “intrabo ad illum”, scilicet per influxus et illapsus gratie, “et cenabo cum illo”, scilicet acceptando et amative michi incorporando ipsum et omnia bona eius tamquam cibos michi amabiles et suaves, “et ipse mecum”, scilicet me et meam dulcedinem et bonitatem iocunde gustando et comedendo ac bibendo et incorporando.
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 16 (VIIa visio)] “Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum. “Longitudo eius tanta est quanta et latitudo”, id est quattuor latera eius sunt equalia. Nam duo sunt longitudo eius et alia duo sunt eius latitudo. Civitas enim beatorum quantum de Deo et bonis eius videt tantum amat, et ideo quantum est in visione longa tantum est in caritate lata; quantum etiam est in longitudinem eternitatis immortaliter prolongata, tantum est iocunditate glorie dilatata.
|
|
in Deo sunt due principales perfectiones ad quas cetere reducuntur [7, 11-12] |
|
sapientia summe lucenssumma lux |
amor superoptimussummum bonum |
Christus (Verbum) |
|
Christo, in quantum est Verbum et verbalis sapientia Patris, appropriatur interna locutio que fit per lucem simplicis intelligentie. [2, 7] |
per hoc mare principalius designatur immensa Christi sapientia plena igne caritatis [15, 2] |
Spiritus Sanctus |
|
Illa (locutio) vero que fit per amoris gustum et sensum appropriatur Spiritui Sancto. Prima autem se habet ad istam sicut materialis dispositio ad ultimam formam. [2, 7] |
sic in tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et un-guentorum et ut tripudium spiritualium iubi-lationum et iocunditatum, per que non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris. [3, 7] |
gustus, gustativa et palpativa experientia (VII stato: 3, 20; 8, 1; 10, 5-7) |
|
letitiapax que exuperat omnem sensumdulcedoiocunditassuavitas |
|
I.7 “Roma e l’ardüa sua opra” (Tab. 14)
I versi di Par. XXXI, 37-39, con la triplice antitesi – “ïo, che al divino da l’umano, / a l’etterno dal tempo era venuto, / e di Fiorenza in popol giusto e sano” -, conducono ad altra opera dell’Olivi, la prima quaestio de domina (de consensu virginali pro Annuntiatione). Ivi il francescano spiega su un piano psicologico il passaggio della Vergine dallo stato precedente la maternità al nuovo stato incominciato con l’assenso dato alla divina concezione. Come nel venire a un alto stato religioso, o nell’ascendere al culmine della contemplazione dalla vita attiva, o nel passare all’altra vita da questo secolo, un fedele prova un’ardua trascendenza, un estraniarsi e un’inusitata novità che pervadono di stupore ogni sentimento, e per questo si sente come morire al suo stato precedente, tanto più Maria, nell’ora dell’assenso, provò quasi un ineffabile morire al suo stato precedente passando a uno stato sovramondano e a una regione inusitata, nella quale doveva venire assorbita in modo radicale e irrevocabile dagli eccelsi abissi degli arcani divini. Di tutti i sentimenti provati dalla Vergine e fatti propri dal poeta, che perviene a ricrearsi “nel tempio del suo voto riguardando”, solo il morire non è espresso in modo esplicito. Anche lo straniarsi è reso col vagheggiare Arcade da parte della madre Elice, entrambi mutati da Giunone e trasformati nel superiore stato di costellazioni (le due Orse).
La quaestio viene comunque incastonata nelle maglie del commento apocalittico con il quale, per la compresenza tematica, è possibile una collazione. Trattando della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione, all’obiezione che una città che misura 12.000 stadi non possa essere contenuta entro mura di 144.000 cubiti, Olivi replica principalmente che questi numeri non debbono essere intesi in senso letterale ma mistico. Un altro argomento è che nelle visioni è possibile vedere prima una cosa e poi un’altra che nella realtà non può stare insieme alla prima, come accade nella visione delle quattro ruote di Ezechiele. Inoltre nelle visioni appaiono molte cose mostruose e inconsuete che si mescolano con quelle consuete, e ciò serve a elevare il contemplante o il lettore in uno stato di stupore (Ap 21, 17).
Il tema del levarsi in stupore è appunto cantato dal poeta nell’Empireo, allorché definisce la propria meraviglia – un cambiamento di stato assimilabile a quello provato dell’Annunziata – di gran lunga superiore a quanto sentito dai barbari, provenienti da settentrione, “veggendo Roma e l’ardüa sua opra … quando Laterano / a le cose mortali andò di sopra” (Par. XXXI, 31-42). Si può notare il tema della ruota (da Ap 21, 17) nel girare insieme di Elice e del figlio Arcade (il riferimento alle ruote della visione di Ezechiele conduce al penultimo verso della Commedia, al volgere “sì come rota ch’igualmente è mossa” il desiderio e la volontà del poeta da parte de “l’amor che move il sole e l’altre stelle”). L’elevarsi del poeta è simmetrico all’andare sopra alle cose mortali da parte del Laterano. Di questo, che letteralmente designa la sede che fu prima degli imperatori e poi dei papi, non può non colpire la concordanza con i “latera” della città celeste. “Laterano”, oltre a indicare genericamente la magnificenza di Roma imperiale e cristiana, può alludere, nel suo ‘andar di sopra’ alle cose mortali, alla conversione dell’impero al cristianesimo. Se poi “Laterano” allude ai quattro lati di una città in somma concordia e che vive nella povertà evangelica (come è la Gerusalemme santa e pacifica), non è escluso che il suo andare sopra le cose mortali sia anche accenno a un vivere del papato non ancora corrotto dall’avidità dei beni temporali (cfr. le parole di san Pietro, a Par. XXVII, 40-45, sul papato del tempo dei martiri: “Non fu la sposa di Cristo allevata / del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, / per essere ad acquisto d’oro usata; / ma per acquisto d’esto viver lieto / e Sisto e Pïo e Calisto e Urbano / sparser lo sangue dopo molto fleto”). Nel poema il nome compare solo un’altra volta, nella “guerra presso a Laterano” condotta da Bonifacio VIII, “lo principe d’i novi Farisei”, contro i cristiani (Inf. XXVII, 85-90). “Laterano”, in questo senso, avrebbe un valore simile a quello della “cerchia antica” dentro la quale Firenze “si stava in pace, sobria e pudica” (Par. XV, 97-99).
Ancora, ad Ap 4, 2, passo da collazionare con Ap 21, 17, il tema dell’elevarsi dello spirito a visioni sempre più ardue si accompagna a quello delle grandi opere recate da Cristo nella fabbrica della Chiesa (“Roma e l’ardüa sua opra”).
Si noterà come questi temi, provenienti dall’esegesi della Gerusalemme celeste, oggetto della settima visione, si ritrovino nei versi variamente appropriati. A cominciare da Purg. IX, 70-72, dove il poeta avvisa il lettore di non meravigliarsi se, con l’elevarsi della materia trattata, egli rafforza lo stile con più arte. Da menzionare, nella medesima cantica, Purg. XV, 10-15 (lo stupore per l’inusitato splendore dell’angelo e il levare le mani per farsi il “solecchio”) e Purg. XXVI, 67-69 (lo stupore del montanaro “quando rozzo e salvatico s’inurba”). Poi un altro appello al lettore circa la meraviglia e lo stupore nel vedere il grifone (la doppia fiera) raggiare negli occhi di Beatrice, “or con altri, or con altri reggimenti” (Purg. XXXI, 121-127): come nelle visioni si possono vedere cose che nella realtà non possono stare insieme, così il grifone-Cristo trasmuta negli occhi della donna le due nature (come possano stare unite verrà rivelato al poeta soltanto alla fine del viaggio). Similmente nell’incontro con san Bernardo: “Uno intendëa, e altro mi rispuose” (Par. XXXI, 58-60). Ancora, questi temi si rinvengono nei versi che precedono la prima mostruosa trasformazione dei ladri, in cui il poeta si rivolge al lettore ribadendo il proprio stupore per quanto vide una volta “levate … le ciglia” (Inf. XXV, 46-49). Oppure nell’appello al lettore a rivolgere con lui la vista “a l’alte rote” (Par. X, 7-9), o nell’incontro con Adamo (Par. XXVI, 85-90).
Tab. 14
PETRUS IOANNIS OLIVI O. F. M., Quaestiones quatuor de domina, ed. D. Pacetti, Quaracchi, Florentiae, 1954 (Bibliotheca Franciscana Ascetica Medii Aevi, VIII), p.8 (Quaestio I): «Videmus quod tanta est vis mutationis status inferioris in superiorem, quod, cum quis est in procinctu et actu ascendendi ad unam altam religionem, aut de statu activae ad contemplationis culmen et statum, aut de hoc saeculo ad aliud, quod homo sentit sibi imminere quamdam mortem, per quam moritur toti statui et vitae priori. Sentit etiam homo quamdam transcendentem arduitatem et quasi extraneitatem seu inusitatam novitatem omnes sensus personae obstupefacientem, ita quod ex hoc aliquando in corpore sequitur magna horripilatio et obrigescentia. Sed plus distat prior status Virginis a sequenti statu suae maternitatis, quam status minimi fidelis et boni differt a statu suo priori. Ergo in hora assensus sui ad illum statum sensit se transire per quamdam ineffabilem mortem sui, quoad suum statum priorem, ad statum omnino supermundanum et ad regionem seu mansionem inusitatissimam, ad quaedam scilicet Dei abyssalia et arcana et superalta, in quibus et a quibus erat funditus et irrevocabiliter absorbenda”. |
|
[Lectura super Apocalipsim, Ap 21, 17; VIIa visio] Si obicias quod civitas habens duodecim milia stadia non potest contineri infra muros centum quadraginta quattuor cubitorum, ad hoc est triplex responsio. […] Tertia est quod in visionibus propter diversa misteria potest una vice videri unum et alia vice aliud, quod secundum rem non potest simul esse cum primo, sicut super Ezechielem de quattuor rotis Ezechielis secun-dum unam opinionem ostendi.
|
Par. XXXI, 31-42Se i barbari, venendo da tal plaga
|
[Ap 21, 17; VIIa visio] Si obicias quod civitas habens duodecim milia stadia non potest contineri infra muros centum quadraginta quattuor cubitorum, ad hoc est triplex responsio. […] Tertia est quod in visionibus propter diversa misteria potest una vice videri unum et alia vice aliud, quod secundum rem non potest simul esse cum primo, sicut super Ezechielem de quattuor rotis Ezechielis secundum unam opinionem ostendi. […] Unde patet quod in visionibus multa monstruosa vel inusitata cum usitatis miscentur, prout expedit misteriis et sublevationi contemplantium vel legentium in stuporem, et ut ex hoc magis pateat ea que monstrantur potius esse mistica quam litteralia. |
|
Purg. XXXI, 121-128Come in lo specchio il sol, non altrimenti
|
Par. XXXI, 58-60Uno intendëa, e altro mi rispuose:
|