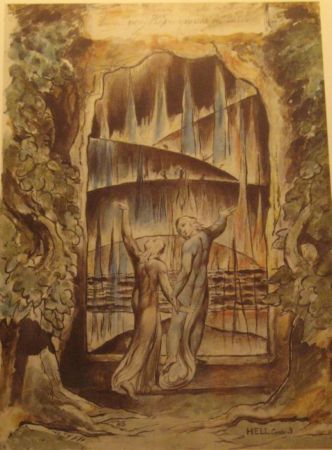Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 365, ff. 89v. – 90r.
Il comune patrimonio moderno cristiano ed europeo, il cui organo per tanto tempo era stato il latino, cominciava allora a rivelarsi come un’unità in una nuova scissione nazionale. Ma quel patrimonio comune aveva, come sua essenza più intima e sua proprietà più cara e più peculiare, la storia umanissima dell’incarnazione e della passione di Cristo; e questa storia era attorniata da tante altre storie, che la annunciavano prefigurandola o la confermavano imitandola.
ERICH AUERBACH [1]
Questa lettura dell’incontro di Dante con il conte Ugolino deve essere considerata come un libro di storia. Essa è dedicata alla memoria di quegli studiosi del Medioevo, in parte conosciuti in parte letti e ammirati, che affrontarono Dante con senso storico: da Raffaello Morghen a Raoul Manselli, da Arsenio Frugoni a Gustavo Vinay, da Girolamo Arnaldi a Ovidio Capitani. Grazie a un confronto documentale stringente e inoppugnabile, essa consente di entrare nella fucina dove venne forgiata la Commedia e di rivivere, quasi leggendo in un diario, le idee presenti alla mente dell’autore nel suo intento, finora sconosciuto, di creare un linguaggio destinato ai predicatori di una riforma della Chiesa che non fu fatta. Restituire storicamente un Dante tutto ‘medievale’, libero da successive e secolari incrostazioni, è forte e nuovo. Bisogna richiedere infatti al lettore, come invitava Benedetto Croce, “che anzitutto si renda familiari le linee fondamentali dell’edifizio medievale e viva dentro questa figurazione, grandiosamente conclusa in sé ma a noi per ogni verso estranea” [2]. La fatica, per il moderno lettore che apprenderà “quel che non può avere inteso”, sarà compensata nel constatare concretamente come, nel “poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra”, il saeculum humanum rivendicò l’autonomia nell’uso del volgare, nella definizione del regime politico, nell’ambito della natura e della ragione, nella valorizzazione degli autori classici. Tutte realtà, proprie del “viver bene” dell’“omo in terra”, che non sono però isolate, ma partecipi della storia sacra dei disegni provvidenziali. Con i segni di questa storia sono vestiti pure gli odi politici e i conflitti intestini alle città della “serva Italia”, anch’essi ‘sacri’ in modo dissonante.
■ La Commedia presta poeticamente “e piedi e mano” a un’esegesi, quella contenuta nella Lectura super Apocalipsim del francescano provenzale Pietro di Giovanni Olivi, imperniata su Cristo, centro dei tempi come aveva inteso Bonaventura [3]. Ciò significa diffondere la storia di Cristo, della sua vita, passione e resurrezione, sull’universo umano. Le sue prerogative possono essere appropriate a chiunque, in conformità o in difformità. Se, come scriveva Auerbach, “le passioni personali, che prima non erano state altro che istinti, ottengono considerazione e dignità” [4], ciò è perché il patire partecipa, in modo retto o distorto, del patire di Cristo. Non solo però del Cristo storico, ma anche dei suoi discepoli spirituali nel secondo avvento, già operante al 1300, nel quale lo Spirito di Cristo muove in terra quanti vi si conformano.
Dante si sentì investito di una missione, attraverso la poesia, di predicazione e di conversione universale. Nuovo Giovanni esiliato e visionario autore di una nuova Apocalisse, nel narrare la sua vera visione fu profeta perché diede alle particolari vicende e personaggi di questo mondo valore universale. Il poeta sale la montagna del purgatorio con segnate sulla fronte le sette “P”, che sono “piaghe”, come l’angelo del sesto sigillo, che Olivi identifica con Francesco, sale da Oriente: «“habentem signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi» (Ap 7, 2). Così l’esegesi, nella Lectura super Apocalipsim integralmente concentrata su Francesco e il suo Ordine, viene variamente diffusa su più soggetti secondo quella che Gianfranco Contini chiamava “mondanità discretiva” [5].
Fu profeta ‘laico’, nel senso che rese sacro il “viver bene” dell’“omo in terra”, con le sue nuove esigenze – lingua, ragione, regime politico, autori classici – e le sue passioni. Il realismo dantesco fa sì che “l’altro mondo è reso sensibile e leggibile con le forme del nostro mondo” [6] ma, armonizzando “e cielo e terra”, nel “poema sacro” le forme del nostro mondo sono inserite in un processo storico che manifesta i segni della volontà divina. Questa storia universale della salvezza è contenuta nella Lectura super Apocalipsim dell’Olivi.
Le norme che regolano il rapporto intertestuale fra Commedia e Lectura sono state più volte indicate nel corso di questa ricerca: rispondenze semantiche in rose di parole-chiave entro spazi testuali ristretti, con accostamenti non banali o scontati; parole-chiave, riferibili alla medesima pagina esegetica, che si riscontrano in più punti del poema; collazione di più passi della Lectura (il cui testo si può scomporre e riaggregare sulla base di elementi settenari), secondo un procedimento analogico tipico delle distinctiones ad uso dei predicatori; elaborazione di una struttura semantica interna al poema, “topograficamente” articolata secondo i sette stati della storia della Chiesa, cioè secondo le categorie in base alle quali Olivi espone l’Apocalisse.
È stato anche sempre sottolineato che l’adesione non significa acquiescenza. Dante aggiorna l’Olivi appropriando i concetti teologici presenti nella Lectura all’Impero, alla filosofia aristotelica e all’umanesimo virgiliano, ad argomenti che, come rilevava Bruno Nardi, riempiono di sé tutta la Commedia [7].
Poema polisemico, secondo quanto l’autore afferma nell’Epistola a Cangrande (Ep. XIII, 20), la Commedia è un universo di segni. Il senso letterale contiene parole che sono chiavi di accesso a un altro testo, la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi. Si tratta di un procedimento di arte della memoria: le parole-chiave operano sul lettore come imagines agentes sollecitandolo verso un’opera di ampia dottrina già da lui conosciuta, ma che rilegge mentalmente parafrasata in volgare, profondamente aggiornata secondo gli intenti propri del poeta, in versi che le prestano “e piedi e mano” e la dotano di exempla contemporanei e noti. Nel senso letterale del “poema sacro”, riservato a tutti, sono incardinati gli altri sensi interpretativi: allegorico, morale, anagogico (che Dante, nell’Epistola a Cangrande, definisce collettivamente “mistici” o “allegorici”). Dante mirava non solo a un pubblico di laici, ma anche di predicatori e riformatori della Chiesa. Questo pubblico di chierici non si formò, perché gli Spirituali (non un gruppo organizzato, ma di sensibilità comune), che dovevano conoscere la Lectura oliviana, furono perseguitati e il loro libro-vessillo, censurato nel 1318-1319 e condannato nel 1326, fu votato alla clandestinità e quasi alla sparizione [8]. Ma la Commedia e la Lectura, testualmente tanto unite, furono anche gli ultimi testimoni, nel Medioevo cristiano, dell’inserimento dell’individuo nell’ordine universale secondo i giudizi di Dio, di una storia della salvezza collettiva, prima che l’individuo restasse solo.
Come gli altri luoghi del “poema sacro”, anche l’episodio del conte Ugolino è percorso dai temi della Lectura super Apocalipsim. Tramite la loro metamorfosi, una particolare vicenda del microcosmo toscano si fa macrocosmo, quasi fosse pianta di ogni odio, bestialità, impazienza, impetramento nel cuore.
■ Ugolino è una figura dell’Antico Testamento, quando nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. L’orribile torre nella quale fu incarcerato coi quattro fanciulli, della quale venne chiavato l’uscio, fu come il sepolcro di Cristo sulla cui porta era posta una pietra grande e pesante. Così il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso alla sua intelligenza spirituale. Se la voce degli antichi profeti riuscì a penetrarvi per qualche spiraglio, anch’essa chiuse la porta con figure e promesse terrene e oppresse il senso carnale dei Giudei piuttosto che elevarlo (Ap 4, 2). Così il profetico sogno del conte, nel quale immaginò la caccia al lupo e ai lupicini sul Monte Pisano da parte dei suoi nemici, fu segno della fine corporale; il poco raggio di sole messosi nel “breve pertugio” della Muda, la torre dei Gualandi dove gli uccelli si mutavano le penne, non lo illuminò verso la resurrezione che, come quella di Cristo, gli avrebbe reso la libertà spirituale. Da quel pertugio Ugolino scorse solo la luna fredda e mondana – designa la scorza che nella legge del Vecchio Testamento chiudeva il senso spirituale -; essa gli scandì il tempo, le sue involute mutazioni gli recarono l’ingannevole “mal sonno”.
I motivi del chiudere e della durezza segnano la descrizione del fondo dell’inferno, “loco onde parlare è duro”, che necessita di rime “aspre e chiocce”. La prima tromba (terza visione apocalittica) risuona sulla cruda durezza della Giudea, terra congelata come il cuore di Faraone (Ap 8, 7). Il conte Ugolino e l’arcivescovo Ruggieri sono “due ghiacciati in una buca” (Inf. XXXII, 125), in mezzo alla “gelata” di Cocito (Inf. XXXIII, 91). Nel doloroso carcere il padre non piange e non lacrima – “sì dentro impetrai” – mentre piangono i figli (vv. 49-50). Prorompe nell’esclamazione “ahi dura terra, perché non t’apristi?” (v. 66). La sua fu “morte … cruda”, come crudele fu la morte di Cristo (v. 20); l’uscio dell’orribile torre viene ‘chiavato’ come fu chiuso il monumento di Cristo (vv. 46-47; con chiaro riferimento ai chiodi della croce). Da questa lapidea durezza e chiusura Ugolino, da vivo, non si è mai liberato.
■ Da morto, Ugolino è segnato dalla bestialità. I suoi atteggiamenti rinviano ad Ap 16, 10-11, all’esegesi della sede della bestia su cui viene versata la quinta coppa, nel periodo più tenebroso e corrotto della storia della Chiesa, che la poesia travasa sullo stato umano. I temi relativi – l’odio, corrodere la fama altrui, mangiare coi denti, vivere bestiale, il dolore del cuore, l’impazienza, la disperazione, l’accecamento – sono altrettanti fili del panno di cui è vestito. Coi denti rode il misero teschio dell’arcivescovo Ruggieri, come Tideo “si rose / le tempie a Menalippo per disdegno”, ed è un roderne la fama: “Ma se le mie parole esser dien seme / che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo” (Inf. XXXII, 127-132; XXXIII, 7-8). “Per sì bestial segno” mostra odio su colui che si mangia, ma ha anche il cuore oppresso da disperato dolore (Inf. XXXII, 133-134; XXXIII, 4-6). Mostra impazienza di fronte all’impassibilità senza pianto del poeta, che considera crudele (XXXIII, 40-42). Non solo si mangia il suo nemico, “come ’l pan per fame si manduca”, ma si morde per il dolore ambo le mani tanto che i figli pensano che lo faccia “per voglia di manicar”, lì dove le mani sostituiscono nella poesia il mordersi la lingua della prosa scritturale – “et commanducaverunt linguas suas pre dolore”; mordersi che è anche rimorso carico d’ira (Inf. XXXII, 127; XXXIII, 58-60). Brancola cieco sopra i figli morti (XXXIII, 72-73). Dopo il racconto, “con li occhi torti / riprese ’l teschio misero co’ denti” in modo ancor più ostinato di prima (vv. 76-77), variazione sul «“Et non egerunt penitentiam ex operibus suis”, scilicet malis, immo, supple, amplius obstinati sunt in illis peragendis» da Ap 16, 11. I denti, “che furo a l’osso, come d’un can, forti” (v. 78): nell’esegesi di Ap 22, 15 i cani sono i detrattori della vita altrui, come i malvagi su cui viene versata la quinta coppa.
Rodere la fama del suo nemico è lo scopo del “fiero pasto” dato al conte per pena eterna. Punizione che, come scrisse Benedetto Croce, è
sanguinante protesta dell’umanità offesa contro la vendetta e il castigo che trapassano i confini dell’umanità stessa. Ugolino, quali che fossero le sue colpe e i suoi delitti, è pur uomo, e i suoi carnefici disconobbero e calpestarono questa qualità di lui; ed ora egli sorge a buon diritto giudice dei giudici, punitore dei punitori, carnefice dei carnefici, e, in questo orrore sull’orrore, il torto suo scema o entra nell’ombra, la sua ragione risplende, perché egli, ferocemente, ferinamente, pur vendica l’umanità [9].
Le sette teste della bestia che sale dal mare (Ap 13, 1) differiscono, secondo Gioacchino da Fiore, dalle teste del drago come le chiese metropolitane, che sono capo alle altre – “capita capitum” -, si distinguono dai propri vescovi. Le teste del drago, “primus motor”, sono cioè teste che stanno sopra altre teste loro sottoposte, e queste teste bestiali che sovrastano le altre sono gli arcivescovi preposti alle chiese metropolitane. Atteggiamento impersonato nei versi dalla posizione sovrapposta del conte Ugolino, vero arcivescovo laico, nel rodere coi denti l’arcivescovo Ruggieri, “sì che l’un capo a l’altro era cappello” (Inf. XXXII, 126), posizione rovesciata rispetto all’esegesi poiché è l’arcivescovo a star sotto, ma che mostra ugualmente, “per sì bestial segno”, due bestie una delle quali soggiace e l’altra soggioga.
■ I sette periodi (status), cioè le categorie che organizzano per settenari l’esegesi apocalittica oliviana, non sono solo periodi storici relativi alla Chiesa nel suo complesso, la quale come un individuo cresce e si sviluppa attraverso essi fino alla maturità, ma anche modi di essere della persona, habitus.
All’opposto della vita devota e del pasto eucaristico, propri degli alti contemplativi del quarto stato, sta l’apertura del quarto sigillo, nella seconda visione apocalittica. I motivi proposti dall’esegesi del quarto cavallo “pallido” – il pallore, la macerazione del corpo, l’aridità, il languore, la fame, la fiacchezza, il marcire pestilenziale, il colore della morte, la compagnia bestiale (Ap 6, 8) – sono puntualmente presenti in vari luoghi del poema e in particolare nelle zone in cui prevale la tematica del quarto stato, appropriato storicamente agli anacoreti dall’alta vita ma troppo ardua a mantenersi, e per questo volta in ipocrisia e falsità per poi essere distrutta dai Saraceni nei luoghi (in Oriente e in Africa settentrionale) dove più fiorì. Il quarto cavallo pallido viene interpretato da Gioacchino da Fiore come la bestia saracena, diversa dalle altre. Ad essa è dato il potere “sulle quattro parti della terra”, che esercita tramite la spada, la fame, la morte e le bestie. Questi quattro strumenti alla lettera significano i vari modi di debellare i nemici, uccisi in battaglia campale, o per fame negli assedi di città che poi, abbandonate dagli uomini, diventano deserti devastati da bestie selvagge. La “spada” designa pure il terrore che questa bestia, occupatrice di molte terre, incute penetrando nell’intimo del cuore e della carne con la paura che deriva dalla sua forza militare; la “fame” denota l’assenza del verbo ristoratore di Cristo; la “morte” indica la mortifera legge di Maometto; le “bestie” la compagnia delle genti bestiali.
Con i motivi propri del cavallo pallido è tessuta la macerata e affamata lupa, simbolo della cupidigia universale, “la bestia” che “dopo ’l pasto ha più fame che pria” (Inf. I, 88, 94, 99). Di essi partecipa, nella sua parodia eucaristica, anche il conte Ugolino, affamato di vendetta sul suo nemico: “e come ’l pan per fame si manduca … O tu che mostri per sì bestial segno … La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator, forbendola a’ capelli / del capo ch’elli avea di retro guasto. …. Breve pertugio dentro da la Muda, / la qual per me ha ’l titol de la fame … In picciol corso mi parieno stanchi / lo padre e ’ figli …” (Inf. XXXII, 127, 133; XXXIII, 1-3, 22-23, 34-35).
■ Come all’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono a parlare “dal voler portate” verso un momento di mutazione e quasi di conversione, sebbene limitata al successivo colloquio (Inf. V, 82-87), così il conte Ugolino “la bocca sollevò dal fiero pasto” per parlare di “come la morte mia fu cruda”. Anch’egli, in vita uomo di pietra del Vecchio Testamento oppresso da un profetico sonno, nell’eterna pena datagli “per sì bestial segno” partecipa da morto del Nuovo, della palingenesi del novum saeculum operante per mezzo del “poema sacro”. La bocca che solleva apre l’uscio chiavato dell’“orribile torre”, assimilato alla pesante pietra rimossa dal sepolcro per la resurrezione di Cristo (Ap 4, 1-2), per cui, per quanto tardivamente, gli si apre l’intelligenza spirituale della Scrittura. Ugolino, la “statua dell’odio, … è tornato uomo”, scrisse De Sanctis [10]. Sostiene Olivi che ogni stato o periodo storico, e in sé anche ogni individuo, partecipa in qualche modo di quello che è lo stato cristiforme per eccellenza, il sesto, coincidente con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Far parlare liberamente, per dettato interiore – la principale prerogativa del sesto stato – è tema che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo, anche nella vecchia roccia infernale. Parlare liberamente di Cristo appartiene alla sesta chiesa; ad essa è dato l’“ostium apertum”, che è “ostium sermonis”, la porta aperta alla favella, il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà, come scrive san Paolo ai Colossesi (Col 4, 3): “Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo”. Os (bocca) è affine a ostium (porta). Il conte Ugolino “la bocca sollevò”, aprendo la porta alla parola che narra della propria passione, proprio nel luogo dove l’intelligenza spirituale dovrebbe essere chiusa. Ma tutto l’Inferno è un contrappunto fra la durezza del giudizio, le bestemmie dei peccatori e l’apertura al ricordo della vita per la parola dirompente, finché essa dura, la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi per poi ricadere, come Ciacco, sollevarsi da atti bestiali per ritornare ad essi dopo aver parlato, come il conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per sé stesse mosse, sta un solo desiderio, di vivere ancora nel libro che è stato altrui aperto.
Se “nelle ghiacciate profondità dell’ultimo Inferno lo strumento retorico più adatto al poeta si rivela essere la parodia” [11], questa investe tragicamente, per dissonanza, la figura di Cristo. La passione del conte fu senza resurrezione se non per le note della poesia; i capelli con i quali si forbisce la bocca sono quelli purgativi di Cristo sommo pastore (Ap 1, 14), degradati dal “fiero pasto” eucaristico sul capo guastato dell’arcivescovo Ruggieri.
■ Nella settima visione, la Gerusalemme celeste si mostra a Giovanni prima in modo inferiore e poi in modo più alto (Ap 21, 2). Secondo Gioacchino da Fiore, la prima descrizione è riferita alla Chiesa peregrinante in terra, la seconda alla Chiesa regnante nei cieli dopo il giudizio. Così Giovanni può vedere da solo nel primo caso, mentre nel secondo necessita dell’aiuto di un angelo. Molte sono le cose della Chiesa presente che i discepoli della verità possono non solo leggere e comprendere, ma anche vedere e ascoltare; ma la Gerusalemme celeste non può essere veduta con gli occhi né si trova espressa nelle Scritture. Per essa si rende necessario un dottore spirituale che tragga i discepoli che hanno raggiunto la perfezione all’intelletto anagogico, in modo che da quel che è noto della città peregrinante in terra vengano rapiti alla visione spirituale della città che regna nei cieli. Il monte sul quale viene levato Giovanni (Ap 21, 10) è pertanto l’intelletto anagogico, grande e alto perché apprende cose grandi e sublimi, come il senso letterale apprende ciò che è transitorio e terreno e l’allegoria lo stato della Chiesa peregrinante che opera in un certo modo tra cielo e terra.
Al termine del viaggio, Dante si ritrova nella Roma celeste come un pellegrino nel tempio del suo voto (Par. XXXI, 43-44). È san Bernardo a trarlo, dal suo peregrinare, al senso anagogico e a fargli levare gli occhi “quasi di valle andando a monte” cosicché veda la regina del cielo, perché “quest’ esser giocondo / … non ti sarà noto, / tenendo li occhi pur qua giù al fondo” (vv. 112-123). Il tema del dottore che mostra cose che non possono essere vedute, ascoltate, o che non si trovano scritte, sta pure nelle parole del conte Ugolino, del quale Dante conosce già la storia ma non può avere inteso come fosse stata cruda la sua morte (Inf. XXXIII, 19-21). All’estremo opposto, in Cocito e nell’Empireo, Ugolino e Bernardo svolgono in forma diversa la funzione di “doctor anagogicus”, il quale trae il lettore dalla verità storica, propria del senso letterale, al sovrasenso di quella poetica.
■ Scorrendo i versi di Inferno XXXIII, zona ‘topograficamente’ dedicata al secondo stato, ai martiri che sostennero e sostengono le tentazioni, il lettore spirituale avrebbe ritrovato, parodiati e torti all’esigenza, alcuni temi ad esso relativi.
Al vescovo della seconda chiesa d’Asia, Smirne (Ap 2, 8), Cristo dice che l’esempio della sua morte e la speranza della vita che per essa si è meritata e il suo potere debbono animare ai martìri; in essi non si deve diffidare ma anzi sperare di conseguire la vita eterna. All’opposto sta Ugolino nei confronti dell’arcivescovo che rode: “Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri, / fidandomi di lui, io fossi preso / e poscia morto, dir non è mestieri” (Inf. XXXIII, 16-18). Come, in altre zone ‘topograficamente’ dedicate al secondo stato, Francesca e Paolo leggevano di Lancillotto “sanza alcun sospetto”, e Guido da Montefeltro si fidò di Bonifacio VIII, così il conte Ugolino nei confronti dell’arcivescovo Ruggieri, “traditore dal traditore tradito”, secondo quanto scrive nella Cronica Giovanni Villani.
Per questo il conte è “vicino” all’uomo di chiesa, suo concittadino e traditore (Inf. XXXIII, 15). Uccidere parenti e “vicini” è tema relativo all’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 4), esegesi che incide profondamente sulle parole di Francesca, il cui marito uccise lei e il proprio fratello. Al termine del canto, frate Alberigo racconta del genovese Branca Doria, che lasciò un diavolo in sua vece nel corpo, ancora vivo su in terra, insieme ad “un suo prossimano”, cioè ad un suo parente che l’aiutò nel tradimento verso il suocero Michele Zanche (vv. 142-147).
Ugolino vuole che Dante oda “come la morte mia fu cruda” (Inf. XXXIII, 20-21). Essere vinto dai propri uccisori con una morte crudelissima corrisponde (Ap 5, 1) all’angustia la quale, fra le caratteristiche della passione di Cristo giudicate secondo il senso umano, rende chiuso il secondo sigillo, alla cui apertura il festoso canto dei martiri mostra invece come nella croce di Cristo sia consolazione e gloria piuttosto che angustia e tribolazione, secondo quanto scritto da san Paolo ai Romani (Rm 5, 3) e ai Corinzi (2 Cor 1, 3-5). La stessa seconda chiesa, Smirne, viene interpretata come “cantico” (Ap 2, 11): i quattro figli del conte Ugolino (storicamente due figli e due nipoti), innocenti e posti “a tal croce” dai Pisani, sono nominati nel “canto” (v. 90).
La seconda vittoria (delle sette proposte alle chiese d’Asia nella prima visione) consiste nel vittorioso conflitto con il mondo e le sue tentazioni, e corrisponde alla lotta dei martiri contro l’idolatria pagana. Di essa si dice: “Chi avrà vinto non sarà leso dalla seconda morte” (Ap 2, 11), in quanto chi avrà sostenuto vittoriosamente i mortali dardi delle tentazioni e delle mortificazioni sarà degno di non essere leso dalla morte eterna. La “prima morte”, quella per cui si estingue la vita naturale, percuote i corpi; la “seconda morte” consiste invece nella tristezza del cuore, nel terrore, nella disperazione e costernazione provocati dalla persecuzione del corpo o dal suo incombere. La seconda è anche la morte indotta dalla pena eterna, che viene così chiamata perché in essa è estinto ogni diletto o riposo: ivi è dolore perpetuo peggiore della morte e che la fa continuamente desiderare (Ap 20, 6). I martiri trionfatori, sicuri del regno della vita eterna, non temono la seconda morte e non la sentono, nel senso che da essa non vengono lesi. Per questo la chiesa di Smirne, oltre che “amara” come la mirra, viene interpretata anche come “cantico”, poiché i santi esultano e si gloriano nelle passioni, secondo quanto dichiara san Paolo ai Romani: “Ci gloriamo nelle tribolazioni” (Rm 5, 3).
Nei versi – “Poi cominciò: Tu vuo’ ch’io rinovelli / disperato dolor che ’l cor mi preme” (Inf. XXXIII, 4-5) – il dolore del cuore, che porta a mordersi la lingua (le mani per Ugolino), e la disperazione sono presenti nell’esegesi della quinta coppa, appropriati alla sede della bestia (Ap 16, 10-11); altri passi, posti a confronto, intervengono ad arricchire di significati le drammatiche parole memori dell’“infandum, regina, iubes renovare dolorem” di Enea a Didone (Aen., II, 3). Per Ugolino parlare a Dante è come una nuova tentazione, dopo aver fallito nel sostenere in vita quella che lo ha condotto alla tristezza del cuore e alla disperazione della “seconda morte”, al mare di dolore amarissimo, peggiore della morte, che lo opprime. La tentazione che egli non vinse fu un amaro rinnovarsi della croce di Cristo. Come rimprovera il poeta a Pisa, “non dovei tu i figliuoi porre a tal croce” (v. 87), e in questo senso il disperato “tu vuo’ ch’io rinovelli” del conte è da accostare al doloroso “veggio rinovellar l’aceto e ’l fiele” detto da Ugo Capeto che profetizza l’attentato di Anagni (Purg. XX, 89).
Si tratta di un dolore mortifero e disperato, che non lascia spazio a sentimentalismi romantici circa l’amor paterno per i figli che il genitore è impotente a salvare, come intendeva De Sanctis. Gioacchino da Fiore, citato ad Ap 15, 1, afferma che dopo le prime quattro virtù, corrispondenti ai quattro animali che stanno intorno alla sede divina (Ap 4, 6-8) – fede, pazienza, umiltà e speranza -, succede lo zelo igneo della carità proprio dello Spirito Santo e della sua sede sostenuta dai quattro animali. Nei reprobi, invece, ai quattro vizi contrari – infedeltà, impazienza, superbia, disperazione – subentra l’odio della fraterna carità, che è peccato contro lo Spirito Santo. Nel dolore disperato è insito il desiderio di vendetta. Le parole rivolte a Dante, che sembrerebbero smentire questo senso dato al dolore – “Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli / pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava; / e se non piangi, di che pianger suoli?” (Inf. XXXIII, 40-42) – memori delle parole di Enea a Didone: “Quid talia fando … temperet a lacrimis?” (Aen. II, 6-8) – sono state interpretate come un patetico appello alla pietas dell’interlocutore [12], che però non partecipa emotivamente rimanendo impassibile, come più avanti nel cammino di Cocito si rifiuterà di aprire gli occhi di frate Alberigo velati dalle lacrime invetriate (vv. 149-150). Quel parlare, che interrompe bruscamente la narrazione, fa riferimento a un dolore carico d’odio, non diverso da quello che l’ha portato a mordersi le mani nel carcere. Sottolinea soprattutto l’impazienza corrosiva del conte ora nell’Antenora come fu nella Muda, alla stregua di quanti, al versamento della quinta coppa, non sopportano di sottoporsi a coloro che considerano pari a sé – “quoad speciem habitus videntur esse unius ordinis cum eis” (Ap 16, 10: vv. 11-12). Un pisano e un fiorentino; entrambi velenosi Toschi, come suona misticamente il nome della terra d’origine.
■ A Ugolino venne inferto un martirio. Soffrì, nel corpo, la fame. Ancor più, dovette sostenere un tormento psicologico, proprio dei tempi moderni. I martiri del sesto stato (il periodo nel quale vivono Olivi e Dante) soffrono nel dubbio, il loro è un “certamen dubitationis” che gli antichi testimoni della fede non provarono per l’evidenza dell’errore in cui incorrevano gli idolatri pagani (prologo, Notabile X). Nel sesto stato il martire non prova soltanto il tormento del corpo, viene anche sospinto a cedere dalla sottigliezza degli argomenti filosofici, dalle distorte testimonianze scritturali, dall’ipocrita simulazione di santità, dalla falsa immagine dell’autorità divina o papale, in quanto falsi pontefici insorgono, come Anna e Caifa insorsero contro Cristo. Per rendere più intenso il martirio, i carnefici stessi operano miracoli. Tutto ciò appartiene alla tribolazione del tempo dell’Anticristo, alla tentazione che induce in errore persino gli eletti, come testimoniato da Cristo nella grande pagina escatologica di Matteo 24: “dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi (cfr. Mt 24, 24)”. Scrive Gregorio Magno, commentando Giobbe 40, 12 – “stringe (nel senso di tendere) la sua coda come un cedro” -: “ora i nostri fedeli fanno miracoli nel patire perversioni, allora i seguaci di Behemot faranno miracoli anche nell’infliggerle. Pensiamo perciò quale sarà la tentazione della mente umana allorché il pio martire sottoporrà il corpo ai tormenti mentre davanti ai suoi occhi il carnefice opererà miracoli”.
Dietro al dubbio ingannatore di cui parla Olivi si cela l’eterna perdizione tramite una falsa Scrittura (Francesca e Paolo: “Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse”) o una falsa immagine di autorità pontificale (Guido da Montefeltro, che non diffidò di Bonifacio VIII), oppure un sentimento di pietà che deve vivere solo quand’è morta (Dante, e lo stesso Virgilio), o di inadeguatezza nel momento in cui non si deve negare il nome di Cristo (“colui / che fece per viltade il gran rifiuto”).
Il conte Ugolino, nel “mal sonno” che gli squarcia il velo del futuro, sogna l’arcivescovo Ruggieri “maestro e donno” nella caccia al lupo e ai lupicini, ben presto stanchi della corsa (Inf. XXXIII, 28-30). L’arcivescovo recita la stessa parte della falsa immagine dell’autorità pontificale già attribuita a Bonifacio VIII nel colloquio con Guido da Montefeltro. Come Guido nell’ascoltare il papa che lo assolve in anticipo dal dargli il consiglio fraudolento su come prendere Palestrina, così anche Ugolino si inganna nel suo “mal sonno” e si crede vinto, e viene vinto nella prova dall’impazienza e dalla disperazione. Appressandosi l’ora “che ’l cibo ne solëa essere addotto”, nel doloroso carcere tutti, padre e figli, sono assaliti dal dubbio: “e per suo sogno ciascun dubitava” (vv. 43-45). Quel sogno era segno fallace della fine che, se pure fosse arrivata per i corpi, non avrebbe condotto di per sé alla dannazione un uomo aperto a Cristo e non impetrato e accecato dall’odio e dal dolore. Al vescovo di Smirne, la chiesa dei martiri, Cristo predice la futura incarcerazione confortandolo a non diffidare della propria assistenza; gli starà sempre accanto nella tentazione, che non sarà ordinata alla sua rovina ma a provarlo e a perfezionarlo (Ap 2, 10). Nel sonno profetico il conte vede, per sé e i fanciulli, solo i segni della fine corporale.
L’arcivescovo Ruggieri, nella caccia al Monte Pisano, è vestito con i panni di Babylon, la prostituta Chiesa carnale (Ap 17, 4-5). Nel riferire al poeta come fu “cruda” la sua morte, il conte Ugolino racconta che, facendo il “mal sonno” che gli squarciò il velo del futuro, vide l’arcivescovo “maestro e donno” della caccia – come Babilonia dominatrice delle genti, crudele e maestra (“adhuc super plures bestiales [gentes] sibi subditas dominatur … Per purpuram etiam et coccinum … potest intelligi crudelitas eius … tamquam omnium regina et magistra”) -, nella quale inseguiva “il lupo e ’ lupicini … con cagne magre, studïose e conte” (la prostituta è “studiose … ornata”). Il tema della sfrontatezza della donna nominata per fama (“et de hoc habet nomen apud omnes famosum, ideo dicitur hoc habere scriptum in fronte”) appare nell’aversi messo l’arcivescovo “dinanzi da la fronte”, cioè in prima fila, la perversa Trinità ghibellina dei Gualandi, Sismondi e Lanfranchi (Inf. XXXIII, 19-20, 28-33).
Il monte, dove si svolge la caccia, impedisce ai Pisani di vedere Lucca (Inf. XXXIII, 28-30). Quella che letteralmente può sembrare un’incidentale indicazione geografica contiene in sé un preciso concetto espresso nell’esegesi apocalittica oliviana. La vista dei Pisani è limitata come nell’Antico Testamento, quando la montagna distinta in tre cime separate da valli, corrispondenti ai tre fini della storia umana (i tre avventi di Cristo: nella carne, nello Spirito e nel giudizio finale), appariva per la distanza agli Ebrei, prima della Redenzione, come un solo monte (prologo, Notabile XIII; così a Ulisse “n’apparve una montagna”; scorgere Lucca, perciò, la città che Gentucca renderà piacevole a Dante, designa una visione più alta).
■ La grande metafora mistica del racconto di Ugolino è quella del libro chiuso. Questo non è mai citato, ma gli elementi che ne fanno segno, nella semantica spirituale, percorrono l’episodio come cellule musicali. Cos’è questo libro, del quale dice Giovanni: “E vidi nella mano destra di Colui che era seduto sul trono un libro scritto dentro e fuori, sigillato con sette sigilli” (Ap 5, 1)? È il volume della Sacra Scrittura e in particolare dell’Antico Testamento, nel quale il Nuovo venne rinchiuso e sigillato e velato sotto varie figure. Contiene le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo, e le elargizioni e preparazioni che spettano alla destra, come le avversità e le cose temporali alla sinistra.
Sta nella destra di Colui che siede sul trono, perché contiene le leggi e i precetti del sommo imperatore e le sentenze e i giudizi del sommo giudice.
Nessuno, se non Cristo, può fondare o promuovere il pieno sviluppo dei sette stati che si succedono nella storia umana, caratterizzati da sigilli che chiudono, totalmente o parzialmente, le illuminazioni divine, e può dunque aprire il libro. Di qui il gemito di Giovanni che proviene dal desiderio che il libro venga aperto. Egli dice infatti: “Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo” (Ap 5, 4). Giovanni assume il tipo del salvatore di tutti i santi padri, per i quali acquista la grazia e la gloria, e impersona colui che impetra ed elargisce per quanti, non potendo accedere al libro, desiderano, gemono e sospirano con tutto il cuore, riconoscendo umilmente che solo Cristo è possente e degno al compito.
Questi pianti e sospiri si manifestano in diversi momenti della storia umana. Sono i santi padri nel limbo dell’inferno, afferma Olivi, a piangere e sospirare affinché il libro venga aperto. Il Limbo dantesco corrisponde alla sede divina prima dell’apertura da parte di Cristo del libro segnato da sette sigilli (Ap 4, 1-5, 4). Come questa apertura era desiderata e sospirata dagli antichi padri, così lo è ora, nel secondo avvento nello Spirito; come all’apertura del sesto sigillo i segnati per milizia e privilegio precedono la turba innumerevole, così la schiera dei sommi cinque poeti coopta Dante, “sesto tra cotanto senno” (Inf. IV, 102); come nel sesto stato le genti saranno convertite “in spiritu magno et alto”, così nel nobile castello albergano gli “spiriti magni”, cioè le genti giuste, antiche (prima del Cristianesimo) e ‘moderne’ (i maomettani Avicenna, Averroè e il Saladino) in un processo della Redenzione ancora aperto che guarda a una nuova età di palingenesi e di conversione universale, che nel caso di Dante si realizza tramite la poesia.
I segreti spirituali contenuti nel libro restano chiusi all’uomo animale, come imposto a Daniele nel Vecchio Testamento (Daniele 12, 4), a Giovanni, scriba dell’Apocalisse, nel Nuovo (Ap 10, 4), e come detto più volte da Cristo (Matteo 7, 6; 17, 9; Luca 8, 10). A questa chiusura accennano le parole del conte Ugolino circa la torre della Muda, nella quale lui e i quattro fanciulli furono rinchiusi fino alla morte – “e che conviene ancor ch’altrui si chiuda” (Inf. XXXIII, 22-24): la torre chiuderà ad altri, come avvenuto per lui, l’intelligenza spirituale del libro. Più avanti nel cammino di Cocito, Dante si rifiuta di aprire a frate Alberigo gli occhi incrostati di lacrime ghiacciate, perché “cortesia fu lui esser villano”, in quanto indegno di vedere la benché minima parte del libro (vv. 148-150).
Questo pianto, sostiene Olivi, è proprio dei momenti (al tempo degli apostoli, delle grandi eresie, quando la Chiesa fu in lutto, e dell’Anticristo) nei quali quanti sono inconsapevoli della ragione che permette le tribolazioni e le “pressure”, e il terrore provocato dall’imminenza dei pericoli, piangono e sospirano affinché il libro segnato da sette sigilli venga aperto, almeno per la parte che è consentito aprire in quel tempo.
Gli innocenti fanciulli rinchiusi nella Muda col conte Ugolino piangono inconsapevoli della causa di tanta tribolazione, della quale Gaddo chiede ragione al padre. «Quando fui desto innanzi la dimane, / pianger senti’ fra ’l sonno i miei figliuoli / ch’eran con meco, e dimandar del pane … Io non piangëa, sì dentro impetrai: / piangevan elli … Poscia che fummo al quarto dì venuti, / Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi, / dicendo: “Padre mio, ché non m’aiuti?”» (Inf. XXXIII, 37-39, 49-50, 67-69). La loro angoscia anela a una libertà dal mondo, in essa sta il desiderio che il libro venga aperto. Ma il padre che dovrebbe essere, come Giovanni nell’Apocalisse, mediatore di questo pianto, resta chiuso, come il libro, nella sua lapidea durezza.
■ Dopo che ha sentito inchiodare l’uscio dell’orribile torre, il conte si è rivolto ai propri figli: “ond’ io guardai / nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto” (Inf. XXXIII, 47-48). Ha di fronte la Scrittura personificata, che gli dà la possibilità di guardare sé stesso e di comprendere, come in uno specchio, le cose invisibili di Dio. Si tratta del motivo del “mare di vetro”, trasparente come cristallo, che sta davanti al trono, descritto ad Ap 4, 6: esso designa pure l’amaro e infinito patire e, per contrasto, la tolleranza del martirio, la contrizione penitenziale. La Scrittura, precetto divino, è come il collirio che provoca le lacrime e l’amara compunzione dei propri peccati per rendere infine chiara la vista (Ap 3, 18). Ma il padre, per tutto il giorno e la notte che segue, non piange né lacrima né parla, fatto di pietra nel cuore. Piangono i figli, che Ugolino guarda in viso in silenzio. Anselmuccio parla dicendogli: “Tu guardi sì, padre! che hai?” (v. 51). Il padre non comprende il senso del piangere dei figli, che nella sofferenza hanno fame e desiderio di cibo spirituale, di apertura del libro. All’alba del secondo giorno da che è stata inchiodata la porta, come un poco di raggio si mette dentro, il padre guarda ancora i figli: “e io scorsi / per quattro visi il mio aspetto stesso” (vv. 56-57). Guardare per la seconda volta nei quattro volti, che sono come i quattro Vangeli, non gli rende la vista delle cose spirituali. Incapace di sopportare le tribolazioni, nella sua impazienza si dispera: “ambo le man per lo dolor mi morsi”. Patire non è per lui motivo di rigenerazione ma di maggior odio. Mordersi le mani per il dolore è variante del versetto della quinta coppa “et commanducaverunt linguas suas pre dolore” (Ap 16, 10), nella cui esegesi i temi dell’odio, del corrodere la fama altrui, del mangiare coi denti, del vivere bestiale, del dolore del cuore, dell’impazienza, della disperazione, della cecità sono altrettanti fili con cui è tessuta la sua veste spirituale.
Il conte verserà lacrime solo da morto, nel racconto della sua fine, lì dove non è più tempo di pentimento. Così piangono i re della terra la caduta improvvisa e irreparabile della maledetta Babilonia, «“dicentes”, scilicet plangendo: “Ve, ve, ve”» (Ap 18, 10). Triplicano la dolorosa interiezione, parlano di Babilonia in terza persona e poi in seconda, al modo di coloro che prima piangono con sé stessi, poi si rivolgono alla persona compianta. È il modo di Francesca: “dirò come colui che piange e dice” (Inf. V, 126), ove si passa dalla prima alla terza persona. E di Ugolino: “parlare e lagrimar vedrai insieme” (Inf. XXXIII, 9). Il conte fu statua in vita, chiuso nella Muda; è uomo nell’Antenora, dove si apre al rimpianto e al rimorso.
■ Il rapporto tra padre e figli, fatto da una parte di impietriti sguardi senza parole, di dolore che porta a mordersi le mani, e dall’altra di pianti, di lacrime e dell’offerta delle proprie misere carni, è la chiave dell’intero episodio. È un dialogo fondato sull’incomprensione, non però come intese De Sanctis: non sono i figli a fraintendere il padre, è questi a non comprendere il valore insito nell’atteggiamento e nell’offerta dei quattro fanciulli. Egli si morde le mani per il dolore, cioè per la rabbia e l’odio che l’acceca; essi accennano a un convivio nel quale venga divorata la carne mortale e misera e resti quello che è spirituale, alla liberazione dal carcere di questa misera vita verso l’eterna patria. Il tema del mangiare la carne compare nella Lectura nell’esegesi di Ap 19, 17-18, dove un angelo, che rappresenta gli alti contemplativi la cui mente è tutta fissa nella solare luce di Cristo e delle sacre scritture (secondo Gioacchino da Fiore si tratta di Elia), fissa gli occhi al sole invitando allo spirituale e serotino convivio dove verrà divorata la carne soggetta a corruzione in modo che resti ciò che è spirituale. L’invito alla spirituale e trionfale divorazione significa l’incorporare in Cristo e nella sua Chiesa i popoli e i re, al modo con cui negli Atti degli Apostoli viene detto a Pietro di uccidere e di mangiare quadrupedi, serpenti e volatili visti in un gran vaso (Ac 10, 9-16). I santi saranno ristorati dal gaudio, dall’amore e dalla dolcezza per la conversione dei Gentili e dei Giudei che avrà luogo, su questa terra e in una Chiesa ancora militante, dopo la morte dell’Anticristo.
Di Pietro e del suo gustare si ricorderà Dante nell’ascesa al cielo. L’angelo che sta fisso nel sole di Ap 19, 17 sarà Beatrice, la quale terrà fissi gli occhi al sole, seguita dal poeta come un raggio riflesso segue quello diretto. Il “trasumanar” verrà reso con l’immagine ovidiana del pescatore Glauco, il quale, gustando un’erba che resuscitava i pesci da lui presi, si tramutò in Dio (Par. I, 67-72; Ovidio, Metam., XIII, 898-968). Glauco, pescatore come Pietro al quale viene detto di mangiare cose apparentemente immonde, in realtà designanti l’incorporazione delle genti infedeli, e Dante hanno preso parte al convivio spirituale, dove si divora ciò che è mortale, in occasione della conversione finale delle genti e di Israele.
La carne divorata nel convivio serotino allestito alla fine dei tempi è quella destinata a morire, e dunque misera. Questa vita, “que est quasi continua mors”, viene definita misera ad Ap 20, 5: da essa risorgono le anime glorificate, sicure dalla “seconda morte”. E l’angelo che ha la faccia come il sole giura ad Ap 10, 5-7 la certezza della fine dei tempi, per consolare gli eletti perseguitati e vessati dalle miserie, i quali desiderano uscire dal carcere di questa vita e sospirano la patria eterna. L’annunzio della caduta di Babilonia, che tanto ha angustiato lo spirito degli eletti, viene da questi considerata ad Ap 14, 8 come l’uscita dal carcere in volo verso la libertà. Miseria, ad Ap 3, 17, sta all’opposto della beatitudine.
Così i quattro innocenti figli di Ugolino trasformano la sofferenza corporale patita nella Muda in un desiderio di liberazione dal carcere della vita verso l’eterno. Posti “a tal croce”, essi sono configurati al Cristo uomo, all’Agnello sacrificato. Come Cristo, mediatore e avvocato, offre gli uomini al Padre che glieli ha dati (Giovanni 17, 6.11, citato ad Ap 8, 3), così essi offrono la propria umanità al padre: “Erano tuoi e li hai dati a me. Padre santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato” – «Tui erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi … e disser: “Padre, assai ci fia men doglia / se tu mangi di noi: tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia”» (Inf. XXXIII, 61-63).
È un’offerta, quella delle misere carni vestite dal padre, che si avvicina ad altra rinuncia alla vita, quella di Catone, il quale in nome della libertà morale lasciò in Utica “la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara”. A questa rinuncia è assimilabile il viaggio di Dante e Virgilio, che hanno fuggita “la pregione etterna”, e il secondo poeta dice del primo a Catone: “libertà va cercando, ch’è sì cara” (Purg. I, 71). Libertà da una nuova Babilonia, storicamente operante; libertà dalla propria Babilonia, la meretrice interiore, fino al compiuto libero arbitrio.
Si comprende perché Dante, pur consapevole che i quattro fanciulli non fossero tutti adolescenti e suoi figli, li faccia chiamare da Ugolino “mie’ figliuoi” e ne certifichi l’“età novella”. Certo, come vuole il Bosco, “per conseguire una maggiore espressività e persuasività” [13]. La tragedia, e l’invettiva che chiede vendetta su Pisa, assumono maggiore intensità poiché i figli che offrono sé stessi al padre realizzano il nuovo sacrificio in terra del Figlio dell’uomo; essi sono martiri, come il “giovinetto” Stefano che sostenne la prova nel secondo stato della Chiesa corrispondente alla puerizia di questa, cioè nell’“età novella”, (Purg. XV, 106-114).
Il padre, indurito, insiste nel silenzio: “Queta’mi allor per non farli più tristi; / lo dì e l’altro stemmo tutti muti; / ahi dura terra, perché non t’apristi?” (Inf. XXXIII, 64-66). Fraintende i figli, perché la tristezza non è loro, ma solo sua, già gravato com’è dalla “seconda morte” disperata. Muta, nell’esegesi apocalittica (Ap 11, 8), è la grande città, la Gerusalemme terrena chiamata “Sodoma” perché muta ed “Egitto” perché tenebrosa, cioè il regno di questo mondo secondo Gioacchino da Fiore, sulle cui piazze giaceranno i corpi dei due testimoni, Elia ed Enoch, uccisi dall’Anticristo.
Il giorno seguente uno dei fanciulli si rivolge ancora al padre: «Poscia che fummo al quarto dì venuti, / Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi, / dicendo: “Padre mio, ché non m’aiuti?”» (vv. 67-69). Il figlio che si rivolge al padre è certamente memore delle parole di Cristo crocifisso in Matteo 27, 46 – “Deus meus Deus meus, ut quid dereliquisti me”, né gli è estranea la reminiscenza di Polite che cade morto ai piedi del padre Priamo (Aen. II, 531-532). Prostrarsi a terra rinvia però anche all’esegesi relativa al vescovo della sesta chiesa, Filadelfia, al quale Cristo promette che verranno a lui, adorando, i Giudei convertiti (Ap 3, 9). Sarà l’atto di Dante di fronte all’angelo portiere, depositario delle chiavi della porta del purgatorio: “Divoto mi gittai a’ santi piedi; / misericordia chiesi e ch’el m’aprisse” (Purg. IX, 109-110). La preghiera di Gaddo adorante non ottiene, invece, dal padre impietrito l’apertura, verso la libertà spirituale, dell’uscio chiavato.
■ I motivi, presenti soprattutto nella citazione di Gioacchino da Fiore ad Ap 9, 13, dei quattro lati dell’altare (interpretati come i quattro Vangeli) dal quale esce una comune voce, di Cristo tradito e consegnato nelle mani dei nemici nel quinto giorno che precede la Parasceve, della sua crocifissione nel sesto giorno, del chiamare contro le scelleratezze della nuova Babilonia, percorrono come cellule musicali il racconto del conte Ugolino (Inf. XXXIII, 43-58, 67-74, 85-89), dove la poesia li appropria variandoli: il padre scorge “per quattro visi il mio aspetto stesso”; vede cadere tre dei suoi quattro figli, posti “a tal croce”, tra il quinto e il sesto giorno di prigionia; li chiama per due giorni (il settimo e l’ottavo) dopo morti, ha voce di aver tradito Pisa consegnando i castelli ai nemici. Ciò che nell’esegesi è concentrato solo su Cristo, nei versi è diffuso: è Pisa ad essere “tradita … de le castella” (per voce comune che accusa Ugolino; “fore traditum … d’aver tradita”: unico caso, nel poema, del participio passato di tradire); ma alla croce essa ha posto i quattro figli del conte (che rode l’arcivescovo Ruggieri, a sua volta traditore), per cui s’è fatta “novella Tebe”, figura antica della “nova Babilon” e della nuova crocifissione di Cristo.
Il poeta invoca perciò che la città, “vituperio de le genti / del bel paese là dove ’l sì suona”, venga punita con il muoversi della Capraia e della Gorgona a chiudere la foce dell’Arno sì da farne annegare gli abitanti, invettiva che contiene il tema del muoversi delle isole e del conseguente sterminio dei popoli che segna il terremoto con cui si apre il sesto sigillo (Ap 6, 14; 16, 20: vv. 79-84).
L’Italia, “’l giardin de lo ’mperio”, la fruttuosa “erba” alla quale è tornato Francesco, la nuova Giudea convertita, è terra d’umiltà, l’“umile Italia” che il Veltro salverà; è pure il “bel paese là dove ’l sì suona”, dove cioè si conferma in terra il sovranazionale canto di lode che gira la sede divina in cielo: «“dicentes: Amen”, id est vere sic sit et fiat» (Ap 7, 11-12).
I tempi che scandiscono la fine del conte e dei quattro fanciulli nella Muda sono gli stessi della passione di Cristo. Ma l’ottavo giorno, la domenica di resurrezione, designato dall’ottava beatitudine – “Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam” (Mt 5, 10) -, o dallo stadio paolino (l’ottava parte del miglio romano) in cui tutti corrono ma uno solo vince il premio e che è misura dei lati della Gerusalemme celeste (1 Cor 9, 24, cfr. Ap 21, 16), non è stato tale per il conte: “vid’ io cascar li tre ad uno ad uno / tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’ io mi diedi, / già cieco, a brancolar sovra ciascuno, / e due dì li chiamai, poi che fur morti. / Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno” (vv. 71-75).
■ Il verso finale – “Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno” (Inf. XXXIII, 75) – se interpretato nel senso letterale, significa che il dolore non poté ucciderlo; il conte morì per fame.
I sensi spirituali, o mistici, insistono su due parole apparentemente contrastanti: dolore, digiuno. Il dolore, che fu dato al conte perché rinnovasse in sé e nei fanciulli la passione di Cristo, non portò a contrizione o a conversione. Alla confluenza dell’“Archian rubesto” con l’Arno, “Bonconte” da Montefeltro, ferito a morte a Campaldino, fu vinto dal dolore e si pentì: “già cieco” come “conte Ugolino” (“Quivi perdei la vista”), una “lagrimetta” lo salvò; cadde lasciando il corpo gelato sulla foce. Inutilmente l’“Archian rubesto”, per la pioggia mossa dal diavolo, alla confluenza con l’Arno “sciolse al mio petto la croce / ch’i’ fe’ di me quando ’l dolor mi vinse” (Purg. V, 100-102, 107, 124-129).
Il dolore che genera odio non recò a Ugolino il pentimento. Fu ucciso dalla fame brutale e bestiale, quella che lo accomuna alla macerata “antica lupa”, fregiata dei mortiferi segni del cavallo pallido dell’Apocalisse (Ap 6, 8).
Neanche il digiuno gli giovò. Ad Ap 15, 2 il mare di vetro (a differenza di Ap 4, 6, dove è “vetro simile a cristallo”) è detto “vetro misto a fuoco”; designa la contemplazione ignea, la macerazione penitenziale, l’amarezza e la tolleranza delle tribolazioni, grande e profonda come il mare, perspicua e solida come il vetro, ma mescolata al fuoco della fervida carità. L’acqua del mare corrisponde al senso letterale della Scrittura, il fuoco all’intelligenza spirituale e ardente. Su questo mare stanno gli spirituali che hanno vinto la bestia e gli “spiritalia et subtilia vitia” dell’Anticristo con la preghiera e con il digiuno. Sono i “fuochi tutti contemplanti” di cui dice san Benedetto nel cielo di Saturno (Par. XXII, 46-48). Descrivendo la moderna decadenza dei monasteri, ricorda il buon principio di essi, e di lui stesso che cominciò “con orazione e con digiuno” (vv. 88-90): si tratta degli strumenti che ad Ap 15, 2 Olivi assegna agli spirituali per conseguire la vittoria contro i sottili vizi dell’Anticristo, in modo da potersi infine elevare sopra il mare di vetro misto a fuoco.
I vizi spirituali e sottili, che un uomo spirituale avrebbe dovuto vincere col digiuno e la preghiera, consistevano nel dubbio indotto dal “mal sonno” che aveva predetto a Ugolino la vittoria mondana del suo nemico Ruggieri, e nell’equivoco tra il domandare il pane da parte dei figli, che è desiderio di cibo spirituale, e il suo mordersi le mani per la disperazione, alludendo a un desiderio materiale di cibo. È proprio dei martiri del sesto stato della Chiesa dover sostenere, oltre alle sofferenze corporali che furono proprie dei primi martiri per la fede, anche un “certamen dubitationis”, il dubbio sulla verità indotto dai persecutori con la sottigliezza degli argomenti filosofici, con le distorte testimonianze scritturali che vinsero Francesca e Paolo, con l’ipocrita simulazione di santità, con la falsa immagine dell’autorità divina o pontificale che perdé Guido da Montefeltro.
Né il senso letterale, dunque, né quello spirituale autorizzano a pensare alla tecnofagia del conte, tesi che, nella certezza del fatto o nel solo sospetto, dal Lana a Borges ha percorso i secoli. Al di fuori della lettera e dello spirito non c’è altro, nel tragico verso oggetto di tanta critica. Affermare che Dante abbia ambiguamente voluto insinuare nel lettore l’ipotesi più terribile – nel senso: “chi vuole intendere, intenda” – è illazione non consentita dall’esame dei testi. In Dante non esiste l’indistinto, né la sua è poesia dalle mezze tinte. L’indubbia oscurità deriva dal fatto che il senso letterale incorpora semanticamente altri sensi contenuti in altra opera, la Lectura super Apocalipsim, e che questo linguaggio per segni si è subito perduto, insieme al suo pubblico e alla chiave che l’apriva, rimanendo la lettera con la selva delle interpretazioni.
Certamente, come scriveva Benedetto Croce, “se questa è la lettera, non è il senso poetico di quel verso, che vien preparato e determinato da tutto il racconto precedente” [14]. Ma questo è segnato, fin dall’inizio, dai temi del dolore, disperato e pieno d’odio, e della fame, non quella del verbo ristoratore di Cristo per cui i fanciulli domandano del pane come la Samaritana domandò la grazia dell’acqua che sazia in eterno la sete (cfr. Purg. XXI, 1-3), ma la fame che, in assenza del Verbo, si fa bestialità e morte per consunzione.
Né il conte che si morde le mani e i fanciulli che gli si offrono in pasto insinuano che alla fine il misero padre abbia divorato le membra dei figli morti. Quel mordersi è sempre indotto dal disperato dolore; l’offerta dei fanciulli, ripetendo quella di Cristo al Padre, fa segno di una divorazione spirituale.
D’altronde una sola cronaca contemporanea, di parte fiorentina e dunque antipisana, riporta la diceria sul cannibalismo (reciproco però fra i cinque prigionieri, non del solo padre) [15]; più realisticamente, gli Annales Ianuenses di Iacopo d’Oria, redatti prima del 1293, riferiscono che “unusquisque sibi manus et brachia comederunt” [16], dato che si rispecchia nel verso “ambo le man per lo dolor mi morsi”.
■ Pietrificata nella Muda per il disperato dolore che genera odio, porta a mordersi le mani e induce incomprensione fra padre e figli, l’umanità di Ugolino si mostra alla vista dei figli caduti esanimi: “ond’ io mi diedi, / già cieco, a brancolar sovra ciascuno, / e due dì li chiamai, poi che fur morti” (Inf. XXXIII, 72-74). Brancola sui corpi come la Niobe ovidiana sui suoi nati – “corporibus gelidis incumbit” (Met. VI, 277-278); chiama come i santi i quali, tristi fino alla disperazione per i mali che pervadono la Chiesa, all’apertura del quinto sigillo invocano la giustizia divina affinché vendichi il loro sangue (Ap 6, 9). Non diversamente la “Roma che piagne / vedova e sola, e dì e notte chiama” il suo Cesare (Purg. VI, 112-114); ‘chiamano’ il poeta stesso nel maledire l’antica lupa, e Ugo Capeto che chiede vendetta sulla dinastia della quale è capostipite (Purg. XX, 10-15, 94-96).
L’invettiva del poeta contro Pisa gli rende giustizia in terra, facendolo erigere a “giudice dei giudici”, come scriveva Croce. Le divisioni intestine della Chiesa carnale, diventata quasi “nova Babilon” (Ap 9, 13), sono appropriate agli odi fra fazioni nelle città “del bel paese là dove ’l sì suona”. Il tema della nuova Babilonia, città divisa per discordie intestine (Ap 16, 19) è nella domanda che Dante pone a Ciacco su Firenze, “città partita” e da “tanta discordia assalita” (Inf. VI, 60-63). L’invettiva contro Pisa, “novella Tebe” per odi fraterni fa concordare la Tebaide di Stazio (I, 1-2) con l’Apocalisse. Essa conferisce “e piedi e mano” all’esegesi del muoversi delle isole (la Capraia e la Gorgona) all’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12-17). Uno sconvolgimento imprevedibile di quel che vi è di più stabile e adatto all’umana quiete in mare; ad esso farà riferimento Carlo Martello parlando della “mala segnoria” angioina, che mosse “Palermo a gridar: ‘Mora! mora!’” (Par. VIII, 67-75).
■ L’episodio non si sottrae alle norme che costantemente regolano il rispondersi della Commedia con la Lectura super Apocalipsim e che rendono questo fenomeno unico, irripetibile, inoppugnabile.
In un apposito studio è stato mostrato (con un centinaio di esempi, ma potrebbero essere molti di più) come, a partire da singole parole, nello stesso verso o nei versi immediatamente circostanti se ne registrano altre che si riferiscono al medesimo luogo dell’esegesi apocalittica (non al solo testo dell’Apocalisse, ma a questo e alla sua esegesi). Un’altra indagine, condotta su circa 300 hapax legomena della Commedia (in quanto parole più rare o studiate) ha evidenziato questo fenomeno in modo sistematico. Più luoghi della Lectura possono essere inoltre collazionati tra loro, secondo un procedimento analogico tipico delle distinctiones ad uso dei predicatori. La scelta non è arbitraria. Vi predispone lo stesso testo scritturale, poiché l’Apocalisse contiene espressioni, come Leitmotive, che ritornano più volte. È determinata da parole-chiave che collegano i passi da collazionare. È suggerita dallo stesso Olivi, nel prologo, per una migliore intelligenza del testo.
Si veda, ad esempio, il caso dell’esegesi di Ap 16, 10-11 (quinta coppa), collazionata con passi relativi alle locuste che escono dal pozzo dell’abisso al suono della quinta tromba (Ap 9, 8-9). Il tema dominante è il dolore del cuore e il rimorso che acceca per l’odio vòlto a corrodere la fama altrui.
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 10-11 (Va visio, Va phiala)]bestialis vita; quoad speciem habitus videntur esse unius ordinis cum eis; ambitio cecat oculos eorum, tum quia odium … aufert omnino lumen ab oculis eorum; pre dolore cordis; “Et commanducaverunt linguas suas pre dolore”; quia proprium sermonem per invidiam et detractionem corrumpunt; destruunt et corrodunt; odiunt et maledicunt; “Et non egerunt penitentiam ex operibus suis” scilicet malis, immo, supple, amplius obstinati sunt in illis peragendis; per impatientiam se corroserunt.[LSA, cap. IX, Ap 9, 5 (IIIa visio, Va tuba)] Per cruciatum autem designatur hic pungitivus remorsus conscientie … Designat etiam iram et offensam quam temporaliter dampnificati et iniuriati a predictis locustis habent contra eas […].[LSA, cap. IX, Ap 9, 8 (IIIa visio, Va tuba)] “Et dentes e[a]rum sicut dentes leonum erant”, tum per crudelitatem detractionum vitam et famam alienam corrodentium et precipue suorum emulorum.[LSA, cap. IX, Ap 9, 9 (IIIa visio, Va tuba)] Per alas autem locustarum designantur hii qui apud eos vocantur perfecti, qui quando veniunt ad conflictum sicut stridentes et rugientes disseminant verba sua, ut videantur superare verbis quos non possunt vincere ratione. |
|
(si) manduca* (Inf. XXXII, 127)
manicar* (Inf. XXXIII, 60)* hapax |
li denti (128); si rose (130); bestial (133); odio, ti mangi (134)per lo dolor mi morsi (58); cieco (73); riprese ’l teschio misero co’ denti (77) |
Ma se le mie parole esser dien seme (Inf. XXXIII, 7)
|
dolor, ’l cor (5); infamia, i’ rodo (8) |
Sòstati tu ch’a l’abito ne sembri
|
………………………………. ma fiorentino
|
E questi sette col primaio stuolo
|
Un altro esempio è “studïose” (Inf. XXXIII, 31), hapax nel poema, che rinvia con la semantica circostante alla prostituta del capitolo XVII dell’Apocalisse (“studiose” è avverbio nel testo latino).
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 3-5 (VIa visio)][…] quondam prefuit et regnavit super bestiales gentes mundi et adhuc super plures bestiales sibi subditas dominatur, dicitur sedere super bestiam. […] “Et mulier erat circumdata purpura et coccino et inaurata auro et lapide pretioso” (Ap 17, 4), id est studiose et pompose ornata carnalibus ornamentis et deliciis et divitiis et gloria huius mundi. Per purpuram etiam et coccinum, seu vestes coloris coccinei, potest intelligi crudelitas eius in martires et in alios quorum sanguine seu occisione fuit cruentata.
|
|
studïose* (Inf. XXXIII, 31)* hapax |
maestro, donno (28); fronte (33) |
L’“Italia” corrisponde alla Giudea, di questa le sono attribuite le prerogative: già terra di frutti e di erbe, creata perché si dedicasse al culto divino, con la sua ostinata durezza verso Cristo da giardino si è fatta deserto, ma alla fine dei tempi si convertirà con umiltà. La particella affermativa “del bel paese là dove ’l sì suona” (Inf. XXXIII, 80) concorda con l’interpretazione della parola ebraica “Amen”, che compare più volte nell’Apocalisse: “id est sic fiat … vere et fideliter sit … fiat hoc quod dictum est … vere sic sit et fiat … vere ita est … id est verus seu veritas” (Ap 1, 6-7; 3, 14; 5, 14; 7, 12; 19, 4; 22, 20-21), assumendo così un valore spirituale di conferma e di umile lode. Lo stesso vale per il bolognese “sipa” (Inf. XVIII, 61) e per “ita” (Inf. XXI, 42), che riprende la forma latina.
A Purg. XXX, 56 la ripetizione “anco … ancora” rende le due parole consecutive del testo sacro “Etiam. Amen” (Ap 1, 7), dove l’uso di due avverbi, uno latino l’altro ebraico, viene interpretato nel senso del piangere in ogni lingua. Nel rivolgersi al conte Ugolino (Inf. XXXII, 135-139), Dante varia i temi presenti ad Ap 1, 7: il piangere (“che se tu a ragion di lui ti piangi”, cioè dell’arcivescovo Ruggieri); il linguaggio che rende certo (“nel mondo suso ancora io te ne cangi, / se quella con ch’io parlo non si secca”).
La presenza di un “panno” sul quale è stata fatta, con infinite variazioni, l’intera “gonna” consente precisi accostamenti: si veda il caso del “disperato dolor” che opprime il cuore del conte (Inf. XXXIII, 5), congiunto con le “disperate strida” (Inf. I, 115) in quanto entrambi i luoghi rinviano all’esegesi della “mors secunda” (Ap 2, 11; 20, 6).
■ Chi intenda approfondire lo stato della ricerca può consultare su questo sito:
-
Pietro di Giovanni Olivi e Dante. Un progetto di ricerca, in “Collectanea Franciscana”, 82 (2012), pp. 87-156 – ENG
-
Amore e vita di poeta. La Vita Nova e l’imitazione di Cristo, dove si mostra come l’incontro fra Dante e le opere esegetiche dell’Olivi (in particolare l’Expositio in Canticum Canticorum e la Lectura super Lucam) risalga a prima dell’esilio, al tempo dell’uscita delle “nove rime”.
LECTURA DANTIS
- Inferno X (PDF)
- Inferno XXVI (PDF)
____________________________________________________________________________________________________________________
[1] E. AUERBACH, Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e nel Medioevo, Milano 19743, p. 283.
[2] B. CROCE, Due postille alla critica dantesca, in “La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia”, 39 (1941), pp. 133-141: 136.
[3] Cfr. J. RATZINGER, S. Bonaventura. La teologia della storia, ed. L. Mauro, S. Maria degli Angeli – Assisi, Porziuncola, 2008 (München 1959), p. 38.
[4] AUERBACH, Lingua letteraria e pubblico (cfr. nt. 1), p. 277.
[5] G. CONTINI, Filologia ed esegesi dantesca (1965) in Un’idea di Dante. Saggi danteschi, Torino, 1970 e 1976, p. 135.
[6] Cfr. Dante Alighieri, Inferno. Revisione del testo e commento di G. INGLESE, Roma 2007, p. 9.
[7] B. NARDI, Pretese fonti della «Divina Commedia», in “Nuova Antologia”, 90 (1955), pp. 383-398, ripubblicato in ID., Dal “Convivio” alla “Commedia”. Sei saggi danteschi, Roma 1960 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi storici, 35-39), pp. 351-370: 364-365.
[8] Sulla censura della Lectura super Apocalipsim cfr. A. FORNI – P. VIAN, Un codice curiale nella storia della condanna della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi: il Parigino latino 713, in “Collectanea Franciscana”, 81 (2011), pp. 479-558; 82 (2012), pp. 563-677.
[9] B. CROCE, La poesia di Dante, Bari 19527 (1920), p. 97.
[10] F. DE SANCTIS, L’Ugolino di Dante (1869), in ID., Saggi critici, a cura di L. RUSSO, III, Bari 1965, pp. 26-51: 48.
[11] G. GÜNTERT, Canto XXXIII, in Lectura Dantis Turicensis, a cura di G. GÜNTERT e M. PICONE, Inferno, Città di Castello 2011, pp. 457-472: 469-470.
[12] Così GÜNTERT, Canto XXXIII, pp. 462-464. Cfr. INGLESE (cfr. nt. 6), p. 367, nt. a v. 42: “La domanda di Ugolino a D. è la domanda del P. a ciascuno dei suoi lettori, in quello che è, probabilmente, il vertice patetico della cantica”.
[13] U. BOSCO, Ugolino della Gherardesca, conte di Donoratico, in Enciclopedia Dantesca, V, Roma 19842 (Istituto della Enciclopedia Italiana), pp. 797-798.
[14] B. CROCE, Letture di poeti, Bari 1950, p. 299.
[15] Cfr. Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento, a cura di A. SCHIAFFINI, Firenze 1926, p. 133.
[16] Cfr. Annales Ianuenses, ed. C. IMPERIALE DI SANT’ANGELO, in Fonti per la Storia d’Italia, XIV bis, Roma 1929 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo), p. 88.
[126] = numero dei versi. 8, 7 = collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]. Not. X = collegamento ipertestuale all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura.Qui di seguito viene esposto l’episodio del conte Ugolino con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (PDF; introduzione in html). I colori seguono l’attribuzione ivi data a ogni singolo stato o gruppo di materia esegetica; nel testo riportato nelle tabelle, per maggiore evidenza, possono talora essere utilizzati in forma diversa. |
|
Inferno XXXII, 124-139 |
|
Noi eravam partiti già da ello,
|
Inferno XXXIII, 1-90 |
|
La bocca sollevò dal fiero pasto 21, 21; 4, 2; 6, 8
|
Abbreviazioni e avvertenze
Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.
LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.
Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).
Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.
Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.
In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.
Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.
Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994.
Dall’esame delle tabelle sinottiche, si noterà come a un medesimo luogo esegetico della Lectura conducono, tramite la compresenza delle parole, più luoghi della Commedia. Per spiegare i significati spirituali dei versi si dovrà pertanto fare riferimento anche ad altri canti, più o meno numerosi, del poema. Ciò significa che la medesima esegesi di un passo dell’Apocalisse è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del poema, ed è una delle norme che regolano il rapporto fra le due opere. Nella spiegazione premessa alle tabelle, in questi casi è stata evidenziata, premettendo al paragrafo il simbolo ■, la parte effettivamente relativa al canto in esame.
INDICE
1. La terra petrosa e gelata. 2. L’arcivescovo laico. 3. Una macabra eucaristia. 4. La sede della bestia. 5. Parlare e lacrimare. 6. La bocca sollevò dal fiero pasto. 7. Disperazione, dolore e tristezza nella “seconda morte”. 8. Il “doctor anagogicus” infernale. 9. L’orribile torre. 10. Un sogno ingannatore. 11. Il pianto sul libro che non s’apre. 12. Lo specchio della Scrittura. 13. L’immortale canto dei quattro fanciulli. 14. I giorni della Passione. 15. E due dì li chiamai, poi che fur morti. 16. Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno. 17. Il bel paese là dove ’l sì suona. Appendice. Il libro scritto dentro e fuori.
1. La terra petrosa e gelata
ch’io vidi due ghiacciati in una buca … “ahi dura terra, perché non t’apristi?” (Inf. XXXII, 125; XXXIII, 66).
Qui, nel pozzo de’ traditori, nel fondo dell’inferno, dall’uomo bestia caschiamo fino all’uomo ghiaccio, all’uomo pietra, a un mondo dove il moto va estinguendosi a poco a poco, sin che la vita scompare del tutto.
(Francesco De Sanctis) [1]
“Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo” (Ap 4, 1). Nella parte proemiale della seconda visione, Olivi spiega che il cielo che viene aperto a Giovanni designa la Chiesa e la Sacra Scrittura, e più precisamente la sua intelligenza spirituale. Come sulla porta della tomba di Cristo era posta una pietra grande e pesante che fu rimossa al momento della resurrezione e dell’uscita di Cristo dal sepolcro, così il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso alla sua intelligenza spirituale. Nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. L’assenza di grandi opere nella Chiesa era anch’essa come una porta chiusa che impediva di contemplare la “fabrica ecclesie”. Colui che per primo aprì la porta e diede voce per salire al cielo fu Cristo, con la sua illuminazione e dottrina. La voce degli antichi profeti, che chiuse la porta con figure e promesse terrene, oppresse il senso carnale dei Giudei piuttosto che elevarlo (cfr. infra).
Il tema della durezza giudaica percorre tutta l’esegesi della prima tromba (Ap 8, 7; terza visione). Il primo angelo, cioè l’ordine dei dottori del primo stato, suonò la tromba predicando nella Giudea. Gioacchino da Fiore (Expositio, pars III, f. 127va-b) identifica questo primo angelo con san Paolo, inviato con i suoi compagni a insegnare che la legge di Mosè non doveva essere osservata secondo la lettera, ma secondo lo spirito. Come conseguenza della dottrina dottorale sui pertinaci Giudei, “fu fatta grandine mista a fuoco e a sangue e fu mandata a terra”. La “grandine” designa la durezza e la pertinacia dei Giudei, induriti e congelati ancor più per la predicazione di Cristo, come il cuore di Faraone si fece più duro alle parole di Mosè. Il “fuoco” indica lo zelo e la fiamma della maligna ira e invidia con cui arsero in modo acre contro Cristo e i suoi; il “sangue” significa la persecuzione ad essi inflitta. La “terra” è la Giudea la quale, come la terra abitabile venne da Dio separata dal mare e liberata dalle acque affinché per l’utilità dell’uomo potesse dare erbe e alberi fruttiferi, così venne separata dal mare delle nazioni e delle genti infedeli affinché gli uomini potessero dedicarsi in quiete al culto divino e produrre i frutti delle buone opere ed essere ivi semplici nel bene come erbe verdeggianti e perfetti come alberi grandi, solidi e fruttuosi. Il miscuglio di grandine, fuoco e sangue “fu mandato a terra” dall’alto zelo di Dio e della sua legge, cadendo con forte impeto. Si può anche intendere che fu conseguenza della celeste dottrina e dell’opera di Cristo.
Ad Ap 16, 21 (sesta visione) la “grandine” dura e fredda, che cade su Babylon (la Chiesa carnale), rappresenta la poena sensus, cioè i durissimi colpi delle pene che procedono dall’ardore dell’ira divina e il freddo rigido della sua severità che si imprime nell’intimo sentimento dei reprobi senza alcun calore pietoso o misericorde, rendendo i loro cuori duri verso qualsiasi bene.
■ I motivi del chiudere e della durezza segnano la descrizione del fondo dell’inferno, “loco onde parlare è duro”, che necessita di rime “aspre e chiocce” per essere descritto: in suo aiuto il poeta invoca le Muse, che aiutarono Anfione a “chiuder Tebe” traendo con il suono della lira le pietre delle mura dalle falde del monte Citerone (Inf. XXXII, 1-15).
Tutto il gelo di Cocito è tessuto con temi petrosi e ghiacciati, dal “grosso velo” invernale del corso del Danubio e del Don “là sotto ’l freddo cielo”, all’irreale caduta di monti come “Tambernicchi” o “Pietrapana”, per cui il ghiaccio “non avria pur da l’orlo fatto cricchi” (vv. 25-30). Anche il “velo” appartiene alla rosa di motivi propri della durezza giudaica, considerata la citazione della seconda Lettera ai Corinzi, 3, 15-16 nella premessa al prologo della Lectura: “Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore; ma quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto”.
Se si collazionano i passi relativi alla prima tromba (Ap 8, 7) e alla grandine ad Ap 16, 21 con l’esegesi della quarta perfezione di Cristo come sommo pastore, che consiste nella maturità del consiglio designata dalla senile e gloriosa canizie del capo e dei capelli, una sapienza assimilata, se astratta, alla durezza e al gelo della neve e, se misericordiosa, alla mollezza e al calore della lana (Ap 1, 14; cfr. anche altrove), si palesano altri fili con cui è tessuta la gelata di Cocito: al freddo e alla durezza si aggiunge il motivo dei capelli (“’l pel del capo” misto dei due fratelli Alberti, i capelli del dischiomato Bocca: Inf. XXXII, 42, 99, 103). Il senso spirituale sottolinea la durezza del giudizio divino, che nella sua sapienza astratta (designata dai capelli simili a neve) punisce senza misericordia e gela le lacrime dei dannati, provenienti da occhi “ch’eran pria pur dentro molli” (v. 46), giudizio che impedisce lo sfogo che purga (le lacrime designano la contrizione; cfr. infra).
I motivi connessi alla grandine si ritrovano nella pena inflitta ai golosi nel terzo cerchio (Inf. VI, 7-12).
■ Il conte Ugolino e l’arcivescovo Ruggieri sono “due ghiacciati in una buca” (Inf. XXXII, 125), in mezzo alla “gelata” di Cocito (Inf. XXXIII, 91). Nel doloroso carcere della Muda il padre non piange e non lacrima – “sì dentro impetrai” – mentre piangono i figli (vv. 49-50). Prorompe nell’esclamazione “ahi dura terra, perché non t’apristi?” (v. 66). La sua fu “morte … cruda”, come crudele fu la morte di Cristo (v. 20); l’uscio dell’orribile torre viene ‘chiavato’ come fu chiuso il monumento di Cristo (vv. 46-47; con chiaro riferimento ai chiodi della croce). Da questa lapidea durezza e chiusura Ugolino, da vivo, non si è mai liberato.
Nel verso “ahi dura terra, perché non t’apristi?” si registra, oltre al tema della durezza giudaica, anche il riferimento all’aprirsi della terra che risucchia in sé fino all’inferno la bestia e il falso profeta (Ap 19, 20): il motivo si trova già nella descrizione della fine di Anfiarao in Inf. XX, 31-32; aprire la terra è appropriato, in Inf. VIII, 130, al messo che aprirà la porta della Città di Dite.
■ Uscito fuori della selva, aspra e dura come il fondo dell’inferno, Dante scorge il colle illuminato dal sole, e questo gli quieta la paura che aveva provato durante la precedente notte di angoscia. Il confronto con gli sviluppi dell’esegesi di Ap 8, 7 – “sicut ad Moysi verba et signa Pharao fortius induravit cor suum” – impone di considerare con attenzione la variante, scartata dal Petrocchi perché minoritaria nelle testimonianze, “che nel lago del cor m’era indurata”, rispetto a “durata” (“perseverata” come spiega Boccaccio), nel senso che la paura gli si era ghiacciata dentro al cuore (Inf. I, 19-21). Come il “lago del cor” di Dante smarrito nella selva, così Cocito è “un lago che per gelo / avea di vetro e non d’acqua sembiante” (Inf. XXXII, 23-24).
I motivi della durezza del cuore e del congelamento segnano ancora frate Alberigo, il quale nella “fredda crosta” della Tolomea, “l’ultima posta” dell’inferno, prega i due poeti di ‘levargli’ (togliere con effetto di elevare a più alta vista, come da Ap 4, 2) dal volto “i duri veli, / sì ch’ïo sfoghi ’l duol che ’l cor m’impregna, / un poco, pria che ’l pianto si raggeli” (Inf. XXXIII, 109-114). I “veli”, come sopra ricordato, sono da riferire al velo steso sul cuore dei Giudei di cui si dice nella seconda Lettera ai Corinzi. Il velo sarà tolto al momento della loro conversione a Cristo, cosa che non avviene con frate Alberigo. A costui è appropriato anche il tema del dare frutti da parte della terra già verdeggiante e poi combusta (la Giudea), e infatti si presenta come “quel da le frutta del mal orto”, con allusione all’uccisione dei suoi parenti a mensa al momento di servire loro le frutta (vv. 118-120).
■ La descrizione degli esempi di superbia punita, scolpiti nel pavimento del primo girone del purgatorio come fossero “tombe terragne”, contiene alcuni motivi della prima tromba (nella zona riservata ai superbi purganti vi è prevalenza dei temi relativi primo stato). Nel gigante Briareo sono presenti i motivi del gelo e della terra: appare “grave a la terra per lo mortal gelo”, trafitto dalla saetta celeste inviata da Giove (Purg. XII, 28-30; nell’esegesi della prima tromba è la grandine a essere inviata dal cielo, la saetta è tema dell’apertura del primo sigillo, ad Ap 6, 2). Il “duro pavimento” (che corrisponde alla durezza della grandine) mostra ancora la punizione di Erifile (uccisa dal figlio Alcmeone in vendetta del padre Anfiarao) per essersi adornata dell’infausta collana fabbricata da Vulcano per le nozze di Armonia, figlia di Venere, con Cadmo (vv. 49-51). La crudeltà e il sangue segnano il “crudo scempio” fatto da Tamiri, la regina degli Sciti che, per vendetta dell’uccisione del figlio, saziò Ciro col sangue gettandone dopo morto il capo in un otre pieno di sangue umano (vv. 55-57).
I motivi antigiudaici dell’esegesi sono appropriati ai vizi dei cristiani e alle loro antiche e mitologiche prefigurazioni, così come lo sono gli elementi negativi che appartengono alla “bestia saracena”, culminanti nella cieca cupidigia designata dalla lupa. La Giudea, un tempo giardino ora fatto deserto, designa l’Italia, come altrove mostrato (cfr. anche infra).
[1] DE SANCTIS, L’Ugolino di Dante, p. 27.
Tab. 1
[LSA, prologus] Nam umbra sui velaminis per lucem Christi et sue legis aufertur secundum Apostolum, capitulo eodem dicentem quod “velamen in lectione veteris testamenti manet non revelatum, quoniam in Christo evacuatur”. Unde “usque in hodiernum diem, cum legitur Moyses”, id est lex Moysi, “velamen est positum super cor” Iudeorum; “cum autem conversus fuerit ad Dominum, auferetur velamen (2 Cor 3, 14-16).[LSA, cap. IV, Ap 4, 1-2 (radix IIe visionis)] Nota etiam quod hec sibi sic monstrantur et sic nobis scribuntur, quod sint apta ad misteria nobis et principali materie huius libri convenientia. Unde per celum designatur hic ecclesia et scriptura sacra, et precipue eius spiritalis intelligentia. Sicut autem in hostio monumenti Christi erat superpositus magnus lapis et ponderosus, qui Christo resurgente et de sepulcro exeunte est inde amotus, sic in scriptura erat durus cortex littere, pondere sensibilium et carnalium figurarum gravatus, claudens hostium, id est [aditum] intelligentie spiritalis. In humanis etiam cordibus erat lapidea durities sensus obtusi, claudens introitum divinarum illuminationum.
|
|
Inf. XXXII, 10-15, 22-48, 52-54, 58-60, 97-105, 124-125Ma quelle donne aiutino il mio verso
|
Inf. XXXIII, 19-21, 46-51, 66, 91-92, 100-102, 109-114, 118-120però quel che non puoi avere inteso,
|
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 21 (radix VIe visionis)] Secunda vero est pena sensus, propter sui intolerabilem excessum redundans in horribiles blasphemationes Dei et iudicii sui. Unde subdit (Ap 16, 21): “Et grando magna sicut talentum descendit de celo in homines; et blasphemaverunt homines Deum propter plagam grandinis, quoniam magna facta est vehementer”. Secundum Isidorum* et Papiam*, talentum perhibetur esse summum pondus in Grecis, et ideo per “talentum” designatur hic summum pondus pene. Quam penam designat hic grando de celo impetuose descendens, quia inter celestes impressiones superioris regionis seu aeris est grando communiter omnibus durior, et per excessum circumstantis caloris frigus ad interiora nubium repellentis et per fortem coagulationem factam ab interno frigore descendit procellosissime et impetuosissime et cum multo exterminio fructuum terre. Et ideo congrue designat durissimam percussionem penarum a Deo et ab ardore sue ire procedentium, et frigidum algorem sue severitatis ad intima reproborum viscera absque omni calore pietatis et misericordie imprimentis et eorum corda contra omne bonum obdurescere facientis.
|
|
2. L’arcivescovo laico
sì che l’un capo a l’altro era cappello (Inf. XXXII, 126).
All’inizio del capitolo XIII (quarta visione), la bestia che sale dal mare ha sette teste e dieci corna (Ap 13, 1). Su questo luogo Gioacchino da Fiore (richiamato da Olivi anche ad Ap 12, 3) afferma che le teste di questa bestia differiscono dalle teste del drago come le chiese metropolitane, che sono capo alle altre e che il drago impersona, si distinguono dai propri vescovi, i quali sono comunque anch’essi “capita Christi”, di cui fanno le veci, e con ciò intende che quei popoli che furono i principali nel perseguitare Cristo e la Chiesa sono, come capi degli altri, propriamente teste della bestia e della massa bestiale. Il riferimento ai “capita capitum”, cioè a delle teste che stanno sopra altre teste loro sottoposte, e queste teste bestiali che sovrastano le altre sono gli arcivescovi preposti alle chiese metropolitane, è impersonato nei versi dalla posizione sovrapposta del conte Ugolino nel rodere coi denti l’arcivescovo Ruggieri, “sì che l’un capo a l’altro era cappello” (Inf. XXXIII, 126), posizione rovesciata rispetto all’esegesi poiché è l’arcivescovo a star sotto, ma che mostra ugualmente, “per sì bestial segno”, due bestie una delle quali soggiace e l’altra soggioga.
Tab. 2
3. Una macabra eucaristia
e come ’l pan per fame si manduca (Inf. XXXII, 127)
Nella storia della Chiesa, il devoto pasto eucaristico appartiene per antonomasia al quarto stato (prologo, notabilia III, XIII). Storicamente, si tratta del periodo che fiorì sotto Giustiniano (527-565), nella santa vita degli anacoreti del deserto. La solitudine contemplativa e la fuga dal consorzio umano sono però prerogative proprie di tutti gli stati e percorrono tutte le vicende umane; sono anche modi di essere dell’individuo inserito nella storia universale della salvezza. Se nello stato precedente, il terzo, prevalsero i dottori, i quali a partire dalla pax costantiniana confutarono con la spada della ragione le eresie e diedero le leggi al popolo di Dio, nel quarto emerse più l’affetto pastorale dei contemplativi. Terzo e quarto stato, dottori e anacoreti, intelletto e affetto, ragione e santità, spada e pastorale, Impero e Papato concorsero nel loro specifico periodo – e concorrono sempre con solare sapienza in quanto categorie dell’individuo – per due diverse strade senza congiungersi, a infiammare il meriggio dell’universo, prima che nel quinto stato (che inizia con Carlo Magno e arriva fino a san Francesco) i beni temporali invadessero la Chiesa trasformandola quasi in una nuova Babilonia. A questa concorrenza, figurata dalle due ali della grande aquila date alla donna (la Chiesa) per volare come regina nel deserto dei Gentili (Ap 12, 14), si riferiscono i celebri versi di Purg. XVI, 106-114, relativi ai “due soli” di Roma, il periodo storico rimpianto da Marco Lombardo, in cui il “pasturale” (il potere spirituale) non aveva spento e congiunto a sé la “spada” (il potere temporale).
Gli stati, e con essi gli individui nella storia, si corrompono. All’opposto della vita devota e del pasto eucaristico sta l’apertura del quarto sigillo, nella seconda visione apocalittica. I motivi proposti dall’esegesi del quarto cavallo “pallido” – il pallore, la macerazione del corpo, l’aridità, il languore, la fame, la fiacchezza, il marcire pestilenziale, il colore della morte, la compagnia bestiale (Ap 6, 8) – sono puntualmente presenti in vari luoghi del poema e in particolare nelle zone in cui prevale la tematica del quarto stato, appropriato storicamente agli anacoreti dall’alta vita ma troppo ardua a mantenersi, e per questo volta in ipocrisia e falsità per poi essere distrutta dai Saraceni nei luoghi (in Oriente e in Africa settentrionale) dove più fiorì. Il quarto cavallo pallido viene interpretato da Gioacchino da Fiore come la bestia saracena, diversa dalle altre. Ad essa è dato il potere “sulle quattro parti della terra”, che esercita tramite la spada, la fame, la morte e le bestie. Questi quattro strumenti alla lettera significano i vari modi di debellare i nemici, uccisi in battaglia campale, o per fame negli assedi di città che poi, abbandonate dagli uomini, diventano deserti devastati da bestie selvagge. La “spada” designa pure il terrore che questa bestia, che molte terre ha occupato, incute penetrando nell’intimo del cuore e della carne con la paura che deriva dalla sua forza militare; la “fame” denota l’assenza del verbo ristoratore di Cristo; la “morte” indica la mortifera legge di Maometto; le “bestie” la compagnia delle genti bestiali.
Con i motivi propri del cavallo pallido è tessuta la lupa. Di essi partecipa, nella sua parodia eucaristica, anche il conte Ugolino:
e come ’l pan per fame si manduca … O tu che mostri per sì bestial segno … La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator, forbendola a’ capelli / del capo ch’elli avea di retro guasto. …. Breve pertugio dentro da la Muda, / la qual per me ha ’l titol de la fame … Con cagne magre, studïose e conte … In picciol corso mi parieno stanchi / lo padre e ’ figli …
Quarto earum pascuali refectioni … Refectio vero eucharistie congruit devotioni anachoritarum … “Et ecce equus pallidus” (Ap 6, 8), id est, secundum Ricardum, ypocritarum cetus per nimiam carnis macerationem pallidus et moribundus … “Et data est illi” id est diabolo, “potestas” scilicet per divinam permissionem, “super quattuor partes terre” id est super omnes terrenis inherentes, “interficere” eos “gladio” scilicet peccati, “et fame” scilicet verbi Dei, “et morte” id est languore corporis vel pestilentia seu tabe mortifera, “et bestiis” id est a bestialibus moribus.
Tab. 3 (cfr. in altro luogo l’esame di questa esegesi)
[LSA, prologus, Notabile III] Patet enim hoc de primo dono. Nam pastoralis cura insistit primo ovium propagationi (I). Secundo earum defensioni ab imbribus et lupis et consimilibus (II). Tertio earum directioni seu deductioni ad exteriora (III). Quarto earum pascuali refectioni (IV). Quinto morborum et morbidarum medicinali extirpationi (V). Sexto ipsarum plene reformationi (VI). Septimo ipsarum in suum ovile reductioni et recollectioni (VII). Constat autem quod propagatio appropriatur prime plantationi ecclesie sub apostolis (I), defensio vero militari pugne martirum (II), directio vero eruditioni doctorum (III), refectio autem studiose et refective devotioni anachoritarum (IV), et sic de aliis.[LSA, prologus, Notabile XIII (IV status)] Refectio vero eucharistie congruit devotioni anachoritarum. |
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 7-8 (IIa visio, apertio IVi sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum quartum, audivi vocem quarti animalis”, scilicet aquile, “dicentis: Veni”, scilicet per imitationem mei et per attentionem ad tibi monstranda, “et vide” (Ap 6, 7).
|
|
Inf. IV, 13-18“Or discendiam qua giù nel cieco mondo”,
|
Inf. XXIX, 61-64, 91-93che li animali, infino al picciol vermo,
|
4. La sede della bestia
O tu che mostri per sì bestial segno / odio sovra colui che tu ti mangi (Inf. XXXII, 133-134).
Bello in principio, dotato di tutti i doni dello Spirito, pacifico, di lunga durata (cinquecento anni a partire da Carlo Magno o da suo padre Pipino), limitato alla sede romana a causa delle devastazioni operate in Oriente dai Saraceni, il quinto stato degenera poi in rilassatezza: alla fine la Chiesa appare corrotta quasi fosse una nuova Babilonia (cfr. prologo, Notabile VII: “circa finem quinti temporis a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta”). La chiesa, delle sette d’Asia, che per eccellenza possiede tutte le perfezioni stellari è la quinta, quella di Sardi, assimilata alla sede romana (Ap 3, 1). Va tuttavia precisato che Roma in quanto meretrice si identifica con la moltitudine dei reprobi, i quali con le loro inique opere impugnano e blasfemano la Chiesa dei giusti peregrina sulla terra. Questa meretrice non deve pertanto essere cercata in un solo luogo ma, come per tutta l’area dell’impero romano è diffuso il grano degli eletti, così per la sua intera latitudine è dispersa la paglia dei reprobi. È l’interpretazione morale e spirituale dei “patres catholici”, che fa salve le prerogative carismatiche della sede romana, data da Gioacchino da Fiore citato da Olivi ad Ap 17, 1.
Il quinto angelo, cioè l’ordine dei santi che zelano nel quinto stato, “versò la sua coppa sulla sede della bestia e il regno di questa si fece tenebroso” (Ap 16, 10; quinta visione). La sede della bestia, cioè della moltitudine bestiale, prevale in numero e potere e quasi assorbe la Chiesa di Cristo con la quale si trova mischiata “localiter et nominaliter”, tanto da essere chiamata Chiesa dei fedeli come quella che è veramente per grazia la sede e la Chiesa di Cristo. Su tale sede dagli enormi e abominevoli vizi gli zelanti del quinto tempo non cessano di versare la coppa del rimprovero, in modo che il suo regno appaia a tutti con evidenza, si voglia o meno, “tenebroso”, cioè dissipato e reso abominevole da sozza ed enorme lussuria, avarizia, simonia, superbia, commercio doloso, astuzia e da quasi ogni malizia, per cui di seguito viene chiamata Babilonia, la meretrice che tiene in mano la coppa aurea piena di abominio (Ap 17, 4).
In particolare, la sede della bestia designa il clero carnale, che nel quinto tempo regna e presiede su tutta la Chiesa e in cui la vita bestiale regna e siede in modo trascendente e singolare come nella sua principale sede ed assai più che nelle plebi laiche ad esso soggette. Secondo Gioacchino da Fiore – che nell’esegesi oliviana della quinta coppa registra due citazioni contro una sola di Riccardo di san Vittore -, costoro ambiscono a regnare al di sopra dei loro confratelli come il diavolo regna al di sopra dei figli della superbia e, poiché all’abito sembrano essere dello stesso livello di coloro che su di essi effondono le coppe dell’ira divina, tanto più sdegnano di essere rimproverati dai propri uguali o dagli inferiori. Il loro regno si fa tenebroso perché l’ambizione acceca i loro occhi, in quanto l’odio che nutrono nei confronti di quanti li rimproverano sottrae ad essi del tutto il lume della vista.
Poiché, impediti dagli spirituali, non possono ottenere quello che vogliono, per il dolore nel cuore e per impazienza prorompono in detrazione di quanti li rimproverano. Per questo segue: “e si mangiarono le proprie lingue per il dolore” (Ap 16, 10). Per “lingue”, secondo Gioacchino da Fiore, si intendono coloro che posseggono il fuoco dello zelo divino e l’ardore di parlare contro le ingiurie fatte a Dio, e tali lingue vengono morse dalle detrazioni fatte senza timore dai rimproverati. Secondo Riccardo di San Vittore, mordersi la lingua significa interrompere il discorso per livore d’invidia e per detrazione, oppure distruggere e corrodere dentro di sé ogni quieto sapore di gioia. “E bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei dolori e delle piaghe” (Ap 16, 11), cioè per il livore dell’invidia e per le piaghe inflitte per la confusione recata dai rimproveri dei santi. Bestemmiano Dio in quanto odiano e maledicono la grazia e la verità divina e il divino zelo dei santi. “E non si pentirono delle loro azioni”, cioè si ostinano nel loro operare malvagio invece di fare penitenza.
Come sempre nella metamorfosi dantesca, gli elementi che nella teologia della storia dell’Olivi sono concentrati sulla Chiesa vengono nel poema rifratti sull’intero creato e in particolare sul mondo umano, che si agita sull’“aiuola che ci fa tanto feroci”.
■ L’espressione “quia quoad speciem habitus videntur esse unius ordinis cum eis” (riferita ai chierici che all’abito sembrano essere dello stesso livello di coloro che su di essi effondono le coppe dell’ira divina) viene traslata, in tutt’altro contesto (per quanto tessuto principalmente con i temi del quinto stato) nel richiamo dei tre fiorentini sodomiti: “Sòstati tu ch’a l’abito ne sembri / essere alcun di nostra terra prava” (Inf. XVI, 8-9; cfr. “abitüati” a Purg. XXIX, 146).
■ La trattazione della quinta coppa è suscettibile di alcune collazioni, con passi anch’essi riferiti al quinto stato. Il “rodere” è proprio dei denti delle locuste che escono dal pozzo dell’abisso al suono della quinta tromba, considerati ad Ap 9, 8 (quinta proprietà), e si tratta del corrodere crudelmente la vita e la fama degli altri. Dell’odio, vizio predominante nella vita bestiale del quinto tempo, si tratta anche nell’esegesi del capitolo XV, il quale fa da introduzione alla quinta visione, che è quella delle coppe (ad Ap 15, 1). Una citazione di Gioacchino da Fiore afferma che dopo le prime quattro virtù, corrispondenti ai quattro animali che stanno intorno alla sede divina (Ap 4, 6-8) – fede, pazienza, umiltà e speranza -, succede lo zelo igneo della carità proprio dello Spirito Santo e della sua sede sostenuta dai quattro animali. Così nei reprobi, ai quattro vizi contrari – infedeltà, impazienza, superbia, disperazione – subentra l’odio della fraterna carità, che è peccato contro lo Spirito Santo.
Questi temi – l’odio, corrodere la fama altrui, mangiare coi denti, vivere bestiale, il dolore del cuore, l’impazienza, la disperazione, l’accecamento – sono altrettanti fili del panno di cui è vestito il conte Ugolino. Coi denti rode il misero teschio dell’arcivescovo Ruggieri, come Tideo “si rose / le tempie a Menalippo per disdegno”, ed è un roderne la fama: “Ma se le mie parole esser dien seme / che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo” (Inf. XXXII, 127-132; XXXIII, 7-8). “Per sì bestial segno” mostra odio su colui che si mangia, ma ha anche il cuore oppresso da disperato dolore (Inf. XXXII, 133-134; XXXIII, 4-6). Mostra impazienza di fronte all’impassibilità senza pianto del poeta, che considera crudele (XXXIII, 40-42). Non solo si mangia il suo nemico, “come ’l pan per fame si manduca”, ma si morde per il dolore ambo le mani tanto che i figli pensano che lo faccia “per voglia di manicar”, lì dove le mani sostituiscono nella poesia il mordersi la lingua della prosa scritturale; mordersi che è anche rimorso carico d’ira, come quello (Ap 9, 5) indotto dalle pungitive e subdole locuste (Inf. XXXII, 127; XXXIII, 58-60). Brancola cieco sopra i figli morti (Inf. XXXIII, 72-73). Dopo il racconto, “con li occhi torti / riprese ’l teschio misero co’ denti” in modo ancor più ostinato di prima (vv. 76-77), variazione sul «“Et non egerunt penitentiam ex operibus suis”, scilicet malis, immo, supple, amplius obstinati sunt in illis peragendis» da Ap 16, 11 (esser ‘torto’, cioè ‘empio’, appartiene all’apertura del terzo sigillo, Ap 6, 5). I “denti, / che furo a l’osso, come d’un can, forti” (v. 78): nell’esegesi di Ap 22, 15 i cani sono i detrattori della vita altrui, come i malvagi su cui viene versata la quinta coppa. Si può notare che forse anche l’espressione “ma se le mie parole esser dien seme” (v. 7) suggerisce una caratteristica delle locuste, che “disseminant verba sua” (è la “vox alarum” trattata ad Ap 9, 9). Il sembrare Dante fiorentino all’ascolto della lingua pare rinviare allo stesso inciso da cui proviene il richiamo dei tre fiorentini sodomiti (vv. 11-12).
All’impazienza del conte ben si addice quella provocata dal versamento della quinta coppa:
Potest etiam effusio huius phiale exponi de pluribus corporalibus bellis et exterminiis temporalis regni ecclesie in hoc quinto tempore factis, ex quo multi per impatientiam se corroserunt et Deum blasphemaverunt.
■In Purg. VI, 82-84 a rodersi l’un l’altro sono i cittadini della “serva Italia”, chiusi da uno stesso muro e da uno stesso fossato, e invece sempre divisi da fazioni che si combattono. Il muro e il fossato sono motivi della Gerusalemme celeste, della “civitas” interpretata come “civium unitas” (Ap 21, 2 .12.18). I temi sono trattati nella settima visione.
Dello stesso tenore sono le parole di Brunetto Latini: “Faccian le bestie fiesolane strame / di lor medesme” (Inf. XV, 73-74), in un contesto (si tratta di una zona nella quale prevalgono i temi del quinto stato) dove l’aver fame del poeta da parte delle fazioni fiorentine si presta ad una variazione del versetto “et commanducaverunt linguas suas pre dolore”, cioè si rodano tra loro e non tocchino Dante, “sementa santa”.
Mordersi la lingua per livore d’invidia e per detrazione si addice ai Malebranche, i dieci demoni che, prima di andare in compagnia di Virgilio e Dante a sorvegliare i barattieri immersi nella pece, “avea ciascun la lingua stretta / coi denti, verso lor duca, per cenno”, cui Barbariccia risponde “con sì diversa cennamella” (Inf. XXI, 136-139; XXII, 10).
Tab. 4
Tab 4 bis (per l’esame compiuto di questa esegesi cfr. Il terzo stato. La ragione contro l’errore, II)
5. Parlare e lacrimare
■ Piangono i re della terra la caduta improvvisa e irreparabile della maledetta Babilonia, «“dicentes”, scilicet plangendo: “Ve, ve, ve”» (Ap 18, 10; l’esame compiuto di questa esegesi è stato condotto altrove). Triplicano la dolorosa interiezione, parlano di Babilonia in terza persona e poi in seconda, al modo di coloro che prima piangono con sé stessi, poi si rivolgono alla persona compianta. È il modo di Francesca: “dirò come colui che piange e dice” (Inf. V, 126), ove si passa dalla prima alla terza persona. E di Ugolino: “parlare e lagrimar vedrai insieme” (Inf. XXXIII, 9). Ai tre sodomiti che gli hanno chiesto (per bocca di Iacopo Rusticucci) se cortesia e valore dimorino “ne la nostra città sì come suole”, riferendosi ad essa in terza persona, Dante risponde direttamente in seconda persona, triplicando in modo anaforico: “La gente nuova e i sùbiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni” (Inf. XVI, 64-75). La dolorosa scritta sulla porta dell’inferno ripete per tre volte “Per me si va”; l’anafora distingue ancora il dire di Francesca, che ripete per tre volte “Amor”.
Le tardive lacrime che l’anima di Ugolino mescola al parlare sono state assenti nella sua prigionia – “Io non piangëa, sì dentro impetrai … Perciò non lagrimai né rispuos’ io” -, al contrario dei quattro fanciulli: “pianger senti’ fra ’l sonno i miei figliuoli … piangevan elli” (Inf. XXXIII, 38, 49-50, 52). Pianto che impetra nel “doloroso carcere” di questa vita un’apertura spirituale, per il desiderio di libertà dall’oppressione della nuova Babilonia; lacrime di una contrizione mancata (cfr. infra).
■ L’esegesi di Ap 1, 7 (“E lo vedrà ogni occhio”) riguarda tutti gli uomini, ma in particolare i malvagi – coloro che “punsero” sulla croce, offesero e disprezzarono Cristo – dei quali sarà proprio piangere, gemere, perdere la gloria, ed anche l’essere “punti”, offesi, dispetti. Scrive Giovanni allo stesso versetto: “Piangeranno tutte le tribù della terra”. Affinché gli si creda con maggiore certezza conferma ciò in duplice lingua, quella gentile e quella ebraica, dicendo: “Etiam. Amen”, cioè piangeranno veramente sé stessi. Entrambe le parole, la latina e l’ebraica (l’etiam latino traduce l’avverbio dal greco, lingua in cui il libro fu scritto) sono poste a ribadire che il pianto sarà vero pianto, confermato in ogni lingua, “gentile” (greco e latino) o ebraica, sia dai fedeli come dagli stessi reprobi, stimolati dall’esperienza della pena. Lo sviluppo nel poema dei motivi offerti da questa esegesi, e in particolare la doppia espressione asseverativa “etiam. amen”, è stato compiutamente esaminato altrove.
Nel rivolgersi al conte Ugolino (Inf. XXXII, 135-139), Dante varia i temi presenti ad Ap 1, 7: il piangere (“che se tu a ragion di lui ti piangi”, cioè dell’arcivescovo Ruggieri), il linguaggio che rende certo (“nel mondo suso ancora io te ne cangi, / se quella con ch’io parlo non si secca”).
All’apertura del sesto sigillo, un vegliardo domanda (“risponde”) a Giovanni: “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono”, cioè di quali e quante dignità sono insigniti, “e donde vengono?”, cioè per quali meriti e quale via di santità sono pervenuti a tanta gloria; e Giovanni, quasi discepolo a maestro: “Signore mio, tu lo sai”, come per dire: io non lo so ma insegnamelo tu che lo sai; e il vegliardo: “Essi sono coloro che sono venuti”, a tanta gloria, “attraverso la grande tribolazione”, cioè attraverso le grandi tribolazioni patite per Cristo. Questi versetti (Ap 7, 13-14), con i motivi che recano, sono ancillari di numerose agnizioni del poema. Si tratta di temi banali, per cui qualcuno chiede chi sia un altro, e da dove venga, tanto ovvi che li si ritrova nelle parole di Nestore a Telemaco (Odissea, III, 71): “ὦ ξει̃νοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλει̃θ’ ὐγρὰ κέλευθα”. Qui però si registra una rosa semantico-tematica, che rende unica quella forma comune di dire e la applica a qualsivoglia situazione. Si osservi il “ditemi chi voi siete e di che genti” di Inf. XXIX, 106, variante dell’inciso “et unde venerunt” di Ap 7, 13; il tema del rispondere di uno dei seniori è appropriato a uno dei due falsari (v. 110), mentre al verso 93 i motivi servono ai due ‘Latini’ per rivolgersi a Virgilio.
Il non sapere, proprio di Giovanni nei confronti del vegliardo, si insinua nelle parole di Ugolino: “Io non so chi tu se’ né per che modo / venuto se’ qua giù – hii … qui sunt … et unde venerunt … ego nescio, sed tu me doce quia tu hoc scis” (Inf. XXXIII, 10-11).
Né Ap 7, 13-14 discorda da quanto si afferma ad Ap 1, 7 sul piangere in ogni lingua, perché i vestiti di bianco dei quali interroga il vegliardo appartengono alla “turba magna” proveniente “ex omnibus gentibus … et linguis” (Ap 7, 9). Le fiere parole del conte rivolte in seguito al poeta – “e se non piangi, di che pianger suoli?” (v. 42) – significano allora ‘in che lingua sei solito piangere?’, al modo in cui Venedico Caccianemico afferma il suo piangere bolognese insieme agli altri (Inf. XVIII, 58-63). Così, ad Inf. XXIX, 106, il poeta chiede al falsari: “ditemi chi voi siete e di che genti”.
Tab. 5 (cfr. la trattazione compiuta di questa esegesi)
[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 10-12.14.17.19 (VIa visio)] Et ideo convertentur ad luctum “dicentes”, scilicet plangendo : “Ve, ve, ve” (Ap 18, 10), id est summa et summe stupenda et lugenda maledictio et dampnatio est ista, scilicet “civitas illa magna Babilon, civitas illa fortis, quoniam una hora venit iudicium tuum”, id est tota dampnatio tua! Loquuntur autem primo de ea in tertia persona et postea in secunda secundum modum plangentium et stupentium, qui primo stupent secum et mox vertunt considerationem suam quasi ad personam quam plangunt. Triplicatio autem dolorose interiectionis, scilicet ipsius “ve”, significat vehementiam stuporis et planctus et casus quem plangunt et etiam consuetum modum graviter plangentium. Et potest legi: Ve, ve, ve, civitas illa magna, quomodo sic cecidit vel cecidisti! […]
|
|
Inf. I, 52-60questa mi porse tanto di gravezza
|
Inf. IV, 31-42Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi 7, 13
|
Tab. 6 (cfr. la trattazione compiuta di questa esegesi)
6. La bocca sollevò dal fiero pasto
La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator, forbendola a’ capelli / del capo ch’elli avea di retro guasto (Inf. XXXIII, 1-3).
La parola-chiave per comprendere la terzina è sollevò. L’esegesi alla quale si riferisce è ad Ap 4, 1-2, già menzionata a proposito della petrosa durezza che ottunde i sentimenti nel fondo dell’inferno, e che ora viene considerata per l’aprirsi, sia pure momentaneo, all’intelligenza spirituale da parte del conte Ugolino.
Nella parte proemiale della seconda visione, Olivi spiega che il cielo che viene aperto a Giovanni designa la Chiesa e la Sacra Scrittura, e più precisamente la sua intelligenza spirituale. Come sulla porta della tomba di Cristo era posta una pietra grande e pesante che fu rimossa al momento della resurrezione e dell’uscita di Cristo dal sepolcro, così il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso alla sua intelligenza spirituale. Nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. L’assenza di grandi opere nella Chiesa era anch’essa come una porta chiusa che impediva di contemplare la “fabrica ecclesie”. Colui che per primo aprì la porta e diede voce per salire al cielo fu Cristo, con la sua illuminazione e dottrina. La voce degli antichi profeti, che chiuse la porta con figure e promesse terrene, oppresse il senso carnale dei Giudei piuttosto che elevarlo.
Cristo, invece, con l’esempio della sua vita spiritualissima, con la morte della sua carne e con l’abbondante infusione del suo Spirito, fece in modo che gli apostoli e qualunque uomo spirituale fossero in spirito e quasi non in carne (Ap 4, 2: “et statim fui in spiritu”), secondo quanto detto da san Paolo ai Corinzi: “L’uomo animale non percepisce né può comprendere le cose dello Spirito di Dio, l’uomo spirituale invece giudica ogni cosa”, cioè è dotato di discernimento (1 Cor 2, 14-15). Cristo, in Giovanni 10, 9, viene definito anche “porta” e “portiere”. Chi con chiara fede e intelligenza si fissa in lui in modo che gli venga incontro in ogni luogo della Scrittura e in ogni fatto della Chiesa, lo avrà in quei luoghi e in quei fatti come il sole che irraggia fugando le tenebre.
Il tema tradizionale della dura pietra rimossa dal sepolcro di Cristo, per cui si apre l’intelligenza spirituale della Scrittura, è in Olivi memore della visione che nella notte di Pasqua aprì a Gioacchino da Fiore la comprensione del libro dell’Apocalisse e di tutta la concordia dell’Antico e del Nuovo Testamento:
Circa medium (ut opinor) noctis silentium et horam qua leo noster de tribu Iuda resurrexisse extimatur a mortuis, subito mihi meditanti aliquid quadam mentis oculis intelligentie claritate percepta de plenitudine libri huius et tota veteris ac novi testamenti concordia revelatio facta est [1].
Il tema giovanneo di Cristo come porta – “Ego sum hostium. Per me, si quis introierit …” – inizia, con l’anafora del “per me”, i tre versi della prima terzina che contiene la scritta della porta dell’inferno. Su di essa sono scritte parole di colore oscuro e dal senso duro, non solo minacciose, ma pure chiuse a ogni illuminazione spirituale (Inf. III, 10-12). I motivi del chiudere e della durezza segnano la descrizione del fondo dell’inferno, “nel loco onde parlare è duro”, che necessita di rime “aspre e chiocce”: in suo aiuto il poeta invoca le Muse, che aiutarono il poeta Anfione “a chiuder Tebe” traendo con il suono della lira le pietre delle mura dalle falde del monte Citerone (Inf. XXXII, 10-14), secondo l’immagine suggerita dall’Ars poetica di Orazio (vv. 394-396) e dalla Tebaide di Stazio (VIII, 232-233; X, 873-877). È anche “cosa dura” dire della selva “selvaggia e aspra e forte” (Inf. I, 4-5). L’Inferno è il luogo dell’antica lapidea durezza, dell’impetrarsi, del parlare duro di cose dure a dirsi, del duro giudizio, del senso duro della scritta al sommo della porta, dei duri lamenti, dei duri demoni, dei duri veli del gelo, della gravezza.
Il tema della pietra rimossa che chiude la tomba, congiunto con quello della durezza, si trova nelle arche degli eretici, “monimenti” dai coperchi “sospesi” e “levati” fino al momento in cui verranno chiusi il giorno del giudizio, dai quali “fuor n’uscivan sì duri lamenti” (Inf. IX, 121-122; X, 8-12). Essere “sospesi” ha qui un senso proprio, da connettere alla contemplazione. Dei quattro animali che ad Ap 4, 6-7 sono in mezzo e intorno al trono della sede divina, quello simile a un’aquila che vola designa coloro che ‘sono sospesi nella contemplazione’. L’apertura del coperchio ‘sospeso’ delle arche allude alla possibilità di vedere il futuro da parte dei dannati. Farinata vede, cioè contempla, le cose che sono lontane nel tempo, senza sapere nulla degli eventi presenti. Ma questa “mala luce”, cui fa riferimento la sospensione del coperchio, verrà meno il giorno del giudizio allorché non ci sarà più futuro e l’avello verrà chiuso e con esso l’accesso all’illuminazione divina, che “ancor ne splende” e consente al ghibellino di profetizzare l’esilio di Dante.
Il levarsi quasi al di fuori del corpo, in puro spirito, viene sperimentato dal poeta nell’ascesa al cielo, cui viene levato grazie al lume divino riflesso in lui dagli occhi di Beatrice, e si esprime nelle parole “S’i’ era sol di me quel che creasti / novellamente, amor che ’l ciel governi, / tu ’l sai, che col tuo lume mi levasti”, cioè solo Dio sa se io ero solo anima o anche col corpo. Parole che, pur memori di quelle di san Paolo rapito al terzo cielo: “sive in corpore sive extra corpus nescio” (2 Cor 12, 2-4), rinviano all’esegesi: “fecit suos apostolos et quoscumque spirituales suos esse in spiritu et quasi non esse in carne”, per quanto fossero ancora in vita (Par. I, 73-75).
Di fronte al “muro” della fiamma, si apre la durezza di Dante al nome di Beatrice, “come al nome di Tisbe aperse il ciglio / Piramo in su la morte, e riguardolla” (Purg. XXVII, 34-42); i motivi del levarsi e del diradarsi delle tenebre sono, dopo l’ultima notte trascorsa sulla montagna, congiunti nella salita all’Eden: gli splendori antelucani mettono in fuga le tenebre e il sonno del poeta, il quale si leva “veggendo i gran maestri già levati”, cioè Virgilio e Stazio (vv. 109-114).
Il diradarsi delle tenebre è accostato al discernere (nel senso del discernere le cose dello spirito) nel Limbo: un “foco” rompe le tenebre a metà, e il poeta, pur da lontano, discerne che il luogo è posseduto da gente degna di onore (Inf. IV, 67-72).
Come all’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono a parlare “dal voler portate” verso un momento di mutazione e quasi di conversione, sebbene limitata al successivo colloquio, così il conte Ugolino “la bocca sollevò dal fiero pasto” per parlare di “come la morte mia fu cruda”. Anch’egli, in vita uomo di pietra del Vecchio Testamento, oppresso da un profetico sonno, partecipa da morto del Nuovo, della palingenesi del novum saeculum operante per mezzo del “poema sacro”. Sostiene Olivi che ogni stato o periodo storico, e in sé anche ogni individuo, partecipa in qualche modo di quello che è lo stato cristiforme per eccellenza, il sesto, coincidente con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Far parlare liberamente, per dettato interiore – la principale prerogativa del sesto stato – è tema che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo, anche nella vecchia roccia infernale. Parlare liberamente di Cristo appartiene alla sesta chiesa – ad essa è dato l’“ostium apertum”, che è “ostium sermonis” –, la porta aperta alla favella, il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà, come scrive san Paolo ai Colossesi (4, 3): “Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo”. Os (bocca) è affine a ostium (porta). Il conte Ugolino “la bocca sollevò”, aprendo la porta alla parola, proprio nel luogo dove l’intelligenza spirituale dovrebbe essere chiusa. Ma tutto l’Inferno è un contrappunto fra la durezza del giudizio, le bestemmie dei peccatori e l’apertura al ricordo della vita per la parola dirompente, finché essa dura, la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi per poi ricadere, come Ciacco, sollevarsi da atti bestiali per ritornare ad essi dopo aver parlato, come il conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per sé stesse mosse, sta un solo desiderio, di vivere ancora nel libro che è stato altrui aperto.
forbendola a’ capelli / del capo. Ugolino si purga temporaneamente dal suo atto bestiale parodiando la quarta perfezione di Cristo in quanto sommo pastore (Ap 1, 14; le dodici perfezioni sono premesse alla prima visione: per un esame compiuto della quarta cfr. altrove). Come i capelli del capo di Cristo, se assimilati alla lana, sono molli per il loro “humor sordium purgativus”, tali sono per il conte i capelli dell’arcivescovo, che avrebbe dovuto essere fidato pastore d’anime. L’esegesi fascia l’immagine di Tideo che “si rose / le tempie a Menalippo per disdegno” (Inf. XXXII, 130-131), tratta dalla Tebaide di Stazio, dove non è presente il motivo del purgarsi (VIII, 760-761): “atque illum effracti perfusum tabe cerebri / aspicit et vivo scelerantem sanguine fauces”.
La purezza della bocca è propria della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione. In essa i cittadini di una vera città, intesa come “civium unitas”, si specchiano come in un vetro terso per la confessione dei propri peccati (Ap 21, 18.21) [2]. Anche il parlare di Ugolino, a suo modo, è una confessione del peccato di Ruggieri, alla quale lo induce Dante – “sappiendo chi voi siete e la sua pecca” – in cambio del metterlo fra le sue vere note da riportare su nel mondo (Inf. XXXII, 135-139).
ch’elli avea di retro guasto. Il sintagma levarsi / di retro rinvia all’esegesi Ap 1, 10, nel punto in cui Giovanni sente una voce dietro le spalle, quasi quella del proprio duce. Si può intendere che egli era in quel momento dedito alla quiete della contemplazione, lontano dalla sollecitudine derivante dall’attività pastorale, che aveva lasciata alle spalle: la voce dunque lo richiama dalla visione delle cose supreme, che gli stanno dinanzi, alla cura d’anime che sta dietro (è l’interpretazione di Riccardo di San Vittore). Oppure (è l’interpretazione di Olivi), considerando che le cose che ci stanno dietro sono invisibili e pertanto superiori, si può intendere che Giovanni ascolti una voce alle spalle che lo elevi e riconduca verso l’alto, mentre con il volto è rivolto in basso, verso cose inferiori. In questo senso, nel Vangelo di Giovanni, si dice che Maria Maddalena, volta indietro, vide Gesù (Jo 20, 14). Al punto rinviano numerosi luoghi del poema. Ugolino ascolta la voce di Dante, solleva la bocca e si volge verso di lui come a qualcosa di più alto dell’atto bestiale al quale è intento. La parodia di Ap 1, 10 è presente anche a Inf. XVIII, 34-39, nel “levar le berze” da parte dei dannati, alle frustate dei demoni “che li battien crudelmente di retro” (cfr. anche Purg. IX, 69-70; XIX, 97-98, 118-119; Par. XXI, 130-132).
Se Ugolino, sollevando la bocca, si libera dalla bestialità per la durata del suo racconto, non così avviene in altri casi.
L’“os”, cioè l’“effrenata locutio … que quidem per sevitiam ire est ignea, et per confusam et tumultuosam obscurationem veritatis et sanctitatis christiani cultus est fumus …”, propria dei cavalieri pseudoprofeti dell’Anticristo (Ap 9, 17; per un esame compiuto cfr. altrove), è quella del gigante Nembrot dalla “fiera bocca” toccata dall’ “ira o altra passïon … anima confusa”, come gli dice Virgilio (Inf. XXXI, 67-75).
Nella descrizione della bestia che ascende dal mare, posta all’inizio del capitolo XIII (Ap 13, 1), si dice che essa ha sette teste e dieci corna, e sulle sue teste nomi di blasfemia. Olivi spiega trattarsi di coloro che si gloriano nel bestemmiare Cristo e i suoi, e in questo sono più famosi degli altri: il nome designa infatti l’essere noto e la fama, lo stare sul capo significa la gloria. Sono motivi recitati in Inf. XXXII, 85-99 da Bocca degli Abati, il traditore di Montaperti bestemmiante e renitente a dare il proprio nome al poeta perché gli dia fama mettendolo “tra l’altre note”. Alla bestia (che designa la gente bestiale) è data la bocca per bestemmiare (Ap 13, 5-6). Alla fine del capitolo (Ap 13, 18), viene spiegato il 666, il “numero del nome” della bestia, che in greco è “Antemos”, cioè contrario. E Bocca brama il contrario della fama e dell’essere nominato e apostrofa Dante come colui che va per l’Antenora, luogo che ha un significato storico-letterale (dalla leggenda medievale della proditoria consegna del Palladio e dell’apertura del cavallo da parte del troiano Antenore) ma consonante con il nome dell’Anticristo costruito sul numero della bestia. L’Anticristo viene d’altronde interpretato come apostata, ed è questa una parte ben assegnabile al malvagio traditore immerso nel ghiaccio di Cocito.
Lo stesso tema dell’essere nominati e famosi si applica in tutt’altra situazione (e in terzine in parte numericamente corrispondenti), allorché Stazio racconta della sua fama di poeta coronato di mirto (Purg. XXI, 85-91). E Stazio, nome del poeta famoso “ancor di là”, segna un’altra coincidenza tra senso letterale e senso spirituale, consonando con la statio in capite che designa la gloria.
[1] Cfr. Expositio, pars I, ff. 39rb-40va: f. 39va; G. L. POTESTÀ, Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Bari 2004, pp. 344-347. Non c’è in Olivi il senso di identificazione con l’evangelista Giovanni presente in Gioacchino da Fiore, per quanto esista una generica testimonianza su una sua illuminazione avuta in una chiesa di Parigi [cfr. D. BURR, The Persecution of Peter Olivi, Philadelphia 1976 (Transactions of the American Philosophical Society, 66/5), pp. 5, nt. 1; 73].
[2] Cfr. La settima visione, I.1.
Tab. 8
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 18.21 (VIIa visio)] Postquam autem dixit quod materia muri erat ex iaspide, dicit (Ap 21, 18): “Ipsa vero civitas”, scilicet erat “aurum mundum simile vitro mundo”. Et infra, postquam egit de materia portarum, subdit (Ap 21, 21): “Et platea civitatis”, scilicet erat, “aurum mundum, tamquam vitrum perlucidum”. Et forte secundum litteram primum dixit de domibus ex quibus constabat civitas, ultimum vero de toto fundo seu planitie intra muros contenta. Per utrumque autem designatur generalis ecclesia et principaliter contemplativorum, sicut per muros militia martirum et pugilum seu defensorum interioris ecclesie, que est per unitatem concordie “civitas”, id est civium unitas, et per fulgorem divine caritatis et sapientie aurea, et per puram confessionem veritatis propria peccata clare et humiliter confitentis et nichil falso simulantis est “similis vitro mundo”, et per latitudinem caritatis et libertatem ac communitate[m] evangelice paupertatis est “platea” celis patula, non tectis clausa, nec domibus occupata, nec domorum distinctionibus divisa, nec isti vel illi instar domorum appropriata, sed omnibus communis et indivisa. Et quia in tertio generali statu, statutis duodecim portis eius, fulgebit singulariter evangelica paupertas et contemplatio, ideo non fit mentio de platea nisi post portas, et ubi mox subditur quod solus Deus est templum et sol huius civitatis (cfr. Ap 21, 22-23). Unde et platea non solum dicitur esse “aurum simile vitro mundo”, id est perspicuo et polito et nulla macula vel pulvere obumbrato, sed etiam dicitur esse sicut “vitrum perlucidum”, id est valde lucidum, quia tunc maior erit cordis et oris puritas et clarior veritas. In ecclesia vero beatorum erit tanta, ut omnia interiora cordium sint omnibus beatis mutuo pervia et aperta.
|
|
Inf. XXXII, 133-139; XXXIII, 1-3“O tu che mostri per sì bestial segno
|
Inf. XVIII, 34-39Di qua, di là, su per lo sasso tetro
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 1-2 (radix IIe visionis)] Nota etiam quod hec sibi sic monstrantur et sic nobis scribuntur, quod sint apta ad misteria nobis et principali materie huius libri convenientia. Unde per celum designatur hic ecclesia et scriptura sacra, et precipue eius spiritalis intelligentia. Sicut autem in hostio monumenti Christi erat superpositus magnus lapis et ponderosus, qui Christo resurgente et de sepulcro exeunte est inde amotus, sic in scriptura erat durus cortex littere, pondere sensibilium et carnalium figurarum gravatus, claudens hostium, id est [ad]itum intelligentie spiritalis. In humanis etiam cordibus erat lapidea durities sensus obtusi, claudens introitum divinarum illuminationum.
|
|
Purg. IX, 67-72mi cambia’ io; e come sanza cura
|
Purg. XIX, 97-99, 118-120Ed elli a me: “Perché i nostri diretri
|
Tab. 9
7. Disperazione, dolore e tristezza nella “seconda morte”
La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati della storia della Chiesa, cioè alle categorie con cui l’Olivi organizza la materia esegetica. Questo ordine interno è registrabile per zone progressive del poema dove prevale, tramite le parole-chiave, la semantica riferibile a un singolo stato. È un ordine dirompente i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ogni stato, che ha differenti inizi, è concatenato per concurrentia, come le maglie di un’armatura, con quello che precede e con quello che segue. Ciascuno stato ha in sé una grande ricchezza di motivi e contiene inoltre temi di tutti gli altri stati, consentendo innumerevoli intrecci e variazioni. Si possono in tal modo redigere mappe che comprendano l’ordine spirituale della Commedia. La ricerca, collocata su un sito per sfruttare gli spazi offerti dalla rete, è pervenuta a una Topografia spirituale della Commedia, dove per quasi ogni verso, o gruppo di versi, collegamenti ipertestuali conducono al “panno” esegetico fornito dalla Lectura super Apocalipsim, sul quale il “buon sartore” ha fatto “la gonna”.
La ‘topografia spirituale’ del poema mostra dunque nell’Inferno cinque cicli settenari corrispondenti agli stati della Chiesa descritti dall’Olivi e ai loro temi contenuti nella Lectura. Questi cinque cicli designano le prime cinque età del mondo [1] (riunite a loro volta nel primo stato generale, che corrisponde alla gioachimita età del Padre), in quanto prefigurazione del primo avvento di Cristo e della Chiesa. L’Inferno è dunque il Vecchio Testamento, duro, petroso, involuto e oscuro nelle sue profezie, che ricade sui tempi moderni.
Il quinto ciclo settenario dell’Inferno, più stretto e breve degli altri, registra con Ugolino e Frate Alberigo, tra Antenòra e Tolomea (Inf. XXXIII), il prevalere della semantica propria del secondo stato, quello dei martiri; il terzo si manifesta con Lucifero (Inf. XXXIV). La dipartita dall’inferno lungo il corpo di Lucifero mostra in rapidissima successione temi del quarto e del quinto stato, mentre il volgersi di Virgilio “a punto in sul grosso de l’anche” segna il passaggio al sesto stato.
Nei precedenti cicli, il viaggio nella storia della Chiesa allargata a tutto il mondo umano ha toccato zone dedicate al secondo stato con i canti dedicati ai lussuriosi (V), ai violenti contro il prossimo (XII), ai ruffiani (XVIII), ai consiglieri di frode latini (XXVII). Personaggi di primo piano, come Francesca e Guido da Montefeltro, sono stati fregiati di segni che rinviano la memoria dell’accorto lettore dal senso letterale all’esegesi del secondo stato. Quei personaggi si collocano in una zona dedicata ai martiri non nel senso che sono assimilabili ai martiri dei primi tempi cristiani, ma perché, di fronte al martirio psicologico dei tempi moderni, furono ingannati da una falsa immagine di Scrittura (Francesca), di autorità papale (Guido) o dal dubbio che tradisce e induce alla disperazione (Ugolino).
Scorrendo i versi di Inferno XXXIII, zona dedicata al secondo stato, ai martiri che sostennero e sostengono le tentazioni, il lettore accorto avrebbe dunque ritrovato, parodiati e torti all’esigenza, alcuni temi ad esso relativi.
Alla seconda chiesa d’Asia, Smirne, e al suo vescovo (prima visione: Ap 2, 8; l’esame compiuto delle tabelle 10, 11, 13 è stato condotto nello studio su Francesca, cap. 2 e 3), Cristo dice che l’esempio della sua morte e la speranza della vita che per essa si è meritata e il suo potere debbono animare ai martìri; in essi non si deve diffidare ma anzi sperare di conseguire la vita eterna. All’opposto sta Ugolino nei confronti dell’arcivescovo che rode: “Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri, / fidandomi di lui, io fossi preso / e poscia morto, dir non è mestieri” (Inf. XXXIII, 16-18). Come Francesca e Paolo leggevano di Lancillotto “sanza alcun sospetto”, e Guido da Montefeltro si fidò di Bonifacio VIII, così il conte Ugolino nei confronti dell’arcivescovo Ruggieri.
Per questo il conte è “vicino” all’uomo di chiesa, suo concittadino e traditore (Inf. XXXIII, 15). Uccidere parenti e “vicini” è tema proprio dell’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 4), la cui esegesi incide profondamente sulle parole di Francesca, uccisa dal marito insieme all’amante. Al termine del canto, frate Alberigo racconta del genovese Branca Doria, che lasciò un diavolo in sua vece nel proprio corpo, ancora vivo su in terra, insieme ad “un suo prossimano”, cioè ad un suo parente che l’aiutò nel tradimento verso il suocero Michele Zanche (vv. 142-147).
Ugolino vuole che Dante oda “come la morte mia fu cruda” (Inf. XXXIII, 20-21). Essere vinto dai propri uccisori con una morte crudelissima corrisponde (Ap 5, 1) all’angustia la quale, fra le caratteristiche della passione di Cristo giudicate secondo il senso umano, rende chiuso il secondo sigillo, alla cui apertura il festoso canto dei martiri mostra come nella croce di Cristo sia consolazione e gloria piuttosto che angustia e tribolazione, secondo quanto scritto da san Paolo ai Romani (Rm 5, 3) e ai Corinzi (2 Cor 1, 3-5). La stessa seconda chiesa, Smirne, viene interpretata come “cantico”: i quattro figli del conte Ugolino, innocenti e posti “a tal croce” dai Pisani, sono nominati nel “canto” (v. 90).
Poi cominciò: “Tu vuo’ ch’io rinovelli / disperato dolor che ’l cor mi preme” (Inf. XXXIII, 4-5).
La seconda vittoria consiste nel vittorioso conflitto con il mondo e le sue tentazioni, e corrisponde alla lotta dei martiri contro l’idolatria pagana. Di essa si dice: “Chi avrà vinto non sarà leso dalla seconda morte” (Ap 2, 11), in quanto chi avrà sostenuto vittoriosamente i mortali dardi delle tentazioni e delle mortificazioni sarà degno di non essere leso dalla morte eterna. La “prima morte”, quella per cui si estingue la vita naturale, percuote i corpi; la “seconda morte” consiste invece nella tristezza del cuore, nel terrore, nella disperazione e costernazione provocati dalla persecuzione del corpo o dal suo incombere. La seconda è anche la morte indotta dalla pena eterna, che viene così chiamata perché in essa è estinto ogni diletto o riposo: ivi è dolore perpetuo peggiore della morte e che la fa continuamente desiderare (Ap 20, 6). I martiri trionfatori, sicuri del regno della vita eterna, non temono la seconda morte e non la sentono, nel senso che da essa non vengono lesi. Per questo la chiesa di Smirne, oltre che “amara” come la mirra, viene interpretata anche come “cantico”, poiché i santi esultano e si gloriano nelle passioni, come dichiara san Paolo ai Romani: “Ci gloriamo nelle tribolazioni” (Rm 5, 3).
“Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli / pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava; / e se non piangi, di che pianger suoli?” (Inf. XXXIII, 40-42). In questi “fieri accenti … usciti dalla sincerità di un dolore impaziente e sdegnoso” (De Sanctis) [2], l’annunzio del cuore deriva anch’esso dall’esegesi della seconda chiesa, propria dei martiri – alla quale Cristo predice le future passioni e la tribolazione in carcere (Ap 2, 10). Il cuore del conte Ugolino, carcerato nella Muda al quale il “mal sonno” squarciò il velo del futuro, è gravido di tristezza, sperimenta il “disperato dolor” proprio della seconda morte. I temi sono già presenti nelle Arpie che fanno i lor nidi nella selva dei suicidi, “che cacciar de le Strofade i Troiani / con tristo annunzio di futuro danno” (Inf. XIII, 10-12) [3]. I vittoriosi martiri non provano la tristezza del cuore (Ap 2, 11), le tentazioni non sono ordinate a loro danno (Ap 2, 10); ma Pier della Vigna, spirito incarcerato, è “anima lesa” dalla seconda morte (v. 47). Di questa prova gli effetti, senza venirne leso, l’anima di Rinieri da Calboli, che nel secondo girone del purgatorio si fa trista “a l’annunzio di dogliosi danni” fatto dal suo compagno di pena Guido del Duca (Purg. XIV, 67-72).
I versi “Poi cominciò: Tu vuo’ ch’io rinovelli / disperato dolor che ‘l cor mi preme” hanno un’origine che, se analizzata, avvicina uno dei possibili metodi della tessitura dantesca. Il dolore del cuore e la disperazione sono già presenti nella quinta coppa, appropriati alla sede della bestia (Ap 16, 10-11; cfr. supra), ma altri passi, posti a confronto, intervengono ad arricchire di significati la drammatica frase memore dell’“infandum, regina, iubes renovare dolorem” di Enea a Didone (Aen., II, 3).
-
Il rinovellare, in primo luogo, proviene da Ap 16, 16, il passo della sesta coppa in cui la guerra contro l’Anticristo viene assimilata alla morte in Megiddo di re Giosia, pianto con forte lamento da Geremia e da tutta la Giudea: questo pianto si è rinnovato al momento della morte di Cristo e si rinnoverà alla fine dei tempi quando una grande tentazione si accompagnerà a un nuovo grande pianto della croce di Cristo e dei suoi martiri (non a caso il luogo della battaglia finale sarà l’“Armagedon”, interpretato come “insorgere della tentazione”).
-
Il tema della tentazione conduce da Ap 16, 16 alla seconda vittoria (Ap 2, 11) propria dei martiri che ne hanno sostenuto i ‘mortiferi’ dardi. Costoro non incorreranno nella “seconda morte”, cioè nella tristezza del cuore e nella disperazione che atterrisce chi cade nella morte eterna. Ad Ap 20, 6 la “seconda morte” è segnata dal dolore perpetuo peggiore della morte e che fa questa sempre desiderare.
-
Il tema della tentazione ‘mortifera’ conduce al ‘mortifero’ dolore che ad Ap 14, 20 contraddistingue l’uscita del sangue dal lago “calcato” propria della settima e ultima guerra: si tratta di un dolore di tale forza quasi il sangue e i visceri dei dannati fuoriuscissero per ridondare in un gran fiume o in un mare di dolore amarissimo.
-
Ancora, il sintagma ‘mortifero’ / ‘calcare’ conduce al premere, che ad Ap 19, 15 designa la durezza dell’ira divina paragonata al furibondo premere calcando le uve in un torchio. Anche ad Ap 11, 1-2 l’essere “calcati” e la “disperazione” sono appropriati ai reprobi.
-
‘Temptatio’, ‘mortiferus’, nei passi della Lectura, sono come cellule musicali le quali, richiamate più volte, adducono altri motivi che concorrono a formare i versi.
Il testo dottrinale contenuto nella Lectura, prima di travasarsi semanticamente nella Commedia, subisce una duplice riorganizzazione. La prima, sulla base delle indicazioni dello stesso Olivi, secondo il materiale esegetico attribuibile ai singoli stati. La seconda, seguendo il principio applicato nelle distinctiones ad uso dei predicatori, secondo lemmi analogicamente collazionati. La “mutua collatio” di parti della Lectura arricchisce il significato legato alle parole e consente uno sviluppo tematico amplificato. Si vedano, ad esempio, le variazioni eseguite sul tema della “voce” o sull’espressione “in medio”, temi più volte iterati nel sacro testo, oppure il modo con cui Ap 1, 16-17 (l’esegesi della decima e undecima prefezione di Cristo come sommo pastore) percorre i versi in collazione con altri passi.
Per Ugolino parlare a Dante è come una nuova tentazione, dopo aver fallito nel sostenere quella che lo ha condotto alla tristezza e alla disperazione della “seconda morte”, al mare di dolore amarissimo che gli opprime il cuore. Quella provata in vita, e che egli non vinse, fu un rinnovarsi della croce di Cristo. Come rimprovera il poeta a Pisa, “non dovei tu i figliuoi porre a tal croce”, e in questo senso il disperato “tu vuo’ ch’io rinovelli” del conte è da accostare al “veggio rinovellar l’aceto e ’l fiele” detto da Ugo Capeto che profetizza l’attentato di Anagni (Purg. XX, 89).
[1] Cfr. LSA, ad Ap 17, 9: «Et subdit Ricardus quod per septem reges, et per septem capita designatos, designatur hic universus populus malorum, qui secundum septem status huius seculi determinantur. Primus scilicet ab Adam usque ad Noe. Secundus a Noe usque ad Abraam. Tertius ab Abraam usque ad Moysen. Quartus a Moys[e] usque ad David. Quintus a David usque ad Christum. Sextus a Christo usque ad Antichristum. Septimus autem sub Antichristo attribuitur» (Par. lat. 713, f. 172ra).
[2] DE SANCTIS, L’Ugolino di Dante, p. 37.
[3] Nella selva dei suicidi (secondo girone del VII cerchio) il gruppo tematico prevalente appartiene al terzo stato; permangono tuttavia numerosi elementi propri del secondo, dei martiri.
Tab. 10 (l’esame integrale è stato condotto altrove)
[LSA, cap. II, Ap 2, 8.10 (Ia visio, IIa ecclesia)] Hiis autem premittitur primo iussio de scribendo hec episcopo huius ecclesie. Et secundo Christi loquentis introductio, et hoc sub forma sequentibus congruente, ibi (Ap 2, 8): “Hec dicit primus et novissimus”, id est cuius eternitas antecedit et principiat omnia, et est ultra omnia etiam futura, et finit ac consumat omnia, quasi dicat: non diffidas te a tuis passionibus per me salvandum, quia ego sum omnium principium et consumator.
|
|
Inf. II, 10-12, 28-30, 34-35Io cominciai: “Poeta che mi guidi,
|
Inf. XXVII, 43-45, 100-105
|
Tab. 11 (l’esame integrale è stato condotto altrove)
16, 16 |
2, 11; 20, 6(secunda mors) |
14, 20; 19, 15; 11, 1-2(calcatus est, calcat, calcabuntur) |
renovabiturtemptationis |
tristitia cordisterror desperativusdolor perpetuusmortifera … temptationis |
mortiferi dolorispremit penis mortiferisdesperate |
Tab. 13 (l’esame integrale è stato condotto altrove)
[LSA, cap. VI, Ap 6, 4 (IIa visio, apertio IIi sigilli)] Subdit ergo: “Et ecce alius”, id est ab equo albo valde diversus, “equus rufus”, id est exercitus paganorum effusione sanguinis sanctorum rubicundus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet romanus imperator vel diabolus, “datum est ei ut sumeret”, id est ut auferret, “pacem de terra”, id est a Deo permissum est ut persequeretur fideles; “et ut invicem se interficiant”, id est ut pagani interficerent corpora fidelium et etiam quorundam fidem, sancti vero interficerent infidelitatem et pravam vitam plurium paganorum, convertendo scilicet eos ad Christum. Vel, secundum Ricardum, “ut invicem se interficiant”, id est ut ipsi persecutores non solum interficiant alienos et remotos, sed etiam suos parentes et notos et domesticos et vicinos *.* In Ap II, v (PL 196, coll. 763 D –764 A). |
|
Inf. V, 97-102, 107Siede la terra dove nata fui
|
Inf. XXIII, 103-108Frati godenti fummo, e bolognesi;
|
[LSA, prologus, Notabile VII] Rursus sicut omnis dies habet mane, meridiem et vesperam, sic et omnis status populi Dei in hac vita. Nam in eterna erit semper meridies absque nocte. Ergo tempus plenitudinis gentium sub Christo debuit ante conversionem alterius populi, scilicet iudaici, habere mane et meridiem et vesperam. Et sic quasi iam vidimus esse completum et a Iohanne in hoc libro descriptum. Nam eius mane commixtum tenebris idolatrie fuit ab initio conversionis gentium usque ad Constantinum. |
[LSA, cap. II, Ap 2, 10 (Ia visio, IIa ecclesia)] “Nichil horum timeas que passurus es” (Ap 2, 10), quasi dicat: passurus quidem es multa, sed non oportet te timere illa, tum quia ego tecum semper ero et protegam, tum quia non sunt ad tuum dampnum, sed potius ad probationem et ad amplius meritum et ad maioris corone triumphum et premium, quia vero iacula que previdentur minus feriunt, et previa preparatio et animatio sui ad illa constanter toleranda multum confert. |
8. Il “doctor anagogicus” infernale
però quel che non puoi avere inteso … cacciando il lupo e ’ lupicini al monte / per che i Pisan veder Lucca non ponno (Inf. XXXIII, 19, 29-30).
Nella settima visione, l’autore dell’Apocalisse tratta della gloria di Gerusalemme, cioè della totalità degli eletti, lì dove dice: “E io, Giovanni, vidi la città santa di Gerusalemme” (Ap 21, 2). Questa viene descritta dapprima sommariamente, poi in modo più compiuto per mezzo di un angelo. Ciò perché, secondo Riccardo di San Vittore, Giovanni prima vede in modo inferiore e poi in modo più alto. Secondo Gioacchino da Fiore, la prima descrizione è riferita alla gloria della Chiesa peregrinante in terra, la seconda alla gloria della Chiesa regnante nei cieli dopo il giudizio. Così Giovanni può vedere da solo nel primo caso, mentre nel secondo necessita dell’aiuto di un angelo. Molte sono le cose della Chiesa presente che i discepoli della verità possono non solo leggere e comprendere, ma anche vedere con gli occhi e ascoltare con gli orecchi; ma la Gerusalemme celeste non può essere veduta con gli occhi né si trova espressa nelle Scritture. Per essa si rende necessario un dottore spirituale che tragga i discepoli che hanno raggiunto la perfezione all’intelletto anagogico, in modo che da quel che è noto della città peregrinante in terra vengano rapiti alla visione spirituale della città che regna nei cieli. Il monte sul quale viene levato Giovanni (Ap 21, 10) è pertanto l’intelletto anagogico, grande e alto perché apprende cose grandi e sublimi, come la lettera apprende ciò che è transitorio e terreno e l’allegoria lo stato della Chiesa peregrinante che opera in un certo modo tra cielo e terra.
■ Il tema del rapimento dal peregrinare terreno alla visione spirituale è presente nel sogno, il primo dei tre fatti sulla montagna del purgatorio, allorché il poeta, nell’ora mattutina in cui la mente è “peregrina / più da la carne e men da’ pensier presa”, si vede rapito dall’aquila alla sfera del fuoco, come Ganimede sul monte Ida “quando fu ratto al sommo consistoro” (Purg. IX, 13-33). Il “foco”, nel quale il poeta arde insieme all’aquila, introduce il tema iniziale del capitolo XXI – il rinnovamento della carne per mezzo della conflagrazione finale: “Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap 21, 1) -; esso è collocato tra l’atmosfera e il cielo della luna, cioè in quello stato tra cielo e terra proprio della Chiesa peregrinante e che corrisponde al senso allegorico della Scrittura.
■ La montagna della purgazione, in cima alla quale sta l’Eden, viene definita “nova terra” da Ulisse (Inf. XXVI, 137). Alla fine dei cinque mesi di viaggio al di là dei “riguardi” posti da Ercole, a Ulisse apparve una montagna, alta e bruna per la distanza (Inf. XXVI, 133-135). Si fondono qui due passi, il primo dal Notabile XIII del prologo della Lectura, il secondo dalla settima visione (Ap 21, 2). Nel Notabile XIII Olivi paragona i tre fini della storia umana, cioè i tre avventi di Cristo, a un grande monte con tre vette, contenente al proprio interno due grandi valli. A chi guarda dalla distanza, il monte appare uno, non trino: tale fu la prospettiva degli Ebrei che vennero prima dell’avvento di Cristo, e quella dei profeti che non distinsero i tre fini. I cristiani che vivono nei primi cinque stati dopo la venuta di Cristo si trovano sulla prima vetta, in condizione di vedere la prima valle chiusa da due dossi: distinguono pertanto lo spazio temporale in cui, tra il primo avvento (nella carne) e l’ultimo (nel giudizio), avviene la conversione delle genti ma non percepiscono lo spazio che sta tra il secondo avvento (nello Spirito, o meglio nei discepoli spirituali), proprio del sesto stato allorché verrà ucciso l’Anticristo, e l’ultimo. Coloro che si trovano a vivere nel sesto stato, o che lo vedono in spirito (come “il calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato”, che altrove, ad Ap 6, 12, Olivi afferma aver visto per rivelazione in spirito, nella sua terza età, il sesto stato), hanno la visione compiuta, poiché trovandosi sulla mediana delle tre vette distinguono tra il primo e il terzo avvento, che alla fine dei tempi sarà segnato dalla conversione di Israele. Essi vedono chiaramente i tre fini nelle profezie dell’Antico Testamento, ove erano oscuramente involuti, e si rendono conto che ogni novità intervenuta nel corso della storia umana è segno figurativo della mutazione e del rinnovamento operati dai tre avventi, verso i quali tutto corre. La prospettiva di coloro che vennero prima di Cristo, i quali videro dalla distanza “una montagna”, è quella di Ulisse [1].
■ La montagna vista da Ulisse, “bruna per la distanza”, è “alta tanto” in quanto rappresenta il senso anagogico, l’intelligenza delle cose spirituali: è la montagna sulla cui cima sta il Paradiso terrestre, dove Dante vedrà forti cose a mettere in versi. Una variante del tema è il monte dove si svolge la caccia al conte Ugolino e ai suoi figli, monte che impedisce ai Pisani di vedere Lucca che, in questo caso, va interpretata come una visione più alta (Inf. XXXIII, 28-30). Senso confermato dalla profezia fatta nel sesto girone del purgatorio da Bonagiunta, il quale mormora al poeta un nome, “Gentucca”, di “femmina … che ti farà piacere / la mia città, come ch’om la riprenda” (Purg. XXIV, 43-45). Quella che letteralmente può sembrare un’incidentale indicazione geografica contiene in sé un preciso concetto espresso nell’esegesi apocalittica oliviana. La vista dei Pisani è limitata come nell’Antico Testamento, quando la montagna distinta in tre cime separate da valli, corrispondenti ai tre fini della storia umana (i tre avventi di Cristo: nella carne, nello Spirito e nel giudizio finale), appariva per la distanza agli Ebrei, prima della Redenzione, come un solo monte.
Al termine del viaggio, Dante si ritrova nella Roma celeste come un pellegrino nel tempio del suo voto (Par. XXXI, 43-44). È san Bernardo a trarlo, dal suo peregrinare, al senso anagogico e a fargli levare gli occhi “quasi di valle andando a monte” cosicché veda la regina del cielo, perché “quest’ esser giocondo / … non ti sarà noto, / tenendo li occhi pur qua giù al fondo” (vv. 112-123). Il tema del dottore che mostra cose che non possono essere vedute, ascoltate, o che non si trovano scritte, sta pure nelle parole del conte Ugolino, del quale Dante conosce già la storia ma non può avere inteso come fosse stata cruda la sua morte (Inf. XXXIII, 19-21). All’estremo opposto, in Cocito e nell’Empireo, Ugolino e Bernardo svolgono in forma diversa la funzione di “doctor anagogicus”.
____________________________________________________________________________________________________________________
[1] L’immagine oliviana del monte trino e uno, che nel Notabile XIII del prologo della Lectura designa la storia umana che corre verso i tre avventi di Cristo, giustificanti qualunque “mutatio veterum et institutio novorum” fatta precedentemente, è probabile adattamento di un passo di Gioacchino da Fiore. L’abate florense, nell’Expositio super Apocalypsim, usa l’immagine di una città, che può essere vista da lontano, dalla porta o dall’interno: «Aliud est enim videre multa, aliud omnia. Aliter videtur civitas cum adhuc per dietam longius distat, aliter cum venitur ad ianuam, aliter cum pergitur intus. Nos igitur qui ad ianuam sumus multa quidem loqui possumus, que aliquando ex toto vel ex parte latebant, sed non sicut hi qui erunt intus et oculo ad oculum videbunt» (Expositio in Apocalypsim, pars IV, distinctio VII, f. 175rb; cfr. F. SANTI, La Bibbia in Gioacchino da Fiore, in La Bibbia nel Medioevo, a cura di G. Cremascoli e C. Leonardi, Bologna 1996, pp. 266-267). Olivi sposta in avanti la posizione che Gioacchino assegna a sé stesso. La vista della città da lontano coincide con il vedere il monte dalla distanza (da parte di coloro che vennero prima di Cristo); lo stare sulla porta corrisponde, nel francescano, allo stare sul primo dei tre dossi; lo stare dentro agli altri due. Il vedente di Olivi, che vive nel sesto stato, sta sul secondo di questi e abbraccia con lo sguardo le tre vette e le due valli che le separano. Si trova dunque all’interno. L’altra immagine oliviana, che descrive il procedere per gradi della “fabrica ecclesie” come un albero che cresce successivamente dalle radici alle foglie, ai fiori, ai frutti (ad Ap 21, 16) è esaminata in P. VIAN, Tempo escatologico e tempo della Chiesa: Pietro di Giovanni Olivi e i suoi censori, in Sentimento del tempo e periodizzazione della storia nel Medioevo, Atti del XXXVI Convegno storico internazionale. Todi 10-12 ottobre 1999, Spoleto 2000 (Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina / Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale dell’Università degli Studi di Perugia), pp. 163-164.
Tab. 14 (l’esame integrale è stato condotto altrove)
9. L’orribile torre
Nella torre dei Gualandi, dove è rinchiuso coi quattro fanciulli, Ugolino vede attraverso una feritoia trascorrere più lunazioni (otto mesi: la prigionia durò dal 1° luglio 1288 al marzo 1289). Le parole del racconto fanno segno della fine della sua vita con i motivi che nell’esegesi sottolineano la fine del mondo, figurata dal settimo stato della storia della Chiesa e dalla settima, breve e ultima visione apocalittica: “Ut enim monstretur quod illa erit finis et terminus huius seculi et brevis respectu priorum temporum … Breve pertugio dentro da la Muda … m’avea mostrato per lo suo forame / più lune già (prologo, Notabile III; Inf. XXXIII, 22, 25-26).
“Più lune già”. Nella Muda, dove si rinchiudono gli uccelli a cambiare le penne, il tempo del conte è scandito dalla mutevole e fredda luna, che designa la scorza che nella legge del Vecchio Testamento chiudeva il senso spirituale. La luna è anche figura della fine di Ulisse. Cinque lunazioni sono passate da quando l’eroe greco e i suoi compagni sono entrati “ne l’alto passo”, in quello che fu un vero e proprio viaggio nel futuro della storia umana, un’andata sensibile al sesto stato della storia della Chiesa, verso un lido allora noto unicamente a Dio, andata che solo un uomo evangelico avrebbe potuto compiere. I versi “Cinque volte racceso e tante casso / lo lume era di sotto da la luna” (Inf. XXVI, 130-131) descrivono una situazione inversa rispetto a quella che, nella radice della quarta visione apocalittica, vede la donna vestita di sole (la Chiesa) tenere la luna, simbolo di ciò che è mutevole e mondano, sotto i piedi come serva (Ap 12, 1): qui cinque volte la luce del sole si era nuovamente accesa “di sotto da la luna” e altrettante spenta, il che allude alle continue mutazioni (la luna designa la sapienza mondana, propria di Ulisse) ma anche allo stare il sole “sotto” la luna che regge e non viceversa.
Il libro dell’Apocalisse, scrive Olivi (prologo, Notabile IV), è chiuso e velato, come nell’Antico Testamento, per quanti sono esclusi dalla Grazia. Solo a chi è degno è data la chiave per aprirlo o il passaggio per entrarvi. Il “breve pertugio” non aprì a Ugolino il libro; le involute mutazioni della luna gli recarono l’ingannevole “mal sonno”.
« […] “E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro voce” (Ap 10, 3). Secondo Gioacchino da Fiore, questi sette tuoni sono i sette spiriti di Dio che emettono universalmente su tutta la terra, come dal terzo cielo, voci spirituali e allegoriche concordi col ruggito dell’angelo sia nel rivelare le grandi cose e gli arcani della gloria di Dio e delle sue opere, soprattutto di quelle che si compiono nelle menti contemplative, sia nel proclamarne i terribili giudizi. […]
Segue: “Io ero pronto a scrivere quando udii una voce dal cielo che mi disse: Chiudi sotto sigillo”, cioè quasi con sigillo fermo nel tuo cuore, “quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo” (Ap 10, 4). Qui viene mostrato in primo luogo il pio desiderio dei discepoli spirituali di diffondere a tutti i sensi spirituali dei sette tuoni che risuonano in modo veemente e stupendo nei loro cuori. In secondo luogo è mostrato in che modo da Cristo e dal suo spirito e dai santi dottori venga imposto loro di non divulgarli all’uomo carnale e animale al quale non è lecito parlare di queste cose secondo quella parola di Cristo (Lc 8, 10; Mt 7, 6): “a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo in parabole” e “non date le cose sante ai cani né ai porci”. Vi sono infatti alcune realtà comuni a tutti che a tutti devono essere predicate, altre invece che non devono essere rivelate a tutti, in particolare prima del tempo, secondo quel passo di Matteo: “Non dite a nessuno di questa visione finché il Figlio dell’Uomo non sia risorto dai morti” (Mt 17, 9); per cui anche sotto il sesto sigillo dell’Antico Testamento l’angelo dice a Daniele: “Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro fino al tempo stabilito” (Dn 12, 4), che era la sesta età nella quale apparve Cristo e in particolare il sesto stato della sua Chiesa, nel quale il libro doveva essere più pienamente aperto, non però ai malevoli e ai maldisposti. Prima della morte dell’Anticristo conveniva che molte cose allora aperte ai santi fossero chiuse ai nemici e anche ai fedeli ancora animali […]» [Si segue, con qualche variante, la traduzione di P. VIAN, in Pietro di Giovanni Olivi. Scritti scelti, Brescia 1989, pp. 139-141].
claude, aperiendus non … malivolis, oportebit claudere adhuc (Ap 10, 4) … richiuso; conviene ancor … si chiuda, aprimi, io non gliel’apersi.
“Infin che ’l mar fu sovra noi richiuso” (Inf. XXVI, 142). Si richiude, su Ulisse e i suoi compagni, il mare (il “pelago” della Scrittura: cfr. Ap 4, 6) ‘aperto’ a gente non disposta, uomini che avevano infranto il divieto di andare oltre le mete poste da Ercole per compiere un “folle volo” verso un mondo che non può essere oggetto di esperienza sensibile, ma solo di rivelazione spirituale.
Cocito è il luogo dove risuona in tonalità più alta il tema del chiudere i segreti spirituali contenuti nel libro all’uomo animale, come imposto a Daniele nel Vecchio Testamento (Daniele 12, 4), a Giovanni, scriba dell’Apocalisse, nel Nuovo (Ap 10, 4), e come detto più volte da Cristo (Matteo 7, 6; 17, 9; Luca 8, 10).
Il tema del chiudere i segreti è nelle parole del conte Ugolino circa la torre della Muda, nella quale lui e i suoi figli furono rinchiusi fino alla morte, “e che conviene ancor ch’altrui si chiuda” (Inf. XXXIII, 22-24): la scelta del Petrocchi di dare ad “altrui” il valore di dativo consente di interpretare sia nel senso letterale – ‘nella quale altri dovranno essere rinchiusi dopo di me’ – sia nel senso che la torre chiuderà ad altri, come avvenuto con Ugolino, l’intelligenza spirituale del libro. Più avanti nel cammino di Cocito, Dante si rifiuta di aprire a frate Alberigo gli occhi incrostati di lacrime ghiacciate, perché “cortesia fu lui esser villano”, in quanto indegno di vedere la benché minima parte del libro (vv. 148-150).
Tab. 15 (l’esame integrale è stato condotto altrove)
Tab. 16 (l’esame integrale è stato condotto altrove)
[LSA, cap. X, Ap 10, 3-7 (IIIa visio, VIa tuba)] “Et cum clamasset, locuta sunt septem tonitrua voces suas” (Ap 10, 3). Secundum Ioachim, hec septem tonitrua sunt septem spiritus Dei, qui missi in omnem terram spiritales et allegoricas voces, velut e tertio celo, emittunt* concordantes rugitui angeli, tam in revelando magnalia et archana glorie Dei et operum eius, et precipue illorum que fiunt in mentibus contemplativis, quam in tonando terribilia iudicia Dei. […]
|
|
Inf. X, 16-21“Però a la dimanda che mi faci
|
Inf. IV, 103-105Così andammo infino a la lumera,
|
Inf. IX, 61-68O voi ch’avete li ’ntelletti sani,
|
Purg. VIII, 19-21Aguzza qui, lettor, ben li occhi al vero,
|
[LSA, incipit (Is 30, 26)] Hec autem lux habet septiformem diem transcendentem velamen umbre legalis, quoniam in hac aperitur trinitatis Dei archanum, ac culpe originalis et actualis vinculum et debitum, et incarnationis Filii Dei beneficium, et nostre redemptionis pretium, et iustificantis gratie supernaturale donum simul et predestinationis ac reprobative subtractionis eiusdem gratie incom-prehensibile secretum, ac spiritualis et perfecti modi vivendi Deumque colendi saluberrimum exemplum ac preceptum et consilium, et eterne retributionis premium et supplicium cum finali consumatione omnium. Hec enim septem sunt velut septem dies solaris doctrine Christi, que sub velamine scripta et absconsa fuerunt in lege et prophetis.[LSA, cap. X, Ap 10, 7] […] est simpliciter verum quod tempus huius seculi tunc omnino cessabit et plene implebitur quicquid Deus per suos prophetas prenuntiavit fiendum, quod vocat “misterium”, id est secretum, quia nichil mundanis occultius quam spiritalis gratia et gloria in electis consumanda, futura etiam Dei iudicia sunt eis occulta et quasi incredibilia. Dicitur etiam “misterium”, quia sub misticis velaminibus sunt prenuntiata. Nec intendo quin principalia corpora huius mundi tunc durent, sed solum quod temporalis et mobilis cursus eius et temporalis status humani generis in hac vita mortali cessabit. |
[LSA, cap. XIII, Ap 13, 9] “Si quis habet aurem”, id est sanam intelligentiam dictorum et dicendorum, “audiat”, id est attente et prudenter consideret id quod est premissum et etiam id quod mox subditur, quia hoc quod subditur multum ei conferet ad servandam fidem et patientiam in tanta tribulatione.[LSA, cap. XII, Ap 12, 6] Item (Ioachim) de hoc ultimo dicit libro V° (Concordie) circa finem prime partis: «Unum dico, quod misteria tertii status subtiliora sunt misteriis secundi status et misteriis primi. […]»*.[LSA, cap. XV, Ap 15, 1] Et secundum Ioachim, dicitur “mirabile” quia mirantur homines cum incipiunt videre que aliquando non viderunt, scilicet cur alii pepercerunt viris impiis et sustinuerunt eos usque ad mortem, alii punierunt eos et occiderunt, et cur aliqui loquuntur eis humiliter et benigne quasi fratribus ad mortem egrotantibus, alii autem in zelo quasi hostibus Dei, sicut Christus primo venit in spiritu levitatis ut redimeret, secundo veniet ut iudex in spiritu iudicii et ardoris **.* Concordia, V 1, c. 17; Patschovsky 3, p. 578, 7-10.** Expositio, pars V, f. 182ra-b; cfr. Concordia, III 1, c. 7; Patschovsky 2, pp. 265, 14-16; 266, 1-14. |
10. Un sogno ingannatore
quand’ io feci ’l mal sonno / che del futuro mi squarciò ’l velame (Inf. XXXIII, 26-27).
Secondo il principio della concorrenza tra gli stati, affermato nel Notabile X del prologo della Lectura super Apocalipsim, il sesto stato – che, iniziato con Francesco d’Assisi, è quello in cui vivono Olivi e Dante – concorre con il secondo, per antonomasia lo stato dei martiri, non per connessione temporale (questo inizia infatti con la persecuzione di Nerone o con la lapidazione di santo Stefano o con la passione di Cristo e dura fino a Costantino), ma a motivo della quantità dei testimoni della fede. Il tipo di martirio è tuttavia diverso. I martiri del sesto stato soffrono nel dubbio, il loro è un “certamen dubitationis” che i primi testimoni della fede non provarono per l’evidenza dell’errore in cui incorrevano gli idolatri pagani. Nel sesto stato il martire non prova soltanto il tormento del corpo, viene anche spinto (“propulsabuntur martires”) dalla sottigliezza degli argomenti filosofici, dalle distorte testimonianze scritturali, dall’ipocrita simulazione di santità, dalla falsa immagine dell’autorità divina o papale, in quanto falsi pontefici insorgono, come Anna e Caifa insorsero contro Cristo. Per rendere più intenso il martirio, i carnefici stessi operano miracoli. Tutto ciò appartiene alla tribolazione del tempo dell’Anticristo, alla tentazione che induce in errore persino gli eletti, come testimoniato da Cristo nella grande pagina escatologica di Matteo 24: “dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi (cf. Mt 24, 24)”. Scrive Gregorio Magno, commentando Giobbe 40, 12 – “stringe (nel senso di tendere) la sua coda come un cedro” -: “ora i nostri fedeli fanno miracoli nel patire perversioni, allora i seguaci di Behemot faranno miracoli anche nell’infliggerle. Pensiamo perciò quale sarà la tentazione della mente umana allorché il pio martire sottoporrà il corpo ai tormenti mentre davanti ai suoi occhi il carnefice opererà miracoli”.
I temi presenti nell’esegesi del “certamen dubitationis”, sostenuto dai moderni martiri, subisce molte variazioni nella Commedia. Dietro al dubbio ingannatore di cui parla Olivi si cela l’eterna perdizione tramite una falsa Scrittura (Francesca e Paolo) o una falsa immagine di autorità pontificale (Guido da Montefeltro, che non diffidò di Bonifacio VIII), oppure un sentimento di pietà che deve vivere solo quand’è morta (Dante, e lo stesso Virgilio), o di inadeguatezza nel momento in cui non si deve negare il nome di Cristo (“colui / che fece per viltade il gran rifiuto”).
Il conte Ugolino, nel “mal sonno” che gli squarcia il velo del futuro, sogna l’arcivescovo Ruggieri “maestro e donno” nella caccia al lupo e ai lupicini, ben presto stanchi della corsa (Inf. XXXIII, 28-30). L’arcivescovo recita la stessa parte della falsa immagine dell’autorità pontificale già attribuita a Bonifacio VIII nel colloquio con Guido da Montefeltro. Come Guido nell’ascoltare il papa che lo assolve in anticipo dal dargli il consiglio fraudolento su come prendere Palestrina, anche Ugolino si inganna nel suo “mal sonno” e si crede vinto, e viene vinto nella prova dall’impazienza e dalla disperazione. Appressandosi l’ora “che ’l cibo ne solëa essere addotto”, nel doloroso carcere tutti, padre e figli, sono assaliti dal dubbio: “e per suo sogno ciascun dubitava” (v. 45), dove forse sarebbe da verificare, perché più coerente con il testo teologico di riferimento – “dabunt signa magna et prodigia” -, la variante “e per suo segno ciascun dubitava”, visto che quel sogno era stato segno fallace della fine che, se pure fosse arrivata per i corpi, non avrebbe condotto di per sé alla dannazione un uomo aperto a Cristo e non impetrato e accecato dall’odio e dal dolore (cfr. il “dubbiar” dei saggi in merito alla Via lattea, accostato al “venerabil segno” della croce formato dai due raggi nel cielo di Marte, a Par. XIV, 97-102).
Al vescovo di Smirne, la chiesa dei martiri, Cristo predice la sua futura incarcerazione confortandolo a non diffidare della propria assistenza; gli sarà sempre accanto nella tentazione, che non sarà ordinata alla sua rovina ma a provarlo e a perfezionarlo (Ap 2, 10). Il conte, nel sonno profetico, vede, per sé e i fanciulli, solo i segni della fine corporale. Non comprende che le sofferenze nel carcere gli sono date per martirio che rinnova la passione di Cristo. L’“orribile torre” – la sua croce – reca “’l titol de la fame”, in apparenza fame di cibo materiale, in realtà assenza di verbo spirituale.
Questi pareva a me maestro e donno … Con cagne magre, studïose e conte (Inf. XXXIII, 28, 31).
“Pareva a me … In picciol corso mi parieno stanchi / lo padre e ’ figli, e con l’agute scane / mi parea lor veder fender li fianchi”. L’immaginar fallace nel “mal sonno”, ribadito tre volte (vv. 28, 34, 36), ripete quanto detto ad Ap 11, 7 dei due testimoni, Elia ed Enoch, vinti e uccisi dalla bestia che ascende dall’abisso “secundum humanam apparentiam”, perché poi, dopo tre giorni e mezzo, essi risorgeranno. Ugolino, con il solo sentire della carne, si vede vinto e morto coi figli: l’essere “stanco” corrisponde al cavallo pallido che si mostra all’apertura del quarto sigillo, che designa la morte (Ap 6, 8), cui pure è da ricondurre il “guastare” nell’inferno il capo del suo vicino e la “fame”.
L’arcivescovo Ruggieri è vestito con i panni di Babylon, la prostituta Chiesa carnale. “La donna era circondata di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, pietre preziose e perle” (Ap 17, 4), era cioè ornata, in modo studioso e pomposo, di adornamenti carnali e mondani. La porpora e il colore scarlatto designano la sua crudeltà verso i martiri e verso quanti la macchiarono col loro sangue. “Teneva in mano una coppa d’oro, colma degli abomini e delle immondezze della sua prostituzione”. Sebbene per “prostituzione” si possa intendere qualsiasi peccato mortale immondo e abominevole per Dio e per i santi, il termine indica soprattutto la simonia e la lussuria per il tempo cristiano e l’idolatria e la lussuria per il tempo pagano, allorché maestra e regina diede da bere a sé e alle genti soggette. Tiene in mano un calice aureo perché la sua gloria e il suo potere temporali appaiono a lei e a tutti i mondani preziosissimi e gloriosissimi come l’oro. “Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso” (Ap 17, 5), di grande mistero e significato: “Babilonia la grande, la madre delle prostituzioni e degli abomini della terra”. Si dice che il nome le stava scritto in fronte – sul luogo del corpo e del volto elevato ed evidente – poiché non nasconde la confusione delle sue colpe e della sua lussuria, ma anzi la rende pubblica, la impone e di essa si gloria e gode e ne porta un nome famoso presso tutti.
Nel riferire al poeta come fu “cruda” la sua morte, il conte Ugolino racconta che, facendo il “mal sonno” che gli squarciò il velo del futuro, vide l’arcivescovo Ruggieri, “maestro e donno” della caccia al Monte Pisano – come Babilonia dominatrice delle genti, crudele e maestra (“adhuc super plures bestiales (gentes) sibi subditas dominatur … Per purpuram etiam et coccinum … potest intelligi crudelitas eius … tamquam omnium regina et magistra”) -, nella quale inseguiva “il lupo e ’ lupicini … con cagne magre, studïose e conte” (la prostituta è “studiose … ornata”; è nota a tutti: “habet nomen apud omnes famosum” – [cointe, ant. franc.; cognitum]). Il tema della sfrontatezza (“ideo dicitur hoc habere scriptum in fronte”) appare nell’aversi messo l’arcivescovo “dinanzi da la fronte”, cioè in prima fila, le famiglie ghibelline dei Gualandi, Sismondi e Lanfranchi (Inf. XXXIII, 19-20, 28-33).
Le “agute scane” (v. 35), che al conte paiono quasi raggiungere le carni dei “lupicini”, fanno riferimento all’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 3), quando appare un cavallo rosso, insanguinato per l’uccisione dei martiri, e anche dei propri parenti e vicini, assimilato ai denti (in tre ordini, come tre sono le consorterie nella caccia) dell’orso, del quale dice il profeta Daniele: “Su, divora molta carne” (Dn 7, 5).
Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi / s’avea messi dinanzi da la fronte (Inf. XXXIII, 32-33).
Nella quinta bolgia, il barattiere navarrese si dichiara capace di ‘far venire’ “Toschi o Lombardi”, nascosti sotto la pece per timore dei Malebranche (Inf. XXII, 97-105). Le parole di Ciampolo, che preludono al “nuovo ludo” con Alichino, fanno suonare grottescamente temi provenienti da Ap 5, 6-7, dove si tratta dell’apertura da parte di Cristo del libro segnato da sette sigilli. Qui il Figlio di Dio, centro mediatore della Chiesa, quasi sedendo nel mezzo della Trinità, dotato della pienezza della sapienza, della provvidenza e della grazia espressa dai sette spiriti (l’increato Spirito è in sé uno e semplice, ma viene detto settiforme nella sua partecipazione) che vengono “messi” nei loro influssi ed effetti, “viene al Padre”, nel senso che fa venire noi al Padre oppure che, nel risorgere, rende a tutti noto ed evidente il suo essere Dio. Ciampolo, che rifà il verso parodiando il motivo del settiforme Spirito che viene messo, “seggendo in questo loco stesso”, promette che “per un ch’io son, ne farò venir sette”, ‘suffolando’ [1], ossia fischiando come quando un barattiere “si mette” fuori dalla pece e, in assenza della guardia dei diavoli, chiama i compagni (il ‘mettersi fuori’ dei barattieri deriva dall’“innotescentia”, cioè il rendersi noto o visibile di Cristo). Il blasfemo e grottesco parlare del navarrese, che l’intertesto rivela, si fonda sul tema dell’unità e della molteplicità, e proprio in un ambito dove si insiste sulla varietà dei linguaggi: oltre ai “Toschi o Lombardi”, il navarrese ha poco prima riferito del “dir di Sardigna”, del quale non sono mai stanchi frate Gomita, “quel di Gallura”, e Michele Zanche di Logodoro.
È da rilevare il particolare valore assunto, ad Ap 5, 6, dal ‘mettere’, a proposito del quale Olivi precisa non potersi affermare che qualcuno “metta sé stesso”, a meno di non intendere che a motivo dei medesimi effetti operati da tutta la Trinità, per i quali il Figlio e lo Spirito si dicono “messi”, si possa dire che la persona “metta sé stessa”. Sembra da qui derivare l’affermazione di Ulisse “ma misi me per l’alto mare aperto” (Inf. XXVI, 100: il greco si è messo da solo in viaggio contro la provvidenza divina; il mare “aperto” è il “pelagus sacre Scripture”, il libro che verrà aperto da Cristo), o il “s’avea messi dinanzi da la fronte” nella caccia che l’arcivescovo Ruggieri fa con “Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi” (quasi una pessima Trinità, Inf. XXXIII, 31-33; cfr. ai vv. 55-56 il “si fu messo” del raggio di sole “nel doloroso carcere”) e, all’opposto, Beatrice nell’Eden, che si mette dinanzi le sette virtù (Purg. XXXIII, 13). Dalla fiumana di luce dell’Empireo (che è il “fluvius” di Ap 22, 1, procedente dalla sede e da tutta la sostanza della Trinità, e designa dunque i doni dello Spirito, che vengono comunicati ai beati) uscivano faville vive “e d’ogne parte si mettien ne’ fiori” (Par. XXX, 64-66) [2].
[1] ‘Insufflare’ è verbo appropriato allo Spirito che fa rivivere (cfr. Ap 7, 1).
[2] Da notare, ad Ap 5, 6, Cristo definito, a motivo dei sette stati della Chiesa, “rex quasi septem regnorum, tum propter septem etates in suo regno contentas, tum propter septem perfectiones exemplares et causales et correspondentes propriis et perfectivis donis septem statuum ecclesie”. Virgilio chiede a Catone: “Lasciane andar per li tuoi sette regni” (Purg. I, 82). Ed è da ricordare quanto si afferma a Convivio IV, xxviii, 15: “E quale uomo terreno più degno fu di significare Dio che Catone? Certo nullo”.
Tab. 17
[LSA, prologus, Notabile X] Sextus vero concurrit cum secundo non in eodem tempore sed in celebri multitudine martiriorum, prout in apertione quinti signaculi aperte docetur (cfr. Ap 6, 9), quamvis in modo martirii quoad aliqua differant. Nam martiria a paganis et idolatris facta nullum certamen dubitationis inferebant martiribus, aut probabilis rationis, propter nimiam evidentiam paganici erroris. Non sic autem fuit de martiriis per hereticos, unum Deum et unum Christum confitentes, inflictis. In sexto autem tempore non solum propulsabuntur martires per tormenta corporum, aut per subtilitatem rationum philosophicarum, aut per intorta testimonia scripturarum sanctarum, aut per simulationem sanctitatis ypocritarum, immo etiam per miracula a tortoribus facta. Nam, teste Christo, “dabunt signa et prodigia magna” (Mt 24, 24). Unde Gregorius, XXXII° Moralium super illud Iob: “stringit caudam suam quasi cedrum” (Jb 40, 12), dicit: «Nunc fideles nostri mira faciunt, cum perversa patiuntur; tunc autem Behemot huius satellites, etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit humane mentis illa temptatio, quando pius martir corpus tormentis subicit, et tamen ante eius oculos miracula tortor facit»*. Propulsabit etiam eos per falsam imaginem divine et pontificalis auctoritatis. Sic enim tunc surgent pseudochristi et pseudochristus contra electos, sicut Annas et Caiphas pontifices insurrexerunt in Christum. Erunt ergo tunc tormenta intensive maiora, tempore autem paganorum fuerunt extensive pluriora: nam plusquam per ducentos annos duraverunt.
|
|
Inf. XXXIII, 28-30, 43-45Questi pareva a me maestro e donno,
|
Par. XIV, 97-102Come distinta da minori e maggi
|
Inf. XXVII, 100-111E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti;
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 8 (Ia visio, VIa ecclesia)] “Et servasti”, id est et quia servasti, “verbum meum”, id est doctrinam mee fidei et mee legis. “Et non negasti nomen meum”, scilicet in angustia persecutionis, aliter enim non est magnum non negare nomen Christi, sed solum cum quis per fortes persecutiones impellitur et quasi cogitur ad negandum. Tunc etiam idem est non negare quod confiteri, quia tacere in tali casu est negare. Ex hoc ergo innuit istum magnam persecutionem fidei sustinuisse, unde et paulo post dicit Christus eum servasse verbum patientie sue (Ap 3, 10). Nota quomodo hoc preclare competit sexto statui, cuius proprie est profiteri et servare legem evangelicam seu regulam non solum preceptorum sed etiam consiliorum Christi, et cuius est Christi nomen constanter et perseveranter confiteri contra perse-cutiones gravissimas duplicis Antichristi, scilicet mistici et proprii, et cuius erit perfectissime convertere totum Israelem […] |
Purg. XXV, 31-36“Se la veduta etterna li dislego”,
|
Purg. XXXI, 37-39Ed ella: “Se tacessi o se negassi
|
Tab. 18 (l’esame compiuto della tabella è stato condotto altrove)
Tab. 19
Tab. 20
Tab. 21
11. Il pianto sul libro che non s’apre
Nel quarto capitolo dell’Apocalisse viene mostrata la gloria e la magnificenza della maestà divina, nel quinto l’incomprensibile profondità del libro che sta per essere aperto da Cristo. Per questo si dice: “E vidi nella mano destra di Colui che era seduto sul trono un libro scritto dentro e fuori, sigillato con sette sigilli” (Ap 5, 1). Il libro designa in primo luogo la prescienza divina e la predestinazione a riparare l’universo per opera di Cristo. Per appropriazione, è il Verbo stesso del Padre in quanto espressivo della sua sapienza e in quanto il Padre, nel generarlo, scrisse in esso tutta la sua sapienza. In secondo luogo, il libro è la scienza delle intelligenze angeliche data ad esse da Dio e in esse scritta, che è scienza di tutta la grazia e la gloria degli eletti e del culto di Dio che deve compiersi per mezzo di Cristo. È pertanto, assai di più, la scienza universale scritta da Dio nell’anima di Cristo. In terzo luogo, è il volume della Sacra Scrittura e in particolare dell’Antico Testamento, nel quale il Nuovo venne rinchiuso e sigillato e velato sotto varie figure (cfr. infra).
Nessuno, se non Cristo, può fondare o promuovere il pieno sviluppo dei sette stati che si succedono nella storia umana, caratterizzati da sigilli che chiudono, totalmente o parzialmente, le illuminazioni divine. Per questo Giovanni dice: “Vidi un angelo forte che predicava a gran voce: ‘chi è degno di aprire il libro e di scioglierne i sette sigilli?’ (Ap 5, 2)”. Oltre che gli spiriti angelici, questo angelo designa i santi profeti, e in particolare Giovanni Battista, che predicarono l’impossibilità che una semplice creatura aprisse il libro. Il Battista infatti disse per sé e per tutti gli altri: “verrà uno più forte di me al quale io non sono degno di sciogliere il laccio del sandalo” (Mc 1, 7; Jo 1, 27). Proprio l’aggettivo “forte”, attribuito all’angelo, sta ad indicare che né in lui né in altri a lui simili stava il potere di aprire il libro. L’angelo parla interrogando e indagando – dice infatti: “chi è degno …?” – per indicare lo stringente desiderio degli altri angeli e dei santi padri che il libro venga aperto e che si trovi qualcuno degno di aprirlo. Interroga al modo dei maestri, che così stimolano e pretendono che i discepoli a loro volta chiedano e apprendano. Il domandare è anche manifestazione sensibile dell’alta meraviglia del richiedente e della rarità, difficoltà e arditezza del ritrovare la cosa richiesta. Ma nessuno era in grado di aprire il libro e di leggerlo, né “in cielo”, da parte di qualche angelo; né “in terra”, da parte di qualsiasi uomo, per quanto perito e santo; né “sotto terra”, dai demoni e dai dannati che stanno nell’inferno, o da parte di un corpo sepolto in terra la cui anima stesse nell’inferno prima della venuta di Cristo (Ap 5, 3). L’impossibilità di vedere può essere limitata al guardare nell’interno del libro oppure estesa al libro stesso chiuso con i sette sigilli, nel qual caso è da intendere che nessuno, senza la grazia di Dio e il presupposto merito di Cristo, poteva conseguire la fede implicita e l’intelligenza di Cristo e della Chiesa procedente verso lo stato della gloria. Alla constatazione di impotenza e di indegnità fa seguito il gemito di Giovanni che proviene dal desiderio che il libro venga aperto. Egli dice infatti: “Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo” (Ap 5, 4). Giovanni, lo scriba dell’Apocalisse, qui assume il tipo del salvatore di tutti i santi padri, per i quali acquista la grazia e la gloria, e impersona colui che impetra ed elargisce per quanti, non potendo accedere al libro, desiderano, gemono e sospirano con tutto il cuore, riconoscendo umilmente che solo Cristo è possente e degno al compito. Questi pianti e sospiri si manifestano in diversi momenti della storia umana. I santi padri, nel limbo dell’inferno, con quanto pianto e quanti sospiri desideravano che il libro venisse aperto a coloro che adoravano Dio! Cristo, nel primo stato della Chiesa, resuscitando e strappando i santi padri dall’inferno, manifestò la propria onnipotenza. Sono però in particolare i contemplativi, propri di tutti gli stati ma in particolare del quarto, a sospirare in modo più alto e intimo degli altri.
■ Il tema della propria indegnità è cantato prima da Virgilio, che dice a Dante che lo lascerà con anima più degna, quella di Beatrice, quando vorrà salire alle beate genti (Inf. I, 121-123). Poi è Dante stesso a non ritenersi degno di andare “ad immortale secolo” dopo Enea e san Paolo (Inf. II, 31-33).
Il Limbo è il luogo dove i motivi che segnano il desiderio che il libro venga aperto sono più sviluppati. Il tema del maestro che interroga per stimolare i discepoli all’apprendimento è nelle parole di Virgilio: “Tu non dimandi / che spiriti son questi che tu vedi?” (Inf. IV, 31-32). All’esposizione fatta dal poeta pagano circa coloro che “furon dinanzi al cristianesmo”, che corrispondono ai “sancti patres” che precedettero l’avvento di Cristo, segue la domanda di Dante per accertarsi se mai alcuno sia uscito di lì per essere poi beato: “Dimmi, maestro mio, dimmi, segnore” (vv. 46-50). Il tema del maestro che interroga per essere interrogato ritorna nel finale dell’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 13), allorché uno dei seniori “risponde”, cioè si rivolge a Giovanni parlando. Il vegliardo dice a proposito della “turba magna” che segue i segnati: “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono”, cioè di quali e quante dignità sono insigniti, “e donde vengono?”, cioè per quali meriti e quale via di santità sono pervenuti a tanta gloria: il “son questi” delle parole di Virgilio, a proposito delle “turbe, ch’eran molte e grandi”, traduce l’ “hii … qui sunt” di Ap 7, 13, e Dante domanda chiamandolo “maestro” e “segnore”.
La risposta di Virgilio è una variazione sul tema che nessuno, salvo Cristo, è potente ad aprire il libro. Da poco infatti il poeta si trovava nel Limbo, quando ci vide venire “un possente, / con segno di vittoria coronato”, per trarvi Adamo, Abele, Noè, Mosè, Abramo, Davide, Isacco, Giacobbe con i suoi dodici figli, Rachele e molti altri, per poi farli beati (vv. 52-63). L’essere potente di Cristo si intreccia con i motivi dell’apertura del primo sigillo, in occasione della quale Cristo appare sul cavallo bianco, potente, vittorioso e coronato (Ap 6, 2).
Ma è il tema del sospirare la variazione più sorprendente. Le turbe dei morti senza battesimo, o di coloro che, vissuti prima del cristianesimo, non adorarono debitamente Dio sono equiparati ai santi padri che precedettero Cristo, stretti dal desiderio (“instans desiderium”) che il libro venga aperto, gementi e sospirosi: “non avea pianto mai che di sospiri … sol di tanto offesi, / che sanza speme vivemo in disio” (Inf. IV, 25-27, 40-42). Lo stesso gemere di Giovanni passa nel cuore di Dante, preso da grande dolore allorché apprende che gente di molto valore si trova “sospesa” nel Limbo (vv. 43-45; cfr. supra). A dire il vero, gli “spiriti magni”, collocati separatamente dalle turbe nel nobile castello, non sospirano, ma parlano “rado, con voci soavi” (v. 114). Essi hanno le caratteristiche dei seniori che stanno attorno al trono. Anch’essi, però, come gli altri vivono “sanza speme … in disio”, poiché per tutti non si verifica quanto segue nel testo apocalittico, nel quale al pianto sospiroso subentra il conforto della promessa che dalla radice di Davide nascerà Cristo, colui che sarà degno di aprire il libro (Ap 5, 5). È da notare che il tema del gemito di Giovanni (Ap 5, 4) ha un suo impiego anche in Inf. III, 22-23, nella progressione di “sospiri, pianti e alti guai” che accoglie il poeta appena varcata la porta dell’inferno. I temi dell’apertura del libro, e del desiderio che questa avvenga, si insinuano poi nell’ingresso di Dante nella Città di Dite.
■Il dubbio di Cavalcante, espresso in forma interrogativa, si appunta sulla lacrimosa espressione: “mio figlio ov’ è? e perché non è teco?” (Inf. X, 60). A lui, dannato, è appropriato il forte pianto di Giovanni ad Ap 5, 4. Questo pianto, sostiene Olivi, è proprio dei momenti (al tempo degli apostoli, delle grandi eresie, quando fu lutto per la Chiesa, e dell’Anticristo) nei quali quanti sono inconsapevoli della ragione che permette le tribolazioni e le “pressure” causate dalle eresie, e il terrore provocato dall’imminenza dei pericoli, piangono e sospirano affinché il libro segnato da sette sigilli venga aperto, almeno per la parte che è consentito aprire in quel tempo. Il pianto di Cavalcante, quasi un lamento femminile [1], si ritroverà nel pianto di Lavinia per la morte suicida della madre Amata, della quale non comprende il motivo (“O regina, / perché per ira hai voluto esser nulla?”, Purg. XVII, 35-36). Il dubbio inconsapevole si insinua anche nella statuaria effigie di Farinata: “E se tu mai nel dolce mondo regge, / dimmi: perché quel popolo è sì empio / incontr’ a’ miei in ciascuna sua legge?” (Inf. X, 82-84). A differenza di Cavalcante non vi sarà pianto, ma solo sospiro dopo la risposta di Dante.
Così piange la Roma «vedova e sola, e dì e notte chiama: / “Cesare mio, perché non m’accompagne?”» (Purg. VI, 112-114), nella “pressura” dei “gentili” (vv. 109-110): l’apostrofe ad Alberto tedesco ripete quattro volte (vv. 106, 109, 112, 115) il “veni et vide” apocalittico detto a Giovanni all’apertura dei primi quattro sigilli. Anche Virgilio mostra di non comprendere la ragione della ‘pressura’ di Dante nella “diserta piaggia”: “Ma tu perché ritorni a tanta noia?” (Inf. I, 76). Il lutto, proprio di Lavinia, segna anche Aristotele e Platone e molti altri, dei quali dice Virgilio, che desiderarono vedere tutto senza frutto, “tai che sarebbe lor disio quetato, / ch’etternalmente è dato lor per lutto” (Purg. III, 34-45); in questo caso il sospiroso desiderio, che fu già dei padri nel Limbo, di vedere tutto il libro aperto (che solo Cristo, nei suoi tre avventi, avrebbe aperto compiutamente) sostituisce il pianto.
Gli innocenti fanciulli rinchiusi nella Muda col conte Ugolino piangono anch’essi inconsapevoli della causa di tanta tribolazione, della quale Gaddo chiede ragione al padre. «Quando fui desto innanzi la dimane, / pianger senti’ fra ’l sonno i miei figliuoli / ch’eran con meco, e dimandar del pane … Io non piangëa, sì dentro impetrai: / piangevan elli … Poscia che fummo al quarto dì venuti, / Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi, / dicendo: “Padre mio, ché non m’aiuti?”» (Inf. XXXIII, 37-39, 49-50, 67-69). La loro angoscia anela a una libertà dal mondo, in essa sta il desiderio che il libro venga aperto. Ma il padre, che dovrebbe essere, come Giovanni nell’Apocalisse, mediatore di questo pianto, resta chiuso, come il libro, nella sua lapidea durezza.
[1] Cfr. E. AUERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, trad. it., I, Torino 19735, pp. 196-197, che propone come modello l’apparizione di Andromaca in Aen. III, 310 sgg.; G. TANTURLI, Dante poeta fiorentino (su Inf. X), in “Studi danteschi”, LXV (2000), pp. 55-57. L’eco virgiliana è però armata dai temi apocalittici tratti dal commento dell’Olivi, con cui concorda.
Tab. 22
[LSA, cap. V, Ap 5, 2-4 (radix IIe visionis)] Quia vero nullus potuit status istos condere, aut eorum formationem plenarie promereri, aut Dei prescientiam propriis viribus scire et aliis revelare nisi solus Filius Dei, unde de ultimo dicit Matthei XI°: “Nemo novit Filium, nisi Pater; nec Patrem quis novit, nisi Filius et cui Filius voluerit revelare” (Mt 11, 27), ideo ad hoc monstrandum subditur (Ap 5, 2): “Et vidi angelum fortem predicantem voce magna: Quis est dignus aperire librum et solvere septem signacula eius?”.
|
|
Inf. I, 121-123; II, 31-33A le quai poi se tu vorrai salire,
|
Inf. III, 22-23; XIX, 64-66Quivi sospiri, pianti e alti guai
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 4-5 (radix IIe visionis)] Attamen hec revelatio et fletus Iohannis potius respicit illa tempora in quibus, propter pressuras heresum et terrores imminentium periculorum, et propter nescientiam rationis seu rationabilis permissionis talium pressurarum et periculorum [et] iudiciorum, flent et suspirant sancti pro apertione libri, quantum ad illa precipue que pro illo tempore magis expedit eos scire. Hoc autem potissime spectat ad triplex tempus.
|
|
Inf. I, 55-57, 76-78
|
Inf. XXXIII, 37-39, 49-51, 67-69Quando fui desto innanzi la dimane,
|
[LSA, prologus, Notabile IX] Nec est hoc contra illud quod in omnibus sequentibus septimus status miro modo prefertur, quia finis septimi, prout septimus sumitur in hac vita ante tempus iudicii, debet malis plurimis inundare ita ut ex tantis malis Deus merito provocetur venire ad iudicandum orbem et ad liberandum electos illius temporis a pressura tantorum malorum.[LSA, cap. VI, Ap 6, 11 (IIa visio, apertio Vi sigilli)] In hac autem persecutione non est dictum quod tale aut tale animal dixerit “veni et vide”, quia «sicut in quattuor animalibus quattuor speciales ordines accipiendi sunt, sic in altare Dei romanam ecclesiam dicimus accipiendam, que peractis quattuor temporibus illorum quattuor ordinum, tam in clero quam in monachis confortata est in Domino Deo suo et viguit pre ceteris quinto tempore apud Latinos» (Ioachim, Expositio, pars II, f. 116rb). |
Purg. VI, 106-117Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, I
|
12. Lo specchio della Scrittura
La Scrittura è “pelago”, il mare vitreo simile a cristallo che sta dinanzi alla sede divina (Ap 4, 6). La Scrittura resta dinanzi alla Chiesa in modo che gli eletti possano in essa vedere l’aspetto del proprio volto e conoscano quali essi siano, e anche possano comprendere le cose invisibili di Dio come in un chiaro specchio e per mezzo di esso. Guardare sé nella Scrittura per conoscere la propria immagine appartiene al conte Ugolino, dopo che ha sentito inchiodare l’uscio dell’orribile torre e al sorgere del sole nel secondo giorno di prigionia, quando “un poco di raggio si fu messo / nel doloroso carcere”: «ond’ io guardai / nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto … e Anselmuccio mio / disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?” … e io scorsi / per quattro visi il mio aspetto stesso» (Inf. XXXIII, 47-48, 50-51, 55-57). Fra i vari significati attribuiti al “mare di vetro”, si addicono al conte l’amaro e infinito patire di Cristo e, per contrasto, la tolleranza del martirio, la contrizione penitenziale. Come egli non sa sopportare le tribolazioni, ed è impaziente e si dispera mordendosi le mani per il dolore, così il guardare nei figli – che sono quattro come i Vangeli – non gli rende la vista delle cose spirituali.
Un altro attributo della Scrittura è di essere assimilata al collirio. Il tema è introdotto ad Ap 3, 18, nel corso dell’istruzione data a Laodicea, la settima delle chiese d’Asia. Il collirio, che all’inizio punge gli occhi in modo amaro e provoca le lacrime, rendendo però alla fine chiara la vista, designa l’amara compunzione dei propri peccati. Così la Scrittura è come il collirio, perché il precetto del Signore è lucente e illumina gli occhi. Ugolino guarda nel viso dei suoi figli che piangono, ma lui non piange né lacrima.
Nell’Eden, Beatrice rimprovera Dante invitandolo a guardarla: “Guardaci ben!” (Purg. XXX, 73). Il poeta guarda nel Lete, “chiaro fonte” le cui acque senza “mistura alcuna” sono limpide e nulla nascondono (Purg. XXVIII, 28-30), ma vedendo la sua immagine prova tanta vergogna da distogliere gli occhi verso l’erba (Purg. XXX, 76-78). Di fronte al rimprovero della donna, che gli pare superba come la madre al figlio “perché d’amaro / sente il sapor de la pietade acerba”, Dante resta “sanza lagrime e sospiri”, gelato attorno al cuore come la neve congelata e addensata dai venti di Schiavonia che soffiano fra i rami degli alberi sul giogo d’Appennino. Il dolce canto degli angeli, che temperano l’amaro delle parole di Beatrice, scioglie però quel gelo come neve al caldo vento del sud e lo trasforma in sospiri e lacrime che sgorgano con fatica dalla bocca e dagli occhi (vv. 79-99).
All’inizio del periodo di purgazione, “le guance lagrimose” di Dante, annebbiate dal “sucidume” infernale, vengono lavate da Virgilio con la rugiada sul “molle limo” ai piedi della montagna, secondo l’indicazione di Catone (Purg. I, 94-99, 121-129).
Se Dante guarda in Beatrice e piange dinanzi a lei, la sua donna è discesa a visitare “l’uscio d’i morti”, dove ha rivolto lacrimando gli occhi lucenti a Virgilio per renderlo ancor più presto al muovere per la salute dell’amico (Inf. II, 115-117; Purg. XXVII, 136-137; XXX, 139-141). Piange, Beatrice, non solo perché donna e amante, come voleva Boccaccio [1]. La “gentilissima” designa la Sacra Scrittura, precetto di Dio che rende lucidi gli occhi, purga, chiarisce e illumina con umiltà l’alta tragedia.
[1] G. BOCCACCIO, Il Comento alla Divina Commedia e gli altri scritti intorno a Dante, a cura di D. Guerri, I, Bari 1918 (Scrittori d’Italia, G. Boccaccio, Opere volgari, XII), pp. 224-225: “E in questo lagrimare ancora più d’affezion si dimostra, dimostrandosi ancora un atto d’amante, e massimamente di donna, le quali, come hanno pregato d’alcuna cosa la quale disiderino, incontanente lagrimano, mostrando in quello il disiderio suo essere ardentissimo”.
Tab. 23
[LSA, cap. IV, Ap 4, 6 (radix IIe visionis)] “Et in conspectu sedis”, scilicet erat, “tamquam mare vitreum simile cristallo”. Per mare designatur Christi amara et quasi infinita passio et lavacrum baptismale et penitentialis contritio et martiriorum perpessio et pelagus sacre scripture. Quodlibet enim horum est puritate et claritate et pervia perspicuitate vitreum et soliditate cristallinum. Hec omnia etiam sunt ad utilitatem ecclesie ordinata et ad cultum et gloriam maiestatis Dei. Scriptura etiam ideo manet in conspectu ecclesie, ut in ea valeant electi species facierum suarum prospicere ad cognoscendum se quales sint, et etiam ut in ipsa tamquam in speculo et per speculum possint intelligere invisibilia Dei. |
|
Inf. XXXIII, 43-58Già eran desti, e l’ora s’appressava
|
Purg. XXX, 73-78, 91-93“Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice.
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 18 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Deinde monet [quartum] defectum expelli, subdens: “et collirio unge oculos tuos ut videas”. Collirium est unctio facta ad purgandum feces oculorum, et est in principio communiter oculorum pungitivum et amaricativum et lacrimarum provocativum et emissivum sed tandem visus clarificativum, et ideo per ipsum designatur amara compunctio de suis peccatis. Hec enim continue tenet aspectum et sensum cordis intime reflexum super se et super suos defectus, et ideo includit et auget primam illuminationem cordis, que est cognitio sui et suorum defectuum includens timoratam considerationem iudiciorum Dei ac sue reverende et tremende simul et piissime maiestatis. Hec autem directe contrariatur presumptioni premisse. Per collirium etiam designatur scriptura sacra: preceptum enim Domini est lucidum illuminans oculos. |
|
Inf. II, 79-81, 115-117; Purg. XXVII, 136-137; XXX, 139-145tanto m’aggrada il tuo comandamento,
|
Purg. I, 94-99, 121-129Va dunque, e fa che tu costui ricinghe
|
13. L’immortale canto dei quattro fanciulli
Ad Ap 8, 3, nell’esegesi della “radice” della terza visione, a Cristo, angelo che sta dinanzi all’altare, “furono dati molti incensi”, cioè molte orazioni a Dio piacenti. Gli vengono dati da quanti pregando affidano sé e i propri voti a lui come nostro mediatore e avvocato e gli chiedono di offrirli a Dio. Costoro gli sono dati dal Padre, come detto in Giovanni 17, 6.11: “Erano tuoi e li hai dati a me. Padre santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato”. E nel Salmo 67, 19 si afferma: “Sei salito in alto e hai ricevuto uomini in dono”. Egli riceve in noi, che siamo le sue membra, i doni della grazia che ci vengono dati. “Gli furono dati molti incensi perché offrisse le preghiere di tutti i santi sull’altare d’oro, posto davanti al trono di Dio”, cioè per offrirle a Dio sopra i meriti derivanti dalla propria umanità, oppure sopra la basilare ara della divina verità e maestà, oppure sopra i meriti aggiunti della gerarchia angelica e dei santi padri che precedettero (l’esame compiuto di questa esegesi è stato condotto altrove).
■ Il tema dell’offerta degli uomini da parte di Cristo, mediatore e avvocato, al Padre che glieli ha dati, come detto in Giovanni 17, 6.11: “Erano tuoi e li hai dati a me. Padre santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato”, percorre i versi che cantano l’offerta al padre delle proprie carni da parte dei figli del conte Ugolino: “Tui erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi … Padre, assai ci fia men doglia / se tu mangi di noi: tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia”.
All’alba del secondo giorno da che era stata inchiodata la porta del doloroso carcere, come un poco di raggio si fu messo dentro, il padre guarda i figli: “e io scorsi / per quattro visi il mio aspetto stesso”. Ha di fronte la Scrittura personificata, che gli dà la possibilità di guardare sé stesso e di comprendere, come in uno specchio, le cose invisibili di Dio. Si tratta del motivo del “mare di vetro”, trasparente come cristallo, che sta davanti al trono, descritto ad Ap 4, 6: esso designa pure l’amaro e infinito patire, e, per contrasto, la tolleranza del martirio, la contrizione penitenziale. La Scrittura, precetto divino, è come il collirio che provoca le lacrime per rendere infine chiara la vista. Ma il padre, per tutto il giorno e la notte precedenti, non ha pianto né lacrimato né parlato, fatto di pietra nel cuore. Hanno pianto i figli, che Ugolino ha guardato in viso in silenzio. Anselmuccio ha parlato, invece, dicendogli: “Tu guardi sì, padre! che hai?”. Il padre non comprende il senso del piangere dei figli, che nella sofferenza hanno fame e desiderio di cibo spirituale, di apertura del libro. Il guardare per la seconda volta nei quattro visi, che sono come i quattro Vangeli, non gli rende la vista delle cose spirituali. Incapace di sopportare le tribolazioni, nella sua impazienza si dispera: “ambo le man per lo dolor mi morsi”. Patire non è per lui motivo di rigenerazione ma di maggior odio. Mordersi le mani per il dolore è variante del versetto della quinta coppa “et commanducaverunt linguas suas pre dolore” (Ap 16, 10), nella cui esegesi i temi dell’odio, del corrodere la fama altrui, del mangiare coi denti, del vivere bestiale, del dolore del cuore, dell’impazienza, della disperazione, della cecità sono altrettanti fili con cui è tessuta la sua veste spirituale.
Il rapporto tra padre e figli, fatto da una parte di impietriti sguardi senza parole, di dolore che porta a mordersi le mani, e dall’altra di pianti, di lacrime e dell’offerta delle proprie misere carni, è la chiave dell’intero episodio. È un dialogo fondato sull’incomprensione, come lo interpretò De Sanctis:
“Non intesero già quel primo sguardo del padre fisso e travolto, quando sentì chiuder l’uscio: ‘Tu guardi sì, padre: che hai?’. Ora non solo non intendono, ma fraintendono quel suo mordersi la mano. ‘Credendo ch’io il fessi per voglia di manicar’. Ignari delle nostre passioni, interpretano quell’atto nel modo più immediato e letterale. Sentono fame, e giudicano da sé: mordere significa per loro mangiare. Il padre che per fame si mangia le mani è tal cosa, li percuote di tale spavento, che ad un attore intelligente farebbe comprendere tutto ciò che si chiude in quel grido: – ‘Padre!’ – accompagnato col subitaneo levarsi in piè di tutti e quattro, essi che stavano a terra esausti per fame. Quel grido, quel levarsi in piè ha la virtù di arrestare il padre, di restituirgli la padronanza di sé, tolto per forza a quell’istante di obblio, di fargli ricordare che è padre, e non gli è permesso di essere uomo. Quel loro offrirsi in pasto al padre non è già sublime sacrificio dell’amor filiale, sentimento troppo virile ne’ teneri petti; è un’offerta trasformata immediatamente in una preghiera, come di cosa desiderata e invocata: – Uccidici! Tronca la nostra agonia! ‘Tu ne vestisti / queste misere carni e tu le spoglia’. ‘Misere carni!’ Essi sentono già dissolversi e mancar la vita. ‘Misere’ qui vuol dire estenuate, dove già penetra la morte. Quelli che spiegano la parola in senso spirituale e ti pescano qui un concetto teologico, meriterebbero di andare a braccetto col padre Cesari, che fra tante sue ‘bellezze di Dante’ trova qui una bruttezza, un fatto fuor del naturale e del verosimile, proprio qui, in questo coro de’ quattro immortali fanciulli, che è stato l’ammirazione de’ secoli” [1].
L’incomprensione, però, non avviene come vuole De Sanctis: non sono i figli a fraintendere il padre, ma è questi a non comprendere il valore insito nell’atteggiamento e nell’offerta dei quattro fanciulli. Egli si morde le mani per il dolore, cioè per la rabbia e l’odio che l’acceca; essi accennano a un convivio nel quale venga divorata la carne mortale e misera e resti quello che è spirituale, alla liberazione dal carcere di questa misera vita verso l’eterna patria. Senza che ci sia bisogno di andare a braccetto col padre Cesari, sono i testi a suggerire questa interpretazione spirituale. Il tema del mangiare la carne compare nella Lectura nell’esegesi di Ap 19, 17-18, dove un angelo, che rappresenta gli alti contemplativi la cui mente è tutta fissa nella solare luce di Cristo e delle sacre scritture (secondo Gioacchino da Fiore si tratta di Elia), fissa gli occhi al sole invitando allo spirituale e serotino convivio dove verrà divorata la carne soggetta a corruzione in modo che resti ciò che è spirituale. L’invito alla spirituale e trionfale divorazione significa l’incorporare in Cristo e nella Chiesa i popoli e i re, al modo con cui negli Atti degli Apostoli viene detto a Pietro di uccidere e di mangiare quadrupedi, serpenti e volatili visti in un gran vaso (Ac 10, 9-16). I santi saranno ristorati dal gaudio, dall’amore e dalla dolcezza per la conversione dei Gentili e dei Giudei che avrà luogo, su questa terra e in una Chiesa ancora militante, dopo la morte dell’Anticristo.
Di Pietro e del suo gustare si ricorderà Dante nell’ascesa al cielo. L’angelo che sta fisso nel sole di Ap 19, 17 sarà Beatrice, la quale terrà fissi gli occhi al sole, seguita dal poeta come un raggio riflesso segue quello diretto. Il “trasumanar” verrà reso con l’immagine ovidiana del pescatore Glauco, il quale, gustando un’erba che resuscitava i pesci da lui presi, si tramutò in Dio (Par. I, 67-72; Ovidio, Metam., XIII, 898-968). Glauco, pescatore come Pietro al quale viene detto di mangiare cose apparentemente immonde, in realtà designanti l’incorporazione delle genti infedeli, e Dante hanno preso parte al convivio spirituale, dove si divora ciò che è mortale, in occasione della conversione finale delle genti e di Israele.
La carne divorata nel convivio serotino allestito alla fine dei tempi è quella destinata a morire, e dunque misera. Questa vita, “que est quasi continua mors”, viene definita misera ad Ap 20, 5: da essa risorgono le anime glorificate, sicure dalla “seconda morte” (cfr. supra). E l’angelo che ha la faccia come il sole giura ad Ap 10, 5-7 la certezza della fine dei tempi, per consolare gli eletti perseguitati e vessati dalle miserie che desiderano uscire dal carcere di questa vita e sempre sospirano la patria eterna. L’annunzio della caduta di Babilonia, che tanto ha angustiato lo spirito degli eletti, viene da questi considerata ad Ap 14, 8 come l’uscita dal carcere in volo verso la libertà. Miseria, ad Ap 3, 17, sta all’opposto della beatitudine.
Così i quattro innocenti figli di Ugolino trasformano la sofferenza corporale patita nella Muda in un desiderio di liberazione dal carcere della vita verso l’eterno. Posti “a tal croce”, essi sono configurati al Cristo uomo, all’Agnello sacrificato. Come Cristo, offrono la propria umanità al padre.
È un’offerta, quella delle misere carni vestite dal padre, che si avvicina ad altra rinuncia alla vita, quella di Catone, il quale in nome della libertà morale lasciò in Utica “la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara”. A questa rinuncia è assimilabile il viaggio di Dante e Virgilio, che hanno fuggita “la pregione etterna”, e il secondo dice del primo a Catone: “libertà va cercando, ch’è sì cara” (Purg. I, 71). Libertà da una nuova Babilonia storicamente operante; libertà dalla propria Babilonia, la meretrice interiore, fino al compiuto libero arbitrio [2].
«Poscia che fummo al quarto dì venuti, / Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi, / dicendo: “Padre mio, ché non m’aiuti?”» (Inf. XXXIII, 67-69). Il figlio che si rivolge al padre è certamente memore delle parole di Cristo crocifisso in Matteo 27, 46 – “Deus meus Deus meus, ut quid dereliquisti me” [3], né gli è estranea la reminiscenza di Polite che cade morto ai piedi del padre Priamo (Aen. II, 531-532). Prostrarsi a terra rinvia però anche all’esegesi del vescovo della sesta chiesa, Filadelfia, alla quale Cristo promette che verranno a lui, adorando, i Giudei convertiti (Ap 3, 9). Sarà l’atto di Dante di fronte all’angelo portiere, depositario delle chiavi della porta del purgatorio: “Divoto mi gittai a’ santi piedi; / misericordia chiesi e ch’el m’aprisse” (Purg. IX, 109-110). La preghiera di Gaddo adorante non ottiene, invece, dal padre impietrito l’apertura, verso la libertà spirituale, dell’uscio chiavato dell’orribile torre.
■ Secondo Gioacchino da Fiore, l’altare designa quel piccolo numero di santi padri e profeti che precedettero la venuta di Cristo, sui quali, come sopra un altare, vennero offerte le orazioni e i voti dei giusti. Non solo infatti la passione di Cristo ci giovò nell’impetrare la misericordia divina, ma anche la fede e il merito dei padri che precedettero; non perché Cristo non sia sufficiente a tutto, ma perché nelle opere di pietà vuole avere consorti i santi padri (Ap 8, 3).
Virgilio, quale antico padre, è l’altare su cui Marzia, la moglie di Catone passata a Ortensio e ritornata al primo marito nell’età estrema della vita, offre la sua preghiera. L’espressione di Virgilio, che sta nel Limbo con la donna dagli occhi casti, riecheggia la preghiera di Cristo al Padre in Giovanni 17, 6.11, citata ad Ap 8, 3: “Tui erant, et michi eos dedisti” │ “ma son del cerchio ove son li occhi casti / di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega, / o santo petto, che per tua la tegni: / per lo suo amore adunque a noi ti piega” (Purg. I, 78-81; cfr. Convivio IV, xxviii, 17). È variante rispetto alle parole dette a Ugolino dai figli: “tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia”; anche Catone, rispetto a Dante, è “padre” (v. 33). Il motivo dell’offerta e del pregare altri perché offrano o preghino, già iniziato con il riferimento a Beatrice, “per li cui prieghi / de la mia compagnia costui sovvenni” (vv. 53-54), prosegue con la promessa del poeta pagano di ringraziare Marzia della grazia fatta da Catone di lasciare andare lui e Dante per i sette regni del Purgatorio (“grazie riporterò di te a lei”, v. 83) e con il rifiuto di Catone di accettare una preghiera che è in realtà lusinga. Ai suoi occhi Marzia piacque tanto di là, tanto da farle in vita ogni grazia da lei richiesta. Ora che dimora nel Limbo, “di là dal mal fiume” d’Acheronte, non può più commuovere il marito, a motivo della legge della grazia che lo ha salvato (vv. 85-90). La corretta preghiera, afferma Catone, deve essere fatta in nome di Beatrice, “donna del ciel” (vv. 91-93).
Pregare perché altri preghino, motivo appropriato a Cristo cui vengono offerti molti incensi affinché li offra sull’altare, è la radice semantico-tematica di molte situazioni nel poema, fra le quali Dante stesso viene a trovarsi, per esempio quando è assediato dalla calca delle ombre “che pregar pur ch’altri prieghi” (Purg. VI, 25-27), che chiedono cioè suffragi per rendere più breve la loro permanenza nell’antipurgatorio. Delle prerogative di Cristo uomo e Figlio, sacerdote, offerente, avvocato si fregia Matelda.
L’altare può essere anche interpretato come la solida verità di fede o come la maestà di Dio su cui debbono essere fondati e offerti i nostri voti e sacrifici. Davanti ad esso sta Cristo uomo che, come pontefice, offre sé e noi a Dio. Né bisogna meravigliarsi che Dio rivesta più ruoli, di altare e di colui al quale vengono presentate le offerte.
L’ultima e più alta variazione è in san Bernardo, avvocato che prega perché altri preghi. Negli occhi dell’oratore si fissano quelli, diletti e venerati da Dio, della Vergine per mostrare quanto le siano grate le devote preghiere che poi rivolge a Dio drizzando lo sguardo all’eterno lume (Par. XXXIII, 40-43). Maria, come Cristo, è insieme altare e pontefice, riceve le preghiere e le offre: “Tui erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi” │ “… tutti miei prieghi / ti porgo … perché tu ogne nube li disleghi / di sua mortalità co’ prieghi tuoi … Ancor ti priego, regina, che puoi / ciò che tu vuoli, che conservi sani, / dopo tanto veder, li affetti suoi. / Vinca tua guardia i movimenti umani …” (vv. 29-37).
“E il fumo degli incensi” (Ap 8, 4), cioè la spirituale fragranza delle devozioni che emanava dalle preghiere dei santi, “salì dalla mano dell’angelo davanti a Dio”, in quanto per merito e intercessione di Cristo offerente furono rese accettabili e, accettate, elevate in alto, con la cooperazione dell’influsso e del ministero della grazia di Cristo operante nella mente dei santi. Così dice san Bernardo: “vedi Beatrice con quanti beati / per li miei prieghi ti chiudon le mani!” (Par. XXXIII, 38-39). Il turibolo aureo (il corpo di Cristo purissimo o i santi oranti che offrono le preghiere degli eletti) è “omni gratia Deo gratum et incenso sacre et odorifere devotionis repletum”. Per “il suo fedel Bernardo” la regina del cielo “ne farà ogne grazia” (cfr. Par. XXXI, 100-102), lì dove Catone può parlare di Marzia solo al passato, “che quante grazie volse da me, fei” (Purg. I, 85-87).
■ Nell’esegesi della sesta delle sette coppe dell’ira divina, che vengono versate nella quinta visione, è esposto, fra gli altri, il tema del venire di Dio al giudizio con la subitaneità di un ladro, sottolineato dall’avverbio “ecce” e dal presente “venio” al posto del futuro ‘veniam’ per togliere ogni possibile stima dell’indugiare e per rendere più attenti, vigili e timorati: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 15). Un passo simmetrico, di più ampia esegesi, si trova ad Ap 3, 3 nell’istruzione data alla chiesa di Sardi, la quinta delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione. Il senso è che se il vescovo della chiesa di Sardi, accusato di essere negligente, intorpidito e ozioso, non vigilerà correggendosi, il giudizio divino verrà da lui come un ladro, che nel tempo notturno arriva di nascosto all’improvviso, senza che si sappia l’ora della venuta. Dalla collazione dei due passi deriva una rosa semantica che si riflette in molti luoghi del poema [cfr. Il sesto sigillo, 1d].
Qui si dà conto in breve unicamente dell’inciso, che si trova solo ad Ap 16, 15 – «“Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus; “et videant”, scilicet omnes tam boni quam mali, “turpitudinem eius”» -, articolato negli elementi vestimenta, virtutes, spoliatus, videant (il primo e il quarto del testo scritturale, il secondo e il terzo dell’esegeta).
A Inf. III, 112-114, la terzina descrive il volontario gettarsi nella barca di Caronte del “mal seme d’Adamo”: “Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie”. È da notare l’accostamento del vedere, appropriato al ramo, con lo spogliarsi, motivi non presenti nella reminiscenza virgiliana – “Quam multa in silvis autumni frigore primo / Lapsa cadunt folia …” (Aen. VI, 309-310) -, e che sono invece nell’esegesi di Ap 16, 15. L’estrema variazione del tema sarà a Par. XXVIII, 115-117: “in questa primavera sempiterna / che notturno Arïete non dispoglia” (l’Ariete è visibile di notte in autunno, di notte arriva il ladro a spogliare; ad Ap 3, 3 è esposto il tema paolino, dalla prima lettera ai Tessalonicesi 5, 2-3, del notturno sopravvenire del “fur” assimilato all’inopinato giudizio divino; partecipano i motivi, dalla settima visione, di Ap 21, 22-25, relativi alla Gerusalemme celeste che non conosce notte).
Nella selva dei suicidi, Pier della Vigna spiega che dopo la resurrezione i suicidi andranno anch’essi nella valle di Giosafat per riprendervi i propri corpi (le “nostre spoglie”) senza però rivestirsene, perché questi saranno da loro trascinati per la selva e appesi ciascuno al pruno che incarcera l’anima (Inf. XIII, 103-108). Il corpo non è in questo caso “la carne glorïosa e santa … rivestita” (cfr. Par. XIV, 43-44), bensì ‘spoglia’, cioè carne spogliata di virtù, “ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie”.
A Inf. XXVII, 127-129, il tema del “fur” è nel “foco furo” che fascia Guido da Montefeltro, che va “sì vestito”, perché gli altri lo vedano (“et videant” / “là dove vedi”): sono tutti motivi da Ap 16, 15.
Nel colloquio con Sordello, anche Virgilio usa il motivo del vestirsi di virtù e di buone opere (Purg. VII, 25-27). Egli ha perduto il cielo “non per far, ma per non fare”, cioè “per non aver fé” in quel Dio “che fu tardi per me conosciuto”. Il “non fare” corrisponde ai «“vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera», e per questo il poeta pagano aggiunge: “quivi sto io con quei che le tre sante / virtù non si vestiro, e sanza vizio / conobber l’altre e seguir tutte quante” (vv. 34-36). Virgilio distingue tra le virtù cardinali, di cui si rivestì, e quelle teologali, di cui non poté rivestirsi. Qui il tardare non è peccato, perché solo la prescienza divina poteva stabilire il tempo della redenzione; designa un fatto ineluttabile e doloroso. A Virgilio non appartiene comunque l’essere ‘spogliato’ di virtù.
A questi temi (congiunti con la citazione di Giovanni 17, 6.11 nell’esegesi di Ap 8, 3) sono interessati anche i celebri versi: “Tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia” (Inf. XXXIII, 62-63).
Ad Ap 16, 15 si riferisce ancora Bonaventura nell’elogio di Domenico: “le novelle fronde / di che si vede Europa rivestire”, aperte da Zefiro, dove i temi dell’aprire e dell’essere nuovo sono tipici del sesto stato (Par. XII, 48).
[1] De Sanctis, L’Ugolino di Dante (1869), pp. 42-43.
[2] Questa l’interpretazione morale di Babilonia, data ad Ap 19, 10: « Nota quod, secundum morale misterium, meretrix Babilon est concupiscentia carnis vel mens pravis concupiscentiis a Deo aversa. Bestia vero, supra quam sedet, est bestialis voluptas vel prava et bestialia obiecta concupiscentie prave, vel bestialis societas menti carnali subiecta et serviens. Septem autem capita bestie sunt septem genera principalium obiectorum concupiscentie prave, que distinguuntur secundum septem genera capitalium vitiorum. Nam unumquodque habet suum formale et proprium et principale obiectum. In sexta autem etate mortalis hominis, scilicet in senio, ceciderunt quinque reges, scilicet quinque sensus (cfr. Ap 17, 10). Tunc tamen precipue regnat sextus, id est avaritia, quem secuturus est septimus, scilicet intolerabilis et desperatus timor et tristitia de mortis imminentia et de mundialis vite nimium dilecte deficientia. Decem autem reges et cornua meretricem cremantia (cfr. Ap 17, 16) sunt decem genera penarum infernalium, quarum quinque sunt sensibiles, secundum quinque sensus corporis quos affligunt, alia vero quinque sunt intellectualia. Primum est certitudo interminabilis eternitatis pene. Secundum est intimus sensus reprobative [despectionis] et ire et inimicitie Dei et omnium sanctorum ad dampnatos. Tertium est corrosivus remorsus conscientie, quia ex culpa propria et pro complacentia vili et transitoria tantam penam promeruerunt et in tanta dampna et supplicia se precipitaverunt. Quartum est tabescentia invidie dampnatorum ad beatos et ad gloriam eorum. Quintum est crepatio importabilis impatientie in summas sui ipsius maledictiones et proprie adnichilationis exoptationes et in Dei et sanctorum et etiam omnium blasphemationes se incessabiliter eviscerantis. Qui autem per horum decem compunctivam et contritivam considerationem in se ipso comburit et occidit prefatam meretricem et reddit ei duplicia secundum demerita eius (cfr. Ap 18, 6), iste cantat quater alleluia et intrat ad nuptias Agni».
[3] Sono parole che proclamano innocenza. Cfr. PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Matthaeum, cap. XXVII, Mt 27, 46, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 10900, f. 191vb: «“Clamavit Iesus voce magna dicens: Hely, Hely […] deus meus deus meus, quare me dereliquisti”. Dixit autem hoc Christus iuxta modum hominum innocentissimorum admirantium quomodo tanta patiuntur et pati permittuntur absque culpa sua». I figli di Ugolino “Innocenti facea l’età novella”, come rimprovera Dante a Pisa.
Gaddo è un nome significante. La prima delle dodici tribù d’Israele da cui provengono i 144.000 segnati all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 5) è quella di Giuda, interpretato come “colui che confessa”. A questa si aggiunge la “visione” timorosa, la considerazione della maestà del Figlio di Dio e dei suoi giudizi, designata dalla seconda tribù di Ruben, interpretato come “figlio che vede” o “figlio della visione”. Dopo questo si esige la virtù dell’astinenza che macera la carne per espugnare virilmente le concupiscenze, designata dalla terza tribù di Gad, interpretato come “cinto”, ossia armato. Primo dei figli a morire per fame, Gaddo concorda nel nome con il digiuno virtuoso e vittorioso sulla carne, a differenza del padre, al quale esso non recò contrizione e conversione, ma la “seconda morte”.
Tab. 24
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 3-4 (radix IIIe visionis)] “Et alius angelus” et cetera (Ap 8, 3). Angelus iste, qui obtulit omnium sanctorum incensum et sacrificium Deo Patri, est Christus sacerdos magnus et pontifex, qui tam natur[a] sue deitatis quam gratia singularis sanctitatis et dignitatis et auctoritatis est longe alius a septem angelis, id est ab universitate doctorum et sanctorum. Qui “venit”, per nature humane et mortalis assumptionem, “et stetit ante altare”, id est ante curiam seu hierarchiam celestem. Pro quanto enim, secundum carnis sue passibilitatem, minoratus est paulo minus ab angelis (cfr. Heb 2, 7; Ps 8, 6), habuit eos quasi ante se.
|
|
Inf. XXXIII, 55-63Come un poco di raggio si fu messo
|
Purg. I, 31-33, 76-93vidi presso di me un veglio solo,
|
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 3-4 (radix IIIe visionis)] Sequitur (Ap 8, 3): “habens turibulum aureum in manu sua”, id est corpus suum purissimum omni gratia Deo gratum et incenso sacre et odorifere devotionis repletum.
|
Par. XXXI, 100-102E la regina del cielo, ond’ ïo ardo
|
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 13-15 (Va visio, VIa phiala)] Hec igitur erit preparatio ad facilius producendum carnalem ecclesiam in errores Antichristi magni et orientalium regum. De quorum adductione, et per quorum suggestionem adducentur, ostendit subdens: “(Ap 16, 13) Et vidi de ore drachonis et de ore bestie et de ore pseudoprophete tres spiritus immundos exire in modum ranarum. (Ap 16, 14) Sunt enim spiritus demoniorum facientes signa et procedunt ad reges totius terre congregare illos in prelium ad diem magnum Dei omnipotentis”. […] Dicuntur autem tres a trino ore exire, tum in misterium trinitatis pessime, sancte trinitati personarum Dei et virtutum eius opposite […].
|
|
Inf. III, 113-114; XIII, 103-104; XXIV, 133-135; XXVII, 127-129; Purg. VII, 34-35; Par. XII, 47-48………………………..fin che ’l ramo
|
Inf. XXXIII, 61-63, 70-71e disser: “Padre, assai ci fia men doglia
|
[LSA, cap. XIX, Ap 19, 17-18 (VIa visio)] “Et vidi unum angelum stantem in sole” (Ap 19, 17). Iste designat altissimos et preclarissimos contemplativos doctores illius temporis, quorum mens et vita et contemplatio erit tota infixa in solari luce Christi et scripturarum sanctarum, et secundum Ioachim inter ceteros precipue designat Heliam. “Et clamavit voce magna omnibus avibus que volabant per medium celi”, id est omnibus evangelicis et contemplativis illius temporis: “Venite, congregamini ad cenam Dei magnam”, id est ad spirituale et serotinum convivium Christi, in quo quidem devorabitur universitas moriture carnis, ut transeat quod carnale est et maneat quod spirituale est. Unde subdit (Ap 19, 18): “ut manducetis carnes regum et carnes tribunorum et carnes fortium et carnes equorum et sedentium in ipsis et carnes hominum liberorum ac servorum ac pusillorum et magnorum”. Hoc, quantum ad populos et reges tunc Christo et eius ecclesie incorporandos, significat idem quod et illud quod dictum est Actuum X° Petro videnti quadrupedia et serpentia et volatilia in magno vase linteo, cui dicitur: “Occide et manduca” (Ac 10, 9-16). Quibus autem verbis explicari posset quanto gaudio et amore et dulcore reficientur sancti de conversione omnium gentium et Iudeorum post mortem Antichristi fienda.[LSA, cap. XIV, Ap 14, 8 (IVa visio, VIum prelium)] Nota quod sicut eius ante casum malitia et potestas supra modum impedivit et angustiavit spiritum electorum et conversionem totius orbis, sic eius exterminium erit sanctis quasi exitus de carcere ad libertatis latitudinem et volatum et exitus de tenebrosissimo fumo fornacis ad lucem solarem et sicut exhoneratio a lapide molari seu a monte immenso. |
|
Inf. XXXIII, 55-63Come un poco di raggio si fu messo
|
Purg. I, 40-42, 70-72“Chi siete voi che contro al cieco fiume
|
[LSA, cap. X, Ap 10, 5-7 (IIIa visio, VIa tuba)] Sequitur (Ap 10, 5): “Et angelus, quem vidi stantem supra mare et supra terram, levavit manum suam in celum (Ap 10, 6) et iuravit per viventem in secula seculorum, qui creavit celum et ea que in illo sunt, et terram et ea que in ea sunt, et mare et ea que in eo sunt, quia tempus amplius non erit; (Ap 10, 7) sed in diebus vocis septimi angeli, cum ceperit tuba canere, consumabitur misterium Dei, sicut evangelizavit per servos suos prophetas”. Iuramentum hoc designat vehementem certitudinem et assertionem quod tempus huius seculi omnino finietur in tempore septime tube. Non enim intendit quod post hoc iuramentum suum non sit tempus amplius, sed quod in voce septimi angeli consumabitur. Iurat autem hoc ita fortiter, tum ad fortius perterrendum malos et terrendo convertendum ad penitentiam, tum ad consolandum electos multiplicibus persecutionibus et miseriis vexaturos et de exilio et carcere huius vite cupientes exire et ad eternam patriam iugiter suspirantes. |
[LSA, cap. XX, Ap 20, 5 (VIIa visio)] Utraque autem conregnatio (regnum gratie et regnum glorie) vocatur hic “resurrectio prima” (Ap 20, 5), quia hec primo in mente precedit; secundo autem subsequetur secunda, scilicet resurrectio corporum. Prima enim, scilicet iustificatio mentis per gratiam, vocatur resurrectio quia per eam resurgimus a morte culpe originalis vel actualis, unde Apostolus ad Colossenses II° dicit: “Consepulti estis Christo in baptismo, in quo et resurrexistis per fidem” (Col 2, 12), et capitulo III° dicit (Col 3, 1): “Si conresurrexistis cum Christo, que sursum sunt querite”. Glorificatio autem anime erit consumatio huius, et etiam per eam resurgent anime a miseria huius vite, que est quasi continua mors. Consimiliter etiam prima mors est mors culpe et etiam temporalis mors, per quam corpus ab anima separatur. Secunda autem est mors pene eterne, que dicitur mors non quod ibi naturalis vita extinguatur, sed quia omnis delectatio et requies est ibi extincta et quia ibi est dolor perpetuus peior morte et faciens continue appetere mortem. |
Tab. 25
[LSA, cap. III, Ap 3, 9 (Ia visio, VIa ecclesia)] Unde subdit: “Ecce faciam illos”, scilicet tales esse, “ut veniant”, id est per influxum mee gratie tantam immutationem cordis faciam in eos ut veniant. Vel sensus est: “faciam” ut illi “veniant et adorent ante pedes tuos”, scilicet querendo humillime et devotissime a te doceri et baptizari et regi. Adorare sumitur hic pro vehementer ipsum venerari et cum signis maxime subiectionis et humiliationis, puta prosternendo se ante pedes eius. Vel potest esse sensus: “et adorent”, scilicet me, “ante pedes tuos”, id est prostrati ante te confitebuntur se credere in me. “Et scient”, scilicet tunc, “[quia]”, id est quod, “ego dilexi te”, quamvis scilicet contrarium appareret pro eo quod non dedi tibi virtutem miraculorum nec fortium operum corporalium.Purg. XXXII, 106-108Così Beatrice; e io, che tutto ai piedi
|
Inf. XXXIII, 67-69Poscia che fummo al quarto dì venuti,
|
[LSA, cap. XV. Ap 15, 3-4 (radix Ve visionis)] Pro operibus vero misericordie, subdunt: “Quia solus pius es”, scilicet per se et substantialiter et summe; “quoniam omnes gentes venient”, scilicet ad te tamquam a te misericorditer vocate et tracte, “et adorabunt in conspectu tuo, quoniam iudicia tua manifesta sunt”, scilicet per evidentes effectus perditionis Antichristi et suorum et salvationis electorum. |
|
14. I giorni della Passione
Al suono della sesta tromba, nella terza visione apocalittica, scrive Giovanni: “E udii una voce dai quattro lati dell’altare d’oro che si trova dinanzi agli occhi di Dio” (Ap 9, 13). Questa voce una, secondo Riccardo di San Vittore, è la voce concorde dell’universale dottrina; i quattro lati dell’altare d’oro designano i predicatori che levano in alto e portano Cristo col predicare i quattro Vangeli alle quattro parti del mondo. Cristo è detto altare, perché su di lui vengono offerti i nostri sacrifici (cfr. Ap 8, 3-4); sta dinanzi agli occhi di Dio perché il Padre si compiacque nel Figlio (cfr. Mt 3, 17; 17, 5; Mr 1, 11; Lc 3, 22). Accanto a questa interpretazione Olivi giustappone quella, tragica, di Gioacchino da Fiore. I quattro lati dell’altare sono i quattro evangelisti dai cui Vangeli una comune voce è udita, dicente che Cristo sarà consegnato a tradimento in mano dei peccatori alla fine del quinto giorno (giovedì) che precede la Parasceve ebraica; che sarà crocifisso, morrà e sarà seppellito nel sesto giorno (venerdì, cioè nella Parasceve). La voce intende dire che al momento del suono della sesta tromba i figli delle tenebre verranno sciolti perché sia compiuta la parola di Cristo: “Quando vedrete che Gerusalemme è circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vicina” (Luca 21, 20).
I quattro lati dell’altare sono pure, secondo Olivi, le quattro virtù di Cristo che chiamano perché i figli delle tenebre siano sciolti, cosicché vengano a punire Babylon che tanti crimini ha commesso contro Cristo alla fine del quinto stato. Lo grida la verità di Cristo da essa conculcata e che invece è degna di essere esaltata, la giustizia di Cristo che esige vendetta con la punizione corrispondente alle colpe, la misericordia di Cristo verso gli eletti troppo oppressi, che devono essere liberati, e la vita e la gloria di Cristo che conviene e giova siano dichiarate a tutto il mondo e da questo adorate e partecipate, il che non può avvenire se prima non siano stati espulsi dalla Chiesa le turpitudini e quanti insozzano.
I motivi dei quattro lati dell’altare da cui esce una comune voce, di Cristo tradito e consegnato nelle mani dei nemici nel quinto giorno che precede la Parasceve, della sua crocifissione nel sesto giorno, del chiamare contro le scelleratezze della nuova Babilonia, percorrono come cellule musicali il racconto del conte Ugolino (Inf. XXXIII, 43-58, 67-74, 85-89), dove la poesia li appropria variandoli: il padre scorge “per quattro visi il mio aspetto stesso”; vede cadere tre dei suoi quattro figli, posti “a tal croce”, tra il quinto e il sesto giorno di prigionia; li chiama per due giorni dopo morti, ha voce di aver tradito Pisa consegnando i castelli ai nemici. Ciò che nell’esegesi è concentrato solo su Cristo, nei versi è diffuso: è Pisa ad essere “tradita … de le castella” (per voce comune che accusa Ugolino; “fore traditum … d’aver tradita”: unico caso, nel poema, del participio passato di tradire); ma alla croce essa ha posto i quattro figli del conte (che rode l’arcivescovo Ruggieri, a sua volta traditore), per cui s’è fatta “novella Tebe”, figura della “nova Babilon” e della nuova crocifissione di Cristo. Il poeta invoca perciò che la città, “vituperio de le genti / del bel paese là dove ’l sì suona”, venga punita con il muoversi della Capraia e della Gorgona a chiudere la foce dell’Arno sì da farne annegare gli abitanti, invettiva che contiene il tema del muoversi delle isole e con il conseguente sterminio dei popoli che segna il terremoto con cui si apre il sesto sigillo (Ap 6, 14; 16, 20) [1]. Il suonare del “sì ” nel “bel paese” trova riscontro nell’amen – “vere sic sit et fiat” – con cui i seniori e gli animali lodano Dio (Ap 7, 11-12). I tempi che scandiscono la fine del conte e dei suoi figli nella Muda sono gli stessi della passione di Cristo. Ma l’ottavo giorno, la domenica di resurrezione, designato dall’ottava beatitudine – “Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam” (Mt 5, 10) -, o dallo stadio paolino (l’ottava parte del miglio romano) in cui tutti corrono ma uno solo vince il premio e che è misura dei lati della Gerusalemme celeste (1 Cor 9, 24, cfr. Ap 21, 16), non è stato tale per il conte: “vid’ io cascar li tre ad uno ad uno / tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’ io mi diedi, / già cieco, a brancolar sovra ciascuno, / e due dì li chiamai, poi che fur morti. / Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno”.
[1] Annegare nelle acque dell’errore è tema dell’esegesi del versamento della terza coppa, ad Ap 8, 11.
Tab. 26
[LSA, cap. IX, Ap 9, 13 (IIIa visio, VIa tuba)] Dicit ergo: “Et audivi vocem unam ex quattuor cornibus altaris aurei, quod est ante oculos Dei”.
|
|
Secundum autem Ioachim, quattuor cornua altaris sunt quattuor evangeliste, a quorum evangeliis unam communem vocem audivimus dicentem Christum fore traditum in manus peccatorum in fine quinte diei que precedit paraceven, die vero sexta crucifixum, mortuum et sepultum; que vox innuit nobis in spiritu quod filii tenebrarum erant solvendi tempore sexti angeli tuba canentis ad complendum illud verbum Christi: “Cum videritis Iherusalem circumdari ab exercitu, tunc scitote quia prope est exterminium eius” (Lc 21, 20)*.
|
Inf. XXXIII, 55-57, 67-74, 79-89
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 14 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Tunc etiam montes, id est regna ecclesie, et “insule”, id est monasteria et magne ecclesie in hoc mundo quasi in solo seu mari site, movebuntur “de locis suis”, id est subvertentur et eorum populi in mortem vel in captivitatem ducentur. […] Est enim tunc nova Babilon sic iudicanda sicut fuit carnalis Iherusalem, quia Christum non recepit, immo reprobavit et crucifixit.muovasi la Capraia e la Gorgona,
|
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 20 (radix VIe visionis)] Deinde effectum huius iudicii insinuat quoad duas partes pene eterne. Quarum prima est pena dampni, scilicet privatio omnis boni iocundi, et hanc tangit cum subdit: “Et omnis insula fugit, et omnes montes non sunt inventi”. Sicut in terra nichil firmius et eminentius aut tutius quam montes, sic in mari nichil stabilius et humane quieti aptius quam insule, et ideo per consumptionem seu non inventibilem subversionem vel per translationem omnium montium et insularum, tam hic quam supra sub apertione sexti sigilli (cfr. Ap 6, 14), designatur consumptio vel subversio solidiorum et emi-nentiorum et immobiliorum statuum et urbium et ecclesiarum et regnorum totius carnalis ecclesie. |
15. E due dì li chiamai, poi che fur morti
Il chiamare dei santi martiri affinché la giustizia divina vendichi il loro sangue viene considerato in più punti da collazionare (Ap 5, 1 si riferisce al difetto che rende chiuso il quinto sigillo; Ap 6, 9-11 ai mali presenti nella Chiesa all’inizio e alla fine del quinto stato). Da tutti questi passi simmetrici si deduce che all’apertura del quinto sigillo i santi, rattristati fino alla disperazione per i mali che invadono la Chiesa, chiedono a gran voce che venga fatta sùbita vendetta contro i carnali del quinto tempo che dispregiano Cristo e i suoi. Con grande desiderio gridano a Dio: “Fino a quando, Signore, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?”. Nel “fino a quando” sta la loro insofferenza ad attendere ancora una vendetta rinviata e che la giustizia divina non può ulteriormente procrastinare. Poiché santo, Dio non può non odiare l’iniquità, e in quanto vero non può non mettere in pratica i mali minacciati e i beni promessi. Tuttavia ai santi del quinto stato viene detto di quietarsi e di aspettare le cose grandi che avverranno all’apertura del sesto sigillo, allorché saranno rivelati segreti fino allora chiusi e si rinnoveranno i gloriosi martìri in modo che il numero degli eletti sia completato.
Il tema del santo desiderio di vendetta che chiama contro i malvagi e che non soffre altra attesa risuona più volte nel poema. Il grande desiderio di Dante di vedere Filippo Argenti attuffato nella broda dello Stige viene soddisfatto mentre tutti gridano “A Filippo Argenti!” (Inf. VIII, 52-63). In principio del canto successivo, a Virgilio tarda l’arrivo del messo celeste che faccia vendetta dei diavoli che hanno chiuso le porte della città di Dite (Inf. IX, 9).
I Malebranche non sono estranei a tale sentimento. Chinano i loro uncini sul poeta per accoccargli un colpo sul groppone, ma vengono trattenuti da Malacoda (Inf. XXI, 100-105). I “maladetti” invitano Rubicante a scuoiare lo sciagurato Ciampolo, ma vengono fermati da Barbariccia affinché Virgilio possa domandare per conto di Dante. Poco dopo, però, Libicocco, ritenendo di aver atteso troppo – “troppo avem sofferto” – gli porta via con l’uncino un brandello di braccio (Inf. XXII, 40-42, 70-72; il maledire appartiene alla tematica del quinto sigillo, ad Ap 5, 1: la sentenza di maledizione nei confronti di chi non rispetta la vecchia legge rende chiuso il sigillo, che apre invece la “pietas indulgens” di Cristo come di una madre verso il figlio).
Il conte Ugolino chiama due volte i figli dopo morti e il desiderio del poeta che Pisa venga punita si sfoga nell’invettiva che succede all’episodio (Inf. XXXIII, 74, 79-84; in questo caso, il chiamare e l’esigere vendetta coincidono con i motivi analoghi contenuti nell’esegesi della sesta tromba, ad Ap 9, 13).
Il tema compare ben tre volte fra gli avari e i prodighi del purgatorio, in una zona (il quinto girone) che principalmente si riferisce al quinto stato. La prima volta è il poeta a maledire l’antica lupa e a domandare al cielo il momento dell’arrivo del Veltro (Purg. XX, 10-15). La seconda volta è Ugo Capeto a chiedere sùbita vendetta a colui che tutto giudica a nome di Douai, Lille, Gand, Bruges vessate da Filippo il Bello (vv. 46-48), come i santi del quinto stato dai quali “expetitur instanter et alte iusta vindicta”. Ancora Ugo Capeto si rivolge a Dio chiedendogli quando potrà godere la gioia di vedere attuata la vendetta per ora nascosta nel suo segreto, chiusa cioè fino a quando, nel sesto stato, verrà il giudizio di Babylon (vv. 94-96). Terminato l’episodio di Ugo Capeto, un terremoto scuote la montagna: si tratta di un’allusione al terremoto con cui si apre il sesto sigillo (vv. 127-141). Allo stesso gruppo tematico appartiene l’accenno di Stazio alla vendetta della passione di Cristo compiuta dal “buon Tito” con la distruzione di Gerusalemme (Purg. XXI, 82-84): il senso letterale è un dato autobiografico di Stazio, quello spirituale un’allusione alla caduta della nuova Babilonia preceduta dal ricordato terremoto, prefigurato dalla fine della vecchia Sinagoga (cfr. prologo, Notabile XI).
Il tema viene usato ancora nell’apostrofe alla “serva Italia” di Purg. VI, con il rivolgersi al “sommo Giove” crocifisso in terra per chiedergli se rivolga altrove i suoi giusti occhi (vv. 118-123). Un ulteriore passo che può essere accostato agli altri è ad Ap 2, 23 (prima visione, quarta chiesa), dove si fa riferimento al fatto che Dio, i cui occhi di fuoco vedono e penetrano tutto, talvolta non punisce i peccatori secondo quanto giustizia esige, e allora sembra ignorare i mali.
L’episodio di Traiano e della vedovella, scolpito nel marmo del primo girone del Purgatorio (Purg. X, 73-93), raffigura la misera madre che chiede vendetta al ‘signore’ della morte del proprio figlio, e che avvenga presto, per un dolore che “s’affretta”. La vedovella chiama l’imperatore “Segnor mio”, come Ugo Capeto che si rivolge a Dio perché punisca il suo sangue. Sta “al freno”, che è tema della quinta tromba (Ap 9, 1), dove designa la rigida e severa disciplina verso i sudditi applicata dai prelati del principio ‘bello’ del quinto tempo. Traiano le risponde di aspettare il suo ritorno, che è quanto viene detto ai santi del quinto stato desiderosi di vendetta. Alla fine Traiano decide di compiere il proprio dovere prima di partire, perché “giustizia vuole e pietà mi ritene”, dove l’esigenza di giustizia fa parte dei temi proposti ad Ap 6, 9-11 (“cum iustitia tua exigat”) e la pietà è tema proprio del quinto stato. Anche l’espressione “Or ti conforta” appartiene al gruppo, essendo riferita nel quinto sigillo alla Chiesa romana, “confortata” da Dio nel suo vigore presso i latini del quinto stato (Ap 6, 11). Traiano, che pietoso rende giustizia alla vedovella, è il modello di quello che dovrebbe fare e non fa Alberto tedesco, il quale (Purg. VI, 97ss.) non viene a vedere la sua Roma “che piagne vedova e sola” come la madre privata del figlio dinanzi al suo glorioso predecessore nel “roman principato”. La diffusissima leggenda, che Dante aveva certo presente, mostra dunque una diversa armatura spirituale.
Chi non ha aspettato, è stato Cesare indotto dallo scismatico Curione, il quale sta nella nona bolgia “con la lingua tagliata ne la strozza”. Vorrebbe non aver mai visto la terra di Rimini dove, scacciato da Roma, spense il dubbio di Cesare se passare o no il Rubicone, affermando che il differire sempre nuoce a chi è pronto (Inf. XXVIII, 97-102). L’episodio deriva da Lucano – “tolle moras; semper nocuit differre paratis … affermando che ’l fornito / sempre con danno l’attender sofferse” -, ma la Pharsalia (I, 269, 280-281) concorda con la Lectura super Apocalipsim. L’attendere, tema che si oppone al motivo del “fornito”, deriva appunto dal quinto sigillo (Ap 6, 9.11), alla cui apertura viene espresso il desiderio dei santi di vedere vendicati i mali della Chiesa: perché differire la vendetta divina? Ai santi viene risposto che l’esecuzione della giustizia divina deve attendere fino al momento in cui sia raggiunto il numero di eletti prestabilito. I tre motivi addotti per attendere gli altri eletti – l’essere tutti conservi dello stesso Signore, la mutua fraternità dallo stesso Padre, la conformità nel martirio – bene si adattano a un caso di guerra civile.
L’attendere di Traiano è speculare a quello di Cesare, con effetti però diversi quanto alle cause della rimozione. Nel primo caso è la vedovella che chiede giustizia, nel secondo Curione che spinge Cesare alla guerra civile, cioè allo scisma ereticale, e come tale è punito. Ciò anche se le parole dello scismatico sono servite agli occulti giudizi divini, che ha voluto le folgoranti imprese sotto il vittorioso e reverendo segno dell’aquila, allorché “Cesare per voler di Roma il tolle” (Par. VI, 57).
Il Vespro siciliano è stato anch’esso un non attendere, determinato dalla “mala segnoria” angioina, con l’effetto dell’irreparabile scisma della Sicilia dal resto d’Italia. Di questa scissione è antica prefigurazione “l’alpestro monte ond’ è tronco Peloro”, di cui dice Guido del Duca a Purg. XIV, 32. “Troncare” non è verbo casuale. Appartiene ai suicidi incarcerati nella mesta selva, che hanno diviso l’anima dal corpo, come ai seminatori di scandalo e scisma. È tema tipico del terzo stato della Chiesa, nel tempo in cui i dottori con la spada della ragione spezzano le eresie che dividono la Chiesa. Una tematica che topograficamente nell’Inferno si ritrova con Ciacco e Pier della Vigna, Niccolò III, Curione e i suoi compagni di pena, Lucifero che maciulla i sommi traditori, Giuda, Bruto e Cassio: da Firenze, “città partita”, alla divisione di sé stessi, allo strazio della Chiesa, agli scismi fino ai traditori di Cristo e del “voler di Roma”.
“Quella sinistra riva … per suo segnore a tempo m’aspettava … E la bella Trinacria … attesi avrebbe li suoi regi ancora …” (Par. VIII, 58-75). Nelle parole di Carlo Martello, l’attendere dei “popoli suggetti”, infranto dal terremoto in apertura del sesto sigillo, è tema dall’ampio sviluppo, proprio dell’apertura del sigillo precedente, il quinto, ove si dice a quanti desiderano ardentemente la vendetta di Dio sui reprobi di aspettare il completarsi del numero degli eletti e le grandi cose che si compiranno nella sesta apertura.
L’espressione “se mala segnoria, che sempre accora / li popoli suggetti” richiama “ond’io m’accoro” detto dalla vedova a Traiano, esempio di ‘buona signoria’ nel rinunciare ad attendere nel far vendetta, mentre l’ingiusto dominio angioino ha reso vano l’attendere della discendenza del giusto Carlo Martello vissuto, come Cristo, per poco tempo.
È da notare che il tema del confortare, unito con quello dell’attendere, compare in luoghi percorsi da altri motivi del quinto stato. Virgilio dice a Dante di attenderlo mentre parla con gli ostinati diavoli custodi della città di Dite e di confortare di buona speranza “lo spirito lasso” (il quinto stato è per antonomasia rilassato nel suo declinare), che qui significa affranto per la paura insinuata dalle “parole maladette” che l’avevano sconfortato (Inf. VIII, 106-108). Ugo Capeto parla di sé non per il conforto che attende da quanti sono ancora in vita (di preghiere o di fama), ma perché vede rilucere tanta grazia in Dante (Purg. XX, 40-42).
Un esempio di clamore perché si attui la vendetta contro la corruzione della Chiesa è nel “grido di sì alto suono” fatto dalle fiammelle che nel cielo di Saturno discendono la scala d’oro per confermare l’invettiva di Pier Damiani contro i moderni pastori. In quel grido, non inteso da Dante, è contenuta una preghiera di vendetta la quale, come gli dice Beatrice, “come madre che soccorre / sùbito al figlio palido e anelo / con la sua voce”, il poeta vedrà prima di morire (Par. XXI, 136-142; XXII, 1-18). E san Pietro è l’ultimo nel poema ad invocare su Caorsini e Guasconi una punizione di Dio che non sembra arrivare. Nei versi (Par. XXVII, 57-60) sono cuciti due temi: il primo è la richiesta a Dio perché giudichi i malvagi, il secondo è quello del buon principio caduto a vile fine (cfr. prologo, Notabile V), secondo l’interpretazione (“principium pulchritudinis”) data al nome della quinta chiesa, Sardi.
È da notare infine come la sublimazione dell’attendere sia la speranza, di cui tanto bene parla Dante di fronte a san Giacomo, suo apostolo eponimo, a Par. XXV, 67ss. – «“Spene”, diss’ io, “è uno attender certo / de la gloria futura» – in un contesto pregno di signacula (si notino quelli relativi alle “bianche stole”) che rinviano la memoria del lettore spirituale all’esegesi oliviana dell’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9-11).
Tab. 27 (l’esame dell’esegesi dell’apertura del quinto sigillo, con riferimento alle citazioni di Gioacchino da Fiore, è stato condotto altrove)
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (IIa visio, Vum sigillum)] In quinta autem (apertione), contra torporem accidie et otii quinti temporis, quod est sentina luxurie et omnis iniquitatis, clamant sancti martires eorum sanguinem, id est penales labores et dolores usque ad mortem, vindicari in illos. […]
|
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 9-11 (IIa visio, apertio Vi sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum quintum, vidi” et cetera. Ea que hic dicuntur possunt referri ad initium quinti status vel ad eius medium vel ad eius extremum. In initio enim eius visa est ecclesia quasi tota deficere, ac si novissimum iudicium huius seculi advenisset. Propter etiam scelera hereticorum et ypocritarum et scismaticorum et apostatantium ad sarracenicam sectam et ceterorum infidelium, videbatur martirium et labor primorum sanctorum vehementer exigere et expetere extremum iudicium dampnationis dari contra reprobos, post tanta sanctorum certamina et testimonia et exempla nolentes Christum et ipsos sequi. […]
|
[Ap 6, 9-11] Referendo vero predicta ad finem quinti status, designatur quod tunc tot et tanta scelera in carnali ecclesia inundabunt, et iam diu est inundare ceperunt, quod tam sancti preteriti quam presentes, ex tanta malorum inundantia fere usque ad desperationem contristati, cum grandi clamore expetunt et adhuc amplius expetent iudicium fieri pro ipsis et contra reprobos. Designatur etiam quod tunc a multis erat putandum finem mundi adesse, propter tantam inundantiam malo-rum et tantam paucitatem bonorum.
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (IIa visio, Vum sigillum)] Tertia ratio septem sigillorum quoad librum veteris testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. (…) Quintum est severitas preceptorum et iudiciorum, quia precipit “non concupisces” et “diliges Deum ex toto corde” (Dt 5, 21; 6, 5), et multa alia infirmitati humani generis ex se impossibilia, et tamen dat sententiam maledictionis omnibus qui non permanserint in omnibus verbis legis. Hanc autem temperat et exponit condescensiva Christi pietas indulgens multa infirmitatibus nostris, sicut mater infantulo suo. Et hoc notatur in quinta apertione, cum expetentibus iustitiam respondetur “ut requiescerent adhuc” per “tempus modicum, donec compleantur conservi eorum et fratres” (Ap 6, 11), id est ut propter pietatem fraterne salutis patienter differant et prolongent iudicia ultionis. |
|
Inf. VIII, 10-11, 52-57, 61, 94-96, 106-108; IX, 9Ed elli a me: “Su per le sucide onde
|
Par. VIII, 58-60, 67-75Quella sinistra riva che si lava
|
Par. IX, 34-35
ma lietamente a me medesma indulgo
la cagion di mia sorte, e non mi noia
Inf. XXI, 100-102; XXII, 40-42, 70-72
Ei chinavan li raffi e “Vuo’ che ’l tocchi”,
diceva l’un con l’altro, “in sul groppone?”.
E rispondìen: “Sì, fa che gliel’ accocchi”.
“O Rubicante, fa che tu li metti
li unghioni a dosso, sì che tu lo scuoi!”,
gridavan tutti insieme i maladetti.
E Libicocco “Troppo avem sofferto”,
disse; e preseli ’l braccio col runciglio,
sì che, stracciando, ne portò un lacerto.
Inf. XXXIII, 74, 81
e due dì li chiamai, poi che fur morti
poi che i vicini a te punir son lenti
Purg. XX, 10-15, 40-41, 46-48, 94-96, 127-128; XXI, 82-84
Maladetta sie tu, antica lupa,
che più che tutte l’altre bestie hai preda
per la tua fame sanza fine cupa!
O ciel, nel cui girar par che si creda
le condizion di qua giù trasmutarsi,
quando verrà per cui questa disceda?
Ed elli: “Io ti dirò, non per conforto
ch’io attenda di là ……………………. ”
Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia
potesser, tosto ne saria vendetta;
e io la cheggio a lui che tutto giuggia.
O Segnor mio, quando sarò io lieto
a veder la vendetta che, nascosa,
fa dolce l’ira tua nel tuo secreto?
quand’ io senti’, come cosa che cada,
tremar lo monte ………………… 6, 12
Nel tempo che ’l buon Tito, con l’aiuto
del sommo rege, vendicò le fóra
ond’ uscì ’l sangue per Giuda venduto
[LSA, prologus, Notabile XI] Deinde per Neronem, misso contra Iudeam Vespasiano et Thito, factus est terremotus sinagogam quasi alteram Babilonem subvertens (cfr. Ap 6, 12) […]
Inf. XXVIII, 97-99
Questi, scacciato, il dubitar sommerse
in Cesare, affermando che ’l fornito
sempre con danno l’attender sofferse.
Par. XXVII, 57-60
o difesa di Dio, perché pur giaci?
Del sangue nostro Caorsini e Guaschi
s’apparecchian di bere: o buon principio,
a che vil fine convien che tu caschi!
[LSA, prologus, Notabile V] (…) idcirco circa finem quinti temporis crevit enormiter laxatio omnimoda et fere in omnes, propter quod digno iudicio permissi sunt ruere in vilissimam fecem heresis Manicheorum.
Par. XXI, 139-142; XXII, 4-7, 10-15
Dintorno a questa vennero e fermarsi,
e fero un grido di sì alto suono,
che non potrebbe qui assomigliarsi;
né io lo ’ntesi, sì mi vinse il tuono.
e quella, come madre che soccorre
sùbito al figlio palido e anelo
con la sua voce, che ’l suol ben disporre,
mi disse: ………………………….
“Come t’avrebbe trasmutato il canto,
e io ridendo, mo pensar lo puoi,
poscia che ’l grido t’ha mosso cotanto;
nel qual, se ’nteso avessi i prieghi suoi,
già ti sarebbe nota la vendetta
che tu vedrai innanzi che tu muoi”.
Par. XXIII, 7-9
previene il tempo in su aperta frasca,
e con ardente affetto il sole aspetta,
fiso guardando pur che l’alba nasca
Tab. 27 bis
[LSA, cap. VI, Ap 6, 9 (IIa visio, apertio Vi sigilli)] Quia vero sufficiens numerus electorum, secundum eternam Dei predestinationem et secundum Christi redemptoris condignam honorificentiam et secundum congruentiam consumationis civitatis celestis et secundum promissionem factam patribus de plena reductione Israelis ad Christum, nondum erat completus, sufficiebatque interim sanctis animabus gloria ipsarum ante resumptionem et glorificationem suorum corporum eis dat[a], ideo primo premittitur primus ordo iustitie, cum dicitur: “vidi subtus altare Dei” et cetera (Ap 6, 9). |
|
Par. XXV, 67-69, 91-96, 124-129“Spene”, diss’ io, “è uno attender certo
|
[Ap 6, 11] Deinde subduntur duo propter que iudicium hoc debet convenienter differri ad tempus.
|
16. Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno
La Scrittura è “pelago”, mare vitreo simile a cristallo che sta dinanzi alla sede divina (Ap 4, 6; cfr. supra). Resta dinanzi alla Chiesa in modo che gli eletti possano in essa vedere l’aspetto del proprio volto e conoscano quali essi siano, e anche possano comprendere le cose invisibili di Dio come in un chiaro specchio e per mezzo di esso. Così guarda Ugolino, dopo che ha sentito inchiodare l’uscio dell’orribile torre: «ond’ io guardai / nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto … e Anselmuccio mio / disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?” … e io scorsi / per quattro visi il mio aspetto stesso» (Inf. XXXIII, 47-48, 50-51, 56-57). Se il “mare di vetro” designa l’amaro e infinito patire di Cristo, la tolleranza del martirio, la contrizione penitenziale, all’opposto il conte non sa sopportare le tribolazioni, è impaziente e si dispera mordendosi le mani per il dolore, guarda nei fanciulli – che sono quattro come i Vangeli, come pure vengono interpretati i “quattro lati dell’altare d’oro” ad Ap 9, 13 – ma, accecato dall’odio, perde la vista delle cose spirituali. Se la Scrittura è come il collirio, che designa l’amara compunzione dei propri peccati (Ap 3, 18), Ugolino guarda nel viso dei suoi figli che piangono, ma lui non piange né lacrima, fatto di pietra nel cuore. Non comprende il senso del piangere dei figli, che hanno fame e desiderio di cibo spirituale, di libertà dalla mondana e carnale Babylon, come dimostra l’offerta al padre delle “misere carni”.
Un passo simmetrico ad Ap 4, 6 è Ap 15, 2, nella “radice” (cioè nella parte proemiale) della quinta visione delle coppe. In questo caso viene descritto lo stato sublime, il trionfo e lo zelo dei santi ai quali spetta di versare tali coppe. Il mare qui (a differenza di Ap 4, 6, dove è “vetro simile a cristallo”) è detto “vetro misto a fuoco”; designa la contemplazione ignea, la macerazione penitenziale, l’amarezza e la tolleranza delle tribolazioni, grande e profonda come il mare, perspicua e solida come il vetro, mescolata al fuoco della fervida carità. L’acqua del mare corrisponde al senso letterale della Scrittura, il fuoco all’intelligenza spirituale e ardente. Il mare è anche l’immensa sapienza di Cristo ripiena del fuoco della carità e di zelante giustizia, l’amara e immensa passione di Cristo trasparente come vetro, mezzo che consente di contemplare le sue viscere.
Questo rompersi del gelo, spandere lacrime nella contrizione per le proprie colpe, farsi vincere dal dolore del pentimento manca del tutto al petroso Ugolino. Chiuso nell’odio, non si apre alla misericordia divina. A differenza dei santi e degli spirituali che ad Ap 15, 2 hanno vinto la bestia, è egli stesso un bestiale.
Il passo ‘radice’ della quinta visione delle coppe è anche l’unico della Lectura in cui compaia un riferimento al digiuno che possa essere applicato alla cruda morte del conte. Vi si dice che gli spirituali debbono vincere gli “spiritalia et subtilia vitia” dell’Anticristo con la preghiera e con il digiuno.
Il verso finale – “Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno” (Inf. XXXIII, 75) – se interpretato nel senso letterale, significa: «‘Dopo, la fame fu più forte del dolore’. Il dolore non poté ucciderlo, la fame sì» [1].
I sensi spirituali, o mistici, insistono su due parole apparentemente contrastanti: dolore, digiuno. Il dolore, che fu dato al conte perché rinnovasse in sé e nei fanciulli la passione di Cristo, non portò a contrizione o a conversione. Alla confluenza dell’“Archian rubesto” con l’Arno, “Bonconte” da Montefeltro, ferito a morte a Campaldino, fu vinto dal dolore e si pentì: “già cieco” come “conte Ugolino” (“Quivi perdei la vista”), una “lagrimetta” lo salvò; cadde lasciando il corpo gelato sulla foce. Inutilmente l’“Archian rubesto”, per la pioggia mossa dal diavolo, alla confluenza con l’Arno “sciolse al mio petto la croce / ch’i’ fe’ di me quando ’l dolor mi vinse” (Purg. V, 100-102, 107, 124-129).
Il dolore che genera odio non recò a Ugolino il pentimento. Fu ucciso dalla fame brutale e bestiale, quella che lo accomuna alla macerata “antica lupa”, fregiata dei mortiferi segni del cavallo pallido dell’Apocalisse (Ap 6, 8). Neanche il digiuno gli giovò. I vizi spirituali e sottili, che un uomo spirituale avrebbe dovuto vincere col digiuno e la preghiera, consistevano nel dubbio indotto dal “mal sonno” che gli aveva predetto la vittoria mondana del suo nemico Ruggieri, e nell’equivoco tra il domandare il pane da parte dei figli, che è desiderio di cibo spirituale, e il suo mordersi le mani per la disperazione, mostrando un desiderio materiale di cibo. È proprio dei martiri del sesto stato della Chiesa dover sostenere, oltre alle sofferenze corporali che furono proprie dei primi martiri per la fede, anche un “certamen dubitationis”, il dubbio sulla verità indotto dai persecutori con la sottigliezza degli argomenti filosofici, con le distorte testimonianze scritturali che vinsero Francesca e Paolo, con l’ipocrita simulazione di santità, con la falsa immagine dell’autorità divina o pontificale che perdé Guido da Montefeltro.
Né il senso letterale, dunque, né quello spirituale autorizzano a pensare alla tecnofagia del conte. Al di fuori della lettera e dello spirito non c’è altro, nel tragico verso oggetto di tanta critica. Affermare che Dante abbia ambiguamente voluto insinuare nel lettore l’ipotesi più terribile – nel senso: “chi vuole intendere, intenda” – è illazione non consentita dall’esame dei testi [2]. In Dante non esiste l’indistinto, né la sua è poesia dalle mezze tinte [3]. L’indubbia oscurità deriva dal fatto che il senso letterale incorpora semanticamente altri sensi contenuti in un’altra opera, la Lectura super Apocalipsim, e che questo linguaggio per segni si è subito perduto, insieme al suo pubblico e alla chiave che l’apriva, rimanendo la lettera con la selva delle interpretazioni.
Certamente, come scriveva Benedetto Croce, “se questa è la lettera, non è il senso poetico di quel verso, che vien preparato e determinato da tutto il racconto precedente” [4]. Ma questo è segnato, fin dall’inizio, dai temi del dolore, disperato e pieno d’odio, e della fame, non quella del verbo ristoratore di Cristo per cui i fanciulli domandano del pane come la Samaritana domandò la grazia dell’acqua che sazia in eterno la sete (cfr. Purg. XXI, 1-3), ma la fame che, in assenza del Verbo, si fa bestialità e morte per consunzione.
Né il conte che si morde le mani e i fanciulli che gli si offrono in pasto insinuano che alla fine il misero padre abbia divorato le membra dei figli morti. Quel mordersi è sempre indotto dal disperato dolore; l’offerta dei fanciulli, ripetendo quella di Cristo al Padre, fa segno di una divorazione spirituale.
D’altronde una sola cronaca contemporanea, di parte fiorentina e dunque antipisana, riporta la diceria sul cannibalismo (reciproco però fra i cinque prigionieri, non del solo padre) [5]; più realisticamente, gli Annales Ianuenses di Iacopo d’Oria, redatti prima del 1293, riferiscono che “unusquisque sibi manus et brachia comederunt” [6], dato che si rispecchia nel verso “ambo le man per lo dolor mi morsi”.
La compiuta metamorfosi del mare di cristallo misto a fuoco (Ap 15, 2) è nel cielo di Saturno. Il “settimo splendore”, che viene definito “cristallo” (Par. XXI, 25; il termine è ad Ap 4, 6, luogo parallelo), si trova congiunto con il segno del “Leone ardente” e raggia il proprio influsso, freddo e secco, “misto … del suo valore”: è cioè “vetro misto a fuoco” (vv. 13-15). In esso Beatrice invita Dante a guardare come in uno specchio (ad Ap 4, 6), per rendere i propri occhi specchi della figura (la scala d’oro) che gli apparirà (vv. 16-18). Nel cielo di Saturno si mostrano gli spiriti contemplanti. San Benedetto tesse le sue parole con i fili tratti da Ap 15, 2, dove il fuoco di cui è misto il vetro del mare designa il fuoco della contemplazione, la fervida carità e l’ardente intelligenza spirituale della Scrittura. A Dante timoroso di essere inopportuno nel domandare, “la maggiore e la più luculenta / di quelle margherite” si rivolge in nome della “carità che tra noi arde”, che se il poeta vedesse come la vedono i beati, non avrebbe esitazione nell’esprimere i suoi concetti (Par. XXII, 28-33). I compagni di Benedetto sono “fuochi tutti contemplanti”. Sono coloro, come Macario e Romualdo, che fermarono i piedi dentro ai chiostri e tennero il cuore saldo, in un momento in cui la regola non era rimasta “per danno de le carte” (vv. 46-51, 74-75). Benedetto, descrivendo la moderna decadenza dei monasteri, ricorda il buon principio di essi, e di lui stesso che cominciò “con orazione e con digiuno” (vv. 88-90): si tratta degli strumenti che ad Ap 15, 2 Olivi assegna agli spirituali per conseguire la vittoria contro i sottili vizi dell’Anticristo, in modo da potersi infine elevare sopra il mare di vetro misto a fuoco.
[1] Cfr. INGLESE, Inferno, p. 369, nt. a v. 75.
[2] Cfr., fra tanti esempi, Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno. Commento di A. M. CHIAVACCI LEONARDI, Milano 2005, p. 992, nt. a v. 75; CONTINI, Filologia ed esegesi dantesca, p. 126.
[3] Cfr. F. D’OVIDIO, Nuovi studi danteschi. Ugolino, Pier della Vigna, i simoniaci, I, Napoli 1932 (Opere, II. I), pp. 51-96: 91-92: “Di solito il genio, e il genio di Dante in ispecie, vede chiaro, ha un fantasma netto, e nettamente lo riproduce. Così vorrebbe aver fatto pur quando la parola lo ha tradito e gli è venuta oscura; per non dir di quando ciò è mera colpa o di vocaboli divenuti arcaici, o di notizie dimenticate, o di nozioni perdute di vista, o di opinioni smesse, o di ottusità dei lettori, o di sofisticherie degl’interpreti”.
[4] B. CROCE, Letture di poeti, Bari 1950, p. 299.
[5] Cfr. Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento, a cura di A. SCHIAFFINI, Firenze 1926, p. 133.
[6] Cfr. Annales Ianuenses, ed. C. IMPERIALE DI SANT’ANGELO, in Fonti per la Storia d’Italia, XIV, Roma 1929, p. 88.
Tab. 28
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 10-11 (Va visio, Va phiala)] Per hanc autem “sedem bestie” principaliter designatur carnalis clerus in hoc quinto tempore regnans et toti ecclesie presidens, in quo quidem bestialis vita transcendenter et singulariter regnat et sedet sicut in sua principali sede et longe plusquam in laicis plebibus sibi subiectis.
|
|
Inf. XXXII, 133-134; XXXIII, 46-58, 72-75
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 6 (radix IIe visionis)] “Et in conspectu sedis”, scilicet erat, “tamquam mare vitreum simile cristallo”. Per mare designatur Christi amara et quasi infinita passio et lavacrum baptismale et penitentialis contritio et martiriorum perpessio et pelagus sacre scripture. Quodlibet enim horum est puritate et claritate et pervia perspicuitate vitreum et soliditate cristallinum. Hec omnia etiam sunt ad utilitatem ecclesie ordinata et ad cultum et gloriam maiestatis Dei. Scriptura etiam ideo manet in conspectu ecclesie, ut in ea valeant electi species facierum suarum prospicere ad cogno-scendum se quales sint, et etiam ut in ipsa tamquam in speculo et per speculum possint intelligere invisibilia Dei.
|
[LSA, cap. XV, Ap 15, 2 (radix Ve visionis)] “Et vidi tamquam mare”. Hic describitur fontalis radix septem effusionum. Et hoc quoad quattuor. Primum est sublimis status et triumphus et zelus sanctorum ad quos spectat effundere. Per “mare” enim “vitreum mixtum igne”, designatur contemplatio ignea et penitentialis maceratio et amaritudo, et etiam tribulationum perpessio magna et profunda sicut mare et perspicua et solida sicut vitrum et igne superfervide caritatis commixta. Sicut etiam in aqua maris designatur doctrina littere, sic in igne intelligentia spiritalis et ardens.
|
|
Tab. 29
17. Il bel paese là dove ’l sì suona*
Il valore di “sì”, confermativo del vero, risulta sempre in tutti i passi della Lectura dove compare la parola “Amen”: “id est sic fiat … vere et fideliter sit … fiat hoc quod dictum est … vere sic sit et fiat … vere ita est … id est verus seu veritas” (Ap 1, 6-7; 3, 14; 5, 14; 7, 12; 19, 4; 22, 20-21). Si può vedere come i motivi che accompagnano l’“Amen” convergano sulle beffarde parole del diavolo che porta ai Malebranche, nella bolgia dei barattieri, “un de li anzïan (un ‘seniore’, come quelli della ‘santa’ turba che adora Dio seduto sul trono, dicendo ‘Amen’) di Santa Zita”, per tornare “per anche” (l’avverbio etiam che accompagna l’“Amen” ad Ap 1, 7 e 22, 20) a Lucca, dove “del no, per li denar, vi si fa ita”, cioè “sì” (Inf. XXI, 37-42).
“Amen, id est vere sic sit et fiat”: è tema proprio dell’Italia, “del bel paese là dove ’l sì suona” (Inf. XXXIII, 80).
Quando Virgilio profetizza del Veltro: “Di quella umile Italia fia salute” (Inf. I, 106), il senso spirituale è ben diverso dalla pur presente reminiscenza di sé stesso “humilemque videmus Italiam” (Aen., III, 523-524). Il poeta pagano pronuncia parole che aprono la memoria del canto di lode della moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni gente, tribù, popolo e lingua, confermata dagli angeli, dai seniori e dai quattro animali che stanno intorno al trono (Ap 7, 10-12): «“dicentes: Salus Deo nostro”, id est salus nostra non nobis ascribatur … scilicet se profunde humiliando Deo, “et adoraverunt Deum (Ap 7, 12) dicentes: Amen”, id est vere sic sit et fiat sicut hec sancta turba decantat et orat”».
In così alta retorica del significante, viene in rilievo la simmetria fra terzine nella numerazione dei versi di singoli canti, o meglio il numero stesso della terzina. Non può essere infatti casuale che l’Italia sia due volte collocata sull’ultimo verso della 35a terzina (vv. 103-105) a Purg. VI (“che ’l giardin de lo ’mperio sia diserto”) e a Par. XI (“redissi al frutto de l’italica erba”).
La semantica rinvia ad Ap 8, 7 (terza visione, prima tromba) e ad Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra), dove si tratta della Giudea, un tempo fiorente giardino poi divenuta deserto per il suo indurirsi contro Cristo. Da essa la donna (la Chiesa) fugge nella solitudine del deserto dei Gentili (il “lito diserto” della montagna del purgatorio), che fiorisce, mentre la Giudea si fa “selva selvaggia” («“in saltum” seu silvam “reputabitur”, id est silvestrescet»). Ma nel sesto stato la Giudea, dopo la conversione delle reliquie delle genti, si volgerà umilmente per ultima a Cristo come promesso al vescovo di Filadelfia, la sesta chiesa d’Asia (Ap 3, 9).
L’Italia, “’l giardin de lo ’mperio”, la fruttuosa “erba” alla quale torna Francesco, la nuova Giudea, è terra d’umiltà: “per … herbas virentes designantur simplices, humilitatem et virorem fidei et vite honeste et pie servantes” (Ap 9, 4, quinta tromba: passo simmetrico ad Ap 8, 7 per il “fenum”); è pure il “bel paese là dove ’l sì suona”, dove cioè si conferma in terra il sovranazionale canto di lode che gira la sede divina in cielo: «“dicentes: Amen”, id est vere sic sit et fiat ».
La stessa esegesi, da Ap 8, 7 (prima tromba) e 9, 4 (quinta tromba) segna anche, a Purg. I (35a terzina), gli umili giunchi sulla riva del purgatorio (è da notare, ancora, come degli stessi temi si faccia segno nelle terzine 44a e 45a di Purg. I, VII – che hanno lo stesso numero di versi – e XXVII).
La turba immensa, non di una sola gente o lingua, ma di ogni gente, tribù, popolo e lingua, che sta davanti al trono e nel cospetto dell’Agnello, avvolta in vesti candide e con le palme nelle mani, designa coloro che sono venuti alla gloria dalla passione, dalla sofferenza e dal martirio, come affermato dal vegliardo (Ap 7, 14). Sono coloro che ad Ap 12, 10-11, al termine della seconda battaglia vinta per intervento di Michele (il secondo stato è quello dei martiri, cui si addice il combattere e la tribolazione), esultano e lodano Dio per la salvezza intervenuta; hanno vinto il diavolo “per mezzo del sangue dell’Agnello”; “non hanno amato le loro anime”, ossia le loro vite corporee, “fino alla morte”, esponendosi per Cristo ad ogni passione. Nella profezia del Veltro, il non essere di una sola gente, tribù, popolo o lingua coloro che stanno dinanzi al trono si adatta ai due versi relativi all’umile Italia, “per cui morì la vergine Cammilla, / Eurialo e Turno e Niso di ferute” (Inf. I, 107-108), nei quali non si fa distinzione tra l’appartenenza di campo dei caduti nella guerra combattuta nel Lazio da Enea, che rientra nel piano provvidenziale, ne “l’alto effetto” per il quale il troiano “fu de l’alma Roma e di suo impero / ne l’empireo ciel per padre eletto” (Inf. II, 16-24).
Il passo da Ap 12, 10, per la compresenza delle parole – dominatio / donna, spes / speranza, virtus / virtute, potestas / potestate, facta est salus / fatt’ hai sana; gratia / grazia, che appare dalla collazione con Ap 7, 10 -, conduce alla preghiera di ringraziamento che nell’Empireo Dante rivolge a Beatrice, donna della salute (Par. XXXI, 79-90).
Di fronte a tanto profondi significati che aprono prospettive di una storia della salvezza collettiva, quale senso ha che l’Italia stia due volte sulla 35a terzina? Forse la risposta si trova nell’esegesi di Ap 12, 6, relativa allo scambiarsi fra selva e deserto fiorito. Esegesi i cui signacula si rinvengono in molti versi fra i quali (ancora una volta la 35a terzina) Purg. VII, 105, riferito con variazione dissonante alla morte nel 1285 di Filippo III l’Ardito in fuga dagli Aragonesi: «“Et mulier”, id est ecclesia, “fugit in solitudinem” … De hac autem solitudine dicitur Isaie … Et capitulo XXXV° (Is 35, 1-2): “Letabitur deserta et invia, exultabit solitudo et florebit quasi lilium”.│morì fuggendo e disfiorando il giglio». Questo deserto che fiorisce è quello profetizzato da Isaia, più volte citato ad Ap 12, 6. Ivi fiorirà la giustizia (“et habitabit in solitudine iudicium et iustitia”, Is 32, 16). Il numero 35 è menzionato nel poema allorché, nel cielo di Giove, a Dante si mostra la scritta dipinta “Diligite iustitiam, qui iudicatis terram”, cioè il primo versetto del libro della Sapienza formato da 35 lettere (“Mostrarsi dunque in cinque volte sette / vocali e consonanti”; Par. XVIII, 88-93). Dante pensava che l’Italia sarebbe stata un giorno la sede della giustizia.
Si noterà che sulla 35a terzina di Inf. I e Purg. IX stanno rispettivamente l’“umile Italia”, della quale il Veltro “fia salute”, e l’umiltà di Dante nel chiedere all’angelo, vicario di Pietro, l’apertura della porta del purgatorio. Non significa che Dante e il Veltro coincidono, ma che quando scriveva i versi che riguardavano la sua conversione interiore, il poeta pensava a una renovatio universale.
“Nel crudo sasso intra Tevero e Arno” (Par. XI, 106). Il riferimento a La Verna, dove il serafino impresse le stimmate su Francesco, fa ancora segno della durezza giudaica, lapidea e legata al solo senso letterale della Scrittura, che sarebbe stata aperta da Cristo con “l’ultimo sigillo”. Nella parte proemiale della seconda visione, dedicata appunto all’apertura dei sette sigilli (Ap 4, 1-2), Olivi afferma che come sulla porta della tomba di Cristo era posta una pietra grande e pesante che fu rimossa al momento della resurrezione e dell’uscita dal sepolcro, così il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso all’intelligenza spirituale. Nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. Colui che per primo aprì la porta e diede la prima voce che ci fece salire al cielo fu Cristo, con la sua illuminazione e dottrina. La rupe alverniate fu per Francesco, che con il sesto stato iniziò un nuovo avvento di Cristo nello Spirito, come il sepolcro di Cristo, della cui vita fu perfetto imitatore. Per Ugolino, che mai volle aprire la sua durezza, il doloroso carcere fu tomba senza resurrezione.
* Si riprende qui quanto già esposto al capitolo 8 della lettura di Paradiso XI-XII.
Tab. 30
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (VIa ecclesia)] Sexta (ecclesia) autem dicitur habere hostium scripturarum [ac] predicationis et cordium convertendorum apertum, et quod Iudei debent ad eam cum summa humilitate adduci, et quod est servanda ne cadat in temptationem toti orbi venturam, quia Dei consilia et mandata longanimiter et patienter servavit, que utique competunt statui sexto. Unde et congrue vocatur Philadelphia, id est salvans hereditatem, quia in regula evangelica, quasi in archa Noe, salvabitur semen fidei et electorum a diluvio Antichristi tam mistici quam aperti.[LSA, cap. VII, Ap 7, 9 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Sequitur: “Post hec vidi turbam magnam” (Ap 7, 9). […] “Quam dinumerare nemo poterat” […] “Turbam”, inquam, non solum ex una gente vel lingua existente[m], sed “ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis stantes ante tronum”, id est ante regiam dignitatem divine maiestatis designatam per tronum. Vel “ante tronum”, id est ante generalem ecclesiam Dei, vel ante supercelestem, vel ante priorem ecclesiam sanctorum. “In conspectu Agni”, id est coram Christo homine tamquam ipsum colentes, et sicut servi stant coram Domino suo ad ipsum serviendum et honorandum. “Amicti stolis albis”, per candorem munditie et gratie et glorie. Nam hec turba videtur hic describi quasi iam per fidem et martirium perducta ad gloriam Dei. “Et palme in manibus eorum”, id est triumphalis gloria de victoria hostium erat et evidenter apparebat in eis. |
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 9 (Ia visio, VIa ecclesia)] Unde subdit: “Ecce faciam illos”, scilicet tales esse, “ut veniant”, id est per influxum mee gratie tantam immutationem cordis faciam in eos ut veniant. Vel sensus est: “faciam” ut illi “veniant et adorent ante pedes tuos”, scilicet querendo humillime et devotissime a te doceri et baptizari et regi. Adorare sumitur hic pro vehementer ipsum venerari et cum signis maxime subiectionis et humiliationis, puta prosternendo se ante pedes eius. Vel potest esse sensus: “et adorent”, scilicet me, “ante pedes tuos”, id est prostrati ante te confitebuntur se credere in me.Inf. XXXIII, 79-80Ahi Pisa, vituperio de le genti
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 10-12.14 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] “Et clamabant voce magna” (Ap 7, 10), id est magna devotione, “dicentes: Salus Deo nostro”, id est salus nostra non nobis ascribatur, quia non est a nobis, sed ascribatur illi a quo est, scilicet “Deo nostro, qui sedet super tronum”, id est divinitati magnifice regnanti, “et Agno”, id est Christo homini. Vel “salus”, quam habet deitas per naturam et Christi humanitas per gratiam, decante[tur] per nos ad eius laudem. “Et omnes angeli stabant in circuitu troni” (Ap 7, 11), tamquam scilicet famulantes regie maiestati Dei, et quasi eius exteriorem superficiem apprehendentes potius quam totalem immensitatem sue infinite et incomprehensibilis profunditatis, vel “in circuitu troni”, id est ad custodiam et protectionem ecclesie; “et seniorum et quattuor animalium, et ceciderunt in conspectu troni in facies suas”, scilicet se profunde humiliando Deo, “et adoraverunt Deum (Ap 7, 12) dicentes: Amen”, id est vere sic sit et fiat sicut hec sancta turba decantat et orat. Dicunt enim “Amen” confirmando laudem sancte turbe et ei iocunde correspondendo et congratulando et Deum pariter conlaudando. […] (Ap 7, 14) “Et dixit michi: hii sunt qui venerunt”, scilicet ad tantam gloriam, “de tribulatione magna”, id est pro magnis tribulationibus, quas ab impiis et etiam a se ipis contra suas concupiscentias concertantibus pro Christo passi sunt. “Et laverunt stolas suas”, id est corpora et animas, “et dealbaverunt eas”, scilicet candore perfecte gratie, “in sanguine Agni”, id est in merito passionis Christi per fidem et baptismum et per penitentiales mortificationes et tandem per martirium participato.Inf. I, 106-108Di quella umile Italia fia salute
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 10 (IVa visio, IIum prelium)] Deinde subditur Dei laus et exaltatio ex hoc facta a beatis in celo et a sanctis in ecclesia, que per celestem vitam ac per spem et desiderium celestium est quasi celum. Unde ait (Ap 12, 10): “Et audivi vocem magnam de celo dicentem: Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri et potestas Christi eius”, facta scilicet est tum per pleniorem et evidentiorem effectum sue virtutis et dominationis super demones cohercendos et salvationis electorum, “quia proiectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die ac nocte”. […]
|
|
Purg. IX, 103-108 (35-36)Sovra questo tenëa ambo le piante
|
Inf. I, 103-108 (35-36)Questi non ciberà terra né peltro,
|
Purg. VI, 103-105 (35)Ch’avete tu e ’l tuo padre sofferto,
|
Par. XI, 103-108 (35-36)e per trovare a conversione acerba
|
Purg. I, 103-105 (35), 133-136 (45)null’ altra pianta che facesse fronda
|
Purg. VII, 103-105 (35)E quel nasetto che stretto a consiglio
|
Purg. VII, 130-136 (44-45)Vedete il re de la semplice vita
|
Purg. XXVII, 133-135 (45)
Vedi lo sol che ’n fronte ti riluce;
|
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7 (IIIa visio, Ia tuba)] “Grando” significat duritiam et pertinaciam Iudeorum, que ad predicationem Christi et apostolorum fuit fortius congelata et indurata, sicut ad Moysi verba et signa Pharao fortius induravit cor suum. […] Per “terram” autem significatur hic Iudea, quia sicut terra habitabilis fuit segregata a mari et discooperta aquis, ut posset homo habitare in ea et ut ipsa ad usum hominis posset fructificare et herbas et arbores fructiferas ferre, sic Deus mare infidelium nationum et gentium separaverat a terra et plebe Iudeorum, ut quiete colerent Deum et facerent fructum bonorum operum, et ut essent ibi simplices in bono virentes ut herbe, et perfecti essent ut arbores grandes [et] solide et fructuose. […] Per “fenum” vero “viride” designantur simpliciores et imbecilliores, qui per bonam vitam virides videbantur et forsitan prius erant.[LSA, cap. IX, Ap 9, 4 (IIIa visio, Va tuba)] Deinde de cohibitione subdit: “et preceptum est illis ne lederent fenum terre neque omn[e] viride neque omnem arborem, nisi tantum homines, qui non habent signum Dei in frontibus suis” (Ap 9, 4). Per “fenum” et per ceteras herbas virentes designantur simplices, humilitatem et virorem fidei et vite honeste et pie servantes; per “arbores” vero perfectos et solidiores facientes magnos fructus. Non permittit ergo Deus istos ledi, nisi ipsi prius per pravum consensum se ipsos lederent et reprobarent. Quamdiu autem in sua bonitate permanendo illis non consentiunt, tota temptatio et tribulatio quam ab illis patiuntur proficit eis ad meritum et premium et ad virtuosum exercitium, et ideo non nocet eis, immo per accidens seu materialiter prodest.[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio, Ium prelium)] “Et mulier”, id est ecclesia, “fugit in solitudinem”. […] De hac autem solitudine dicitur Isaie XXXII° (Is 32, 15-16): “Erit desertum in Chermel”, id est [sic] pinguis in gratiis sicut prius fuerat Iudea, “et Chermel”, id est Iudea, “in saltum” seu silvam “reputabitur”, id est silvestrescet, “et habitabit in solitudine iudicium et iustitia” et cetera. Et capitulo XXXV° (Is 35, 1-2): “Letabitur deserta et invia, exultabit solitudo et florebit quasi lilium. Gloria Libani data est ei, et decor Carmeli et Sa[r]on”. Et capitulo XLI° (Is 41, 19): “Dabo in solitudine cedrum et spinam et mirtum et lignum olive, ponam in desertum abietem” et cetera. Et capitulo LIIII° (Is 54, 1): “Letare, sterilis que non paris, quia multi filii deserte magis quam eius que habet virum”.[LSA, cap. IV, Ap 4, 1-2 (radix IIe visionis)] Nota etiam quod hec sibi sic monstrantur et sic nobis scribuntur, quod sint apta ad misteria nobis et principali materie huius libri convenientia. Unde per celum designatur hic ecclesia et scriptura sacra, et precipue eius spiritalis intelligentia. Sicut autem in hostio monumenti Christi erat superpositus magnus lapis et ponderosus, qui Christo resurgente et de sepulcro exeunte est inde amotus, sic in scriptura erat durus cortex littere, pondere sensibilium et carnalium figurarum gravatus, claudens hostium, id est [ad]itum intelligentie spiritalis. In humanis etiam cordibus erat lapidea durities sensus obtusi, claudens introitum divinarum illuminationum.
|
|
Tab. 31
[LSA, cap. I, Ap 1, 6 (Salutatio)] “Amen”, id est sic fiat; vel “amen”, id est vere et fideliter sit ei.[LSA, cap. I, Ap 1, 7 (Salutatio)] “Plangent”, inquam, “omnes tribus terre”. Secundum Ricardum, “tribus terre” vocat omnes terrena diligentes et terrena Christo preferentes. Et ut certius sibi credatur confirmat hoc in duplici lingua, scilicet gentili et hebrea, dicendo: “Etiam. Amen”, id est vere plangent se. “Amen” enim est hebreum, sed “etiam” est latinum, pro quo est ibi adverbium grecum, quia hic liber fuit scriptus in greco. Utraque autem lingua, scilicet greca et latina, est gentilis. Per hec autem innuit quod in omni lingua fidelium hoc confirmabitur, et omnis lingua reproborum hoc clamabit experimento penarum compulsa.[LSA, cap. XXII, Ap 22, 20-21 (Conclusio)] Deinde ad magis confirmandum subdit (Ap 22, 20): “Dicit”, scilicet predicta, “qui testimonium perhibet ipsorum”, scilicet Christus, secundum Ricardum: «Christus enim cuncta que in hoc libro sunt attestatur». Posset tamen dici quod Iohannes dicit hoc de se ipso. Nam et in fine evangelii sui consimiliter dicit: “Hic est discipulus ille qui testimonium perhibet de hiis” (Jo 21, 24), et sicut hic confirmative subdit: “Etiam. Amen”, sic et ibi subdit: “Et scimus quia verum est testimonium eius”. Posuit autem hebreum “amen”, et ultra hoc adverbium grecum pro quo nos habemus latine “etiam”, ut innuat hoc omnimode et in omni lingua esse indubitabiliter asserendum.
|
|
Inf. XXI, 37-42Del nostro ponte disse: “O Malebranche,
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 11-12 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] “Et omnes angeli stabant in circuitu troni […] et seniorum et quattuor animalium, et ceciderunt in conspectu troni in facies suas”, scilicet se profunde humiliando Deo, “et adoraverunt Deum (Ap 7, 12) dicentes: Amen”, id est vere sic sit et fiat sicut hec sancta turba decantat et orat. Dicunt enim “Amen” confirmando laudem sancte turbe et ei iocunde correspondendo et congratulando et Deum pariter conlaudando.[LSA, cap. XIX, Ap 19, 4 (VIa visio)] Deinde ostendit quomodo communi laudi sanctorum correspondebit laus prelatorum presidentium collegiis sanctorum. Unde subdit: “Et viginti quattuor seniores et quattuor animalia ceciderunt et adoraverunt Deum sedentem super tronum dicentes: Amen, alleluia”, id est vere est Deus ineffabiliter laudandus. Dicendo enim “amen” confirmant laudem communitatis suorum subditorum, et post hoc addunt et ipsi suam laudem dicendo “alleluia”.Inf. XXXIII, 79-80Ahi Pisa, vituperio de le genti
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 8.14 (radix IIe visionis)] Ex hiis autem patet ratio tante iubilationis sanctorum et laudis ex libri apertione que hic immediate subditur, cum dicitur (Ap 5, 8-9): “Et cum aperuisset librum, quattuor animalia et viginti quattuor seniores ceciderunt coram Agno habentes singuli citharas et phialas aureas plenas odoramentorum, que sunt orationes sanctorum, et cantabant” et cetera. In qua quidem laude primo premittitur laus sanctorum hominum; secundo laus angelorum predicte laudi correspondentium, ibi: “Et vidi et audivi” (Ap 5, 11); tertio assensus sanctorum erga laudem angelorum, ibi: “Et quattuor animalia dicebant: Amen” (Ap 5, 14). Vel prout per quattuor animalia et seniores designantur angeli, tunc in prima ponitur laus superiorum ordinum, in secunda autem laus inferiorum ordinum mota a laude superiorum, in tertio vero confirmatio laudis inferiorum per superiores. […]
|
|
Appendice
Il libro scritto dentro e fuori
■ Nel quarto capitolo dell’Apocalisse viene mostrata la gloria e la magnificenza della maestà divina, nel quinto l’incomprensibile profondità del libro che sta per essere aperto da Cristo. Per questo si dice: “E vidi nella mano destra di Colui che era seduto sul trono un libro scritto dentro e fuori, sigillato con sette sigilli” (Ap 5, 1). Il libro designa in primo luogo la prescienza divina e la predestinazione a riparare l’universo per opera di Cristo. Per appropriazione, è il Verbo stesso del Padre in quanto espressivo della sua sapienza e in quanto il Padre, nel generarlo, scrisse in esso tutta la sua sapienza. In secondo luogo, il libro è la scienza delle intelligenze angeliche data ad esse da Dio e in esse scritta, che è scienza di tutta la grazia e la gloria degli eletti e del culto di Dio che deve compiersi per mezzo di Cristo. È pertanto, assai di più, la scienza universale scritta da Dio nell’anima di Cristo. In terzo luogo, è il volume della Sacra Scrittura e in particolare dell’Antico Testamento, nel quale il Nuovo venne rinchiuso, sigillato e velato sotto varie figure.
Con i temi del libro è tessuto, nel cielo di Giove, il linguaggio dell’aquila. Rifeo Troiano, quinta delle luci sante che cerchiano l’occhio della benedetta immagine, per la grazia che deriva “da sì profonda fontana”, inaccessibile a occhio creato, mise in terra tutto il suo amore per la giustizia e così, di grazia in grazia, Dio gli aperse l’occhio alla futura redenzione umana facendo in modo che credesse. Più avanti nell’esegesi, ad Ap 5, 3, si afferma che nessuno, senza la grazia di Dio e la presupposizione del merito di Cristo, poteva avere l’implicita fede e l’intelligenza simboleggiata dal libro chiuso con i sette sigilli. Alla meraviglia del poeta di vedere un pagano fra i beati (insieme a Traiano, che però già la leggenda voleva salvato) l’aquila replica dichiarando remota la radice della predestinazione dalle viste create (Par. XX, 118-124, 130-132). Si può notare in queste parole la presenza di termini come “fontana” e “radice”, che ad Ap 4, 2 sono appropriate alla profondità del libro che Cristo dovrà aprire, libro che è quello della predestinazione divina e nel quale è scritta la scienza della grazia (Ap 5, 1).
Nel canto precedente, l’aquila ha già fatto riferimento all’apertura del “volume” nel quale verranno scritti i “dispregi” dei regnanti (Par. XIX, 112-114): in questo caso l’apertura del libro segnato dai sette sigilli di Ap 5, 1 coincide con l’apertura del libro della vita di Ap 20, 12, per cui i morti verranno giudicati per quanto è ivi scritto, secondo le loro opere. Come spiegato nell’esegesi, il libro che sta nella destra di Colui che siede sul trono contiene nel suo profondo interno anche le leggi e i precetti del sommo imperatore e le sentenze e i giudizi del sommo giudice. Così l’aquila afferma che il vedere umano “ne la giustizia sempiterna … entro s’interna” come l’occhio nel “pelago” (è il termine che, ad Ap 4, 6, designa la Scrittura), il cui fondo, per quanto visibile dalla riva, gli rimane però celato in alto mare per la profondità (Par. XIX, 58-63): “proda” e “pelago”, cioè la riva e l’alto mare, corrispondono al di fuori e all’interno del libro (cfr. le parole di Pier Damiani a Par. XXI, 94-96 e di Dante a san Pietro a Par. XXIV, 70-72).
Un’altra applicazione del guardare dentro al libro è nella visione finale, allorché nel “profondo” della luce eterna il poeta vede come “s’interna”, unito dal legame d’amore “in un volume”, quello che nell’universo “si squaderna”, cioè si mostra diviso (Par. XXXIII, 85-87).
■ Il libro sta nella destra di Dio (Ap 5, 1), sia perché è nel suo pieno potere e facoltà, sia perché contiene le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo, e le elargizioni e preparazioni che spettano alla destra, come le avversità e le cose temporali alla sinistra.
Sta nella destra di Colui che siede sul trono, sia perché contiene le leggi e i precetti del sommo imperatore e le sentenze e i giudizi del sommo giudice, sia perché la sua intelligenza richiede una mente alta, stabile, matura, quieta e raccolta, come è proprio dell’intelligenza divina.
È un libro scritto dentro e fuori, poiché il libro della Sacra Scrittura ha un senso letterale di fuori, mentre dentro contiene il senso anagogico, quello allegorico e quello morale. Di fuori il senso letterale narra le storie, le gesta e gli esempi dei santi e le loro opere esteriori; dentro sono le più profonde sentenze dei divini precetti e degli insegnamenti sapienziali.
I motivi della profonda sapienza contenuta dentro al libro sono propri dell’elogio che nel cielo del Sole Tommaso d’Aquino fa della quinta e più fulgida luce fra gli spiriti sapienti: “entro v’è l’alta mente u’ sì profondo / saver fu messo, che, se ’l vero è vero, / a veder tanto non surse il secondo” (Par. X, 112-114). Le espressioni “entro”, “alta mente”, “profondo saver” coincidono con elementi semantici del testo esegetico. La luce resta innominata, ma in Par. XIII, 31-111 Tommaso chiarisce, pur senza mai nominarlo, che si tratta del più sapiente dei re, cioè di Salomone. Nella prima terzina del suo elogio, l’Aquinate afferma che la luce “spira di tale amor, che tutto ’l mondo / là giù ne gola di saper novella” (Par. X, 109-111), alludendo alle dispute terrene dei teologi, divisi tra i sostenitori della salvezza di Salomone e quelli della sua dannazione a motivo della lussuria senile. Così, a tutto il mondo che brama di avere notizie, Tommaso dà l’annuncio che l’anima non solo è salvata, ma è la luce “più bella” e “più dia” del quarto cielo (cfr. Par. XIV, 34).
Lo spirare d’amore è motivo che si ritrova nel medesimo capitolo quinto (Ap 5, 8). Dopo che l’Agnello ha preso il libro, i quattro animali e i ventiquattro seniori si prostrano dinanzi a lui, avendo ciascuno un’arpa e coppe d’oro colme di profumi. Le coppe (“phiale”) sono i cuori dei santi, lucenti per la sapienza, dilatati per la carità, splendenti di aurea fiamma per la contemplazione e ripiene di profumi che ridondano dalle devote orazioni. Come i profumi che sprigionano dal fuoco salgono verso l’alto e riempiono di odore tutto l’edificio, così le devote orazioni salgono alla presenza di Dio, lo raggiungono e piacciono per il loro esser soavi a Lui e a tutta la curia celeste e subceleste. Come il profumo che si diffonde spira in modo invisibile dagli aromi, così i devoti affetti di coloro che pregano spirano invisibili e si diffondono in modo amplissimo nelle varie maniere del santo amore, come è evidente nella varietà dei santi affetti espressi e messi in opera nei Salmi.
Lo stesso desiderio del mondo di aver nuove, di sapere cioè se Salomone sia o meno salvato, corrisponde al desiderio che il libro venga aperto, che è il tema fondamentale del quinto capitolo.
Le parole che Tommaso d’Aquino dice di Salomone sono tessute, non diversamente da quanto avviene per gli altri versi del poema, con i fili tratti dalla “pestifera postilla” dell’Olivi su cui si accanivano gli inquisitori domenicani. Proprio la figura di Salomone sembra una maschera, dietro la quale sta il maestro spirituale di Dante. Già Raoul Manselli sottolineava come il silenzio di Dante su Olivi, su un personaggio che non poteva non conoscere e stimare, potrebbe essere connesso con le polemiche e con il giudizio di ortodossia cui erano soggette le opere del francescano che, dopo morto, subì una persecuzione senza precedenti [1]. Si potrebbe anche affermare che, essendo la Commedia metamorfosi della Lectura super Apocalipsim, non era necessario che il poeta incontrasse nel suo pellegrinaggio il frate minore, la cui opera sempre gli stava innanzi e della cui teologia aveva rivestito Beatrice la quale, almeno nel poema sacro, non esiste al di fuori di essa. Eppure, se mai Pietro di Giovanni avesse dovuto trovar luogo nella Commedia, nessuna collocazione migliore avrebbe avuto che nel cielo del Sole. Lì avrebbe potuto ascoltare il suo ideale avversario in teologia, Tommaso d’Aquino, fare l’elogio di Francesco; sarebbe stato accanto al suo maestro Bonaventura, a Riccardo di San Vittore e a Gioacchino da Fiore, i due autori tanto citati nella Lectura, a Dionigi l’Areopagita, dal cui pensiero fu molto influenzato. Avrebbe udito da Bonaventura riprovare la mancanza di equilibrio nell’interpretare la Regola da parte del rigorista Ubertino da Casale, che pure dell’Olivi fu discepolo a Firenze e strenuo difensore nella “magna disceptatio”, e del rilassato Matteo d’Acquasparta, che come Ministro generale inviò nel 1287 Pietro di Giovanni al convento fiorentino di Santa Croce. La reticenza di Tommaso sul nome della quinta luce, rimediata in Par. XIII con un complesso argomentare che sembra aggiunto apposta per fornire un’interpretazione autentica a un’incertezza equivoca, giustifica il dubbio che il desiderio del mondo di sapere sulla salvezza o sulla dannazione dell’innominato non riguardi unicamente la lussuria di Salomone, ma pure e soprattutto la dottrina dell’Olivi. Le parole di Tommaso, che comunque non entrano nel merito della controversia, avrebbero come retroscena la battaglia intorno agli scritti dell’Olivi iniziata dopo la morte di questi (1298) e culminata, dopo la soluzione compromissoria tra la Comunità francescana e gli Spirituali trovata al concilio di Vienne (1311-1312), nella proibizione della lettura delle opere di Pietro di Giovanni, messe al rogo a Marsiglia (1319), e nella condanna della Lectura da parte di Giovanni XXII cinque anni dopo la morte di Dante (1326). La sentenza di riabilitazione del francescano, pronunciata in cielo dalla somma autorità di una delle parti avverse, proverrebbe da una figura esterna al suo Ordine, dal quale vennero le più aspre persecuzioni, e ciò è conforme all’infiammata cortesia reciproca tra Tommaso e Bonaventura, il primo dei quali si farebbe corifeo sia di Francesco sia di colui che aveva interpretato la Regola del “poverel di Dio” come un Vangelo vissuto. La redazione del Paradiso, generalmente collocata a partire dal 1316, è contemporanea all’inasprirsi della persecuzione contro la Lectura (nel 1318 Giovanni XXII ne affidò l’esame a otto maestri in teologia): quanto basta per spiegare il silenzio su Olivi da parte di Dante, che dal francescano aveva preso il “libro” per farne con i versi cosa nuova.
Questo significa che nel cielo del Sole si assiste a una pacificazione generale delle controversie terrene, a un vero e proprio giubileo: Tommaso d’Aquino presenta a Dante la luce più fulgida, dentro la quale è contenuta la vera sapienza cristiana, e poi Sigieri, altro avversario dei Domenicani; quindi narra la vita di Francesco. Bonaventura, il maestro di Olivi, narra la vita di Domenico, mentre gli luce accanto Gioacchino da Fiore. Quindi Tommaso insiste nell’elogio della sapienza “sufficiente” di Salomone come esempio di “regal prudenza”, che non fu rivolta alla filosofia mondana, e critica alcune degenerazioni di questa. Nel canto successivo, è la stessa luce di Salomone a parlare su richiesta di Beatrice, per risolvere un dubbio di Dante sulla luminosità dei beati dopo la resurrezione dei corpi. È un Salomone che splende di umiltà: dalla “luce più dia / del minor cerchio” esce “una voce modesta, / forse qual fu da l’angelo a Maria” (Par. XIV, 34-36). L’immagine dell’Olivi era quella del sapiente per eccellenza: “dono Dei sapiens vir”, lo definiva Angelo Clareno, che vi scorgeva il ‘sole’ profetizzato dall’Oraculum Cyrilli “propter splendidissimam sapientiae et scientiae sibi divinitus infusae multiformitatem” [2].
I temi propri del libro sono presenti, in un contesto tutto diverso da quello di Salomone, nella presentazione che Giustiniano fa di sé stesso (Par. VI, 10-12, 22-27). Da una parte stanno i motivi provenienti da Ap 5, 1: trarre “d’entro le leggi” (il libro contiene all’interno le leggi del sommo imperatore), “l’alto lavoro” (che corrisponde all’alta mente richiesta per l’intelligenza del libro), la “destra del ciel … sì congiunta” alle imprese di Belisario (il libro sta nella destra di Dio e contiene le promesse della grazia e della gloria; il congiungere è tema appropriato ai forti angoli delle mura della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione – Ap 21, 12, come pure il ‘posarsi’ è tema connesso con lo stadio, che è misura della città – Ap 21, 16) [3]. Da Ap 5, 8, il passo della cetra e delle coppe tenute in mano dai seniori utilizzato da Tommaso d’Aquino per descrivere la “quinta luce”, deriva il tema dello spirare da parte del primo amore e quello del beneplacito divino (è possibile una collazione con il passo simmetrico di Ap 16, 1, in cui i ministri del giudizio si apprestano a versare le coppe per ispirazione, comando e beneplacito di Dio, passo all’origine delle parole di Ulisse: “com’ altrui piacque”, e dello stesso Giustiniano il quale, a proposito del “sacrosanto segno” dell’aquila, afferma che “Cesare per voler di Roma il tolle”; cfr. altrove).
Se la “quinta luce”, oltre ad essere Salomone, designa Olivi, allora il medesimo panno – il libro della sapienza divina – offre i fili per ordire la figura del Cesare che ebbe in mano il sacrosanto segno dell’aquila, la figura del re prudente e quella della sapienza teologico-esegetica: dal libro, come da una fonte, discendono entrambe le autorità, la temporale e la spirituale. La sapienza di Salomone, come elogiata da Tommaso d’Aquino, non fu solo politica, ma anche filosofica, di una filosofia non inutile o fine a sé stessa: “non per sapere il numero in che enno / li motor di qua sù, o se necesse / con contingente mai necesse fenno; / non si est dare primum motum esse, / o se del mezzo cerchio far si puote / trïangol sì ch’un retto non avesse” (Par. XIII, 97-102). Salomone fece un “uso povero”, prudente e proporzionato, della sapienza, sfrondata del superfluo, al modo con cui Giustiniano trasse “d’entro le leggi … il troppo e ’l vano”.
Il tema dell’ispirazione d’amore si ritrova appropriato al poeta del “dolce stil novo”, come egli stesso dice a Bonagiunta: “I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto” (Purg. XXIV, 52-54). A Dante sono ancora appropriati, nelle parole di rimprovero pronunciate da Beatrice nell’Eden, i motivi connessi alla “destra di Dio” che contiene le elargizioni della grazia, dategli “ne la sua vita nova” (l’espressione si trova ad Ap 5, 9, nell’esegesi del “canticum novum”) prima che il mal seme lo facesse cadere, dopo la morte della sua donna, tanto in basso (Purg. XXX, 109-117).
■ Il libro, definito ad Ap 5, 1 “volumen”, scritto dentro e fuori, che sarebbe incongruo affermare distinto per quaderni e carte, ha una forma immaginaria a guisa di rotolo, con sette pieghe, ciascuna delle quali chiusa da un sigillo. A ciascuna apertura, si presentavano a Giovanni le immagini da lui descritte dei cavalli e dei cavalieri, come se uscissero vive da dentro le pieghe (Ap 6, 1).
Sui motivi propri del libro è tessuta la visione finale dell’unità e semplicità di Dio, volume che nel profondo della sua essenza lega con amore tutto ciò che “si squaderna” in modo diffuso per l’universo (Par. XXXIII, 85-87). Ma è soprattutto in Inf. XI, il canto in cui Virgilio spiega l’ordinamento e la distribuzione dei dannati, che questi temi vengono sviluppati. L’inferno è formato da nove cerchi ma, a ben vedere, nel discorso di Virgilio e nelle domande di Dante ne vengono enumerati solo sette. Tre sono dentro le mura della Città di Dite: il cerchio dei violenti (a sua volta diviso in tre gironi), il cerchio dei fraudolenti veri e propri (Malebolge, dove sono i fraudolenti verso chi non si fida) e il cerchio minore dei traditori (i fraudolenti verso chi si fida). Quattro sono fuori le mura, meno martellati dalla giustizia divina in quanto meno offesero: gli iracondi e gli accidiosi dello Stige (“quei de la palude pingue”), i lussuriosi (“che mena il vento”), i golosi (“che batte la pioggia”), gli avari e i prodighi (“che s’incontran con sì aspre lingue”). Se mancano all’appello il primo cerchio (il Limbo) e il sesto (gli eretici), ciò è forse perché Virgilio non ha bisogno di dire altro sul luogo dove sconta la pena e perché la sua spiegazione dell’ordinamento infernale avviene accanto all’arca dell’eretico papa Anastasio II, cioè nel sesto cerchio. Oppure essa è memore di quanto sostenuto da Tommaso d’Aquino circa l’eresia la quale, in modo analogo alla bestialità rispetto alla malizia umana, era da collocare “extra numerum peccatorum” (In IV Sent., ds 13, qu 2, ar 2) [4]. In ogni caso, esempio di concordia fra la dottrina aristotelica e l’esegesi apocalittica, l’enunciazione dei sette cerchi corrisponde al tema del libro scritto “dentro e fuori” e segnato sulle sette pieghe. Anche il riferimento alle “carte” della Fisica di Aristotele, utilizzata da Virgilio per precisare la posizione degli usurai, concorda con siffatta tematica. Ad Inf. IX, 106-109, il desiderio di guardare “dentro” la città di Dite, una volta varcata la porta, è il desiderio di guardare l’interno del libro.
È da notare che alcuni elementi semantici presenti ad Ap 6, 1 (la forma immaginaria del libro, il suo essere scritto, la presenza di “pieghe” da cui le immagini si mostravano a Giovanni come se uscissero vive) si ritrovano in Par. XXIV, 25-27. Tra le anime discese dall’Empireo al cielo delle stelle fisse, che girano danzando, una si distacca dalle altre per volgersi attorno a Beatrice “con un canto tanto divo, / che la mia fantasia nol mi ridice”. Si tratta di san Pietro: la penna del poeta è incapace di descrivere quel canto, “ché l’imagine nostra a cotai pieghe, / non che ’l parlare, è troppo color vivo”. La variazione poetica è fra le più lontane dal tema originario. Si può tuttavia notare che, pur con i temi rovesciati nel significato e con diversa appropriazione, permane nei due testi il contrasto tra la forma immaginaria e la realtà viva, sensibile: come il libro era immaginario e non reale, e le immagini dei cavalli e dei cavalieri che uscivano dalle pieghe erano anch’esse immaginarie come se fossero vive, così l’“imagine nostra”, cioè la nostra fantasia (e conseguentemente il parlare, che ha limiti ancor più ristretti) è “troppo color vivo” (cioè troppo sensibile) rispetto “a cotai pieghe”, cioè a tali sfumature (che costituiscono la parte interna del libro, quella più spirituale). Fin dall’esegesi del primo capitolo, Olivi ha posto la questione del rapporto tra la visione intellettuale di Giovanni e le similitudini corporee, di cui necessita per essere compresa ed espressa: in questa vita non si verificano visioni dell’intelletto che non facciano uso di similitudini corporee [5]. Non poter ridire il canto dei compagni dell’Agnello sul monte Sion è tema presente ad Ap 14, 3.
[1] Cfr. R. MANSELLI, Olivi, in Enciclopedia Dantesca, IV, p. 136.
[2] ANGELUS CLARENO, Expositio regulae fratrum Minorum, ed. L. Oliger, Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam, 1912, Epilogus, p. 231; Liber chronicarum sive tribulationum ordinis Minorum, 5, 41, a cura di G. Boccali, Santa Maria degli Angeli 1999, p. 474; G. L. POTESTÀ, Angelo Clareno. Dai Poveri Eremiti ai Fraticelli, Roma 1990 (Nuovi studi storici, 8), pp. 154, nt. 7, 204 e nt. 56.
[3] Cfr. La settima visione, I, 5.
[4] Cfr. INGLESE, Inferno, p. 144, nt. a XI, 82, che cita il passo tomista a prova di come all’eresia possa essere applicata l’espressione “matta bestialitade”.
[5] Cfr. La settima visione, Appendice.
Tab. App. 1
Tab. App. 2
[LSA, cap. V, Ap 5, 8 (radix IIe visionis)] Phiale [igitur] iste sunt corda sanctorum per sapientiam lucida, per caritatem dilatata, et per contemplationem splendidam et flammeam aurea, et per devotarum orationum redundantiam odoramentis plena. Sicut enim odoramenta per ignem elicata sursum ascendunt totamque domum replent suo odore, sic devote orationes ad Dei presentiam ascendunt et pertingunt, eique suavissime placent et etiam toti curie celesti et subcelesti. Sicut [etiam] diffusio odoris spiratur invisibiliter ab odoramentis, sic devote affectiones orantium spirantur invisibiliter et latissime diffunduntur ad varias rationes dilecti et ad varias rationes sancti amoris, prout patet ex multiformi varietate sanctorum affectuum qui exprimuntur et exercentur in psalmis. |
|
Par. VI, 10-12, 22-27Cesare fui e son Iustinïano,
|
Par. X, 109-114La quinta luce, ch’è tra noi più bella,
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (radix IIe visionis)] “Et vidi in dextera sedentis super tronum librum scriptum intus et foris, signatum sigillis septem” (Ap 5, 1). Preostensa gloria et magnificentia maiestatis Dei, hic accedit ad ostendendum profunditatem incomprehensibilem libri sui. Qui quidem liber est primo idem quod Dei essentialis prescientia et totius reparationis universe fiende per Christum predestinatio, et per appropriationem est ipsum Verbum Patris prout est expressivum sapientie eius et prout Pater, ipsum generando, scripsit in eo omnem sapientiam suam. […]
|
|
Inf. II, 85-87“Da che tu vuo’ saver cotanto a dentro,
|
Purg. XXX, 109-117, 142-145Non pur per ovra de le rote magne,
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 9 (radix IIe visionis)] Unde subditur: “Et cantabant canticum novum”. Novum quidem, tum quia omnia que de Christo cantantur sunt nova, est enim novus homo et nova eius lex et vita et familia et gloria; tum quia numquam veterascit nec est de aliquo veteri et caduco et cito interituro, sed de eternis aut ad eternitatem ordinatis; tum quia renovat et in novitate divina conservat suos cantatores. |
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] Secundum autem Ricardum, per duodecim angulos cuiuslibet porte intelliguntur universi minores et meritis occultiores, quia angulus occultum significat, et duodenarius universitatem.
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 16 (VIIa visio)] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia” (Ap 21, 16). Stadium est spatium in cuius termino statur vel pro respirando pausatur, et per quod curritur ut bravium acquiratur, secundum illud Apostoli Ia ad Corinthios, capitulo IX°: “Nescitis quod hii, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium?” (1 Cor 9, 24), et ideo significat iter meriti triumphaliter obtinentis premium. Cui et congruit quod stadium est octava pars miliarii, unde designat octavam resurrectionis. Octava autem pars miliarii, id est mille passuum, sunt centum viginti quinque passus, qui faciunt duodecies decem et ultra hoc quinque; in quo designatur status continens perfectionem apo-stolicam habundanter implentem decalogum legis, et ultra hoc plenitudinem quinque spiritualium sen-suum et quinque patriarchalium ecclesiarum. |
Par. VI, 22-27Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,
|
Par. IX, 115-117, 121-123Or sappi che là entro si tranquilla
|
Tab. App. 3