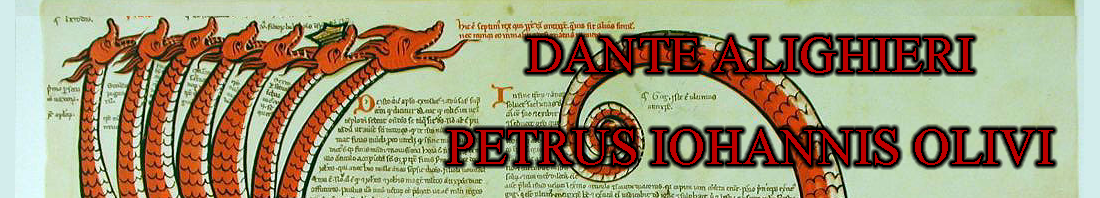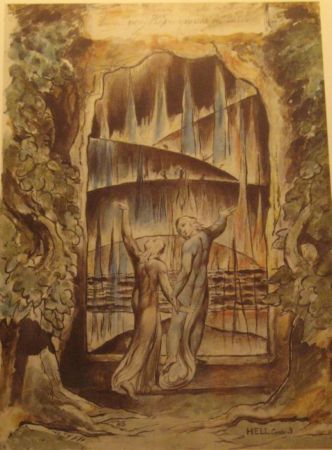Introduzione. 1. La montagna della Gentilità. 1.1. Fuga ai monti. 1.2. Il campo. 1.3. L’aspro diserto. 2. Il desiderio impossibile della ragione umana (il terzo stato). 3. Un passo fermo per l’erta montagna (il quarto stato). 4. L’insegna dei naviganti. 5. Volgersi e ricordare nel “libro della vita”. 6. Poi sorridendo disse: “Io son Manfredi…”. 7. Bellezza e nobiltà. 8. Il ciglio diviso e la piaga pettorale. 9. Beatus qui legit. 10. In co del ponte presso a Benevento, / sotto la guardia de la grave mora. 11. L’instabilità delle vicende e dei giudizi umani. 12. Il lavacro pluviale e il vento dello Spirito. 13. Quasi lungo ’l Verde. 14. “Un tempo, due tempi e la metà di un tempo”. 15. Pregare perché altri preghino.
[3] = numero dei versi. 6, 15 = collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]. Not. XI = collegamento ipertestuale all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura.Qui di seguito viene esposto Purgatorio III con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (PDF; introduzione in html). I colori seguono l’attribuzione ivi data a ogni singolo stato o gruppo di materia esegetica; nel testo riportato nelle tabelle, per maggiore evidenza, possono talora essere utilizzati in forma diversa. |
Purgatorio III |
Avvegna che la subitana fuga 6, 15
|
Introduzione
I. Nel sottosuolo di una società sacrale
[…] il riferimento evangelico preparerà, anzi favorirà all’interno del regime della grazia, la scoperta delle leggi della natura, la coscienza delle esigenze della ragione, il valore delle strutture della società: regime unico della grazia, sempre, in cui la natura, la ragione, la società serviranno tanto meglio la fede e la grazia, quanto non lo faranno più sotto una tutela infantile, ma nell’autonomia dei loro metodi […] Dante sarà ancora il testimone di una gerarchia statica in cui gli “stati del mondo” rimangono come nel sottosuolo di una società sacrale. Ma già cominciano ad avere ripercussioni su tutto il comportamento cristiano […] (M.-D. Chenu, La teologia nel dodicesimo secolo, a cura di P. Vian, Milano 1986 [1957], pp. 272-273).
Divisione letterale e armatura spirituale
■ Il canto III del Purgatorio si divide, secondo il senso letterale, in tre parti: il turbamento di Dante al vedere che solo lui, e non Virgilio, fa ombra ai raggi del sole, per il che teme di essere stato abbandonato dalla sua guida, cui fa seguito la turbata riflessione dell’antico poeta sui limiti della ragione umana (vv. 1-45); l’arrivo ai piedi del monte e l’incontro con le anime degli scomunicati che indicano la via ai due pellegrini (vv. 46-102); l’ascolto delle parole di Manfredi (vv. 103-145) [1].
I sensi mistici che trascorrono nei versi rompono questa tripartizione, connettono fra loro le parti, ripropongono, con forma variata, temi presenti in altri luoghi del poema. Le maglie dell’armatura spirituale, cioè della dottrina contenuta nella Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi, alla quale parole-chiave incardinate nel senso letterale rinviano con procedimento di ars memorandi, danno alla Commedia un ordine interno fondato su ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati della storia della Chiesa, cioè alle categorie con cui l’Olivi organizza la materia esegetica. Questo ordine interno è registrabile ‘topograficamente’ per zone progressive del poema dove prevale, tramite le parole-chiave, la semantica riferibile a un singolo stato. È un ordine dirompente i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ogni stato, che ha differenti inizi, è concatenato per concurrentia, appunto come le maglie di un’armatura, con quello che precede e con quello che segue. Si può pertanto leggere la Commedia – vero e proprio viaggio per exempla – come avrebbero potuto leggerla gli Spirituali francescani, predicatori e riformatori della Chiesa per i quali la Lectura di Olivi era un libro-vessillo. Il papato avignonese, perseguitando gli Spirituali nel secondo decennio del Trecento e condannando la “pestifera postilla” nel 1326, seppellì nel silenzio il linguaggio spirituale del “poema sacro”, poiché il pubblico che poteva comprenderlo non esisteva più già alla morte del suo autore.
Il lettore spirituale poteva leggere, nel commento di Olivi all’Apocalisse, un passo scritto nel 1297, a tre anni dalla conclusione del XIII secolo (il frate sarebbe morto a Narbonne l’anno seguente), dove venivano riassunti i tragici eventi degli ultimi trent’anni, ovvero della quarantaduesima generazione gioachimita se computata dalla morte o dall’ascensione di Cristo. Manfredi sconfitto e ucciso da Carlo d’Angiò a Benevento nel 1266, Corradino di Svevia sconfitto a Tagliacozzo e poi giustiziato a Napoli nel 1268, nel 1282 i Vespri siciliani, la rinuncia di Celestino V il 13 dicembre 1294, l’elezione di Bonifacio VIII il 24 dello stesso mese. Novità, queste due ultime, da intendere in senso negativo; precedute o accompagnate da dissidi fra re e regni cristiani, sono, secondo gli esperti, preparazione del “grande male”, cioè dell’avvento dell’Anticristo.
[LSA, cap. XII, Ap 12, 6] Prout vero inchoantur a Christi morte vel ascensione, sic in initio XLIIe apparuit circiter per tres menses stella comata valde grandis et stupenda, tuncque Manfredus Frederici filius, usurpatorie regnum Cecilie contra ecclesiam tenens, est per Karolum devictus et occisus, et paulo post Colradus filius Colradi filii Frederici. Et in XLIIa generatione Petrus rex Aragonum invasit Cecilie regnum, et ex tunc secuta sunt multa dissidia inter reges et regna que quibusdam non indoctis videntur esse preparatoria magni mali. In fine autem huius XLIIe generationis contingit novitas electionis Celestini pape et successoris eius et quorundam aliorum nunc ingravescentium.
Manfredi, nella Lectura oliviana, appare un usurpatore – “usurpatorie regnum Cecilie contra ecclesiam tenens” -; nella Commedia è testimone del fatto che la maledizione del clero non può nulla di fronte all’amore divino conciliante nel pentimento. Ma questo rovesciamento, da parte di Dio, del giudizio ecclesiastico è cantato con versi tessuti sui temi offerti dalla stessa Lectura, la quale viene così trasformata secondo gli intenti del poeta che presta liberamente “e piedi e mano” alla dottrina ivi esposta. Carlo d’Angiò, il vincitore di Benevento, nella medesima cantica è fregiato con i motivi delle malvagie e perfide locuste apocalittiche, che si annidano nella casa di Francia, maledetta dal suo capostipite Ugo Capeto.
■ La medesima esegesi di un passo dell’Apocalisse è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del poema. Questo comporta che, per spiegare i significati spirituali dei versi di un canto, si deve fare riferimento anche ad altri canti, più o meno numerosi, come in una composizione musicale variazioni o Leitmotive si possono seguire sull’intero spartito e la parte non è comprensibile se separata dal tutto.
Già nella prima terzina di Purg. III – “Avvegna che la subitana fuga / dispergesse color per la campagna, / rivolti al monte ove ragion ne fruga” – la fuga al monte rinvia ad Ap 6, 15 (sesto sigillo), tema intrecciato con il furtivo sopravvenire del giudizio divino contro i tardi e negligenti ad Ap 3, 3 e 16, 15 (quinta chiesa, sesta coppa: passi simmetrici), che si registra nel finale del canto precedente (cfr. cap. 1.1). In tal modo i versi che descrivono l’intervento di Catone a disperdere le anime da poco giunte alla riva del purgatorio, tutte fisse e attente con Dante e Virgilio ad ascoltare l’amoroso canto di Casella che intona dolcemente “Amor che ne la mente mi ragiona” (Purg. II, 118-133), e la conseguente fuga alla montagna della purgazione, attribuiscono “aspetto umano” alla dottrina esposta in quei passi esegetici. Ma agli stessi passi rinviano molti altri luoghi della Commedia. Così la “campagna” fa segno della dottrina esposta ad Ap 6, 2 (primo sigillo) e la relativa semantica (campo–bianco–arco–corda ecc.) si registra per il poema con tutte le possibili variazioni e intrecci (cfr. cap. 1.2). Oppure le espressioni “i’ mi ristrinsi a la fida compagna … la mente mia, che prima era ristretta, / lo ’ntento rallargò” (Purg. IIII, 4, 12-13), appropriate dall’autore a sé medesimo, fanno riferimento al Notabile XI del prologo della Lectura, dove riguardano l’interpretazione, ora estesa ora coartata, della Scrittura.
La montagna del purgatorio, luogo della conversione dei Gentili
Dopo le prime cinque età del mondo (corrispondenti all’Antico Testamento, la gioachimita età del Padre), che hanno segnato la discesa a spirale per i cinque cicli settenari dell’Inferno, con il Purgatorio inizia la sesta età, quella di Cristo (l’età del Figlio), che ha sette stati, corrispondenti ai sette periodi della storia della Chiesa. Dapprima, nel cosiddetto “antipurgatorio”, si registrano in successione temi prevalenti dei primi cinque stati. Il sesto stato della sesta età (con cui si apre l’età dello Spirito) inizia con l’apertura della porta di san Pietro (la porta del purgatorio). Questo sesto stato procede anch’esso con andamento settenario, per cui ha sette momenti, corrispondenti principalmente a un girone della montagna, ma non del tutto, perché sempre l’ordine spirituale del poema rompe i confini letterali e le divisioni materiali, concatenando semanticamente i temi di uno stato prevalente con quelli del periodo precedente e con quelli del seguente e intrecciandoli con temi di tutti gli altri periodi.
È spiegato nel Notabile VII del prologo della Lectura che il sesto stato della Chiesa è il secondo stato di Cristo e ha i suoi sette tempi per cui la Chiesa, come fosse una sfera, si ricongiunge circolarmente al primo apostolico tempo. Il settimo dei sette momenti del sesto stato della Chiesa coincide con il settimo stato generale della Chiesa, che nel poema corrisponde in parte all’ultimo girone della montagna (il settimo, dove si purgano i lussuriosi) e in parte all’Eden, con cui si chiude la seconda cantica.
Il settimo stato dell’Olivi si realizza parte in questa vita (come pregustazione in terra della gloria eterna, cioè fin sulla cima della montagna) e in parte nella futura (nel senso della quiete delle anime beate in attesa della resurrezione, che è la materia del Paradiso).
Il Purgatorio dunque, secondo il senso spirituale, è la storia della Chiesa che corre verso il suo sesto stato, punto di riferimento di tutte le vicende umane, antiche e moderne, che ad esso cooperano. Non è casuale che nel sesto girone della montagna sia chiarificata e riconosciuta, nel colloquio con Bonagiunta da Lucca, la poetica delle “nove rime” di Dante, già “sesto tra cotanto senno” cooptato nella “bella scola” dei poeti del Limbo.
La montagna del purgatorio possiede inoltre le caratteristiche del “deserto” della Gentilità (cfr. cap. 1.3). Nella sesta età del mondo, che comincia con il primo avvento di Cristo, la Chiesa si forma prima fra i Giudei ma poi, a causa della loro durezza e ostinazione, si rivolge ai Gentili. Inizia così quello che san Paolo, nella Lettera ai Romani, chiama il tempo della “pienezza delle genti” (Rm 11, 25-26), che si concluderà solo nel sesto stato della sesta età con la conversione delle reliquie delle genti e poi dei Giudei, i quali per ultimi si volgeranno a Cristo. Il tempo della “plenitudo gentium” non si limita dunque a quello stato felicissimo segnato dalla pace sotto il divo Augusto, che rese l’umanità disposta al primo avvento di Cristo (cfr. Monarchia, I, xvi, 1-2), ma continua ben oltre, fino alla conclusione del quinto stato della Chiesa, il quale concorre con il sesto distinguendosi da esso solo con la caduta di Babylon, e dunque perviene fino al 1300 e oltre (il quinto stato dura circa cinquecento anni a partire da Carlo Magno).
Ciò trova corrispondenza nell’esegesi di Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra), dove si dice che la donna (la Vergine Maria, la Chiesa), il cui figlio era stato rapito (Cristo risorto e asceso al cielo, dopo il tentativo del drago di divorarlo al momento del parto, Ap 12, 4), “fuggì in solitudine” nel deserto dei Gentili, per sottrarsi ai Giudei, nutrirsi di realtà spirituali ed evitare le tentazioni. Se l’Inferno corrisponde alla Giudea, ostinata persecutrice da fuggire trasformata in selva, il motivo del deserto, applicato al Purgatorio, indica il luogo dove il poeta ascende nel nutrimento delle cose divine e si nasconde dalle tentazioni.
Nella seconda cantica, l’aggettivo “gentile” – dove al significato di ‘cortese’ si aggiunge quello di gente agitata da guerre intestine come il mare in tempesta – ricorre sette volte (più la forma sostantivata a Purg. VI, 110), contro quattro occorrenze nell’Inferno e nessuna nel Paradiso (se si esclude l’altra forma sostantivata a Par. XX, 104). Dante rimane nel purgatorio tre giorni e mezzo (la seconda cantica si chiude al meriggio del quarto giorno), cioè un periodo di tempo corrispondente ai 1260 anni di permanenza della donna nel deserto (l’espressione “un tempo, due tempi e la metà di un tempo”, ad Ap 12, 14, indica un periodo di tre anni e mezzo, ovvero di quarantadue mesi nei quali i trenta giorni sono computati come anni).
La spiaggia che circonda in basso la montagna è “lito diserto, / che mai non vide navicar sue acque / omo, che di tornar sia poscia esperto” (Purg. I, 130-132). Questo è detto con riferimento a Ulisse, che non volle negare a sé l’esperienza sensibile del “mondo sanza gente”, cioè deserto fino all’arrivo di Cristo, allorché la Giudea si farà selvaggia e il deserto dei Gentili fiorirà (Inf. XXVI, 100-102; 114-117). Prima di quel lido finì il viaggio dell’eroe greco: “quando n’apparve una montagna, bruna / per la distanza” (vv. 133-134). La terra proibita alla ragione umana – alla sapienza di questo mondo che la croce avrebbe dimostrato stolta – non era solo una terra senza abitanti, l’“extra notum nobis orbem” di cui scrive Seneca (Epist. LXXXVIII), era figura della terra che sarebbe stata data ai Gentili, luogo della loro conversione a Cristo, che si sarebbe compiuta solo nel sesto stato della Chiesa. L’ultimo viaggio dell’eroe greco fu un’andata sensibile al sesto stato, un viaggio nel tempo futuro verso un lido allora noto unicamente a Dio, andata che solo un uomo evangelico del 1300 avrebbe potuto compiere.
Non è casuale che l’incontro con Stazio, che avviene nel passaggio dal quinto al sesto girone della montagna e poi continua fino all’Eunoè, registri il massimo punto possibile di avvicinamento in terra tra la sapienza pagana e quella cristiana. Citando i versi della quarta egloga virgiliana che celebrano la rinnovata età dell’oro, Stazio dichiara il suo debito verso Virgilio: “Per te poeta fui, per te cristiano” (Purg. XXII, 64-73). Se tra i due poeti sta il mistero della predestinazione per cui uno fu toccato dalla Grazia e l’altro no, qui Virgilio è non solo profeta del primo avvento di Cristo ma anche della seconda e altrettanto grande “renovatio”, quella del sesto stato, del novum saeculum in cui ha luogo la conversione delle genti e del popolo d’Israele fino allora escluso.
La ragione contro l’errore
Nella prospettiva storico-escatologica offerta dal “panno” della Lectura super Apocalipsim, che la “gonna” poetica adatta a situazioni e personaggi reali, vestendoli con figure scritturali variamente appropriate (ad esempio, la Giudea è figura antica dell’Italia), il terzo canto del Purgatorio si colloca in una zona topograficamente afferente al terzo stato della Chiesa (cfr. cap. 2).
I sette stati non sono solo periodi storici relativi alla Chiesa nel suo complesso, ma anche modi di essere della persona, habitus. La tematica che essi esprimono può dunque semanticamente permeare fenomeni naturali, luoghi geografici e persone del “poema sacro”.
Segnato dal primato dell’intelletto sui sensi, realizzazione dell’uomo razionale, il terzo stato è il luogo della discrezione e dell’esperienza, al cui regime soggiace il falso e nebuloso immaginare; il luogo del sapere (la “cura sciendi”) che è “de veris et de utilibus, seu de prudentia regitiva actionum et de scientia speculativa divinorum”; è il depositario della lingua vera e della vera fede, della scrittura che non erra, della giusta misura contro ciò che è oscuro e intorto, della bilancia che rettamente pesa la divinità del Figlio di Dio contro gli Ariani che non la ritenevano somma, uguale e consustanziale a quella del Padre; i suoi dottori (il terzo stato è assimilato al sacramento del sacerdozio) sono perfettamente illuminati nella sapienza; sono maestri del senso morale, “mores hominum rationabiliter et modeste componens”, assimilato al ‘vino’ con il quale ardono contro i vizi e accendono all’amore delle virtù; è il tempo delle leggi e della spada che scinde le eresie e, in genere, l’errore; dell’autonomia della potestà temporale, una delle due ali della grande aquila date alla donna (la Chiesa) per vincere il drago nella terza e quarta guerra (Ap 12, 14).
I motivi del terzo periodo sono prevalenti, nell’Inferno, in cinque zone: le divisioni e la discordia fiorentine nel colloquio con Ciacco (Inf. VI); il dividersi violento dell’anima dal proprio corpo nei suicidi (Inf. XIII); la divisione della Chiesa, bella donna straziata per oro e argento dai papi simoniaci (Inf. XIX); i seminatori di scandalo e scisma, dove sta anche il Mosca che fu causa delle discordie fiorentine (Inf. XXVIII); Lucifero, che con ognuna delle sue tre bocche “dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla”, cioè il traditore di Cristo e i traditori del volere di Roma (Inf. XXXIV, 55-67).
Appartengono dunque al terzo periodo quei motivi tipici del rompere e del dividere propri dei dottori nei confronti delle eresie e dell’errore, i quali tanto segnano canti come Inf. XIII o XXVIII, che appartengono alla medesima regione tematica. In Purg. III, nel cosiddetto “antipurgatorio”, il tema della rottura è appropriato al sole, “rotto … dinanzi a la figura” corporea del poeta, su cui si infrangono i raggi fiammeggianti; vedere il lume del sole “fesso” in terra fa fermare e indietreggiare per meraviglia la schiera degli scomunicati (vv. 16-18, 88-96). La roccia della montagna che sale è “sì erta” che “tra Lerice e Turbìa la più diserta, / la più rotta ruina è una scala, / verso di quella, agevole e aperta” (vv. 46-51; la salita, dopo che le anime hanno indicato la via, avviene “per entro ’l sasso rotto”: Purg. IV, 31). Il tema si ripresenta con lo scomunicato Manfredi, che “l’un de’ cigli un colpo avea diviso” (Purg. III, 108) e mostra una ferita nella parte superiore del petto: le “due punte mortali” per le quali a Benevento ebbe “rotta la persona” (vv. 118-119).
La terra, “oscura” per l’ombra di Dante, registra un motivo proveniente dal terzo sigillo alla cui apertura, ad Ap 6, 5, si mostra un cavallo nero (v. 21). È già vespro a Napoli, dice Virgilio, “dov’ è sepolto / lo corpo dentro al quale io facea ombra” (vv. 25-26).
Virgilio asserisce la follia di chi spera che la ragione umana “possa trascorrer la infinita via / che tiene una sustanza in tre persone”. Utilizzando, nelle turbate parole, il tema dei “molti uomini” morti per l’errore ricordati nell’esegesi della terza tromba (Ap 8, 11), invita l’“umana gente” a stare al “quia”, a non desiderare cioè di conoscere con la ragione le cose trascendenti, come fecero invece coloro ai quali questo desiderio inappagato è dato come pena eterna nel Limbo: “io dico d’Aristotile e di Plato / e di molt’ altri” (Purg. III, 34-45). Così l’esegesi del terzo stato – iniziato con Costantino, quando il mondo apparve con evidenza sottoposto allo scettro di Cristo, e la fede dovette essere spiegata al mondo convertito contro le insorgenti eresie – viene appropriata anche ai saggi che vennero prima di Cristo, a “color che ragionando andaro al fondo, / s’accorser d’esta innata libertate; / però moralità lasciaro al mondo” (Purg. XVIII, 67-69), prefigurazione antica dei dottori della Chiesa e del senso morale della Scrittura (ma erranti nel desiderare “veder tutto” prima del tempo). La ragione umana, fondata sul senso, induce all’errore, come avvenne al tempo delle eresie.
Il panno della Lectura tessuto con i temi del terzo periodo della Chiesa unisce, in Purg. III, il lume del sole rotto, il corpo di Dante che fa ombra e rende oscura la terra (“tenebra, / od ombra de la carne o suo destino”: Par. XIX, 64-66), la persona del re svevo ferita in battaglia, il desiderio inappagato di sapere dato per lutto agli antichi savi.
È ancora proprio dei dottori parlare la vera e unica lingua di Cristo (prologo, Notabile XIII), e Manfredi prega Dante di recarsi al suo ritorno dalla bella figlia Costanza, “e dichi ’l vero a lei, s’altro si dice” (Purg. III, 117).
La successiva, ampia zona della seconda cantica dedicata al terzo stato riguarda, passata la “porta di san Pietro”, la cornice degli iracondi, dove si sperimenta una “imaginativa” non sensibile ed erronea, ma mossa da celeste lume (terza vittoria, Ap 2, 17; Purg. XVII, 13-18); ivi Virgilio, “l’alto dottore”, ragiona su amore dividendo secondo il buono operare o il suo contrario (Purg. XVII, 84-XVIII, 75).
Una montagna erta ma pietosa
La cura pastorale, che storicamente si divide in sette momenti, provvede nel terzo periodo a condurre all’esterno il gregge. Anche le età dell’uomo, severamente corrette dallo zelo, sono sette; la terza corrisponde all’adolescenza leggera e agitata dal vento dell’errore (prologo, Notabile III). Così le anime degli scomunicati “come le pecorelle escon del chiuso / a una, a due, a tre” (Purg. III, 79-80). Nel quarto periodo, la cura pastorale provvede alla pascuale refezione del gregge – il pastus -; corrisponde all’età virile, stabile e ferma (stabilis se firmantem … stans), ma in seguito difettosa nella sua pertinacia. Così nel gregge degli scomunicati, dopo le prime pecorelle che escono, “l’altre stanno / timidette atterrando l’occhio e ’l muso” (vv. 80-81). Questa tematica del quarto stato si registra con tono insistente nei versi circostanti: “fermando ’l passo … e tu ferma la spene … stetter fermi … stassi … s’arresta … restaro” (vv. 53, 66, 71-72, 83; cfr. cap. 3).
La tematica ‘quarta’ fa segno dell’alta montagna che i due poeti devono ascendere, assimilata al quarto stato, proprio degli alti contemplativi (o anacoreti). Dalla loro altezza essi caddero (prologo, Notabile V), per cui nel canto successivo, all’inizio dell’erta salita, Virgilio ammonisce il discepolo: “Nessun tuo passo caggia; / pur su al monte dietro a me acquista” (Purg. IV, 37-38). Dante connette alla stabile fermezza del quarto stato il motivo del piede / passo, congiunzione d’altronde suggerita dall’esegesi dei piedi solidi dell’angelo di Ap 10, 1 e di quelli di Cristo simili all’oricalco (Ap 1, 15; 2, 18), designanti la perfezione della vita attiva, nella quale furono pure eccelsi i contemplativi del quarto stato, simbolo per antonomasia delle res gestae.
Le parole di Virgilio – “Or chi sa da qual man la costa cala … ditene dove la montagna giace” (Purg. III, 52, 76) mutano registro e fanno segno del quinto stato, del quale è tipico, dopo l’ardua e a lungo insostenibile solitudine dei contemplativi del periodo precedente, il pietoso condiscendere verso le moltitudini associate. Nel Notabile VII del prologo della Lectura super Apocalipsim si recano gli esempi di Cristo che condiscese agli infermi e del solitario Adamo al quale venne sottratta una forte “costa” (simbolo della solitudine austera degli anacoreti del quarto stato), che Dio nel creare Eva riempì di pietas. Più volte nel poema la “costa” della ripa infernale, o della montagna del purgatorio, che giace o che è corta o che cala o che pende, si abbina allo “scendere” in modo da far via in giù o in su, indicando la rottura della solitaria arditezza, del luogo “alpestro” a vantaggio del condiscendere pietoso, del dar via.
Al quarto stato, prorpio degli alti contemplativi, si riferisce un’importante citazione di Gioacchino da Fiore ad Ap 12, 14 (cfr. cap. 4). Secondo l’abate calabrese, come nel Genesi le opere del quarto giorno – il sole, la luna e le stelle – vengono chiamate “segni e tempi e giorni e anni” (Gn 1, 14), così nella quarta visione dell’Apocalisse la donna che sta nel cielo ed è adornata dal sole, dalla luna e dalle stelle viene detta “grande segno” (Ap 12, 1) e il suo tempo, che è il quarto della Chiesa, viene distinto in “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” (Ap 12, 14). Il medesimo tema compare nel quarto sigillo dell’Antico Testamento, nel quale Elia, Eliseo e i figli dei profeti furono come il sole, la luna e le stelle ed Elia venne nascosto lontano da Gezabele per tre anni e mezzo, periodo nel quale la pioggia della predicazione venne sottratta alla gente peccatrice. Gioacchino ritiene che la donna – la Vergine che portò Cristo nel ventre, lo partorì e lo allattò – sta a significare la Chiesa delle vergini, madre e nutrice dei fedeli, formata da uomini e donne dalla giusta vita che, come le stelle del cielo segnano il cammino ai naviganti, sono segni ed esempi agli altri, in modo che sappiano dove andare coloro che li considerano.
Le anime degli scomunicati riconciliati con Dio in fin di vita, che errano ai piedi della montagna trenta volte il tempo vissuto nella scomunica, fanno “insegna” coi dossi delle mani a Dante e a Virgilio in modo che tornino indietro procedendo innanzi a loro: sono la trasposizione degli uomini e delle donne dalla giusta vita di cui parla Gioacchino da Fiore che, come le stelle del cielo, segnano il cammino ai naviganti (Purg. III, 100-102). Il tema della Chiesa madre e nutrice dei fedeli è appropriato a Costanza, la “bella figlia” di Manfredi “genitrice / de l’onor di Cicilia e d’Aragona”, di Federico e Giacomo, alla quale il re svevo prega il poeta di andare, una volta ritornato al mondo, per spiegare il suo vero stato, che è di salvezza, nonostante la condanna della Chiesa (vv. 114-117).
II. Un nuovo ideale di vita e di civiltà
Siquidem illustres heroes, Fredericus Cesar et benegenitus eius Manfredus, nobilitatem ac rectitudinem sue forme pandentes, donec fortuna permisit humana secuti sunt, brutalia dedignantes. Propter quod corde nobiles atque gratiarum dotati inherere tantorum principum maiestati conati sunt, ita ut eorum tempore quicquid excellentes animi Latinorum enitebantur primitus in tantorum coronatorum aula prodibat; et quia regale solium erat Sicilia, factum est ut quicquid nostri predecessores vulgariter protulerunt, sicilianum vocetur: quod quidem retinemus et nos, nec posteri nostri permutare valebunt (De vulgari eloquentia, I, xii, 4).
[…] le alte lodi che di Manfredi pronunciarono in genere trovatori, uomini di cultura e tutti quei cronisti che, per non essere strettamente legati alla Chiesa o per propria indipendenza di giudizio, seppero sollevarsi al disopra delle passioni politiche del momento, ci mostrano chiaramente la generale tendenza a riconoscere nello Svevo quei caratteri che fanno legittimamente di lui un preannunziatore degli atteggiamenti di spirito che prevarranno poi nell’età dell’Umanesimo e del Rinascimento. Dante con acuta penetrazione ha colto del resto e fermato per sempre in espressioni lapidarie il significato intimo dell’opera che Manfredi, sulle orme del suo grande padre Federico II, dette, più che all’incremento della cultura in genere, per l’affermazione di un nuovo ideale di vita e di civiltà […] E in perseguire humana, brutalia dedignantes, è senza dubbio adombrato il concetto di un sapere che è insieme culto di quanto è nobile e alto nella natura umana, di una cultura che è insieme spiritualità, cioè humanitas. […] più vicino spiritualmente a Cesare Borgia che non a Federico I Barbarossa […] come un signore del Rinascimento, egli si sforza di giungere al regno contando soprattutto su se stesso e cercando di vincere la fortuna con la virtù (R. Morghen, L’età degli Svevi in Italia, Palermo 1974, pp. 170, 206-207).
L’aprirsi della memoria leggendo il “libro della vita”
E un di loro incominciò: “Chiunque
tu se’, così andando, volgi ’l viso:
pon mente se di là mi vedesti unque”.
Io mi volsi ver’ lui e guardail fiso
All’inizio della parte narrativa della sua esposizione, Giovanni precisa sette circostanze generali e degne di lode proprie delle visioni successivamente descritte. La sesta circostanza (Ap 1, 10-11; cfr. cap. 5) consiste nel fatto che gli viene ingiunto solennemente di scrivere la visione e di inviarla alle chiese d’Asia, come intendesse dire: non per mia iniziativa, ma per speciale comando divino ho scritto ed invio. Per cui soggiunge: “E udii una voce dietro di me”. È “vox magna”, in quanto il suono esce da una persona di grande virtù, eccitando mirabilmente Giovanni; è “come una tromba”, sia perché esorta alla guerra contro i vizi e contro l’esercito dei reprobi, sia perché invita a banchetti di gloria.
Il comando proviene da una voce udita dietro le spalle. Stare dietro può essere inteso nel senso che Giovanni era in quel momento dedito alla quiete della contemplazione, lontano dalla sollecitudine derivante dall’attività pastorale, che aveva lasciata alle spalle: la voce dunque lo richiama dalla visione delle cose supreme, che gli stanno dinanzi, alla cura d’anime che sta dietro (è l’interpretazione di Riccardo di San Vittore). Oppure (è l’interpretazione di Olivi), considerando che le cose che ci stanno dietro sono invisibili e pertanto superiori, si può intendere che Giovanni ascolti una voce alle spalle che lo elevi e riconduca verso l’alto, mentre con il volto è rivolto in basso, verso cose inferiori. In questo senso, nel Vangelo di Giovanni, si dice che Maria Maddalena, volta indietro, vide Gesù (Jo 20, 14).
Al richiamo del maestro Dante si volge, e come Maria vide Cristo risorto, così vede “Farinata che s’è dritto”, anch’egli a suo modo risorto, e questo vedere, come dice Virgilio, è “tutto” dalla cintola in su (Inf. X, 31-33). Anche Dante, come Giovanni, ha prima ascoltato il suono della “vox magna” e si è poi voltato per apprenderla in modo totale. Una conversione a chi parla che si ripete nel volgere il viso verso Manfredi: “volgi ’l viso … Io mi volsi ver’ lui” (Purg. III, 104, 106). Se a Giovanni, l’autore dell’Apocalisse, la voce ingiunge di scrivere la visione rivelata, il re svevo prega Dante di rivelare il suo stato di salvato alla figlia Costanza, e dunque di scriverne nel suo poema: “revelando a la mia buona Costanza / come m’hai visto” (vv. 143-144).
Nell’Eden la voce di Beatrice chiamerà il poeta con il proprio nome (“quando mi volsi al suon del nome mio, / che di necessità qui si registra”: Purg. XXX, 62-63). Un nome pregno di significato, che qui viene specificato come vengono specificati i nomi delle sette chiese alle quali deve essere inviata la visione.
Manfredi dice ancora: “pon mente se di là mi vedesti unque” (Purg. III, 105). Nell’endecasillabo si intrecciano due motivi. Il primo fa segno del risvegliarsi dal torpore per rammentare un edenico “prima” di bellezza, al quale viene invitato, ad Ap 3, 3, il vescovo di Sardi, la quinta chiesa d’Asia. Il secondo consiste, ad Ap 20, 12, nell’apertura del “libro della vita”, dove si legge l’increata scienza e giustizia divina – quella che ha deciso di salvare Manfredi cassando il giudizio delle gerarchie ecclesiastiche -, che verrà aperto alla vista di tutti i predestinati alla vita eterna per il conferimento finale della gloria, e ai dannati per l’evidenza dell’effetto esteriore e del giudizio.
Volgersi (Ap 1, 10), porre mente a un ‘prima’ (Ap 3, 3), vedere il mai visto (Ap 20, 12) sono congiunti e con varia libertà appropriati nel poema, dalle quattro stelle viste sul “lito diserto” del purgatorio (Purg. I, 22-24) al volgersi verso Manfredi (Purg. III, 103-106, 109-110).
“Biondo era e bello e di gentile aspetto”
Nel purgatorio, “regno” dei Gentili, Manfredi attende di transitare per la “porta di san Pietro”. “Biondo era e bello e di gentile aspetto” (Purg. III, 107; cfr. cap. 7). Se i primi due aggettivi si rispecchiano nelle testimonianze delle fonti contemporanee, Ricordano Malispini e Saba Malaspina, e il ritmo dell’endecasillabo muove dalla descrizione di Davide unto da Samuele [1 Sm (1 Rg) 16, 12], il terzo aggettivo “è tutto dantesco” [2]. Dante poteva concordare tutti e tre con l’esegesi apocalittica di Olivi. “Bello” corrisponde al bel principio di Sardi, la quinta chiesa dalla pienezza stellare (Ap 2, 1), tema di cui si fregiano luoghi e personaggi del poema, dall’“Italia bella” a Matelda, la “bella donna” che nell’Eden rammenta al poeta “l’età de l’oro e suo stato felice”; alla Firenze antica, “così bello / viver di cittadini”, come rimpiange Cacciaguida; a Costanza, la “bella figlia” di Manfredi sposa di Pietro III e “genitrice / de l’onor di Cicilia e d’Aragona”, morta clarissa nel 1302. La bellezza nell’esegesi appartiene alla Chiesa, nel poema è diffusa su più soggetti, non escluse le aule regie.
Il colore “biondo” si registra nella sede del soglio divino circuita dall’iride: fra i diversi colori, gli si avvicina il croceo, giallo oro (Ap 4, 2-3). Sulla sede il verde si staglia più degli altri colori: esso accompagna Manfredi in vita (“mentre che la speranza ha fior del verde”) e in morte (“di fuor del Regno, quasi lungo ’l Verde”).
Il trono divino è circondato dai seggi dei ventiquattro seniori, dodici dei quali, secondo Gioacchino da Fiore, designano i dodici apostoli dei Gentili (gli altri dodici sono in figura dei futuri ‘evangelici’); essi sono nobili dalle bianche stole con auree corone sul capo. Con la nobiltà gentile della sede divina, che ha già fornito panno per gli “spiriti magni” che albergano nel “nobile castello” del Limbo, concorda l’aspetto “gentile” di Manfredi.
Viene in tal modo reso sacro quanto affermato nel De vulgari eloquentia I, xii, 4, di Federico II e del suo “benegenitus” Manfredi, “illustres heroes”, i quali avevano fatto in modo che quanti erano nobili di cuore e dotati di grazie aderissero loro e, poiché la sede del trono regale era la Sicilia, tutto ciò che gli Italiani di animo eccellente producevano a quel tempo vedeva dapprima la luce in quella reggia e di conseguenza quanto è stato finora prodotto in volgare viene chiamato siciliano, “nec posteri nostri permutare valebunt”. I posteri hanno poi mutato questa sentenza, ma il ricordo di quei magnanimi vive ancora nel poema.
Il “ciglio” della superbia diviso e la “piaga a sommo ’l petto”
“Ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso” (Purg. III, 108; cfr. cap. 8). Se dividere, rompere, scindere sono motivi propri dei dottori che nel terzo stato della Chiesa combattono con la spada le eresie, le ciglia sono appropriate allo stato successivo, il quarto, dei contemplativi dall’alto volo: “altivolum supercilium vite anachoritice” (prologo, Notabile VI). Ma al quarto stato appartiene anche la superbia, che la morte, designata dal cavallo pallido all’apertura del quarto sigillo (Ap 6, 8 [5, 1]), doma e frange. Dunque dividere il ciglio equivale a piegare la superbia, nel tempo che lo Svevo è stato “in sua presunzïon” sotto il decreto di scomunica (v. 140). Farinata, udito dei ‘maggiori’ di Dante, “levò le ciglia un poco in suso” (Inf. X, 45).
Mostrare le piaghe del mondo “ricenti e vecchie” è proprio dei due testimoni, Enoch ed Elia (Ap 11, 6; cfr. Inf. XVI, 10-11). Ma la piaga pettorale ostentata da Manfredi – “e mostrommi una piaga a sommo ’l petto” (Purg. III, 111) – non può non ricordare quella, che fu letale, inferta dalla lancia nel costato di Cristo, tesi cara a Olivi, condannata dal Concilio di Vienne nel 1311-1312.
Parlare sorridendo
«Poi sorridendo disse: “Io son Manfredi” …» (Purg. III, 112). “Quel ‘sorridendo’ […] è un’espressione vista, nella creazione del personaggio: una espressione di regalità, consapevole, naturalmente, consapevole e perciò serenamente distaccata. Il sorriso, quel sorriso, fa lontane le piaghe della fine violenta […]” [3].
Il sorriso rinvia a una delle pagine più alte della Lectura, all’esegesi del volto di Cristo che irradia, nel sesto stato, più luce e più rivelazione della Scrittura (Ap 1, 16), i cui temi si registrano in molti luoghi del poema e percorrono variati soprattutto la terza cantica. Manfredi, parte di quel seme di Federico II che alcuni identificavano con l’Anticristo mistico, secondo opinioni raccolte da Olivi ed esposte ad Ap 13, 18, dove è trattata l’esegesi del numero del nome della bestia – il DCLXVI -, è fasciato da motivi cristiformi.
Un apocalittico rivelare
A Purg. III, 142-143, Manfredi, del cui destino eterno non si dice il vero tra i vivi, prega Dante di andare, una volta tornato al mondo, dalla figlia “revelando a la mia buona Costanza / come m’hai visto”, le riveli cioè il mirabile giudizio divino sul padre, che ha stravolto il giudizio degli umani pastori. Lo Svevo parla un linguaggio escatologico; l’Apocalisse è infatti rivelazione, e la visione che Dante deve manifestare è una sola, come quella che ebbe Giovanni a Patmos – “tutta tua visïon fa manifesta” asserisce Cacciaguida (Par. XVII, 128; cfr. cap. 9) -, anche se poi il nuovo Giovanni, nello scriverla, ha dovuto come l’antico adattarla agli intelletti umani, prestandole “e piedi e mano” forniti da fatti e personaggi reali.
Per abbreviare la sua attesa fuori della “porta di san Pietro”, Manfredi prega Dante di rivelare “a la mia buona Costanza / come m’hai visto, e anco esto divieto; / ché qui per quei di là molto s’avanza” (Purg. III, 142-145; cfr. cap. 15). Il motivo dell’offerta e del pregare altri perché offrano o preghino, tema ricorrente nella seconda cantica, rinvia ad Ap 8, 3, nell’esegesi della “radice” della terza visione apocalittica, dove a Cristo, angelo che sta dinanzi all’altare, “furono dati molti incensi”, cioè molte orazioni a Dio piacenti. Gli vengono dati da quanti pregando commettono sé e i propri voti a lui come nostro mediatore e avvocato e gli chiedono di offrirli a Dio. Dante, in questo caso come in altri, opera come imitatore di Cristo.
Anche il computo del tempo di attesa che può venire abbreviato per le preghiere dei vivi – “per ognun tempo ch’elli è stato, trenta, / in sua presunzïon, se tal decreto / più corto per buon prieghi non diventa” (vv. 139-141) – è variazione sull’espressione “per un tempo, due tempi e la metà di un tempo” (Ap 12, 14; non si tratta dell’unico caso nel poema; cfr. cap. 14) con la quale viene indicato un periodo di tre anni e mezzo, formati da quarantadue mesi (12 x 3 + 6) i cui trenta giorni sono considerati come anni, periodo corrispondente ai 1260 anni di permanenza della donna (la Chiesa) nel deserto dei Gentili. “Trenta” è numero che rinvia a Cristo, che fu battezzato a trent’anni; con Giovanni Battista, come dice Cristo in Matteo 11, 11-12 e in Luca 16, 16, inizia il tempo in cui i violenti si impadroniscono del regno dei cieli.
Leggere con carità
La causa finale del libro dell’Apocalisse, ciò che si consegue attraverso la sua intelligenza e osservanza, è la beatitudine: “Beato chi legge e chi ascolta” (Ap 1, 3; cfr. cap. 9). L’intelligenza si ottiene tramite la lettura e l’ascolto; la prima spetta ai dottori o ai letterati, il secondo ai laici. Per la salvezza non basta tuttavia apprendere o sapere senza conservare nell’affetto – con fede, speranza, carità e timore – e nelle opere, per cui si aggiunge: “e chi conserva”.
A questo fine non è si è ispirato Bartolomeo Pignatelli, infierendo sul corpo di Manfredi sconfitto a Benevento: “Se ’l pastor di Cosenza, che a la caccia / di me fu messo per Clemente allora, / avesse in Dio ben letta questa faccia”, quella misericordiosa: «“Beatus qui legit, qui audit et servat ea” […] et sic omnia sunt a nobis servanda vel agendo illa vel credendo ea cum caritate et spe vel timore» (Purg. III, 124-126). E quella distorta lettura priva di carità, fatta dal vescovo, pure stona con il nome del papa – “Clemente” (IV) – che l’ha inviato.
Altri versi rinviano al medesimo punto esegetico: Par. X, 125-126 (“Beatus … qui audit” – “l’anima santa che ’l mondo fallace / fa manifesto a chi di lei ben ode”, cioè Boezio; il manifestare è verbo tipico della rosa offerta dall’esegesi dei primi versetti apocalittici); Inf. XIV, 16-18 (“O vendetta di Dio, quanto tu dei / esser temuta da ciascun che legge / ciò che fu manifesto a li occhi miei!”, senza l’avverbio “ben”, ma con l’accostamento del leggere il lato temibile del libro – “cum caritate et spe vel timore” – al manifestare).
L’attesa della gloria sotto la pietra angolare del ponte
La Gerusalemme celeste, oggetto della settima visione apocalittica, è una città ideale descritta con similitudini materiali: fosse, muro, porte, case, piazza, angoli, misure dei lati, pietre preziose, fiume, rive, albero, frutti. Aspetti, questi, che vengono applicati agli uomini, i quali partecipano così delle sue divine qualità. Nell’esegesi la città è la Chiesa dei contemplativi, cioè dei beati; ma anche la Chiesa peregrinante e militante in terra ne può ben pregustare la pace. La vittoria del sesto stato, cioè degli uomini che in terra combattono contro Babylon, la Chiesa carnale, affinché si instauri un novum saeculum, consiste nell’aver iscritto nella mente il nuovo nome della Gerusalemme che discende dal cielo in terra, e che è detta essere visione di pace (Ap 3, 12). Di essa maggior gusto si potrà provare nel successivo settimo ed ultimo stato.
Nella Commedia gli angoli della Gerusalemme celeste sono in figura sia di persone come di parti strutturali, quali i ponti i quali, definiti anche ‘archi’ come gli angoli sono “archus prelii”, hanno funzione di congiungere. Il lombardo co rende “caput anguli”, qualità di Cristo presente nei forti e unitivi angoli della Gerusalemme celeste (Ap 21, 12; cfr. cap. 10).
Il tema di Cristo “caput anguli et lapis angularis” è nelle parole di Manfredi: “l’ossa del corpo mio sarieno ancora / in co del ponte presso a Benevento, / sotto la guardia de la grave mora” (Purg. III, 127-129).
Per “mora” si intende letteralmente il coacervo di pietre gettate dai soldati nemici che coprì la sepoltura dello sconfitto svevo, secondo quanto narrato dai cronisti. Spiritualmente, l’espressione “sotto la guardia” contiene un tema dall’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9.11), quando ai santi del quinto stato viene detto di aspettare ancora per poco tempo, perché il numero degli eletti non è completo secondo quanto stabilito dall’eterna predestinazione divina. Nell’attesa, “le anime di coloro che furono uccisi” stanno “sotto” l’altare di Dio; ad esse vengono date due stole bianche (per l’anima e per il corpo). Non si intendono solo le anime dei primi martiri, ma anche di quanti con forte penitenza crocifissero e uccisero i vizi e le concupiscenze della carne. Manfredi intende dire che, dopo il pentimento estremo, il suo corpo sarebbe rimasto nell’attesa (“mora”, da moror, dimorare) della gloria futura sotto la protezione di Cristo “caput anguli” (“in co del ponte”). Ma altro è stato il governo delle sue ossa fatto dal “pastor di Cosenza”. Attendere è tema precipuo del quinto stato, registrabile in numerosi luoghi del poema, soprattutto poco dopo l’incontro con il re svevo, quando Sordello fa da guida nella valletta dei principi negligenti (Purg. VII-VIII). L’attesa, come risponderà Dante esaminato da san Giacomo nell’ottavo cielo, è insita nella “spene … attender certo / de la gloria futura” (Par. XXV, 67-69); il poeta stesso e poi san Giovanni parlano delle due “bianche stole”, una delle quali il corpo attende fino alla resurrezione (vv. 91-96, 124-129). “Mora”, la sepoltura di Manfredi “magno lapillorum et lapidum acervo” per Saba Malaspina, il “monte grande di sassi” secondo Ricordano Malispini, la “grande mora di sassi” per Villani; oppure il “muro” come propone Frugoni [4], fa segno spiritualmente dell’attesa certa, da morto, della gloria futura, compimento di quella verde speranza in terra alla quale le parole dello Svevo poi accennano: “mentre che la speranza ha fior del verde” (Purg. III, 135).
Una variazione della tematica è in Virgilio, allorché nella bolgia dei barattieri (la quinta) passa “di là dal co del ponte” per ‘congiungersi’ (segno di forza e di vittoria) con la “ripa sesta”, cioè con l’argine fra la quinta e la sesta bolgia, dove viene con successo alla “baratta” con i Malebranche (Inf. XXI, 64-66). Dante, nel frattempo, sta “giù” acquattato dietro uno spuntone di roccia che lo ripara, come i santi martiri, all’apertura del quinto sigillo, stanno protetti sotto l’altare di Dio (vv. 58-60).
“Pacta non sunt utique servanda”
La scomunica condannava Manfredi con i reprobi nel fuoco eterno; le sue ossa furono trasferite “di fuor dal regno”. Letteralmente si tratta del Regno di Sicilia che il sovrano svevo, secondo la Chiesa, aveva usurpato. Spiritualmente, l’espressione “di fuor dal regno” fa segno del “lacus inferni”, calcato dall’ira divina, dove stanno i dannati «“extra civitatem”, id est extra locum et collegium beatorum» (Ap 14, 20), fuori cioè dal regno dei beati. Ivi sono le “tenebre exteriores” (Matteo 8, 12; 22, 13); l’anatema era confermato gettando a terra i ceri e calpestandoli, “a lume spento”, come avvenne per Manfredi.
La maledizione dei pastori, il cui operato avrebbe dovuto essere ispirato dalla carità, ha invece perpetuato le sentenze dei sacerdoti della vecchia legge, attenti solo alla lettera di questa, ignari dell’umana infermità (Ap 5, 1). Certamente, anche nel Nuovo Testamento la maledizione colpisce Babylon, la meretrice apocalittica, e quanti hanno commercio con essa perderanno ogni speranza di lucrare (Ap 18, 10), ma, come afferma Manfredi, il ritorno a Dio non sarà perduto “mentre che la speranza ha fior del verde”. I pastori della Chiesa trasmutano a loro piacimento, ma altro è il giudizio divino.
“Vespero è già colà dov’ è sepolto / lo corpo dentro al quale io facea ombra; / Napoli l’ha, e da Brandizio è tolto” – “Di fuor dal regno, quasi lungo ’l Verde, / dov’ e’ le trasmutò a lume spento” (Purg. III, 25-27, 134-135). Ottaviano fece trasferire il corpo di Virgilio da Brindisi a Napoli; Bartolomeo Pignatelli, il “pastor di Cosenza” inviato da Clemente IV alla caccia di Manfredi, ne fece trasferire il corpo fuori dal Regno di Sicilia. Per quanto l’intento sia stato onorifico nel primo caso, di maledizione nel secondo, si tratta di due translationes. La prima, relativa alla sepoltura di Virgilio, designa la perdita di un primato, come quello che passa di chiesa in chiesa ed è considerato nell’esegesi di Ap 2, 5. Entrambe fanno segno dell’instabilità delle vicende umane, sotto il regime della Fortuna, che permuta e trasmuta a suo piacimento (Inf. VII, 78-80). Delle continue mutazioni, che apparentemente procedono nello stesso giudizio divino, tratta il passo sulla “commutatio pontificatus” che Olivi inserisce come “figurale exemplum” nel VII Notabile del prologo della Lectura (cfr. cap. 11).
Nell’Antico Testamento si registrò un continuo mutare delle stirpi sacerdotali, nonostante i patti stabiliti da Dio con alcune di esse. Qualcosa di simile si registra nel Nuovo. Con Pietro e con gli apostoli il sacerdozio fu infatti dato alla stirpe evangelica, quindi venne utilmente e ragionevolmente commutato a uno stato fondato sul possesso dei beni temporali, la cui durata va da Costantino al termine del quinto stato. In questo periodo, i pontefici che preferirono la povertà evangelica ai beni temporali segnarono di nuovo, e in modo raddoppiato, il prevalere del primo ordine, quello del sacerdozio apostolico. Alla fine di queste mutazioni, il pontificato dovrà ritornare al primo ordine, al quale spetta per diritto di primogenitura e per la maggiore perfezione derivante dalla conformità con Cristo. Questo ritorno sarà agevolato non solo dall’imperfezione insita nel possesso dei beni temporali, ma pure da quegli enormi difetti – superbia, lussuria, simonie, liti, frodi e rapine – da cui la Chiesa, divenuta alla fine del quinto stato quasi una nuova Babilonia, risulterà macchiata e confusa dai piedi al capo.
Questi temi vengono liberamente variati da Dante. Nell’Inferno, si comincia con la Fortuna, che Dio “ordinò general ministra e duce / che permutasse a tempo li ben vani / di gente in gente e d’uno in altro sangue” (Inf. VII, 78-80).
È ancora la trasmutante Fortuna a entrare nel dialogo con Brunetto Latini. Le è associato il motivo del patto non compiuto nelle parole di Dante: “Non è nuova a li orecchi miei tal arra”, cioè la predizione sul corso della propria vita, che è come un contratto non perfezionato (Inf. XV, 94). Poi, il tema della “commutatio” del pontificato è appropriato al vescovo di Firenze Andrea de’ Mozzi, macchiato dalla “tigna” della sodomia, che Bonifacio VIII, nel 1287, trasferì alla sede di Vicenza (“fu trasmutato d’Arno in Bacchiglione”, vv. 110-114).
Richiamato da Virgilio dopo la “baratta” coi diavoli, Dante, che s’era acquattato dietro a una roccia, torna dalla sua guida temendo che i diavoli non mantengano il patto, come, nell’agosto 1289, temettero i fanti ghibellini “ch’uscivan patteggiati di Caprona / veggendo sé tra nemici cotanti” (Inf. XXI, 93-96; tema del timore indotto dagli esempi precedenti).
Il consiglio che Guido da Montefeltro avrebbe dato a Bonifacio VIII per prendere Palestrina nel 1299 – “lunga promessa con l’attender corto / ti farà trïunfar ne l’alto seggio” (Inf. XXVII, 110-111) -, nel senso: ‘patteggia col nemico, prometti molto e mantieni poco’, è sarcastica memoria del passo sulla “commutatio pontificatus” del notabile VII del prologo della Lectura, dove si dice che, nell’Antico Testamento, Dio non serbò il patto di mantenere per sempre una stessa stirpe nel sommo sacerdozio, e di un altro luogo (ad Ap 5, 1) dove si aggiunge che, nel Nuovo Testamento, Cristo non mantenne tutte le promesse fatte dai profeti.
Nell’invettiva contro l’“antica lupa”, che nel quinto girone degli avari e prodighi precede l’incontro con Ugo Capeto, Dante invoca il cielo, il cui girare nelle sfere si ritiene trasmuti le condizioni umane, affinché venga il Veltro che la farà discedere. Subito dopo la voce di Ugo parla della povertà di Maria e del “buon Fabrizio”, che preferì la povertà alle ricchezze offertegli dai nemici di Roma (Purg. XX, 13-15, 19-27).
Sullo stesso panno è tessuto quanto Cacciaguida dice di Cangrande, che disprezzerà le ricchezze e trasmuterà molta gente facendo cambiare condizione a ricchi e poveri (Par. XVII, 82-84, 89-90).
Dante applica alla storia umana la legge che regola, secondo l’Olivi, la storia della Chiesa, fatta di traslazioni, trasmutazioni, patti non mantenuti da Dio stesso (secondo il giudizio umano), prima del ritorno alla stabilità. Questa legge non vale più soltanto per il papato, povero nel cominciare con san Pietro e poi, dopo Costantino, ricco, in vista del ritorno al primo tempo. Questa legge diventa universale, il papato è solo una parte del tutto.
Il canto del ritorno
Il terzo canto del Purgatorio registra, fra i suoi temi principali, quello del ritorno. È nelle parole degli scomunicati, “gente degna” che fa “insegna” del cammino ai due poeti come ai naviganti: «“Tornate”, disse, “intrate innanzi dunque”» (Purg. III, 100-102). È nell’asserzione di Manfredi: “Per lor maladizion sì non si perde, / che non possa tornar, l’etterno amore” (Purg. III, 133-134). Nell’esegesi della sesta vittoria, quella conseguita dagli uomini evangelici, si dice che la contemplazione, iniziata da Dio, attraverso la città celeste ascende in Cristo suo re e torna e rientra circolarmente nella gloria divina (“redit et reintrat” in Deum: Ap 3, 12). Una variazione è già stata percepita nell’uscita “a riveder le stelle”: “Lo duca e io per quel cammino ascoso / intrammo a ritornar nel chiaro mondo” (Inf. XXXIV, 133-134: il tema è sulla 45a terzina, come nelle parole di Manfredi). Il ritorno della mente a Dio per la sua città avviene “per suavitatem amoris”; tali le parole di Manfredi: “che non possa tornar, l’etterno amore” (Purg. III, 134). Un ritorno che comporta il termine delle trasmutazioni considerate nel Notabile VII del prologo della Lectura: “redeat ad ordinem primum”.
Di questo ritorno nulla hanno sentito papa e vescovo. L’accanimento dei pastori d’anime sulle ossa di Manfredi dissacrate, sbandite e oltraggiate dalle intemperie – “Or le bagna la pioggia e move il vento” (Purg. III, 130; cfr. cap. 12) – non è molto diverso dal governo che il vendicativo diavolo fa del cadavere di Buonconte da Montefeltro caduto a Campaldino, anch’egli come il re svevo tardivo nel pentimento, travolto dall’“Archian rubesto” gonfio per la pioggia e sospinto in Arno (Purg. V, 94-129). La citazione virgiliana relativa all’insepolto Palinuro, che impregna le parole di Manfredi – “nunc me fluctus habet versantque in litore venti” (Aen. VI, 363) -, ribadisce l’assenza di pietas da parte degli uomini di Chiesa e la sventura di chi in morte non può placidamente riposare. Ma il governo dei pastori non ha coinciso con il giudizio di Dio, che ben conosce l’argomento del ritorno: “la bontà infinita ha sì gran braccia, / che prende ciò che si rivolge a lei” (Purg. III, 122-123).
La pioggia, nel caso di Manfredi, non è quella “sì spiacente” che batte in eterno Ciacco (Inf. VI, 46-48); è piuttosto un lavacro purgativo. Il sangue di Cristo ha lavato i peccati, come i lebbrosi vengono sanati nel bagno di sangue caldo (Ap 1, 5). La dottrina di Cristo è pioggia che irriga, come la “voce di molte acque” che distilla nel cuore e reca refrigeranti lacrime e sospiri (Ap 1, 15; 14, 2). La pioggia, fraternamente caritatevole, feconda la terra, la cui fertilità prepara il solare terzo stato generale del mondo, l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore (Ap 10, 1; 14, 14-17). Gli stessi martìri sono purgativi, agiscono contro il torpore mentale (Ap 2, 1).
Il vento, che muove le ossa di Manfredi, è anche quello dello Spirito, di cui parla Ezechiele citato ad Ap 7, 1: “Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano” (Ez 37, 9).
Il motivo della terra che aiuta la Chiesa degli eletti, “quasi dulce flumen” (Ap 12, 14; cfr. cap. 13), conduce alle parole del re sul proprio corpo trasmutato “a lume spento” dall’originaria sepoltura, per l’eccesso di zelo da parte del vescovo di Cosenza verso un morto scomunicato: “l’ossa del corpo mio sarieno ancora / in co del ponte presso a Benevento, / sotto la guardia de la grave mora. / Or le bagna la pioggia e move il vento / di fuor dal regno, quasi lungo ’l Verde”, in un luogo sconosciuto presso il Liri (Purg. III, 124-132). Al di là della sua identificazione geografica, il “Verde” allude al colore verde, graziosissimo agli eletti, che nel quarto capitolo è tema della sede, circondata dall’iride simile allo smeraldo, su cui siede Dio dall’aspetto di pietra di diaspro (Ap 4, 3). L’inciso “quasi lungo ’l Verde”, dopo il riferimento alle ossa bagnate dalla pioggia e mosse dal vento, sembra posto a contrastare gli effetti di una dannazione voluta dal papa e dal vescovo ma non dalla misericordia divina. Il nome del fiume anticipa pertanto il motivo della terzina seguente, in cui Manfredi afferma che la scomunica dei pastori non impedisce il ritorno dell’“etterno amore, / mentre che la speranza ha fior del verde”.
Opposta agli “uomini di Chiesa”, sta l’idea che Dante ha della Chiesa, “che, di contro alla strutturazione per gerarchie e decretali, ha tensioni di ritorno evangelico a una missione di grazia, di misericorde salvezza, consonanze ‘spirituali’” [5].
Padre e figlio divisi in eterno
“Manfredi è unito al padre nel mito politico-letterario della grande curia-scuola siciliana” [6]. È però da lui, che giace nelle arche infuocate degli eresiarchi con Farinata e Cavalcante, il padre di Guido (Inf. X, 119), eternamente diviso. Perché questa differenza fra padre e figlio? Se si può sottolineare la prospettiva antiangioina e antifrancese che segna la seconda cantica [7], dove Ugo Capeto maledice la propria discendenza, vero nido di apocalittiche locuste come rivelano i significati spirituali, perché Dante ha messo all’inferno Federico II, “ultima possanza” del seme imperiale?
Con l’Uberti, e con Omberto Aldobrandesco purgante nella cornice dei superbi, Federico II doveva condividere la concezione della nobiltà per “antico sangue” e “opere leggiadre”. Così viene citato, e contestato nonostante il rilievo provvidenziale dato all’autorità imperiale, in Convivio IV, iii, 6: “domandato che fosse gentilezza, rispuose ch’era antica ricchezza e belli costumi”. È l’ultima menzione di Federico II prima che Farinata ne riveli l’eterna dannazione come epicureo. Nel mezzo sta la vocazione di Dante al viaggio, il suo sentirsi eletto, segnato con gli amici di Dio per un’alta missione, “sesto tra cotanto senno” non per nobiltà acquisita dai propri “maggior” ma per quella nobiltà di spirito che discende direttamente dalla grazia donata. È Dio, “appo cui non è scelta di persone” in base alla presunzione dell’antico, che rende i singoli “quasi dèi” (Convivio, IV, xx, 3-6). Questa idea di nobiltà fu la porta per cui i Gentili dall’“onrata nominanza” avrebbero di lì a poco trovato albergo nel “nobile castello” del Limbo, posti ivi da Dio in quanto giusti; per interiore gusto spirituale, tratto dagli occhi di Beatrice, il poeta sarebbe asceso al cielo “qual si fé Glauco nel gustar de l’erba / che ’l fé consorto in mar de li altri dèi” (Par. I, 67-69). Nel sesto stato della storia della Chiesa, sostiene Olivi, si compie la conversione dei Gentili, solo iniziata con il primo avvento di Cristo. Questa incorporazione degli infedeli, “non per viam carnis, nec per viam naturae, sed per viam gratiae ad Dei filiationem et propinquitatem”, fu fatta nel tempo della legge di natura, prima della circoncisione, e nel tempo della pienezza delle genti (di cui dice san Paolo ai Romani 11, 25-26), e avverrà di nuovo nel tempo della conversione finale di ciò che rimane dei Gentili e di Israele [8].
Brunetto Latini, dannato fra i sodomiti, asserisce che “le bestie fiesolane” (i fiorentini) non dovranno toccare Dante, pianta “in cui riviva la sementa santa / di que’ Roman che vi rimaser quando / fu fatto il nido di malizia tanta”, che parteciparono cioè alla fondazione di Firenze (Inf. XV, 76-78). Il ‘rimanere’ del seme ha un particolare valore, come spiegato ad Ap 12, 17, al momento della guerra del quinto stato (quarta visione), condotta dal drago contro le rimanenze (le reliquie) del seme della donna, rappresentate da coloro che custodiscono i precetti divini e danno testimonianza di Cristo. Queste reliquie designano l’evangelista Giovanni (secondo Gioacchino da Fiore) o la Chiesa latina (secondo Olivi), sola rimasta dopo le devastazioni saracene e lo scisma greco, come in un vaso di vino purissimo, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e più pura, rimangono solo poche reliquie vicine alle impurità e quasi con esse mescolate. Dante è pertanto ‘reliquia’ del seme che rimane – assimilato alla Chiesa romana – accanto e commisto al letame delle “bestie fiesolane”. Nelle parole di Brunetto, il “romanus populus … ille sanctus, pius et gloriosus” (Monarchia, II, v, 5), di cui Dante è seme rimasto, è ammantato dalla veste che nell’esegesi scritturale spetta alla Chiesa di Roma, la sola ‘rimasta’ di una Chiesa prima diffusa su tutto l’orbe, della quale il seme degli antichi Romani è dunque prefigurazione. Il tema del purissimo seme della donna che rimane, da Ap 12, 17, è anche singolarmente consonante con quanto affermato in Convivio IV, v, 5-6: “Per che assai è manifesto la divina elezione del romano imperio, per lo nascimento della santa cittade, che fu contemporaneo alla radice della progenie di Maria”, “una progenie santissima”, ordinata a “l’albergo dove ’l celestiale rege intrare dovea”, il quale “convenia essere mondissimo e purissimo”.
Essere “sementa santa” dei Romani, esclusa ogni discendenza per nobiltà di sangue, è appellativo che designa il primato nella lingua, in quella volgare, nuova e universale quanto fu il latino antico, in attesa che riviva l’imperiale Curia dispersa, dopo la morte dell’“ultima possanza”. Federico II ha in comune con Farinata la concezione della nobiltà fondata sull’antico sangue, è però antica anche la sua poetica. Se, grazie a lui e al suo degno figlio Manfredi, nella regale sede di Sicilia vide la luce “quicquid nostri predecessores vulgariter protulerunt” (De vulgari eloquentia, I, xii, 4), ora una nuova lingua supplisce alla vacanza imperiale, di un istituto comunque indefettibile.
Chiuso nella sua durezza lapidea e ferrea, aspra a dirsi, l’Inferno corrisponde all’Antico Testamento, articolato nelle prime cinque età del mondo. Il volgersi di Virgilio sull’anca di Lucifero segna il passaggio alla sesta età, la quale è il tempo della Chiesa, rivissuto nel moderno viaggio di Dante che va verso il sesto stato, il novum saeculum che tanto s’aspetta. Ciò non sminuisce affatto la credenza nelle pene dell’inferno o del purgatorio. Il sentimento storico di speranza del nuovo, che Gioacchino da Fiore aveva scorto nell’Apocalisse e che Olivi aveva ricondotto allo Spirito di Cristo operante nella storia attraverso i suoi moderni discepoli, si accompagna in Dante a una ferma positività della legge e della morale. Federico II fu realmente epicureo, Brunetto Latini sodomita. La misericordia divina ha salvato Manfredi dai suoi orribili peccati nonostante la maledizione dei pastori, tuttavia il sovrano svevo, morto “in contumacia … di Santa Chiesa”, deve attendere fuori della “porta di san Pietro”. L’inferno non è un simbolo. Ma in esso il viaggio che percorre la storia dell’umanità, marcata dai segni della divina provvidenza, si lascia alle spalle non solo la cruda, vecchia roccia infernale, ma anche l’antico modo di poetare, proprio di quanti vennero prima nella Curia imperiale siciliana, i quali, posti al di qua del “dolce stil novo”, non seguirono l’interno dettatore come una regola evangelica imposta e accettata e che, in qualche modo, appartennero all’Antico Testamento della poesia (cfr. Purg. XXIV, 49-63).
Dante è cosciente che il cammino verso il glorioso porto è ancora lungo, “ché ’l nome mio ancor molto non suona”, come dirà a Guido del Duca nel secondo girone della montagna (Purg. XIV, 21). Ma già Farinata lo apostrofa in tal senso: “La tua loquela ti fa manifesto / di quella nobil patrïa natio, / a la qual forse fui troppo molesto” (Inf. X, 25-27). Non è solo citazione del passo di Matteo 26, 73 – “loquela tua manifestum te facit” – riferito alla negazione di san Pietro. Rinvia anche all’esegesi dell’ultima visione apocalittica (Ap 22, 16), allorché Cristo parla manifestando – “loquitur ut … manifestator” – la propria regale autorità e la sua “claritas” magistrale ed esemplare e dice: “Ego sum radix et genus David”, cioè radice della progenie da cui discese la “sementa santa”, della quale Dante è ora unico depositario.
Nel finale di Inf. XV non viene assegnata a Brunetto una vittoria postuma quasi che – come voleva Auerbach [9] – la figura, “la cara e buona imagine paterna”, rompa la cornice della pena. Il suo correre non è degradante come quello degli ignavi, è però solo parvenza di vittoria, un’imitazione di Cristo non riuscita, una corsa senza vero premio. Chi prenderà quel premio – “la gloria de la lingua” -, togliendolo ad altri, sarà Dante il quale, come dice lo stesso Latini, è “sementa santa” dei Romani, vero loro erede nell’universalità dell’eloquio.
[1] Cfr. A. FRUGONI, Il canto III del “Purgatorio”, in “Nuove letture dantesche”, III, Firenze 1969, pp. 267-290: 273, riedito in IDEM, Scritti su Manfredi, Roma 2006 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici, 72), pp. 85-108: 91.
[2] Ibid., p. 96 [278].
[3] Ibid., pp. 105-106 [287-288].
[4] Ibid., pp. 98-100 [280-282].
[5] Ibid., pp. 106-107 [288-289], dove viene citato R. MANSELLI, Dante e l’“Ecclesia Spiritualis”, in Dante e Roma. Atti del Convegno di studio a cura della “Casa di Dante”, sotto gli auspici del Comune di Roma, in collaborazione con l’Istituto di Studi Romani, Roma 8-9-10 aprile 1965, Firenze, 1965, pp. 115-135, ripubblicato in IDEM, Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo. Studi sul francescanesimo spirituale, sull’ecclesiologia e sull’escatologisno bassomedievali, introduzione e cura di P. Vian, Roma, 1997 (Nuovi studi storici, 36), pp. 55-78.
[6] Ibid., p. 88 [270].
[7] Ibid., p. 89 [271].
[8] Cfr. PETER OF JOHN OLIVI, On the Bible. Principia quinque in Sacram Scripturam, ed. D. Flood – G. Gál, St. Bonaventure University, New York 1997 (Franciscan Institute Publications, Text Series, 18), III, De doctrina Scripturae, 44-45, pp. 91-93.
[9] Cfr. A. M. CHIAVACCI LEONARDI, nel commento a Inf. XV, 124, Milano 2007, p. 475.
■ Chi intenda approfondire lo stato della ricerca può consultare su questo sito:
-
Pietro di Giovanni Olivi e Dante. Un progetto di ricerca, in “Collectanea Franciscana”, 82 (2012), pp. 87-156 – ENG
-
Petrus Iohannis Olivi in the Italian Peninsula. Images and Influences between Literature and History (Assisi 2015)
-
Amore e vita di poeta. La Vita Nova e l’imitazione di Cristo, dove si mostra come l’incontro fra Dante e le opere esegetiche dell’Olivi (in particolare l’Expositio in Canticum Canticorum e la Lectura super Lucam) risalga a prima dell’esilio, al tempo dell’uscita delle “nove rime”.
LECTURA DANTIS
-
Inferno X (PDF)
Abbreviazioni e avvertenze
Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.
LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.
Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).
Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.
Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.
In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.
Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.
Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994.
1. La montagna della Gentilità
1.1. Fuga ai monti
Avvegna che la subitana fuga / dispergesse color per la campagna, / rivolti al monte ove ragion ne fruga (Purg. III, 1-3)
Nei versi che descrivono l’intervento di Catone a disperdere le anime da poco giunte alla riva del purgatorio, tutte fisse e attente con Dante e Virgilio ad ascoltare l’amoroso canto di Casella che intona dolcemente “Amor che ne la mente mi ragiona” (Purg. II, 118-133), si registra l’elaborazione di alcuni motivi del gruppo che si può chiamare del “fur”, in quanto presenti nell’esegesi relativa all’improvviso, furtivo sopravvenire del giudizio divino, esposta in due passi simmetrici, Ap 3, 3 e 16, 15.
Il primo passo (Ap 3, 3) è parte dell’istruzione data alla chiesa di Sardi, la quinta delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione. Se il vescovo della chiesa di Sardi, accusato di essere negligente, intorpidito e ozioso, non vigilerà correggendosi, il giudizio divino verrà da lui come un ladro, che arriva di nascosto all’improvviso, senza che egli sappia l’ora della venuta. È giusto infatti che chi non conosce sé stesso a causa della negligenza e del torpore non conosca l’ora del proprio giudizio e sterminio. Costui non vede la luce a motivo delle sue tenebre; erroneamente crede e desidera di poter vivere a lungo nella prosperità ritenendo che il giudizio possa essere a lungo ritardato, e con speranza presuntuosa spera di venire infine salvato. Ma l’Apostolo dice ai Tessalonicesi che “il giorno del Signore verrà di notte come un ladro. E quando diranno: ‘pace e sicurezza’, allora verrà su di loro una repentina distruzione” (1 Th 5, 2-3). Ma ai santi non verrà come un ladro, per cui san Paolo aggiunge: “Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro: voi tutti infatti siete figli della luce e del giorno. Pertanto, non dormiamo come gli altri, ma vigiliamo e restiamo sobri. Quelli che dormono, infatti, dormono di notte” (ibid., 5, 4-7). È questa una prefigurazione dell’occulto avvento e giudizio di Cristo alla fine del quinto stato e all’inizio del sesto, che verrà spiegato all’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12).
Il tema del venire come un ladro si trova anche in un passo simmetrico, proprio della sesta delle sette coppe che vengono versate nella quinta visione (Ap 16, 15), dove si parla di un giudizio improvviso e subitaneo, sottolineato dall’avverbio “ecce” e dal presente “venio” al posto del futuro ‘veniam’ per togliere ogni possibile stima dell’indugiare e per rendere più attenti, vigili e timorati. Inoltre si definisce beato colui che vigila e custodisce le sue vesti, cioè le virtù e le buone opere, per non andar nudo, cioè spogliato di esse, sì che tutti vedano le sue sconcezze, cioè il suo peccato e la pena piena di confusione inflitta nel giorno del giudizio.
Da questi difetti vengono escluse poche persone buone, i cui nomi sono noti a Cristo per la loro santità, per cui si dice: “Ma hai pochi nomi in Sardi” (Ap 3, 4). Il dono della grazia che ciascuno ha ricevuto come proprio dà a ogni uomo un nome per il quale egli è conosciuto. La carità divina, in quanto comune a tutti i buoni, dà un comune nome ai santi, che sono così chiamati cittadini di Gerusalemme.
Il finale di Purg. II registra, nel silenzio del tema principale (del “ladro”), il contrapporsi alla negligenza del rimprovero da parte di Catone, “veglio onesto” (vv. 119-121; “veglio” equivoca tra ‘vecchio’ e ‘vigilante’), e si tratta di motivi che provengono da Ap 3, 3. L’invito ad andare a purgarsi – “Correte al monte a spogliarvi lo scoglio / ch’esser non lascia a voi Dio manifesto” (vv. 122-123) – contiene il motivo del «“Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus» da Ap 16, 15. ‘Spogliarsi lo scoglio’ del peccato è un rivestirsi di virtù. È da notare che nel canto precedente Virgilio ricorda a Catone il suo suicidio in Utica, “ove lasciasti / la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara” (Purg. I, 74-75): non è casuale che il versetto precedente, Ap 16, 14, parli del “dies magnus Dei omnipotentis”, cioè del giudizio di cui poi si dice che verrà subitamente come un ladro. È ancora da notare come il corpo, detto ‘spoglia’ nel caso dei suicidi puniti nella selva infernale, sia chiamato “vesta” nel caso di Catone, che vigilò e custodì le virtù e le buone opere. Lo stesso motivo compare nel coro dei quattro figli del conte Ugolino: “tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia” (Inf. XXXIII, 62-63). Essi offrono in sacrificio al padre una carne peritura e hanno fame di cibo spirituale, come Catone di libertà, per cui agli uni e all’altro la morte non fu amara [1].
Le anime che il gridare di Catone fa fuggire verso la montagna sono paragonate ai colombi che abbandonano il cibo “se cosa appare ond’ elli abbian paura” (Purg. II, 124-132). Anche nella similitudine sono presenti motivi del gruppo: a “et subito faciet hec iudicia” (Ap 16, 15) corrisponde “subitamente”, al “timoratiores reddat” (Ap 16, 15) l’“abbian paura”, mentre il fuggire delle anime “com’ om che va, né sa dove rïesca” è da ricondurre al non sapere l’ora del giudizio (Ap 3, 3). Fuggire atterriti ai monti è inoltre un tema connesso ad Ap 6, 15, l’apertura del sesto sigillo cui è assimilato il venire di Cristo come un ladro proposto alla chiesa di Sardi. È appunto un fuggire “al monte” (Purg. II, 122, 131; III, 1, 3: “fugient … inter saxa montium” – la fuga ai monti e alle ‘pietre’ è motivo tipico dell’anno del giubileo) [2].
Nel complesso dei versi si mantengono i concetti teologici di un sopravvenire improvviso che suscita la paura del giudizio (da notare la presenza dell’avverbio “ecco”, da Ap 16, 15, a Purg. II, 119), della necessità di vigilare contro ogni negligenza e torpore, del custodire le proprie vesti, cioè le virtù e le buone opere. Tace, come si è già notato, il tema principale, quello del “fur”.
I due passi (Ap 3, 3 e 16, 15), che sono loci paralleli, se analogicamente collazionati, offrono una serie di parole-temi soggette a variata elaborazione in numerosi luoghi del poema [3].
Nel secondo balzo del cosiddetto “antipurgatorio”, fra i morti per violenza e negligenti nel pentimento sino all’ultima ora, Iacopo del Cassero ripete il motivo paolino di quanti dicono “pax et securitas”, ammettendo di essere stato ucciso dai sicari del marchese Azzo d’Este a Oriago, presso Padova (1298), proprio nel luogo, “in grembo a li Antenori”, dove credeva di essere più sicuro (Purg. V, 52-54, 73-76).
Lo stesso motivo risuona nell’apostrofe a Firenze – “tu ricca, tu con pace” -, dove il ‘tardare’ (la giustizia, per ponderazione) assume un significato positivo rispetto all’esegesi (Purg. VI, 130, 137).
Nel colloquio con Sordello, Virgilio usa il motivo del vestirsi di virtù e di buone opere da Ap 16, 15 (Purg. VII, 25-27). Egli ha perduto la visione di Dio “non per far, ma per non fare”, cioè “per non aver fé” (v. 8) in quel Dio “che fu tardi per me conosciuto” (v. 27). Da notare il tardare, da Ap 3, 3; il “non fare” corrisponde ai «“vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera», da Ap 16, 15. Per questo il poeta pagano aggiunge: “quivi sto io con quei che le tre sante / virtù non si vestiro, e sanza vizio / conobber l’altre e seguir tutte quante” (vv. 34-36). Virgilio distingue tra le virtù cardinali, di cui si rivestì, e quelle teologali, di cui non poté rivestirsi. Qui il tardare non è peccato, perché solo la prescienza divina poteva stabilire il tempo della Redenzione; designa un fatto ineluttabile e doloroso. Delle quattro parole fondamentali del gruppo da Ap 16, 15 (“vestimenta”, “virtutes”, “bona opera”, “spoliatus”) solo l’ultima, quella negativa, non viene pronunciata da Virgilio.
Più avanti nel canto, Sordello guida i due poeti alla valletta dei principi, dove il tema della negligenza e del tardare (da Ap 3, 3) sono generali, ma in particolare appropriati a Rodolfo d’Asburgo (re d’Italia dal 1273 al 1291), “che potea / sanar le piaghe c’hanno Italia morta, / sì che tardi per altri si ricrea” (Purg. VII, 91-96).
Il tardare è proprio del cielo della Luna, che delle sfere celesti è quella che si muove più lentamente. In essa si manifestano i beati che hanno negletto i voti (Par. III, 51, 55-57). Piccarda varia ancora i temi. Fu infatti clarissa, secondo la norma per cui “nel vostro mondo giù si veste e vela, / perché fino al morir si vegghi e dorma / con quello sposo ch’ogne voto accetta / che caritate a suo piacer conforma” (vv. 97-102). Il vestirsi, da Ap 16, 15, è speculare al vegliare da Ap 3, 3; il dormire (motivo anch’esso presente, in senso negativo, ad Ap 3, 3) corrisponde al ‘velare’, che in altri momenti dell’esegesi teologica è accostato al sonno.
“Fu tarda” la conversione di Adriano V, che purga l’avarizia nel quinto girone della montagna (Purg. XIX, 106); il successore di Pietro (papa Fieschi regnò per soli trentotto giorni nel 1276) aggiunge il tema dell’eccezione di pochi buoni della chiesa di Sardi (Ap 3, 4) allorché menziona la sua buona nipote Alagia, la moglie di Moroello Malaspina (vv. 142-145). Le parole “e questa sola di là m’è rimasa” contengono il tema del rimanere del purissimo seme, proprio dell’esegesi della quinta guerra (Ap 12, 17).
[1] Cfr. La Passione secondo il conte Ugolino, tab. 24.
[2] Cfr. L’anno delle pietre misericordiose.
[3] Cfr. Dante e Gioacchino da Fiore, I, tab. I.8 e nota relativa; Il sesto sigillo (PDF), cap. 1d.
[LSA, cap. III, Ap 3, 3-4 (Ia visio, Va ecclesia)] Deinde comminatur eidem iudicium sibi occulte et inopinate superventurum si non se correxerit, unde subdit: “Si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur” (Ap 3, 3), qui scilicet venit latenter et ex improviso ut bona auferat et possessorem occidat. Unde subdit: “et horam nescies qua veniam ad te”. Iustum enim est ut qui se ipsum per negligentiam et torporem nescit, nesciat horam iudicii sui et exterminii. Talis etiam propter suas tenebras non videt lucem, ac erronee credit et optat se diu in prosperitate victurum et Dei iudicium diu esse tardandum, et etiam spe presumptuosa sperat se esse finaliter salvandum, propter quod Ia ad Thessalonicenses V° dicit Apostolus quod “dies Domini veniet in nocte sicut fur. Cum enim dixerint: pax et securitas, tunc superveniet eis repentinus interitus” (1 Th 5, 2-3). Quibus autem, scilicet sanctis, et quare non veniet sicut fur ostendit subdens: “Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos dies illa tamquam fur comprehendat; omnes enim vos estis filii lucis et diei. Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed vigilemus et sobrii simus. Qui enim dormiunt nocte dormiunt” et cetera (ibid., 5, 4-7). Nota quod correspondenter prefigurat hic occultum Christi adventum et iudicium in fine quinti status et in initio sexti fiendum, prout infra in apertione sexti signaculi explicatur.
|
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 15 (IIa visio, apertio VIi sigilli, IVum initium] Tunc etiam, tam propter illud temporale exterminium quod sibi a Dei iudicio velint nolint sentient supervenisse, quam propter despe-ratum timorem iudicii eterni eis post mortem superventuri, sic erunt omnes, tam maiores quam medii et minores, horribiliter atoniti et perterriti quod preeligerent montes et saxa repente cadere super eos. Ex ipso etiam timore fugient et abscondent se “in speluncis” et inter saxa montium. |
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 15 (Va visio, VIa phiala)] Quia vero Deus tunc ex improviso et subito faciet hec iudicia, ideo subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 15). Fur enim venit latenter ad furandum, ne advertat hoc dominus cuius sunt res quas furatur. Non autem dicit ‘veniam’ sed “venio”, et hoc cum adverbio demonstrandi, ut per hoc estimationem de sua mora nobis tollat et ad adventum suum nos attentiores et vigilantiores et timoratiores reddat. Ad quod etiam ultra hoc inducit per promissionem premii et comminationem sui oppositi, unde subdit: “Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus; “et videant”, scilicet omnes tam boni quam mali, “turpitudinem eius”, id est sua turpissima peccata et suam confusibilem penam in die iudicii sibi infligendam. |
Purg. II, 118-133; III, 1-3Noi eravam tutti fissi e attenti
|
Purg. VII, 25-27, 34-36, 91-96Non per far, ma per non fare ho perduto
|
1.2. Il “campo”
“Quando l’Agnello aprì il primo sigillo, vidi e udii uno dei quattro animali che diceva con voce di tuono: ‘vieni e vedi’” (Ap 6, 1). Il primo dei quattro animali, il leone, tra il corruscare di miracoli annunzia cose nuove, grandi e mirabili, risuonando con voce di tuono e predicando in modo possente, magnifico e ruggente. Invita Giovanni a ‘venire’, cioè a prestare maggiore attenzione, e a ‘vedere’ quello che segue per mezzo dell’intelligenza spirituale. Il leone designa i pastori e gli apostoli del primo stato della Chiesa, come pure il potere regale e la gloria di Cristo che risorge trionfante.
■ I motivi del ruggire e del tuonare, accostati al porre attenzione, sono incastonati nella descrizione dell’apertura della porta del purgatorio, che ‘rugghia’ stridendo più di quanto fece la rupe Tarpea allorché Cesare si impadronì dell’erario in essa custodito cacciandone “il buono Metello” (Purg. IX, 133-139). Dante si rivolge “attento al primo tuono”: qui i temi dell’apertura del primo sigillo si intrecciano con quelli propri dell’angelo del decimo capitolo (sesta tromba), che ha la faccia come il sole e grida anch’egli a gran voce come un leone che ruggisce. Dopo il suo grido, i sette tuoni fanno udire la loro voce (Ap 10, 3).
All’apertura del primo sigillo appare Cristo resuscitato, seduto su un cavallo bianco (Ap 6, 2). Si mostra cioè nel suo corpo glorioso e nella Chiesa primitiva resa bianca dalla grazia della rigenerazione e irradiata dalla luce della sua resurrezione. Sedendo su di essa, Cristo uscì nel campo del mondo non pavido o infermo, ma con somma magnanimità e insuperabile virtù. Condusse infatti nel mondo i suoi apostoli come leoni animosi e potenti nell’operare miracoli. In essi aveva l’arco della predicazione capace di saettare e di penetrare i cuori. Gli era stata data anche la corona regale, secondo quanto si dice in Matteo 28, 18: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra”. La corona riguarda anche gli apostoli, che aveva fatto principi e re spirituali di tutta la Chiesa e di tutto il mondo. Con l’arco saetta i reprobi con sentenze di condanna, con la corona glorifica i buoni. Cristo “uscì vittorioso per vincere”, cioè, secondo Riccardo di San Vittore, convertendo quelli fra i Giudei che aveva eletto per vincere i Gentili predestinati. Nella sua stessa uscita nel mondo apparve vittorioso come se avesse già vinto tutto.
■ Il tema del campo, nell’esegesi quello vittorioso di Cristo nel mondo, assume nel poema molteplici forme. Si trova da solo, come nella “buia campagna” che trema prima dello svenimento di Dante in Inf. III, 130-131, o nella “grande campagna, / piena di duolo e di tormento rio” che il poeta vede appena varcata la porta della città di Dite (Inf. IX, 109-111), o nel “campo maligno” di Malebolge che ha nel mezzo “un pozzo assai largo e profondo” (Inf. XVIII, 4-5), o nella “campagna” che precede il monte al quale fuggono per purgarsi le anime adunate ad ascoltare il canto di Casella e disperse da Catone (Purg. III, 1-3). Il Paradiso terrestre è “campagna santa”, piena di ogni semenza (Purg. XXVIII, 5, 118-119: seminare la fede è uno dei motivi del primo stato, come risulta dal Notabile III del prologo).
Congiunto con il motivo della gloria, intesa però come “mondan romore”, il tema del “campo” è appropriato ai superbi purganti. Cimabue, afferma Oderisi da Gubbio, “credette … ne la pittura / tener lo campo”, che è stato invece traslato a Giotto (Purg. XI, 94-96). Provenzan Salvani, “quando vivea più glorïoso”, messa da parte ogni vergogna, “liberamente” si piantò a mendicare nel Campo di Siena per raccogliere il denaro necessario al riscatto dell’amico prigioniero di Carlo d’Angiò (vv. 133-138). Se deporre la viltà per la magnanimità appartiene al Cristo vittorioso che esce in campo all’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2), affiggersi “liberamente” appartiene ai segnati che all’apertura del sesto sigillo ricevono il sigillo di Dio sulla fronte. In questa impressione del segno è inclusa la fede e la devozione per l’adorazione, l’imitazione, l’esaltazione della passione di Cristo. Avviene in fronte, allorché ai segnati è data la costante e magnanima libertà di confessare pubblicamente la fede e di osservarla, predicarla e difenderla. In fronte si mostra infatti il segno dell’audacia e della strenuità o della pusillanimità e dell’inerzia, della gloria o della vergogna (Ap 7, 3). Lo stesso ‘stare fisso’ è una prerogativa della sesta vittoria (Ap 3, 12). Così il Campo di Siena fu per il Salvani, come per Cristo, luogo di vittoria: l’atto di umiltà, per il quale “si condusse a tremar per ogne vena”, tolse a colui che “fu presuntüoso / a recar Siena tutta a le sue mani” lo stare fuori dai gironi della montagna a purgare la negligenza della tarda conversione (Purg. XI, 122-123, 138, 142). Da notare la presenza del tema del campo, dal primo sigillo, anche nelle precedenti parole di Omberto Aldobrandesco – “ch’io ne mori’, come i Sanesi sanno, / e sallo in Campagnatico ogne fante” (vv. 65-66; la terzina che precede è segnata dai temi della prima tromba, ad Ap 8, 7) -, tema che si ritrova più avanti nel secondo girone, dove prevalgono i temi del secondo stato, nelle parole di Sapìa senese: “Eran li cittadin miei presso a Colle / in campo giunti co’ loro avversari” (Purg. XIII, 115-116).
Tutta la prima cornice della montagna è sotto il segno del biancheggiare dei marmi (cfr. Purg. X, 72). Si tratta del segno del primo avvento di Cristo, nel primo stato della Chiesa, che si rinnova nell’età moderna, cioè nel sesto stato, e raggiungerà il culmine allorché, nel sesto girone, nel colloquio con Bonagiunta da Lucca verrà esposta la poetica delle “nove rime”. Le immagini di umiltà scolpite nel candore della pietra si riferiscono all’Annunciazione, a David (dalla cui radice nacque Maria) e alla moglie Micòl (la “donna dispettosa e trista” che appare come antica prefigurazione della superba nuova Babylon), a Traiano che rende giustizia alla vedovella. Come fu umile il primo stato della Chiesa, così il sesto stato dovrà più degli altri umiliarsi.
Il contrasto tra la magnanimità e la viltà affiora nel racconto che Virgilio, ombra magnanima, fa a Dante, offeso nell’anima da viltà, circa i motivi del suo muovere dal Limbo per farlo “campare”, cioè per salvarlo a una vita di milizia, e anche in questo caso si insinuano i temi della “signatio” all’apertura del sesto sigillo (Inf. II, 43-48, 68; Ap 7, 3).
Il campo è dall’esegesi accostato al colore bianco. È bianca di brina la “campagna” che il villanello vede sgomento scambiandola per neve, ma che poco dopo cambia faccia facendogli tornare la speranza di nutrire il proprio gregge (Inf. XXIV, 1-15). Si può qui ricordare la quarta perfezione di Cristo come sommo pastore trattata nel primo capitolo (Ap 1, 14), i cui capelli sono bianchi come la lana e come la neve. La lana lenisce col calore, è molle, temperata e soave nel candore; la neve è fredda, congelata, rigida e intensa nel candore non sostenibile alla vista. Così la sapienza di Cristo, che è umore che impingua e che purga le colpe, è da una parte calda per la pietà e condescensiva in modo contemperato alle nostre facoltà; è dall’altra astratta, rigida e intensa. Non a caso la similitudine del villanello cade “in quella parte del giovanetto anno / che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra”: il passaggio dalla neve alla sua bianca sorella brina segna il passaggio dal rigido inverno, gelato e chiuso, al condiscendere temperato e pietoso verso la necessità di cibo delle pecorelle.
Un altro accostamento di ‘campo’ e di ‘bianco’ è nella rabbiosa profezia di Vanni Fucci al termine di Inf. XXIV: “e con tempesta impetüosa e agra / sovra Campo Picen fia combattuto … sì ch’ogne Bianco ne sarà feruto” (vv. 147-150), dove la sconfitta annunciata dei Bianchi pistoiesi da parte dei Neri fiorentini alleati coi lucchesi, capitanati da Moroello Malaspina (1302, a Serravalle), significherà la sconfitta di tutti i Bianchi esuli, Dante compreso.
I motivi dell’arco e delle frecce sono propri dei centauri “armati di saette”, che corrono tra la base della ripa e la fossa del Flegetonte sanguigno, anch’essa “in arco torta”. Tre di essi si staccano dalla schiera per andare incontro a Virgilio e a Dante “con archi e asticciuole prima elette”: eleggere, cioè scegliere con cura le frecce dalla faretra (che sono le sentenze di condanna di Cristo e dei suoi), corrisponde all’elezione dei predestinati da inviare nel mondo a convertire i Gentili (Inf. XII, 52-60). I tre centauri, che vanno saettando i violenti contro il prossimo che si traggono via dal sangue bollente più di quanto sia stato dato loro in pena, formano una pessima Trinità, come appare nell’esegesi di Ap 1, 8 (Cristo alfa e omega) e della sesta coppa (Ap 16, 13).
■ Il colore bianco, connesso all’uscire (l’“exire in campum” di Cristo), è proprio dell’angelo nocchiero che conduce le anime dalla foce del Tevere al lido del purgatorio, del quale Dante vede prima un bianco indistinto, che si precisa in seguito essere le ali, e poi, a poco a poco, un altro bianco che esce di sotto al primo, che è la veste (Purg. II, 22-26). I cavalli bianchi designano d’altronde anche la capacità di trasportare propria degli angeli e dei santi che ad Ap 19, 14, nella battaglia finale contro l’Anticristo, formano l’esercito di Cristo, il quale combatte anch’egli su un cavallo bianco (la sua umanità candida per innocenza e gloria) per la giustizia e la verità (Ap 19, 11), con in capo la corona regale, simbolo del premio da attribuire ai propri soldati dopo la certa vittoria (Ap 19, 12).
L’arrivo dell’angelo, nell’ora mattutina, è fulmineo. Il poeta vede “un lume per lo mar venir sì ratto, / che ’l muover suo nessun volar pareggia” (Purg. II, 16-18): corrisponde alla diffusione della fede nel mondo propria del primo stato della Chiesa, che fu veloce come la luce del sole che procede istantanea da oriente a occidente (che è la direzione dell’angelo) e trascorre alla stregua della folgore (prologo, Notabile XII). Altrettanto veloce è la partenza dell’angelo sul suo “vasello snelletto e leggero” (Purg. II, 41, 49-51), dopo aver fatto alle anime il segno della croce, che è tema del secondo stato (designa la confermazione, il secondo sacramento; al primo stato appartiene il battesimo: prologo, Notabile XIII).
La prima vittoria (Ap 2, 7) consiste nella vittoriosa uscita (“victoriosus egressus”) dal mondo. Gli spiriti seduti entro la navicella cantano il salmo 113, il cui primo versetto è “In exitu Isräel de Aegypto” (Purg. II, 46-48): come affermato nel Convivio II, i, 7, significa, nel senso anagogico, l’uscita dell’anima dal peccato “santa e libera in sua potestate”; oppure allegoricamente, come detto nell’Epistola XIII, 21, significa la nostra redenzione per opera di Cristo; moralmente designa la conversione dell’anima dal lutto e dalla miseria del peccato allo stato di grazia, anagogicamente l’uscita dell’anima santificata dalla schiavitù della presente corruzione alla libertà dell’eterna gloria.
Anche le indicazioni orarie corrispondono al primo stato. A Purg. I, 115-117 si dice che “l’alba vinceva l’ora mattutina / che fuggia innanzi, sì che di lontano / conobbi il tremolar de la marina”. L’alba che vince l’ora del mattino, cioè l’ultima parte della notte, designa Cristo “equus albus” del primo sigillo – che esce vittorioso in campo -, mentre “il tremolar de la marina” accenna già al secondo stato, di cui è proprio il tema del mare.
Partito l’angelo nocchiero, ancora temi dal primo sigillo si registrano nel saettare la luce da parte del sole (Cristo, che esce vittorioso in campo su un cavallo bianco, ha in mano arco e frecce), “ch’avea con le saette conte / di mezzo ’l ciel cacciato Capricorno” (Purg. II, 55-57).
È da ricordare ancora che il tema del campo, peculiare dell’apertura del primo sigillo, riaffiora in principio di Purg. III, allorché Catone ha disperso in fuga “per la campagna”, verso la montagna della purgazione, le anime portate al lido dall’angelo nocchiero, che avevano indugiato ad ascoltare il dolce canto di Casella (cfr. supra).
■ Il “celestial nocchiero” riproduce, nel tempo del viaggio di Dante, il primo avvento di Cristo. Ciò corrisponde al tempo che percorre la topografia spirituale della seconda cantica. Dopo le prime cinque età del mondo (corrispondenti all’Antico Testamento, la gioachimita età del Padre), che hanno segnato la discesa a spirale per i cinque cicli settenari dell’Inferno, con il Purgatorio inizia la sesta età, quella di Cristo (l’età del Figlio), che ha sette stati, corrispondenti ai sette periodi della Chiesa. Dapprima, nel cosiddetto “antipurgatorio”, si registrano in successione temi prevalenti dei primi cinque stati. Il sesto stato della sesta età (con cui si apre l’età dello Spirito) inizia con l’apertura della porta di san Pietro (la porta del purgatorio). Questo sesto stato procede anch’esso con andamento settenario, per cui ha sette momenti, corrispondenti principalmente a un girone della montagna, ma non del tutto, perché sempre l’ordine spirituale del poema rompe i confini letterali e le divisioni materiali, concatenando i temi di uno stato prevalente con quelli dello stato che precede e con quelli dello stato che segue e intrecciandoli con temi di tutti gli altri periodi.
Punto di arrivo è la vasta zona dedicata al sesto momento del sesto stato della Chiesa, che ha inizio nel forte terremoto che scuote la montagna mentre Dante e Virgilio si trovano ancora nel quinto girone (Purg. XX, 124-141) e procede fino al settimo girone: è in questa zona ‘sesta’, tutta pregna dei motivi relativi al novum saeculum prodotto del secondo avvento di Cristo nello Spirito, che viene esposto, nel dialogo fra Dante e Bonagiunta da Lucca, il manifesto poetico delle “nove rime” (Purg. XXIV, 49-63).
È spiegato nel Notabile VII del prologo della Lectura che il sesto stato della Chiesa (quello, iniziato nel 1206 con la conversione di Francesco, nel quale vivono Olivi e Dante) è il secondo stato di Cristo e ha i suoi sette tempi per cui la Chiesa, come fosse una sfera, si ricongiunge circolarmente al primo apostolico tempo. Il settimo dei sette momenti del sesto stato della Chiesa coincide con il settimo stato generale della Chiesa, che nel poema corrisponde in parte all’ultimo girone della montagna (il settimo, dove si purgano i lussuriosi) e in parte all’Eden, con cui si chiude la seconda cantica. Il Purgatorio dunque, secondo il senso spirituale, è la storia della Chiesa che corre verso il suo sesto periodo (status), punto di riferimento di tutte le vicende umane, antiche e moderne, che ad esso cooperano [1].
Il settimo stato si svolge parte in questa vita, parte nell’altra. In questa vita consiste nella “quieta et mira participatio future glorie”, come se si vedesse la Gerusalemme celeste discendere in terra, nel pregustare in questo secolo la vita eterna poco prima della fine del mondo; nell’altra vita corrisponde alla resurrezione dei corpi, alla glorificazione dei santi e alla consumazione finale di tutte le cose. Può anche essere inteso come il periodo in cui le anime sante stanno in quiete prima della resurrezione dei loro corpi. In quanto si svolge in questa vita, il settimo stato è figurato nell’Eden, che è collocato in terra; in quanto spetta all’altra vita, il settimo stato coincide con il Paradiso, che ha un proprio particolare ordine spirituale, anch’esso fondato su cicli settenari.
■ I temi dell’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2) che segnano, a Purg. II, l’arrivo dell’angelo nocchiero, sono stati in parte anticipati, quasi fossero avvolti in un nucleo non ancora del tutto aperto, in Inf. IV. Chiusosi il canto precedente con il terremoto che scuote la “buia campagna” (Inf. III, 130-131), la fede che vince, “instar lucis solaris […] in gloriam Christi et lucis sue” (prologo, Notabile XII), è nel domandare di Dante a Virgilio, “per volere esser certo / di quella fede che vince ogne errore”, se mai alcuno sia uscito dal Limbo (ad Ap 2, 7 l’uscire – il “victoriosus egressus de mundo” – è proprio della prima vittoria; una ripresa sarà il canto “In exitu Isräel de Aegypto”). Virgilio risponde che era arrivato da poco all’inferno “quando ci vidi venire un possente, / con segno di vittoria coronato” per trarvi gli antichi padri (Inf. IV, 46-63): la figura di Cristo corrisponde a quella potente, vittoriosa e coronata dell’esegesi dell’apertura del primo sigillo (cfr. ad Ap 5, 1) [2]. Il vincere si ripropone poco dopo nel “foco / ch’emisperio di tenebre vincia” (Inf. IV, 68-69), la “lumera” che fascia il nobile castello dove stanno gli “spiriti magni” (v. 103) [3]. L’apertura del primo sigillo, se applicata alla storia della Chiesa, corrisponde alla trionfale e vittoriosa andata di Cristo all’inferno dopo la resurrezione per strapparvi con la sua potenza i santi padri che stavano nel Limbo. In seguito, trasferito agli apostoli il potere delle chiavi, la sua onnipotenza si mostrò nell’operare miracoli (Ap 5, 13).
Cristo, che all’apertura del primo sigillo appare vittorioso, è luce che espelle le tenebre: “Qui enim per claram fidem et intelligentiam sic in Christo figitur ut in omni loco scripture et in omni facto sue ecclesie sibi occurrat, et hoc sub congrua proportione ad illa loca et opera, erit sibi ad omnia sicut sol omnia loca illa et opera irradians, noctis tenebris inde expulsis”, si afferma ad Ap 4, 1-2. La “fede che vince ogne errore”, il “possente, / con segno di vittoria coronato” e il “foco / ch’emisperio di tenebre vincia” non sono separabili: in tutti e tre i casi sono espressioni di Cristo. Ciò significa che i saggi infedeli, che stanno nel “nobile castello”, ebbero solo illuminazioni parziali, cioè il libro venne loro parzialmente aperto sotto il velame della profezia, per quanto spettava al momento in cui vissero. Ad Ap 2, 7 Olivi afferma che a Cristo in quanto uomo è appropriata la voce (o l’insegnamento) esteriore; in quanto Verbo e verbale sapienza del Padre gli è appropriato anche il parlare interiore che avviene per mezzo della luce della semplice intelligenza. L’insegnamento che avviene tramite il gusto e il sentimento dell’amore è appropriato allo Spirito Santo (cioè allo Spirito di Cristo, che resta sempre il centro della storia). Il primo modo, l’esteriore, si pone rispetto al secondo come la disposizione materiale rispetto all’ultima forma. Alla “lumera”, che vince a metà le tenebre, manca ancora l’insegnamento dello Spirito di Cristo, che nei tempi moderni porterà a compiutezza quel foco, e farà “piena d’amore” la sola “luce intellettual”. La Redenzione è già avvenuta ma non si è completamente esplicata. Gli antichi padri tratti per Cristo dal Limbo alla beatitudine sono figura degli “spiriti magni”. Nel Limbo gli spiriti vivono, nel loro desiderare che il libro venga aperto – “e sol di tanto offesi / che sanza speme vivemo in disio” (Inf. IV, 41-42) -: si tratta dell’unico caso, nell’Inferno, di dannati che hanno una ‘vita’ come atto che continua, in un luogo in cui l’unica vita possibile è quella del poeta che registra il ricordo delle vite e delle opere passate. Come scrisse Orazio, “Dignum laude virum Musa vetat mori; / caelo Musa beat” [4]. Ma questo far beati nel caso di Dante non è affatto una finzione poetica, perché il “poema sacro” procede di pari passo con una teologia della storia che corre verso la piena apertura storica del libro. Il “foco / ch’emisperio di tenebre vincia” (Inf. IV, 68-69) è così anticipazione del “maggior foco … de la viva stella / che là sù vince come qua giù vinse”, che Dante vede nel trionfo delle schiere di Cristo discese all’ottavo cielo (Par. XXIII, 88-93). La Vergine, infatti, come glossa Olivi ad Ap 12, 1-2, vinse in terra dodici tentazioni, e per questo l’Apocalisse la designa nella “mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius coronam stellarum duodecim”. È la Chiesa primitiva, alla quale si ricongiunge l’“ordo evangelicus et contemplativus” dei tempi finali, partorita nel suo corpo mistico con sommo dolore e angustia. Si illumina l’affermazione di Virgilio circa l’“umana gente” che desidera sapere e soprattutto i savi che gli sono compagni nel Limbo: “ché, se potuto aveste veder tutto, / mestier non era parturir Maria” (Purg. III, 38-39). Quasi al termine del viaggio, la “lumera” del “nobile castello, / sette volte cerchiato d’alte mura, / difeso intorno d’un bel fiumicello”, dal “verde smalto” del prato (Inf. IV, 103, 106-108, 118), è diventato, senza mura, il “lume in forma di rivera / fulvido di fulgore, intra due rive / dipinte di mirabil primavera” (Par. XXX, 61-63), che si rivela essere la città dei beati. Il numero sette è un preciso riferimento ai sette stati della Chiesa, decisi nella prescienza divina ma non ancora manifestati compiutamente nella storia, che il pellegrino dovrà tutta ripercorrere e anche anticipare prima di congiungere la propria vista col valore divino.
Il libro fu dunque prima chiuso, ma non tanto che Dio non ne consentisse ai suoi eletti una qualche vista: “iste liber debuit esse sic clausus quod solis introducendis a Deo esset pervius. Sollempnia enim opera temporum futurorum non expedit clare revelari antequam fiant, et tamen oportet ibi esse aliquas claves et hostia per que idonei possint suo tempore ad illa intrare” (prologo, Notabile IV). Cristo mediatore della storia, tra Vecchio e Nuovo Testamento, non è più l’unico fine nel suo avvento carnale, perché anche nel Nuovo le illuminazioni progrediscono per sette stati fino al punto – nel sesto e settimo stato della Chiesa – che segna il suo secondo avvento nell’“ordo evangelicus et contemplativus”, prima del terzo avvento nel giudizio. Con il primo avvento, dunque, non si completa la rivelazione né è compiuta la storia della salvezza.
■ Abbinato al motivo del vincere, il tema del campo (Ap 6, 2) caratterizza il commiato di Brunetto Latini: al sopraggiungere di una schiera che non è la propria e con la quale non può stare, pena giacere cent’anni sotto la pioggia di fuoco senza potersi fare riparo con le mani, nell’allontanarsi “parve di coloro / che corrono a Verona il drappo verde / per la campagna; e parve di costoro / quelli che vince, non colui che perde” (Inf. XV, 121-124).
Con san Domenico, una delle due ruote, insieme a san Francesco, della biga della Chiesa, questa “si difese / e vinse in campo la sua civil briga”, ossia la lotta contro gli eretici (Par. XII, 106-108). San Giacomo avvampa d’amore verso la speranza, che non lo abbandonò mai “infin la palma e a l’uscir del campo”, cioè dalla battaglia terrena, variazione dell’uscire vittorioso di Cristo, come se avesse già vinto, nel campo del mondo (Par. XXV, 82-84).
Nei versi di Inf. XV e Par. XXV fa da contrappunto un altro tema, quello paolino del vincere il premio correndo nello stadio, proprio della settima visione (Ap 21, 16). La misura della città celeste è di 12.000 stadi. Lo stadio è lo spazio al cui termine si sosta o “si posa” per respirare e lungo il quale si corre per conseguire il premio. Designa il percorso del merito che ottiene il premio in modo trionfale, secondo quanto scrive san Paolo ai Corinzi: “Non sapete che tutti corrono nello stadio, ma di costoro uno solo prende il premio?” (1 Cor 9, 24). Ciò concorda con il fatto che lo stadio è l’ottava parte del miglio, e in questo senso designa l’ottavo giorno di resurrezione. L’ottava parte del miglio corrisponde a 125 passi, che rappresentano lo stato di perfezione apostolica che adempie i precetti del decalogo (12 apostoli x 10 comandamenti), cui si aggiunge la pienezza dei cinque sensi e delle cinque chiese patriarcali.
Brunetto Latini lascia dunque la compagnia del suo discepolo: “Poi si rivolse, e parve di coloro / che corrono a Verona il drappo verde / per la campagna; e parve di costoro / quelli che vince, non colui che perde” (Inf. XV, 121-124). Più che sfuggire alla pena di giacere cent’anni sotto la pioggia di fuoco senza potersi far schermo con le mani, in quanto correndo riesce a raggiungere la sua schiera, il premio che egli consegue è la fama del suo Tesoro che ha raccomandato a Dante (vv. 119-120). In ogni caso, può essere curioso notare che il paragone con il palio di Verona chiude il canto e il riferimento alla vittoria sta nel 124° verso, uno in meno dello “stadio” paolino. Più interessante è constatare come l’uscire in campo apparendo vittorioso, non pavido o infermo, sia tema proprio di Cristo all’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2). Dal confronto è possibile rilevare diversi aspetti, nel rispondersi fra i due testi: la compresenza di elementi semantici, la collazione di passi simmetrici della Lectura (da Ap 6, 2), una figura retorica (la perissologia, cioè un’affermazione seguita dalla negazione del suo contrario: “e parve di costoro / quelli che vince, non colui che perde”) suggerita dalla prosa (“apparuit in ipso exitu totus victoriosus et ac si iam totus vicisset […] exivit in campum totius orbis non quasi pavidus aut infirmus”), l’appropriazione a Brunetto, che è un dannato, di motivi propri di Cristo.
L’espressione di Brunetto – “e non tocchin la pianta, / s’alcuna surge ancora in lor letame”, riferita a Dante “sementa santa” (Inf. XV, 74-76) – trasforma un tema della sesta vittoria (Ap 3, 12), allorché il nuovo nome di Cristo viene iscritto intendendo ‘cristiano’ come ‘unto del Signore’, nel senso del Salmo 104, 15: “Non toccate i miei consacrati”. Chi consegue la sesta vittoria – ed è uomo evangelico che sta fisso in Cristo come una colonna nel tempio – ha iscritto nella mente il nome di Dio padre, immagine paterna che si imprime come quella di un padre spirituale nella prole, di un abate nella propria religione. Nella mente di Dante è “fitta … la cara e buona imagine paterna” di Brunetto Latini che gli insegnava “come l’uom s’etterna”, immagine che ora l’“accora” (Inf. XV, 82-85). Anche nell’inferno esistono momenti di apertura all’imitazione di Cristo, per quanto solo nel ricordo della vita passata che la poesia registra.
Da notare ancora che l’arrivo al cielo della Luna è tanto veloce quanto il ‘posarsi’ di una freccia (“un quadrel”, per concordare con l’ambito tematico della città, la Gerusalemme celeste descritta nella settima visione, posta appunto “in quadro”) che vola dopo essersi staccata dalla balestra (Par. II, 23-25; cfr. infra, cap. 10, tab. 27). Dal momento in cui inizia la descrizione dell’ascesa al cielo (con il verso 43 del primo canto del Paradiso), fino al congiungersi con la prima stella (che coincide con il 25° verso del secondo canto: “giunto mi vidi”), sono esattamente 125 versi, come i passi dello stadio paolino (Ap 21, 16).
In Par. XXV, 79-81, a san Giacomo è appropriato anche il tema della folgorante luce di Cristo (dal prologo, Notabile XII: “dentro al vivo seno / di quello incendio tremolava un lampo / sùbito e spesso a guisa di baleno”). Da notare la presenza del verbo respirare (che è hapax nel poema: “vuol ch’io respiri a te che ti dilette / di lei”, vv. 85-86), richiamato dal posarsi nella descrizione finale del quietarsi del suono, dolcemente mischiato, delle voci dei tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, come i remi che “per cessar fatica o rischio … tutti si posano al sonar d’un fischio”, i quali prima percuotevano l’acqua (vv. 130-135). Respirare e posarsi sono segno del conseguimento del premio, dopo il correre nello stadio (Ap 21, 16). Il tema del posarsi è congiunto con quello della quiete e della pace proprio del settimo stato, libero da ogni fatica o opera servile (prologo, Notabile XIII; Ap 10, 5-7).
■ Nell’esegesi dell’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2) viene citato Gregorio Magno su Giobbe 29, 20: “il mio arco nella mia mano si riprenderà”, cioè si rinnoverà in una nuova gloria. L’arco designa la Sacra Scrittura, che ha nella corda il Nuovo Testamento e nel corno il Vecchio. Come nel tendere la corda si curva il corno dell’arco, così il Nuovo Testamento rende molle la durezza del Vecchio e la grazia di Cristo addolcisce il rigore dei precetti legali. La corda che inclina il corno dell’arco designa pure lo zelo che tira con forza a sé le anime per la loro salvezza. Dallo zelo partono le frecce della predicazione, che sono frecce di amore e di timore, cioè promesse, ammonimenti, minacce, rimproveri.
È Beatrice la corda che tira a sé Dante verso la salute: i suoi occhi sono “li smeraldi / ond’Amor già ti trasse le sue armi” (Purg. XXXI, 116-117), la corda con la quale Amore lo prese (Par. XXVIII, 11-12). È corda la provvidenza divina, che dispone l’ordine dell’universo saettando con l’arco che indirizza tutte le creature al proprio fine: per la sua virtù Beatrice e Dante vengono portati all’Empireo, “come a sito decreto” (Par. I, 124-126). L’ascesa al cielo avviene nel meriggio, quando “quasi tutto era là bianco / quello emisperio” (vv. 44-45), cioè quello del purgatorio, pienamente illuminato dal sole: il bianco, accanto alla corda e all’arco, è uno dei temi appropriati a Cristo nell’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2).
Un “corno” che si inclina è quello di Ulisse, “lo maggior corno de la fiamma antica” che comincia “a crollarsi mormorando” dopo le parole di Virgilio (Inf. XXVI, 85-87). L’aggettivo ‘maggiore’, che distingue tra Ulisse e Diomede colui che ebbe più grande fama, ha un riferimento ad Ap 8, 7, nell’esegesi della prima tromba, dove si afferma che la tentazione giudaica contro Cristo si fondò sul fatto di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’ (cioè degli avi) e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo, così da non poter essere vinta se non con la fermezza della fede e della carità (cfr. altre appropriazioni in Farinata e in Omberto Aldobrandesco).
La corda e il nuovo sono accostati nell’atto con cui Virgilio, volgendosi verso il lato destro, getta la corda, che Dante aveva “intorno cinta”, nel burrone dove precipita il Flegetonte verso Malebolge (Inf. XVI, 106ss.). Dante pensa tra sé a questo atto come a un “novo cenno”, che il maestro segue con attento sguardo e al quale è necessario “che novità risponda”. Poi afferma apertamente che si deve essere cauti presso a coloro i quali, come Virgilio, non solo vedono gli atti esteriori ma penetrano col senno nei pensieri altrui. La corda, “novo cenno” al quale viene in su Gerione, è uno dei momenti che nell’Inferno sono segnati dalla prevalenza dei temi del sesto stato, indice di un rinnovamento, per quanto si tratti di novità incompiuta o, come nel caso, fraudolenta (cfr. infra). Fallace passaggio dal vecchio al nuovo è, nella settima bolgia, il farsi molle della pelle del ladro che si sta mutando da serpente in uomo, mentre l’altro ne assume la durezza; le due nature sono in continua, reciproca mutazione e la forma di uomo non si mantiene regredendo a bestia (Inf. XXV, 109-111).
San Giovanni, esaminando Dante sulla carità, gli chiede se senta “altre corde” tirarlo verso Dio, cioè, come spiega il Buti, “altri movimenti che ti tirino ad amare Iddio, come la corda tira chi vi è legato” (Par. XXVI, 49-51). L’Apostolo ha già ascoltato come il poeta si senta tratto a Dio per gli argomenti della ragione umana (Aristotele) e per l’autorità della Scrittura che con essa concorda (Mosé e lo stesso Giovanni). Questa seconda domanda di Giovanni è tessuta anche con motivi che sorprendono per la loro apparente distanza. L’ottava proprietà delle locuste, che al suono della quinta tromba escono dal pozzo dell’abisso aperto e privo di freno, è di avere le code aculeate simili a quelle degli scorpioni (Ap 9, 10). La coda designa l’intenzione finale e occulta, la coda dello scorpione incurvata verso l’alto e davanti indica la velenosa e fraudolenta intenzione di pungere quasi per stimolare verso i beni superiori e che stanno innanzi agli altri. Gli aculei della coda delle locuste penetrano sottili e acuti nel cuore lasciando la puntura del peccato e il rimorso. Questi motivi, propri di una piaga apocalittica, sono variati nelle parole dell’Evangelista: “Ma dì ancor se tu senti altre corde / tirarti verso lui, sì che tu suone / con quanti denti questo amor ti morde” (denti e mordere, nonché suonare, sono proprietà delle locuste). A Dante “non fu latente la santa intenzione / de l’aguglia di Cristo”, cioè non fu occulta intenzione come quella velenosa delle locuste e lo stimolare verso l’alto non fu fraudolento ma chiaro nell’indicare il fine al quale desiderava condurre la risposta del poeta (Par. XXVI, 52-54). La quale riprende il tema del morso per dichiarare ciò che ha concorso a formare la carità, e si tratta di “tutti quei morsi / che posson far lo cor volgere a Dio” (vv. 55-57). Anche la definizione di san Giovanni come “aguglia di Cristo”, se secondo la lettera deriva dal simbolo dell’aquila che gli è proprio, per fonetica spirituale concorda con gli “aculei” delle locuste i quali, privati della loro malefica efficacia, indirizzano all’amore del sommo bene. Non è questo l’unico luogo del poema che trasforma in senso positivo un passo che nel testo dell’Apocalisse è appropriato a figure o a situazioni negative, e di ciò altrove si è trattato.
Quelle “altre corde” che tirano verso Dio (i “morsi” della carità), diverse dagli argomenti filosofici e dall’autorità della Scrittura, corrispondono al mancato tirarsi su verso Beatrice, la quale dopo morta non era più cosa fallace, e ciò di fatto costituisce l’oggetto dell’aspro rimprovero della donna nell’Eden: “qual cosa mortale / dovea poi trarre te nel suo disio?” (Purg. XXXI, 52-54). A lei, “pria … che discendesse al mondo” furono ordinate “per sue ancelle” le virtù cardinali (vv. 106-108), su cui si fonda la beatitudine terrena (quella che la Monarchia assegna alla guida dell’Imperatore per mezzo degli insegnamenti della filosofia, Mon. III, xv, 7-10), come i seniori (gli antichi padri che vennero prima di Cristo) sono, nell’esegesi della sede divina prima dell’apertura del libro, famuli ordinati alla difesa della Chiesa (Ap 4, 4). Lo stesso tema del pungitivo rimorso, negativo nelle locuste, esaltato nell’esame sulla carità di fronte a Giovanni, percorre il tema del pentimento di Dante di fronte a Beatrice: “Di penter sì mi punse ivi l’ortica … Tanta riconoscenza il cor mi morse” (Purg. XXXI, 85-90). Simmetriche sono le espressioni “di tutte altre cose qual mi torse / più nel suo amor”, di fronte alla donna non ancora svelata che “vincer pariemi più sé stessa antica” (vv. 83, 86-87), e “tratto m’hanno del mar de l’amor torto, / e del diritto m’han posto a la riva”, di fronte a san Giovanni (Par. XXVI, 62-63).
Le parole della donna contengono anche i motivi della perfezione di Cristo trattata ad Ap 1, 18 (prima visione): “Io sono vivo e fui morto”, cioè per la verità e per la vostra salute, quasi dicesse: è buono per te umiliarti e morire per me, perché come io fui morto per te e fui come l’ultimo, così anche tu in ciò perverrai alla gloria. Dante avrebbe ben dovuto, come afferma Beatrice nel suo rimprovero, al momento della prima delusione verso le cose di questo mondo causata dalla morte della sua donna, levarsi dietro a lei che non era più cosa mortale (Purg. XXXI, 55-57). Il “bene possum te a morte ad vitam eternam sublevare” è motivo che risuona anche nell’espressione “Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice”, con cui la donna apparsa nell’Eden si rivolge, “regalmente ne l’atto ancor proterva”, al suo amico (Purg. XXX, 70-73).
■ Un altro significato da attribuire ai termini arco, corno è nel proemio del libro, dove dopo l’esposizione dei suoi sette primati in quanto uomo, Cristo stesso introduce il proprio primato in quanto Dio, affermando di essere Alfa e Omega, il principio e la fine (Ap 1, 8). Olivi spiega che l’Alfa, essendo figura di forma triangolare, designa la trinità delle persone nell’unità dell’essenza. L’Omega (in effetti ‘O’ nella grafia e nella lettura) è invece una figura circolare che ha alla sommità un’apertura dal cui fondo esce una “media virgula” tra i due archi o corni della circonferenza. Questa rappresenta l’unità e l’eternità di Dio, l’apertura la sua potenza e carità nel creare e nell’elargire i doni, i due archi designano il Padre e il Figlio, la “virgula” procedente dal loro mezzo designa lo Spirito, che procede dal Padre e dal Figlio ed è nesso di entrambi.
Nella descrizione del Flegetonte, l’infernale “riviera del sangue”, è presente l’immagine dell’Omega, trasformata nel disegno di una Trinità negativa. La fossa, dove scorre il fiume (il fondo), è “in arco torta” (Inf. XII, 52-53), intorno al fosso corrono i Centauri. Dante ne incontra tre, e paiono una controfigura delle tre persone divine: il “gran Chirón”, Folo (il cui nome concorda nel suono con “Figlio”) e Nesso, che svolge la funzione di congiunzione come la persona dello Spirito (vv. 67-72). Nesso è anche colui che porta in groppa Dante e, attraversando il Flegetonte, svolge un’effettiva funzione di ‘nesso’ tra il primo e il secondo girone dei violenti. La “virgula” da cui escono i doni elargiti dallo Spirito si ritrova nel fiumicello, rosso per il sangue bollente, che esce dalla selva e se ne va per l’arena del sabbione, “quale del Bulicame esce ruscello / che parton poi tra lor le peccatrici” (Inf. XIV, 76-81). Che si tratti proprio dei doni dello Spirito, intesi in senso negativo, lo dimostra la presenza del verbo ‘partire’ appropriato all’acqua del ruscello che esce dal Bulicame: come si può vedere ad Ap 5, 6 (passo simmetrico a quello di Ap 1, 4, dove il secondo modo del dare, ivi trattato, proviene dai sette spiriti che stanno dinanzi al trono), l’increato spirito di Cristo, in sé uno e semplice, viene ‘partito’, cioè diviso, in sette doni [5]. Una variante del medesimo tema è l’uscita nell’Eden da una sola sorgente di un’unica acqua che poi da sé si ‘diparte’ nel Tigri e nell’Eufrate (nel Lete e nell’Eunoè, Purg. XXXIII, 112-117).
■ I nodi e le rotelle dipinte su Gerione corrispondono alla corda che Dante porge a Virgilio “aggroppata e ravvolta” e che questi usa, gettandola nel burrone, come segnale di richiamo per far venire in su la tripartita fiera (Inf. XVI, 106-123). Nell’episodio, fra i più oscuri del poema, convergono numerosi temi. In primo luogo vi si trova il motivo dell’acqua che non può essere attraversata. Ad Ap 5, 5, dove cita Gregorio Magno a proposito dei nodosi argomenti dell’Anticristo che avviluppano le coscienze [6], Olivi afferma che i tre momenti storici nei quali si compie l’apertura del libro sono prefigurati in Ezechiele 47, 3-5. Il profeta vede dell’acqua scaturire dal lato destro del tempio, che un uomo misura con una cordicella in mano: per i primi mille cubiti le acque arrivano ai piedi, per i secondi fino alle ginocchia, per i terzi fino alle reni, per i successivi mille cubiti le acque sono tanto salite e divenute così profonde da non poter più essere attraversate. Così nella Chiesa, all’inizio, la semplicità dei Gentili fissò i piedi nel fondamento della fede. Al tempo di Costantino, l’impero romano e tutto il mondo piegò le ginocchia dinanzi a Cristo, che poi i dottori nel terzo stato dimostrarono contro gli eretici dover essere adorato come sommo Dio. Nel quinto stato rilassato, le reni sono ripiene di concupiscenza. Al momento dell’apertura del sesto sigillo, le acque della sapienza non possono essere più guadate.
Cingersi i fianchi indica la restrizione della concupiscenza carnale (Ap 1, 13). La corda “intorno cinta”, con la quale Dante pensava “prender la lonza a la pelle dipinta”, simbolo della concupiscenza della carne, designa il quinto stato rilassato: il poeta si è appena lasciato alle spalle i sodomiti, e i canti che li riguardano (Inf. XV-XVI) sono tessuti con prevalenza di fili tematici propri del quinto stato. In precedenza, nel cerchio degli eretici, l’ombra dell’epicureo Cavalcante “s’era in ginocchie levata” (Inf. X, 52-54). Ancor prima, entrando nella Città di Dite, Dante e Virgilio avevano mosso “i piedi inver’ la terra, / sicuri appresso le parole sante” pronunciate dal messo celeste il quale, dopo aver aperto la porta, aveva apostrofato duramente gli ostinati diavoli (Inf. IX, 104-105). I tre momenti coincidono con le tre misurazioni descritte in Ezechiele e applicate da Olivi a tre degli stati: il primo (la Chiesa degli apostoli), il terzo (gli eretici), il quinto (del quale è propria la rilassatezza). Tuttavia, secondo Olivi, nella fase finale del quinto stato non predomina solo la lussuria, ma prevalgono frodi, simonie, rapine generate dal possesso dei beni temporali. La “concupiscentia carnis” (la lussuria) è accompagnata e superata dalla “concupiscentia oculorum” (l’avarizia), nel senso della prima lettera di Giovanni 2, 16: “tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo”. A questi tre fondamentali errori sono assimilate le tre porte occidentali della Gerusalemme celeste, descritta nella settima visione (Ap 21, 13).
Dante si trova sul ciglio del burrone in cui risuona il rimbombo dell’acqua del Flegetonte che cade nel cerchio sottostante: è evidente che il fiume, già passato in groppa al centauro Nesso nel cerchio dei violenti contro il prossimo, non può più essere superato se non con mezzi nuovi e straordinari. Il poeta, seguendo quanto Virgilio gli ha ordinato, scioglie tutta la corda che lo cinge e la porge alla guida “aggroppata e ravvolta”. Si può notare che “l’ebbi tutta da me sciolta” fa riferimento a una citazione del De civitate Dei (XX, 8) ad Ap 20, 3, a proposito del potere di tentare da parte del diavolo, legato o sciolto in base alla misura stabilita da Dio. Questo atto segna il passaggio dalla lonza a Gerione, dalla lussuria ai nodi e agli intrecci della frode (le “perplexitates” dei Moralia di Gregorio Magno): dunque a una tentazione completa, per cui la corda, che è freno alla tentazione, è tutta sciolta. Segna anche il passaggio dal quinto al sesto stato.
Ciò è dimostrato dal confronto con un passo del quarto libro della Concordia di Gioacchino da Fiore citato da Olivi prima di procedere, nella terza visione, all’esegesi della sesta tromba (Ap 9, 13). Gioacchino ritiene incauto definire con precisione gli anni dopo la quarantesima generazione, cioè a partire dal sesto stato, che coincide con la quarantunesima generazione. Usa l’immagine dei marinai, che in vista del porto ammainano le vele e utilizzano altri strumenti per venire a proda, oppure quella di coloro che, dopo aver navigato per lidi sicuri e conosciuti, iniziano a solcare acque sconosciute in modo cauto e circospetto. Sono questi motivi presenti nell’episodio della corda. Virgilio si volge verso il lato destro: lato che indica la potestà cui tutto soggiace [7], ma che può anche alludere alle acque che sgorgano dal lato destro del tempio, secondo Ezechiele, 47, 3-5. Getta quindi la corda nel burrone. Subito Dante pensa tra sé a questo atto come a un “novo cenno”, che il maestro segue con attento sguardo e al quale “e’ pur convien che novità risponda”. Poi afferma apertamente che si deve essere cauti presso a coloro i quali, come Virgilio, non solo vedono gli atti esteriori ma penetrano col senno nei pensieri altrui. Comune con l’immagine di Gioacchino è l’essere cauti (proprio di Dante nei confronti di Virgilio) o circospetti (proprio di Virgilio) di fronte alle novità. Il poeta pagano è antica “figura” dell’abate calabrese, come mostrato altrove.
Guardare con circospezione ogni atto, intento o cenno fa parte del gruppo di temi aggregati attorno al motivo centrale degli ‘occhi fiammeggianti’, propri della quinta perfezione di Cristo sommo pastore ad Ap 1, 14. Guardare attorno con attenzione in una situazione nuova e nell’incertezza del cammino si ritrova nella circospezione con cui Virgilio e Stazio varcano la soglia del sesto girone del purgatorio (il numero è anche segno del sesto stato). Sono passate le prime quattro ore del giorno e la quinta non è ancora pervenuta alla metà del suo corso (l’ora è fra le dieci e le undici antimeridiane; l’ora del sesto stato è il meriggio), quando Virgilio, con l’assenso di Stazio, decide che il cammino da prendere è verso destra, volgendo le spalle al ciglio del balzo, non diversamente dal modo per seguire la via tenuto negli altri gironi (Purg. XXII, 115-126).
Ma perché la corda, che prima prende la lonza e poi trae Gerione? Nell’esegesi dell’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2), qui sopra già considerata, al momento in cui Cristo compare su un cavallo bianco con un arco in mano, viene citato Gregorio Magno su Giobbe 29, 20: “il mio arco nella mia mano si riprenderà”, cioè si rinnoverà in una nuova gloria. L’arco designa la Sacra Scrittura, che ha nella corda il Nuovo Testamento e nel corno il Vecchio. Come nel tendere la corda si curva il corno dell’arco, così il Nuovo Testamento rende molle la durezza del Vecchio e la grazia di Cristo addolcisce il rigore dei precetti legali. La corda è pertanto associata al nuovo e connessa con il potere di tirare a sé. In tal senso Virgilio la usa come “novo cenno” a cui risponde il venire in su di Gerione il quale, pur avendo tutte le caratteristiche dell’Anticristo, concederà i suoi forti omeri per trasportare in volo Virgilio e Dante, “nova soma” (Inf. XVII, 99), dal settimo cerchio dei violenti all’ottavo di Malebolge, dove stanno i fraudolenti. I versi che riguardano Gerione si aprono con l’immagine della corda e con essa si chiudono, allorché, posti i poeti al fondo e scaricate le loro persone, la fiera “si dileguò come da corda cocca” (Inf. XVII, 136), espressione che riprende il tema dell’arco e delle frecce presente ad Ap 6, 2. Questo tema, appartenente all’apertura del primo sigillo che avviene nel primo stato, quello della Chiesa degli apostoli, non è dissonante dalla presenza dei temi del sesto stato della Chiesa, perché questo, che inizia con Francesco, è ritorno al primo, “unde et quasi circulariter sic iungitur primo tempori Christi ac si tota ecclesia sit una spera et ac si in sexto eius statu secundo incipiat status Christi habens sua septem tempora sicut habet totus decursus ecclesie, sic tamen quod septimus status sexti sit idem cum septimo statu totius ecclesie”.
Gerione d’altronde riassume in sé motivi che sono propri del sesto stato, al quale appartiene anche il tema della novità che è proprio dell’inconsueto agire di Virgilio. Gran parte del tessuto della descrizione della bestia, nella prima parte di Inf. XVII, è formata da fili che provengono dalla sesta tromba e la tematica percorre anche l’episodio degli usurai. Il venire di sopra della bestia al nuovo segno dato dalla corda gettata dall’alto da Virgilio (Inf. XVI, 121), come pure il suo venire a proda al cenno del poeta pagano (Inf. XVII, 5, 7-8), dà forma al tema da Ap 3, 9 del ‘far venire’ coloro che si dicono Giudei ma mentiscono perché non lo sono, i quali saranno convertiti alla fede e sottoposti al magistero del vescovo di Filadelfia. La facoltà di parlare data al sesto vescovo (Ap 3, 8: l’apertura della porta è anche apertura dell’ostium sermonis, ovvero rimozione della precedente imposizione di tacere) si traspone nel non poter il poeta tacere la cosa meravigliosa, mentre il giurare proprio dell’angelo della sesta tromba (Ap 10, 5-7) passa nel giurare da parte del poeta “per le note di questa comedìa” (Inf. XVI, 124-129). Portare Dante salvo in groppa al fiero animale da parte di Virgilio, fatto che il maestro ricorda al discepolo titubante a entrare nel fuoco purgante (Purg. XXVII, 22-24), corrisponde al significato del nome della sesta chiesa, Filadelfia, interpretata come quella che “salva l’eredità”, cioè il seme evangelico, nella grande tentazione.
[1] “Il suo purgatorio corrisponde infatti nell’aldilà a quel che nel mondo dei vivi è la Chiesa, la comunità dei credenti pellegrina verso la patria. La liturgia, forma visibile della Chiesa, tiene in questo universo di segni lo stesso posto” (A. M. CHIAVACCI LEONARDI, commento a Purg. II, 49 [Milano 2007]).
[2] Al primo stato appartiene il sacramento del battesimo (prologo, Notabile XIII), e il seminare che è la prima “parte” della fede (prologo, Notabile III). Dirà Dante a san Pietro nell’ottavo cielo: “ché tu intrasti povero e digiuno / in campo, a seminar la buona pianta / che fu già vite e ora è fatta pruno” (Par. XXIV, 109-111; alla sesta vittoria, ad Ap 3, 12, appartiene il “victoriosus ingressus in Christum”). La fede si sviluppa in sette partes: in tal senso sono da intendere, a Inf. IV, 36, le parole di Virgilio sul battesimo, “ch’è parte de la fede che tu credi” (dove tutti i codici, salvo il Cortonese nell’edizione dell’antica vulgata del Petrocchi, recano «parte» e non «porta» come reca invece lo stesso editore). “Parte” è da intendere come ‘prerogativa’, ‘qualità’, propria dei singoli sette doni dello Spirito increato, uno semplicissimo ma partito nella storia della Chiesa, sviluppata secondo sette stati.
[3] Si può notare come gli elementi semantici offerti dal Notabile XII del prologo a proposito della “diffusio fidei […] velox instar lucis solaris ab oriente in occidentem subito procedentis et instar fulguris universa subito discurrentis” siano compresenti nel “lustro” che “sùbito trascorse” per la foresta dell’Eden, “tal che di balenar mi mise in forse”, una luce che poi si precisa essere quella di “un foco acceso”: è la luce che emana dai sette candelabri, cioè dai sette doni dello Spirito divino di cui si dice ad Ap 5, 6 che è in sé uno e semplice, ma ‘partito’, cioè diviso nei sette stati (Purg. XXIX, 16-18, 34-36). Questo “foco” è guida dei ventiquattro seniori nella processione, i quali ad Ap 4, 4 circondano la sede divina e dei cui motivi sono fasciati gli “spiriti magni”. La sua luce, però, non è quella che nel Limbo “emisperio di tenebre vincia” (Inf. IV, 68-69), è quella di una luna più che piena: “più chiaro assai che luna per sereno / di mezza notte nel suo mezzo mese” (Purg. XXIX, 52-54). Ciò corrisponde all’Antico Testamento, posto in rapporto al Nuovo come la luna al sole, ed infatti il Nuovo è designato dal trionfale carro tirato dal grifone-Cristo, a confronto del quale sarebbe povero il carro del Sole (v. 117). Essere più che luna e più che sole, che ad essa subentra “sì come luce luce in ciel seconda” (v. 91), conduce all’incipit della Lectura, tratto da Isaia 30, 26, dove si spiega che alla fine del mondo, in gloria di Cristo, la luce della luna sarà come la luce del sole, e che questa risplenderà della luce di sette giorni, interpretati come la conclusione dei sette stati, allorché non ci sarà più velo. Ciò avverrà, secondo Isaia, “in die qua alligaverit Dominus vulnus populi sui et percussuram plage eius sanaverit”: nell’Eden è descritto il giorno nel quale il grifone lega il timone del carro al grande albero, che rifiorisce (Purg. XXXII, 49-51). Questi motivi troveranno la più compiuta trasformazione nel trionfo delle schiere di Cristo discese all’ottavo cielo (Par. XXIII).
[4] Orazio, Carmina IV, 8, 28-29.
[5] Sul tema cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, 2.13 («Il volgare illustre, uno semplicissimo e molteplice»), tab. XXVII-XXVIII.
[6] Il pianto di Giovanni (Ap 5, 4: “Et ego flebam multum”) designa i momenti nei quali i santi, inconsapevoli della causa che permette le tribolazioni (le ‘pressure’), piangono e sospirano affinché il libro venga aperto, almeno per la parte che è consentito aprire in quel tempo. Tre sono in particolare i periodi interessati (ad Ap 5, 5): il tempo degli apostoli, prima della discesa dello Spirito Santo; quello delle eresie (in particolare l’ariana) e quello dell’Anticristo, o che precede di poco l’apertura del sesto sigillo. In quest’ultimo gli eletti patiranno un tale aggrovigliarsi delle coscienze da essere indotti nell’errore. Così Gregorio Magno (la cui autorità ancora una volta, come nel passo del “certamen dubitationis” nel X Notabile del prologo, è addotta da Olivi a testimone degli insidiosi ultimi tempi), commentando il passo di Giobbe 40, 12, “Nervi testiculorum eius perplexi sunt”, spiega che gli argomenti dei predicatori dell’Anticristo, allo scopo di attirare i buoni, sono annodati, quasi come nervi intrecciati, con asserzioni dolose che non è possibile sciogliere e che avvelenano i cuori con le parole mostrando innocenza nell’operare. Di qui il “dubbio” (che è “error” e “nodo” che Farinata scioglie) di Dante di fronte alla “mala luce” dei dannati, che vedono il futuro ma non il tempo che s’appressa (Inf. X, 94-96, 112-114), e anche la questione posta a Virgilio sugli usurai, che è “groppo” (Inf. XI, 91-96). Brunetto Latini dice dei “mal protesi nervi” lasciati a Vicenza dal vescovo di Firenze Andrea dei Mozzi, dove Bonifacio VIII l’aveva trasferito (“colui … che dal servo de’ servi / fu trasmutato d’Arno in Bacchiglione”, Inf. XV, 112-114).
L’aggrovigliarsi dei nodi, proprio degli argomenti dolosi dei predicatori dell’Anticristo che mostrano un aspetto innocente, si trasforma nei “nodi” e nelle “rotelle” di cui Gerione ha dipinto il dorso, il petto e i fianchi. Gerione, “sozza imagine di froda” che ha la faccia di uomo giusto con pelle di fuori benigna (Inf. XVII, 7-15), è incastonato in una vasta elaborazione dei temi della quinta tromba. Alle locuste è dato il potere di nuocere come gli scorpioni (Ap 9, 3). Lo scorpione è blando nella faccia (ad Ap 9, 7 si dice pure che le locuste hanno la faccia umana, cioè si fingono umane e modeste e paiono fare tutto razionalmente), ha le braccia aperte all’amplesso ma con la coda punge e infonde il suo veleno. Così gli ipocriti, mentre blandiscono esteriormente e anteriormente, realizzano in fine da dietro le loro maliziose intenzioni estorcendo i beni temporali, soddisfacendo lussurie e lascivie con quanti si congiungono e infondendo i propri pravi costumi. Dalle locuste il mostro infernale deriva la faccia d’uomo giusto, le “branche” (cioè le zampe, che però concordano nel suono con “brachia”, cioè con le ‘braccia’ degli scorpioni) e la coda con la velenosa forca a guisa di scorpione.
[7] Cfr. Lectura Dantis, Inferno X (PDF), cap. I.
Tab. 2
[LSA, cap. VI, Ap 6, 1-2 (apertio Ii sigilli)] Dicit ergo (Ap 6, 1): “Et vidi quod aperuisset Agnus unum”, id est primum, “de septem sigillis; et audivi unum”, id est primum, “de quattuor animalibus”, quod scilicet est leo, “dicens tamquam vocem tonitrui”, quia coruscantibus miraculis nova et grandia et mirabilia nuntiavit, ideo quasi vox tonitrui sonuit et etiam quia potenter et magnifice instar leonis rugientis predicavit: “Veni”, scilicet per maiorem atten-tionem, “et vide”, scilicet per intelligentiam spiritalem, hec que sequuntur. |
Purg. IX, 133-139E quando fuor ne’ cardini distorti
|
Duplici ex causa leo demonstrat visa prime apertionis. Prima est quia leo signat primum ordinem ecclesie, scilicet pastorum seu apostolorum; ipsorum autem proprie fuit monstrare primum statum ecclesie in eis et sub eis formatum. Secunda est quia per leonem Christi resurgentis triumphalis et regalis potestas et gloria designatur.
|
|
Inf. III, 130-131; IX, 110-111; XII, 52-63, 73-75; XIV, 58-66; XV, 121-124; XVI, 82-84; XVIII, 4-5; XXII, 1, 21; XXIV, 7-9, 147-150; Purg. III, 1-2; XXVIII, 5, 118-119Finito questo, la buia campagna
|
Inf. I, 91-93; II, 43-45, 67-69“A te convien tenere altro vïaggio”,
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 2 (apertio Ii sigilli)] In prima autem apertione (Ap 6, 2) apparet Christus resuscitatus sedens in equo albo, id est in suo corpore glorioso et in primitiva ecclesia per regenerationis gratiam dealbata et per lucem resurrectionis Christi irradiata, in qua Christus sedens exivit in campum totius orbis non quasi pavidus aut infirmus, sed cum summa magnanimitate et insuperabili virtute. Nam suos apostolos deduxit in mundum quasi leones animosissimos et ad mirabilia facienda potentissimos, et “habebat” in eis “archum” predicationis valide ad corda sagittanda et penetranda. […]
|
|
[LSA, prologus, Notabile III] Quarta ratio est quia quodlibet predictorum septem donorum potest subdistingui in septem partes sive proprietates, ita quod prima a proprietate correspondet primo statui et secunda secundo et sic de aliis, ut sic sint septies septem. […] De tertio (dono) etiam patet. Nam magistralis tuba seu expositio intendit fidei et eius scientie seminande (I), et deinde radicande seu roborande (II), deinde explicande (III), deinde amplexande (IV), deinde contemperande, unicuique scilicet secundum suam proportionem (V); intendit etiam finaliter eam imprimere et sigillare (VI) et tandem glorificare seu glorificatam exhibere (VII). Et patet correspondentia primi ad primum statum et secundi ad secundum et sic de aliis.
|
Purg. I, 115-117; II, 7-9, 13-18, 22-26, 46-51, 55-57; III, 1-3L’alba vinceva l’ora mattutina
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 2 (apertio Ii sigilli)] In prima autem apertione (Ap 6, 2) apparet Christus resuscitatus sedens in equo albo, id est in suo corpore glorioso et in primitiva ecclesia per regenerationis gratiam dealbata et per lucem resurrectionis Christi irradiata, in qua Christus sedens exivit in campum totius orbis non quasi pavidus aut infirmus, sed cum summa magnanimitate et insuperabili virtute. Nam suos apostolos deduxit in mundum quasi leones animosissimos et ad mirabilia facienda potentissimos, et “habebat” in eis “archum” predicationis valide ad corda sagittanda et penetranda. […]
|
|
Par. XII, 106-108; XXV, 79-87, 130-135Se tal fu l’una rota de la biga
|
Inf. XV, 121-124Poi si rivolse, e parve di coloro
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 16 (VIIa visio)] “Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum. […] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia” (Ap 21, 16). Stadium est spatium in cuius termino statur vel pro respirando pausatur, et per quod curritur ut bravium acquiratur, secundum illud Apostoli Ia ad Corinthios, capitulo IX°: “Nescitis quod hii, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium?” (1 Cor 9, 24), et ideo significat iter meriti triumphaliter obtinentis premium. Cui et congruit quod stadium est octava pars miliarii, unde designat octavam resurrectionis. Octava autem pars miliarii, id est mille passuum, sunt centum viginti quinque passus, qui faciunt duodecies decem et ultra hoc quinque; in quo designatur status continens perfectionem apostolicam habundanter implentem decalogum legis, et ultra hoc plenitudinem quinque spiritualium sensuum et quinque patriarchalium ecclesiarum. |
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 2 (apertio Ii sigilli)] In prima autem apertione apparet Christus resuscitatus sedens in equo albo, id est in suo corpore glorioso et in primitiva ecclesia per regenerationis gratiam dealbata et per lucem resurrectionis Christi irradiata, in qua Christus sedens exivit in campum totius orbis non quasi pavidus aut infirmus, sed cum summa magnanimitate et insuperabili virtute. Nam suos apostolos deduxit in mundum quasi leones animosissimos et ad mirabilia facienda potentissimos, et “habebat” in eis “archum” predicationis valide ad corda sagittanda et penetranda. […]
|
|
Inf. XVI, 103-117; XVII, 133-136così, giù d’una ripa discoscesa,
|
Purg. XXXI, 115-117; Par. XXVIII, 10-12Disser: “Fa che le viste non risparmi;
|
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7 (IIIa visio, Ia tuba)] Vel per hoc designatur quod temptationem que simul habet magnam speciem boni et veri, et auctoritatem et testimonium maiorum et antiquiorum et in sapientia famosiorum, et sequelam maioris et quasi totalis partis populi, nullus potest vincere nisi sit in fide et caritate firmus ut terra vel arbor et non fragilis et instabilis et cito arefactibilis sicut fenum. Talis autem fuit temptatio iudaica contra Christum. |
|
Tab. 3
[LSA, cap. IX, Ap 9, 5.10 (IIIa visio, Va tuba)] Per cruciatum (Ap 9, 5) autem designatur hic pungitivus remorsus conscientie et timor gehenne, qui fidelibus in gravia peccata cadentibus non potest de facili deesse. Designat etiam iram et offensam quam temporaliter dampnificati et iniuriati a predictis locustis habent contra eas […].
|
|
Par. XXVI, 49-63“Ma dì ancor se tu senti altre corde
|
Purg. XXXI, 52-54, 85-90e se ’l sommo piacer sì ti fallio
|
Tab. 4 (cfr. Nota)
[NOTA]
La dodicesima e ultima perfezione di Cristo come sommo pastore (prima visione) è il confortare e sollevare in modo familiare gli inferiori resi umili e tremanti dalle due precedenti perfezioni. Ciò avviene sia col tatto che solleva sia con soavi parole; per esprimere il primo si dice: “e pose la sua destra sopra di me”, per le seconde si aggiunge: “non temere” (Ap 1, 17).
Virgilio prende per mano Dante per confortarlo prima di metterlo “dentro a le segrete cose” dei cerchi infernali (Inf. III, 19-21). Così avviene nel condurre il discepolo verso il cespuglio che incarcera il fiorentino suicida (Inf. XIII, 130-132) e nell’avanzare verso i giganti che appaiono a Dante torri (Inf. XXXI, 28-31).
Cristo soggiunge quindi tre doppie perfezioni, la cui fede e conoscenza possano essere di conforto (Ap 1, 17-18). La prima è: “Io sono il primo e l’ultimo”, cioè il principio e la fine, oppure il primo per dignità ed eternità e l’ultimo per umiltà, con la quale mi sono umiliato alla morte in croce.
La seconda è: “Io sono vivo e fui morto”, cioè per la verità e per la vostra salute. Perché non si creda che ora abbia una vita mortale come prima, soggiunge: “ecco, vivo nei secoli”, quasi affermasse: ti posso ben sollevare dalla morte alla vita eterna, io che mi sono elevato dalla morte e che sono causa e fine di tutto, oppure quasi dicesse: è buono per te umiliarti e morire per me, perché come io fui morto per te e fui come l’ultimo, così anche tu in ciò perverrai alla gloria.
La terza è: “e ho le chiavi della morte e dell’inferno”, cioè ho il potere di trarre chiunque dal sepolcro della morte, sia essa la morte del corpo o quella causata dalla colpa, e anche di trarre chiunque dal profondo dell’inferno. Le chiavi, che designano la potestà di aprire e di chiudere, si possono anche intendere come il potere di condannare e di introdurre i dannati nella morte della pena eterna e nel luogo infernale. In questo caso, poiché le parole di Cristo sono rivolte a confortare e non a terrorizzare, la prima interpretazione è la più corretta. A conclusione dell’esame delle dodici perfezioni di Cristo sommo pastore, a lui attribuibili come causa efficiente ed esemplare, Olivi afferma che esse possono essere applicate sia ai perfetti prelati sia agli eletti, che sono come le membra del corpo mistico di cui Cristo è il capo (nel senso che gli occhi sono appropriati ai contemplativi, i piedi agli attivi, la voce ai dottori e ai giudici). In altri termini, si apre la possibilità di appropriarle variamente.
Alla seconda doppia perfezione di Cristo, trattata ad Ap 1, 18, fa riferimento, nella comune risposta dei tre fiorentini sodomiti, il verso “quando ti gioverà dicere ‘I’ fui’” (Inf. XVI, 84). Non è detta tutta l’espressione di Cristo, che giova nell’umiliarsi e morire per poi pervenire alla gloria – “io sono vivo e fui morto” -, ma il ricordare dopo il viaggio quanto visto non è, in questo caso, solo il dolce ricordo come quello di cui Enea parla ai compagni (Aen., I, 203), ma è un ricordo che giova alla salute, la memoria dolorosa della “profonda notte … d’i veri morti” (Purg. XXIII, 121-122). Il verso precedente – “e torni a riveder le belle stelle” – cuce il tema del tornare a Dio, dalla sesta vittoria (Ap 3, 12), con quello della pienezza stellare e della bellezza proprio della quinta chiesa (Ap 3, 1; cfr. Il sesto sigillo, cap. 2b, tab. XI-9).
Variante del “et sum vivus et fui mortuus … bene possum te a morte ad vitam eternam sublevare” è quanto Virgilio dice del suo discepolo al centauro Chirone: “Ben è vivo, e sì soletto / mostrar li mi convien la valle buia; / necessità ’l ci ’nduce, e non diletto” (Inf. XII, 85-87), un mostrare necessario che è tra le cause per cui Giovanni scrive l’Apocalisse (Ap 1, 1). Due canti dopo, il superbo Capaneo stravolge il versetto: «“et sum vivus et fui mortuus” – gridò: “Qual io fui vivo, tal son morto”» (Inf. XIV, 51). Rivolgendosi al traditore Bocca degli Abati, Dante lo cita in modo corretto: “Vivo son io, e caro esser ti puote“, che cioè il poema ti renda fama eterna (Inf. XXXII, 91-93). Giustiniano, portavoce del “sacrosanto segno” dell’aquila, sottolinea l’attualità della giustizia che esso incarna: “Cesare fui e son Iustinïano” (Par. VI, 10).
Beatrice, “regalmente ne l’atto ancor proterva”, continua: “Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice” (Purg. XXX, 70-73). Le sue parole contengono i motivi della perfezione di Cristo trattata ad Ap 1, 18: “et sum vivus et fui mortuus”, cioè per la verità e per la vostra salute. “Bene possum te a morte ad vitam eternam sublevare … – Ben ti dovevi, per lo primo strale / de le cose fallaci, levar suso / di retro a me che non era più tale”: al momento della prima delusione verso le cose di questo mondo causata dalla morte della sua donna, Dante avrebbe ben dovuto, come afferma Beatrice nel rimproverarlo, levarsi dietro a lei che non era più cosa mortale (Purg. XXXI, 55-57). Cristo che parla è principio e fine; il fine dell’Apocalisse è la beatitudine (Ap 1, 3).
Virgilio possiede, almeno in parte, la terza perfezione di Cristo, perché ha la possibilità di portare Dante fuori dell’inferno, avendo già fatto il cammino altra volta (“ben so ’l cammin”), quando gli scongiuri di “Eritón cruda” lo fecero entrare nella Città di Dite per trarvi un’anima dalla Giudecca, il luogo infernale più oscuro e basso (Inf. IX, 16-30). Possiede anche in parte la seconda perfezione – “et sum vivus et fui mortuus” -, considerate le sue parole: “Ver è ch’altra fïata qua giù fui” (v. 22), interpretate alla luce di quanto egli stesso afferma delle anime del Limbo, unici dannati ai quali sia attualmente appropriato il verbo vivere: “e sol di tanto offesi / che sanza speme vivemo in disio” (Inf. IV, 41-42). Le parole con cui il poeta pagano racconta a Dante del suo precedente viaggio servono a rassicurare e a confortare il discepolo intimorito dall’atteggiamento ostinato dei diavoli e dalla reticenza dello stesso Virgilio.
Il tema del potere dato dalle chiavi, appropriato a Bonifacio VIII nel racconto reso da Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 103-105), o all’angelo portiere del purgatorio (Purg. IX, 117-129), è da confrontare con quello della “chiave di David” proprio della sesta chiesa (Ap 3, 7).
Tab. 5
[LSA, cap. I, Ap 1, 8] Deinde post septem primatus Christi secundum quod homo tangit primatum eius secundum deitatem, introducens eum de se ipso loquentem: “Ego sum alpha et o” (Ap 1, 8), quod exponit subdens: “principium et finis”. Quia “a” seu “alpha” est primum elementum in greco, ideo ponitur hic pro principio, et quia “o” est ultimum, ideo ponitur pro fine. Per hec autem ascribit [sibi] plenitudinem totalis causalitatis omnium: nam a principio omnia inchoantur et a fine et in fine omnia consumantur.
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1; clausura IIi sigilli] Tertia ratio septem sigillorum quoad librum Veteris Testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. […] Secundum est bellicositas iniuriarum ultrix ac ire et impatientie nutrix. Quasi enim ubique narrat et laudat et monet et etiam mandat corporalia bella Israel contra suos hostes. Hanc autem evacuat patientie vigor usque ad tolerantiam omnis persecutionis et mortis in secunda apertione notatus.
|
Tab. 6
[LSA, cap. V, Ap 5, 5 (radix IIe visionis)] Tertio ad tempus Antichristi seu ad tempus aliquantulum precedens plenam apertionem sexti signaculi. Tunc enim erunt mire perplexitates conscientie in electis ita ut, teste Christo, fere in errorem ducantur (cfr. Mt 24, 24). Unde Gregorius, Moralium XXXII° super illud Iob: “Nervi testiculorum eius perplexi sunt” (Jb 40, 12) dicit hoc ideo dici, «quia argumenta predicatorum Antichristi dolosis assertionibus innodantur ut alligationum implicatio, quasi nervorum perplexitas, etsi videri possit, solvi non possit. Plerumque autem cum corda verbis inficiunt, in opere innocentiam ostendunt, neque enim aliter ad se traherent bonos»*. […]
|
|
Inf. IX, 104-105; X, 52-54e noi movemmo i piedi inver’ la terra,
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 2 (IIa visio, apertio Ii sigilli)] Secundum etiam Gregorium, Moralium XIX° in fine, super illud Iob: “Et archus meus in manu mea instaurabitur” (Jb 29, 20), per archum scriptura sacra significatur, ita quod per cordam archus designatur Testamentum Novum, per cornu vero Testamentum Vetus. Sicut enim dum corda archus trahitur cornu curvatur, sic per Novum Testamentum duritia Testamenti Veteris emollitur. Gratia enim Christi facit nobis dulcescere rigorem preceptorum legis. Vel per cordam designatur zelus animarum ad earum salutem fortiter tractus et totum robur cordis, quasi cornu archus, secum inclinans et trahens. A tali enim zelo manant sagitte predicationis, id est sagitte promissionum et monitionum ac comminationum et exprobrationum, et sagitte amoris et timoris.[LSA, cap. IX, Ap 9, 13 (VIa tuba)] Item (Ioachim) IIII° libro (Concordie), ubi agit de quadragesima secunda generatione, dicit quod «articulus temporis eius melius relinquitur Deo, qui hec et multa alia in sua posuit potestate. Non enim pertinet ad concordiam querere numerum annorum in novo, ubi non habetur in veteri, et ultra quadragesimam generationem aliquid per certum numerum incautius diffinire. Nec mirum. Solent enim et naute, conspecto comminus portu, navis armamenta deponere et aliis auxiliis competenter inniti»*. Item supra eodem, agens de generatione quadragesima, dicit: «Usque ad presentem locum per experta, ut ita dicam, littora navigantes securo navigio iter faciebamus. Amodo cautius est agendum et hinc inde circumspecte reli[quum] itineris peragendum, utpote qui per incognita navigare incipimus», et cetera**.
* S. Gregorii Magni Moralia in Iob, libri XI-XXII, cura et studio M. Adriaen, Turnholti 1979 (Corpus Christianorum. Series Latina, CXLIII A), lib. XIX, cap. XXX, 55, 72-86 (n. 55), pp. 1000-1001 (= PL 76, coll. 133 C – 134 B). * Concordia, IV 1, c. 44; Patschovsky 2, pp. 469, 20; 470, 1-6.** Concordia, IV 1, c. 38; Patschovsky 2, p. 453, 2-5. |
[LSA, cap. XX, Ap 20, 3 (VIIa visio: cfr. Aug., De civ. Dei, XX, 8)] Sciendum etiam circa hec quod numquam respectu hominum huius vite tota eius temptativa potestas ligatur seu cohibetur, nec tota sic totaliter solvitur quin sub mensura a Deo prefixa, prout ordini universi expedit, refrenetur. Unde et pro tanto respectu prescitorum est quoad quid ligatus, quia non permittitur in eos quantum vellet sevire nec in omne genus vel in omnem excessum facinorum eos pro libitu precipitare, sed nichilominus illud tempus in quo longe minus temptare permittitur vocatur per quandam anthonomasiam tempus sue ligationis, et illud in quo plus permittitur dicitur tempus solutionis eius. Et secundum hoc illud verbum: “ut non seducat amplius gentes” et cetera habet diversimode exponi; semper tamen est sensus: “ut non seducat amplius”, scilicet sicut prius.[LSA, cap. I, Ap 1, 13 (Ia visio)] Succingi circa renes designat restrictionem inferiorum concupiscentiarum et operum carnis.[LSA, cap. I, Ap 1, 14] Quinta (perfectio summo pastori condecens) est contemplationis speculative et practice zelativus et perspicax fervor et splendor, omnes actus et intentiones et nutus ecclesiarum circumspiciens, unde subdit: “et oculi eius velut flamma ignis”.[LSA, cap. XXI, Ap 21, 13 (VIIa visio)] Tres (porte) etiam sunt ab aquilone, ad aperiendum aquilonarem algorem et procellam et obscuritatem hostilium temptationum et certaminum, que sunt principaliter a tribus, scilicet a carne et mundo et diabolo, seu a concupiscentia carnis et a concupiscentia oculorum et superbia vite (cfr. 1 Jo 2, 16), seu ab errore et favore et terrore. Error enim seductorius impugnat veritatem et eius intelligentiam, favor autem mundanus et adulatorius allicit et inficit voluntatem, terror autem comminatorius et malignus inducit pusillanimitatem et fugam et frangit constantiam. Unde primum est proprie [contra] rationalem, secundum contra concupiscibilem, tertium vero contra irascibilem. |
|
1.3. L“aspro diserto”
Nella Lectura i Gentili sono strettamente congiunti con il “deserto”, sui significati di quest’ultimo conviene ora soffermarsi. Nella sesta età del mondo, che comincia con il primo avvento di Cristo, la Chiesa si forma prima fra i Giudei ma poi, a causa della loro durezza e ostinazione, si rivolge ai Gentili. Inizia così quello che san Paolo, nella Lettera ai Romani, chiama il tempo della “pienezza delle genti” (Rm 11, 25-26), che si concluderà solo nel sesto stato della sesta età con la conversione delle reliquie delle genti e poi dei Giudei, i quali per ultimi si volgeranno a Cristo. Secondo il disegno divino, la conversione di Israele deve essere preceduta da quella delle genti (“donec plenitudo gentium intraret”). Il tempo della “plenitudo gentium” non si limita dunque a quello stato felicissimo segnato dalla pace sotto il divo Augusto, che rese l’umanità disposta al primo avvento di Cristo (cfr. Monarchia, I, xvi, 1-2), ma continua ben oltre, fino alla conclusione del quinto stato della Chiesa, il quale concorre con il sesto distinguendosene solo con la caduta di Babylon, e dunque perviene fino al 1300 e oltre (il quinto stato dura circa cinquecento anni a partire da Carlo Magno).
Ciò trova corrispondenza nell’esegesi di Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra), dove si dice che la donna (la Vergine Maria, la Chiesa), il cui figlio era stato rapito (Cristo risorto e asceso al cielo, dopo il tentativo del drago di divorarlo al momento del parto, Ap 12, 4), “fuggì in solitudine”. Tre sono i significati della “solitudine”. Il primo è lo stato della professione e della fede cristiana separato dal giudaismo e da ogni altro dopo la morte e l’ascensione di Cristo. Il secondo è la vita e la contemplazione (“conversatio et contemplatio”) spirituale e celeste alla quale fuggì e ascese la Chiesa dopo aver ricevuto con abbondanza lo Spirito Santo, affinché potesse attendere a nutrirsi di sole cose divine nascondendosi e difendendosi dalle tentazioni diaboliche. Il terzo è la terra delle genti, che allora era deserta, priva cioè di Dio e del suo culto, nella quale la Chiesa si rifugiò dall’ostinata incredulità e persecuzione dei Giudei. Di questa solitudine dice il profeta Isaia: “Ci sarà un deserto nel Carmelo”, cioè pingue di grazie come lo era stata prima la Giudea, “e il Carmelo”, cioè la Giudea, “sarà considerato una selva”, cioè diventerà selvaggio, “e nella solitudine abiterà il giudizio e la giustizia” (Is 32, 15-16). E ancora: “Si rallegreranno i deserti e i luoghi inaccessibili, esulterà la solitudine e fiorirà come un giglio. Le è data la gloria del Libano, il decoro del Carmelo e di Saron” (Is 35, 1-2); “Darò alla solitudine il cedro, la spina, il mirto e l’ulivo, porrò nel deserto l’abete” (Is 41, 19); “Allietati, o sterile che non partorisci, poiché più numerosi sono i figli di colei che è stata deserta di colei che è maritata” (Is 54, 1). Questa fuga sottende un futuro dominio universale, perché si dice che il figlio della donna “erat recturus omnes gentes”.
La donna trova così nel deserto dei Gentili, della fede e della contemplazione cristiana, “il luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni” (Ap 12, 6). Il suo è un pasto spirituale, con il quale incorpora i Gentili nella fede di Cristo. La durata temporale di questo nutrirsi nel deserto viene riproposta, sempre nella quarta visione, al momento della terza e quarta guerra (che sono riunite in un’unica trattazione), lì dove viene detto che alla donna “furono date le due ali della grande aquila”, per volare nel deserto ed esservi nutrita “per un tempo, due tempi e la metà di un tempo” cioè per tre anni e mezzo (Ap 12, 14; “tempo” equivale ad “anno”), ovvero per 1260 anni, computando i giorni come anni (30 giorni al mese per 42 mesi) [1]. Le ali vennero date alla donna “per volare nel deserto, nel suo luogo”. Nella prima guerra si dice che la donna “fuggì” nel deserto, nel luogo apprestatole da Dio (Ap 12, 6); qui si dice che “volò” nel deserto verso il luogo che già era suo: non fuggì cioè dalla Giudea verso le genti, ma volò con magnificenza come regina e signora delle genti per l’intero deserto dei Gentili verso il luogo del suo regno e del suo dominio. Volare nel deserto designa anche la vita solitaria degli anacoreti e la sublime contemplazione delle cose celesti e il volo che ad esse si volge.
I temi del deserto e del fuggire, da Ap 12, 6, percorrono l’inizio del poema: Dante si volge indietro a guardare la “selva selvaggia” (“silvam … silvestrescet”), che egli ‘fugge’ ancora con l’animo (Inf. I, 5, 25-27); riposatosi un poco, riprende “via per la piaggia diserta” (vv. 28-29), vede Virgilio “nel gran diserto” (v. 64), entra “per lo cammino alto e silvestro” (Inf. II, 142); la “diserta piaggia” è pure nelle parole di Beatrice al poeta pagano (v. 62). “Già fu lieta / d’acqua e di fronde” l’Ida in Creta, montagna che “or è diserta come cosa vieta”, all’interno della quale sta dritto il gran Veglio (Inf. XIV, 97-99).
Se queste immagini dell’Inferno corrispondono alla Giudea, ostinata persecutrice da fuggire trasformata in selva, il motivo del deserto, applicato al Purgatorio, indica il luogo dove il poeta ascende nel nutrimento delle cose divine e si nasconde dalle tentazioni. L’erta salita della montagna avviene per via quasi inaccessibile, a confronto della quale “tra Lerice e Turbìa la più diserta, / la più rotta ruina è una scala, / verso di quella, agevole e aperta” (Purg. III, 49-51). Varcata la porta del purgatorio e saliti al primo girone, i due poeti si fermano su un pianoro “solingo più che strade per diserti” (Purg. X, 19-21). La montagna della purgazione è chiamata “aspro diserto” nel Padre nostro recitato dai superbi che chiedono per sé “la cotidiana manna”, cioè il nutrimento spirituale, e per i vivi di non sperimentare la virtù umana con le tentazioni (Purg. XI, 13-15, 19-21; appunto nel “deserto” la donna ha un pasto spirituale e ivi si nasconde e difende dalle tentazioni diaboliche: le prerogative della donna, cioè della Chiesa o del corpo mistico di Cristo, sono distribuite dal poeta ai morti e ai vivi, che per esse sono congiunti nella preghiera dei superbi). Al deserto si aggiunge il motivo del fuggire: l’arrivo al purgatorio è fuga dalla “pregione etterna”, cioè dall’infernale durezza giudaica (Purg. I, 40-41); le anime sono da Catone volte in “subitana fuga” al monte che purga (Purg. III, 1-3); Dante si risveglia dal sonno, nel corso del quale è stato portato da Lucia presso la “porta di san Pietro”, come Achille dopo che la madre Teti l’ebbe ‘trafugato’ dal centauro Chirone portandolo a Sciro, per sottrarlo ai pericoli della guerra di Troia, che corrispondono alle tentazioni del mondo (Purg. IX, 34-42; il fuggire, in questo caso, è anche un tema proprio dell’apertura del sesto sigillo, da Ap 6, 12-17; cfr. supra).
Il tema da Isaia 54, 1, della donna sterile che deve allietarsi rispetto a quella feconda, congiunto col tema del fuggire, risuona amaro nel compianto sulla decadenza della Romagna fatto da Guido del Duca, che si rivolge al castello di Bertinoro chiedendogli perché non fugga via, come hanno fatto i Mainardi, suoi signori, e molta altra gente per non ritrovarsi tra i malvagi, e loda “Bagnacaval, che non rifiglia”, cioè gli sterili Malvicini, riprovando invece i conti di Castrocaro e quelli di Conio, che si ostinano a generare cattivi discendenti (Purg. XIV, 112-117). Il versetto di Isaia 54, 1 – “Letare, sterilis que non paris, quia multi filii deserte magis quam eius que habet virum” – è usato qui in senso diverso, amaro ma positivo, rispetto all’Ida di Inf. XIV, 97-99, “che già fu lieta / d’acqua e di fronde” e che “or è diserta come cosa vieta”. Nel girone successivo, Dante ribadisce a Marco Lombardo che “lo mondo è ben così tutto diserto / d’ogne virtute” (Purg. XVI, 58-59).
La donna della Firenze antica rimpianta da Cacciaguida “era certa / de la sua sepultura”, sicura di non dover uscire da Firenze andando esule a morire per il mondo, e non era stata ancora “nel letto diserta”, ossia abbandonata dal marito andato in Francia a mercatare (Par. XV, 118-120).
Il tema della fuga presente ad Ap 12, 6 può connettersi con quello della fuga da Babilonia, necessaria per evitare di mescolarsi ai malvagi e di essere puniti in quanto compartecipi, che si trova in più punti dell’Apocalisse (ad esempio ad Ap 14, 9 e 18, 4).
La montagna del purgatorio possiede dunque le caratteristiche del “deserto” della Gentilità. L’aggettivo “gentile” vi ricorre sette volte (più la forma sostantivata a Purg. VI, 110), contro quattro occorrenze nell’Inferno e nessuna nel Paradiso (se si esclude l’altra forma sostantivata a Par. XX, 104). Dante vi rimane tre giorni e mezzo (la seconda cantica si chiude al meriggio del quarto giorno), cioè un periodo di tempo corrispondente ai 1260 anni della permanenza della donna nel deserto. La spiaggia che circonda in basso la montagna è “lito diserto, / che mai non vide navicar sue acque / omo, che di tornar sia poscia esperto” (Purg. I, 130-132). Questo è detto con riferimento a Ulisse, che non volle negare a sé, nella sua solitudine (“sol con un legno”), e ai suoi pochi compagni (“quella compagna / picciola da la qual non fui diserto”), l’esperienza del “mondo sanza gente”, cioè deserto fino all’arrivo di Cristo, quando la Giudea si farà selvaggia e il deserto dei Gentili fiorirà (Inf. XXVI, 100-102; 114-117). Prima di quel lido finì il viaggio dell’eroe greco: “quando n’apparve una montagna, bruna / per la distanza” (vv. 133-134). Ulisse volle sperimentare con i sensi il “mondo sanza gente”. La terra proibita alla ragione umana – alla sapienza di questo mondo che la croce avrebbe dimostrato stolta – non era solo una terra senza abitanti, l’“extra notum nobis orbem” di cui scrive Seneca (Epist. LXXXVIII), era figura della terra che sarebbe stata data ai Gentili, luogo della loro conversione a Cristo, che si sarebbe compiuta solo nel sesto stato della Chiesa. L’ultimo viaggio dell’eroe greco fu un andare sensibilmente al sesto stato, un viaggio nel tempo futuro verso un lido allora noto unicamente a Dio, andata che solo un uomo evangelico del 1300 avrebbe potuto compiere.
Non è casuale che l’incontro con Stazio, che avviene nel passaggio dal quinto al sesto girone e poi continua fino all’Eunoè, registri il massimo punto possibile di avvicinamento in terra tra la sapienza pagana e quella cristiana.
L’esegesi di Ap 12, 6, con il Carmelo trasformato in selva e la selva-deserto in giardino, contiene i fili intrecciati nel rimprovero ad Alberto d’Asburgo e al padre Rodolfo di essersi disinteressati dell’Italia “indomita e selvaggia” e di aver lasciato, trattenuti dalla cupidigia dei propri interessi in Germania, “che ’l giardin de lo ’mperio sia diserto” (Purg. VI, 103-105; il tema è ripetuto, per il regno di Boemia devastato da Alberto nel 1304, a Par. XIX, 115-117).
Ancora una variazione dei motivi del fuggire e del giardino è nelle parole di Sordello che qualificano Filippo III di Francia il quale, sconfitto dagli Aragonesi nel 1285, “morì fuggendo e disfiorando il giglio”, dove il disonore dell’insegna di Francia è assimilata alla trasformazione del giardino (il giglio) in deserto (Purg. VII, 103-105).
Il tema del fuggire il drago, nell’esegesi proprio della donna (Ap 12, 4), è da Cacciaguida usato per designare la prepotenza degli Adimari, “l’oltracotata schiatta che s’indraca / dietro a chi fugge”, ma che si fa agnello con chi mostra i denti o la borsa (Par. XVI, 115-117).
Da notare l’accostamento tra gli opposti motivi dell’impinguarsi di grazie (del Carmelo) e dell’inselvatichirsi (della Giudea) nelle parole di Tommaso d’Aquino sull’Ordine domenicano, “u’ ben s’impingua, se non si vaneggia”, ma il cui gregge “di nova vivanda / è fatto ghiotto, sì ch’esser non puote / che per diversi salti non si spanda”, cioè per lontane selve (‘salto’, nel senso di selva, è unica occorrenza nel poema, connessa, come nell’esegesi di Ap 12, 6, con l’impinguarsi). Da notare che Tommaso si trova in una ghirlanda che “s’infiora” di piante, cioè di spiriti; il “beato serto” (cioè la corona) è un rinvio mentale a un “diserto” fiorito (cfr. Par. X, 91-96, 100-102; XI, 124-126, 137-139).
[1] Combinando Apocalisse 12, 6.14 con Daniele 12, 6-7.11-12, il 1260 può essere esteso a 1290 e a 1335 anni. Il passo di Daniele 12, 11-12 – “dal tempo in cui sarà tolto il sacrificio perpetuo e sarà eretto l’abominio della desolazione ci saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e perviene a 1335 giorni” -, come ha dimostrato Guglielmo Gorni (Lettera nome numero. L’ordine delle cose in Dante, Bologna 1990, pp. 126-127), è ben conosciuto all’autore della Vita Nova. Il quale, dopo aver perduto la sua Beatrice, va lacrimando “in questa desolata cittade” e scrive ai principi della terra introducendo la lettera con il tema tratto dalle Lamentazioni del profeta Geremia: “Quomodo sedet sola civitas” (Vita Nova, 19.8 [XXX 1]). Beatrice, nata nel 1266 e morta l’8 giugno 1290, si colloca tra due numeri mistici presenti nella profezia di Daniele. Non solo il 1290, continua il Gorni, è anno-chiave, ma anche il 1335: Dante, infatti, nato nel 1265, sarebbe nel 1335 arrivato a settant’anni, ossia alla beatitudine, dopo aver effettuato il suo viaggio ultraterreno, nel 1300, a trentacinque anni (la metà di settanta che segna il colmo dell’arco della vita umana, come affermato in Convivio IV, xxiv, 3).
Tab. 7
Par. X, 91-96, 100-102Tu vuo’ saper di quai piante s’infiora
|
Par. XI, 124-126, 137-139Ma ’l suo pecuglio di nova vivanda
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio, Ium prelium)] “Et mulier”, id est ecclesia, “fugit in solitudinem”. Per solitudinem simul intelliguntur hic tria.
|
|
Inf. I, 5, 25, 29, 64; II, 62, 142; IV, 64-66esta selva selvaggia e aspra e forte ……
|
Purg. I, 118, 130-132; II, 52-53; III, 49-51; X, 20-21; XI, 13-15, 19-21Noi andavam per lo solingo piano ……
|
2. Il desiderio impossibile della ragione umana (il terzo stato)
Il terzo canto del Purgatorio registra, nella “topografia spirituale della Commedia”, parole-chiave che rinviano la memoria del lettore accorto alla dottrina del terzo dei sette stati della storia della Chiesa, prefigurati nell’Antico Testamento, così come esposta, nella Lectura dell’Olivi, aggregando la materia esegetica relativa al terzo dei vari settenari nei quali si divide l’Apocalisse.
Il terzo periodo è oggetto di uno specifico studio al quale si rinvia. Qui vengono toccate solo alcune delle numerose variazioni, semantiche e concettuali, sui temi ‘terzi’ nel corso del poema, necessarie per la comprensione di quanto interessa in Purg. III.
Segnato dal primato dell’intelletto sui sensi, realizzazione dell’uomo razionale, il terzo stato è il luogo della discrezione e dell’esperienza, al cui regime soggiace il falso e nebuloso immaginare; il luogo del sapere (la “cura sciendi”) che è “de veris et de utilibus, seu de prudentia regitiva actionum et de scientia speculativa divinorum”; è il depositario della lingua vera e della vera fede, della Scrittura che non erra, della giusta misura contro ciò che è oscuro e intorto, della bilancia che rettamente pesa la divinità del Figlio di Dio contro gli Ariani che non la ritenevano somma, coeguale e consustanziale a quella del Padre; i suoi dottori (il terzo stato è assimilato al sacramento del sacerdozio) sono perfettamente illuminati nella sapienza; sono maestri del senso morale, “mores hominum rationabiliter et modeste componens”, assimilato al ‘vino’ con il quale ardono contro i vizi e accendono all’amore delle virtù; è il tempo delle leggi e della spada che scinde le eresie e, in genere, l’errore; dell’autonomia della potestà temporale, una delle due ali della grande aquila date alla donna (la Chiesa) per vincere il drago nella terza e quarta guerra (Ap 12, 14): contiene insomma tutti gli elementi che Dante ritiene utili per conseguire la felicità su questa terra. Il terzo dei quattro animali che circondano la sede divina ad Ap 4, 6-8, quello che ha la faccia quasi di uomo, designa il senso morale, ma anche la ragione, l’impero, le leggi: “Tertium rationale et imperiosum seu legislativum”. Dei due fini proposti all’uomo dalla Provvidenza dei quali si tratta nella Monarchia, la beatitudine di questa vita e la beatitudine della vita eterna (III, xv, 7-10), il primo corrisponde alle realizzazioni del terzo stato della Chiesa secondo l’Olivi. A questo fine, al quale presiede l’Imperatore, si giunge attraverso la filosofia, seguendola nell’operare secondo le virtù morali e intellettuali: essa è speculare, nel rapporto instaurato tra la Lectura e la Commedia, al lume dei dottori della Chiesa che reggono con la ragione. All’altro fine, la beatitudine della vita eterna che spetta al papa, si perviene attraverso gli insegnamenti spirituali che trascendono la ragione umana, seguendoli nell’operare secondo le virtù teologali: a questi corrisponde la santa vita e la “pascualis refectio”, il “pastus” degli anacoreti, cui è appropriato lo stato successivo, il quarto, corrispondente all’altra ala della grande aquila data alla donna. “Spada” e “pasturale”, i “due soli” rimpianti da Marco Lombardo (Purg. XVI, 106-114) , come terzo stato (dottori) e quarto (anacoreti), possono concorrere a illuminare come soli l’orbe, ma non identificarsi.
■ “Queste cose dice Colui che possiede la rumphea”, cioè la spada, “acuta da entrambi i lati” (Ap 2, 12). Così Cristo introduce l’istruzione alla chiesa di Pergamo – la terza delle sette chiese d’Asia, alle quali scrive Giovanni nella prima visione apocalittica – presentandosi contro i pestiferi dottori dell’erronea dottrina e setta come terribile confutatore dall’incisiva dottrina e dalla sentenza di condanna della sua bocca. Dice “da entrambi i lati” sia perché scinde e taglia qualsiasi vizio senza distinzione di persone, sia perché distrugge i vizi contrari. Ario, da una parte, erra dicendo che il Figlio è sostanzialmente diviso dal Padre come fosse una sua creatura. Sabellio, dal lato opposto, afferma che il Padre e il Figlio sono la stessa persona. La fede di Cristo scinde e taglia entrambi gli errori.
Se si adunano tutti gli elementi semantici che, nei vari passi relativi al terzo stato, designano l’operare dei dottori della Chiesa e si raccolgono attorno al tema della rumphea, la ‘spada acuta’, si ottengono molte varianti al motivo del rompere, dividere e scindere. Da Ap 2, 1 (terzo esercizio, significato del nome della terza chiesa) provengono dividens cornua; frangebat et dissolvebat. Da Ap 2, 12-17 (esegesi dell’istruzione alla chiesa di Pergamo) rumphea; spata acuta; per incisivam doctrinam; scindit et resecat; contrarios errores destruit; illorum errores confundam et convincam; per prudentiam effugantem illorum nubila et errores. Da Ap 5, 1 (motivi di chiusura del terzo sigillo) infringens et reprobans. Da passi estranei al terzo stato, ma aggregabili per simmetria, provengono penetrantior (Ap 1, 16: altra identificazione di Cristo come gladius acutus); quadripertita divisio (Ap 9, 13); dilacerabunt (Ap 17, 6); lacerarent carnes eius (Ap 19, 18); lacerantes (Ap 22, 15); dispertiti (Ap 5, 9), dispersa (Ap 12, 13), (disperdere è presente in vari luoghi); evellam (Ap 2, 5); evellens (6, 8); truncate (Ap 14, 15). Le folgori, che si ripresentano in più punti del testo sacro, sono i santi quoad vitia incisivi (Ap 4, 5), oppure i fulgura … superfervidorum eloquiorum sic penetrantium et scindentium et incendentium corda (Ap 8, 5).
In alcune zone dell’Inferno questa tematica, dello scindere l’eresia che a sua volta divide, è preponderante:
1) È presente in Cerbero (Inf. VI, 18-21), che “graffia li spirti ed iscoia ed isquatra”, mentre i peccatori “de l’un de’ lati fanno a l’altro schermo” per ripararlo dalla pioggia: l’immagine dei “miseri profani” che si rivoltano spesso sul fianco rende l’essere la spada ‘acuta da entrambi i lati’. “Isquatra” ha un riferimento ad Ap 9, 13 (sesta tromba), nella “quadripertita divisio” del clero e della vita religiosa nelle sentenze contrarie operata nel terzo inizio del sesto stato, assimilata alla divisione in quattro parti delle vesti di Cristo, mentre la tunica inconsutile e indivisa designa la Chiesa spirituale. Sono questi i temi che introducono l’episodio di Ciacco, che ha come principale oggetto le divisioni di Firenze, la “città partita” e assalita da tanta discordia.
Ai prodighi, che insieme agli avari vengono “a li due cozzi” nel quarto cerchio infernale – “e d’una parte e d’altra, con grand’ urli, / voltando pesi per forza di poppa” (Inf. VII, 26-27) – sono appropriati temi del terzo stato (gli avari e i prodighi concorrono come il terzo stato dei dottori e il quarto degli anacoreti): essi, che “con misura nullo spendio ferci” (il ponderare è tema del terzo sigillo, ad Ap 6, 5), risorgeranno dal sepolcro “coi crin mozzi” a motivo della “sconoscente vita” (il discernere con l’intelletto è anch’esso proprio dei dottori; vv. 42, 53, 57), dove i “crin” sono i capelli che ad Ap 1, 14 designano la quarta perfezione di Cristo sommo pastore, cioè la moltitudine e l’ornato dei sottilissimi e spiritualissimi pensieri e affetti, oppure la pienezza dei doni dello Spirito Santo che adornano la cima della mente.
2) Nella selva dei suicidi, incarcerate nelle piante, sono punite le anime feroci che si sono separate per sé dal corpo. Virgilio invita il discepolo a troncare qualche fraschetta da una pianta per rendere “tutti monchi” i suoi pensieri che credevano le voci udite proprie di gente nascosta. Il poeta coglie un ramoscello “da un gran pruno” e il “tronco” grida: “Perché mi schiante?”, e poi, “fatto … di sangue bruno … ‘Perché mi scerpi?’” (Inf. XIII, 28-35). Dalla “scheggia rotta” escono insieme parole e sangue (vv. 43-44). Il “tronco” di Pier della Vigna parla ancora spiegando cosa avviene “quando si parte l’anima feroce / dal corpo ond’ ella stessa s’è disvelta” (vv. 91-95). I poeti, attenti alle parole del “tronco”, vengono sorpresi dal rumore provocato da due scialacquatori inseguiti da nere e bramose cagne, “nudi e graffiati, fuggendo sì forte, / che de la selva rompieno ogne rosta” (vv. 109, 115-117). Uno dei due, Iacopo da Santo Andrea, si nasconde dietro un cespuglio, ma le cagne “quel dilaceraro a brano a brano” (vv. 127-128). Il cespuglio, un fiorentino suicida, piange invano “per le rotture sanguinenti” (vv. 131-132).
3) La terza bolgia, dei simoniaci, presenta anch’essa numerose variazioni sul tema del rompere. Anticipato nella bolgia degli adulatori da Taide, “quella sozza e scapigliata fante / che là si graffia con l’unghie merdose” (Inf. XVIII, 130-131), lo si ritrova nei “fóri” della pietra livida nei quali sono confitti a testa in giù i simoniaci (Inf. XIX, 14), simili ai pozzetti del “mio bel San Giovanni”, uno dei quali venne rotto dal poeta per salvare uno che stava per annegare (vv. 19-20). Le piante dei piedi dei peccatori sono accese dalla fiamma che si muove dai calcagni alle punte e le giunture guizzano così forte “che spezzate averien ritorte e strambe” (vv. 25-27). “Là giù nel fondo foracchiato e arto” (v. 42), portato dal suo maestro presso il “rotto” dove sta come palo Niccolò III (vv. 44-45), il poeta rimane scornato, cioè confuso (che può derivare da “dividens cornua”, interpretazione di Pergamo, il nome della terza chiesa) alle parole del pontefice che crede egli sia Bonifacio VIII arrivato prima del tempo a prendere il suo posto nel foro (vv. 58-60). E nelle parole di Niccolò III rivolte al presunto Bonifacio – “Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio / per lo qual non temesti tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio?” (vv. 55-57) – è contenuto il motivo che accomuna il canto dei simoniaci a quello di Ciacco e a quello dei suicidi: dopo le divisioni e la discordia fiorentine, dopo il dividersi violento dell’anima dal proprio corpo, ecco la divisione della Chiesa, bella donna straziata per oro e argento.
4) La nona bolgia, dove pure sono puniti dei peccatori che in vita crearono divisioni, i seminatori di scandalo e di scisma, è forse la più rappresentativa della tematica. Le anime hanno tutte le membra forate o mozze (Inf. XXVIII, 19; da considerare anche il riferimento alla battaglia di Tagliacozzo al v. 17). Maometto, “rotto dal mento infin dove si trulla”, così come “non si pertugia” una botte, si dilacca (cioè ‘si divarica’, anche qui un riferimento al “dividens cornua”, espressione con cui viene interpretato il nome della terza chiesa, Pergamo); Alì è “fesso nel volto dal mento al ciuffetto” (vv. 22-33). Pier da Medicina “forata avea la gola / e tronco ’l naso infin sotto le ciglia”, con una sola orecchia (vv. 64-66); Curio sta “con la lingua tagliata ne la strozza” e il Mosca ha “l’una e l’altra man mozza, / levando i moncherin per l’aura fosca” (vv. 100-10); Bertran de Born va tenendo per le chiome il “capo tronco”, portando “partito” il proprio cervello per aver partito, cioè diviso, un padre dal figlio (vv. 121, 139-141). La vista del poeta non deve, al dire di Virgilio, soffermarsi troppo “là giù tra l’ombre triste smozzicate” (Inf. XXIX, 4-6). Il tema è presente ancora nella successiva decima bolgia, zona dove prevalgono i temi del quarto stato, nel rompersi de “lo comun rincalzo”, cioè del vicendevole appoggio di due dannati seduti che, alle parole di Virgilio, si separano per volgersi a guardare Dante vivo (vv. 97-99).
Il tema della dvisione del Padre dal Figlio operata dall’eresia ariana è in Bertran de Born, il quale spinse il figlio di Enrico II d’Inghilterra a ribellarsi al padre, dividendo persone tanto congiunte. Per “contrapasso” la sua pena consiste nell’andare portando per i capelli il proprio capo tronco, diviso dal midollo spinale che è il “suo principio” (Inf. XXVIII, 136-142). Anche gli altri dannati “de la trista greggia” dei seminatori di scandalo e di scisma puniti nella nona bolgia sono segnati dal tema della spada: compiuto il loro giro, sono infatti costretti a sottoporsi ogni volta al taglio della spada da parte di un diavolo poiché le precedenti ferite si chiudono prima di ripassargli dinanzi (vv. 37-42). Anche in questo ferire dividendo e richiudersi si può forse scorgere la presenza del motivo delle due opposte eresie, l’una di Ario che divide le persone divine, l’altra di Sabellio che le rende una sola, entrambe scisse e tagliate dalla spada ancipite.
5) Il tema della spada (la rumphea, che concorda nel suono con rompere) che scinde e taglia è appropriato a Lucifero, il quale con ognuna delle sue tre bocche “dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla” e, per maggior pena, graffia Giuda che pende dalla bocca anteriore scorticandogli il dorso, mentre gli altri due sono i traditori di Cesare, Bruto e Cassio (Inf. XXXIV, 55-60).
Nell’Inferno ci sono dunque cinque momenti che si riferiscono al terzo stato. Un’attenta analisi può dimostrare che queste cinque ‘zone’ sono precedute da altrettante nelle quali prevalgono i temi del secondo stato (dei martiri) e sono seguite da altre nelle quali prevalgono invece i temi del quarto stato (degli anacoreti o contemplativi). Questi cinque momenti coincidono con le tradizionali cinque età del mondo precedenti il primo avvento di Cristo (sesta età), cioè con l’Antico Testamento [1].
Non che questi temi del terzo stato non siano presenti altrove nella prima cantica, ma essi sono preminenti nelle predette zone. Né le zone riferite agli stati coincidono con un canto, perché l’ordine spirituale rompe quello letterale diviso per canti, cerchi, gironi, cieli. Né le predette zone mostrano esclusivamente temi del terzo stato, perché ogni stato contiene in sé temi di tutti gli altri.
Per quanto Dante distingua “con assoluta precisione teorica” gli eretici che sforzano i sacri testi dai seminatori di discordia e di scisma che “rompono la coerenza organica dell’unità della Chiesa e della pace della vita politica” [2], il confronto testuale mostra, da una parte, la quasi totale assenza dei temi del terzo stato dell’Olivi (che riguardano proprio la lotta all’eresia) nel sesto cerchio dell’Inferno [3], mentre, d’altra parte, essi sono diffusissimi altrove e prevalenti (come avviene per i temi degli altri stati) in precise zone. Nell’Inferno essi riguardano le fazioni fiorentine, i suicidi, i papi simoniaci [4], gli scismatici, i traditori di Cristo e di Cesare. Questo dividere in sostanza l’uomo, nei suoi vari aspetti, da Dio e dalla sua giustizia è assimilabile alle eresie, che divisero l’umanità di Dio dalla sua divinità, degradando la prima o confondendola con la seconda, come quelle di Ario e di Sabellio, i quali, secondo quanto dice Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole, “furon come spade a le Scritture / in render torti li diritti volti” (Par. XIII, 127-129).
Da rilevare che l’esempio delle opposte eresie di Ario e di Sabellio in materia trinitaria è recato nella Summa theologiae (I, qu. 31, a. 2). Esso è tuttavia ripreso dall’Olivi nell’esegesi della terza chiesa d’Asia (Ap 2, 12), che lo accosta al tema della spada, da collazionare con il tema del retto o torto pesare la Scrittura dall’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5): tutti motivi assenti nell’Aquinate.
■ Anche nella seconda cantica si ritrovano quei motivi tipici del rompere e del dividere propri dei dottori della Chiesa nei confronti delle eresie e dell’errore, i quali tanto segnano canti come Inf. XIII o XXVIII, che appartengono alla medesima regione tematica. In Purg. III, nel cosiddetto “antipurgatorio”, il tema della rottura è appropriato al sole, “rotto” “dinanzi a la figura” corporea del poeta, su cui si infrangono i raggi fiammeggianti; vedere il lume del sole “fesso” in terra fa fermare e indietreggiare per meraviglia la schiera degli scomunicati (vv. 16-18, 88-96). La roccia della montagna che sale è “sì erta” che “tra Lerice e Turbìa la più diserta, / la più rotta ruina è una scala, / verso di quella, agevole e aperta” (vv. 46-51; la salita, dopo che le anime hanno indicato la via, avviene “per entro ’l sasso rotto”: Purg. IV, 31; “ruina” è tema del secondo stato). Il tema si ripresenta con lo scomunicato Manfredi, che “l’un de’ cigli un colpo avea diviso” (Purg. III, 108) e mostra una ferita nella parte superiore del petto: le “due punte mortali” per le quali a Benevento ebbe “rotta la persona” (vv. 118-119).
|
■ Nel terzo girone della montagna, dove si purgano gli iracondi, nel fumo oscuro come la notte, Virgilio raccomanda a Dante di non dividersi da lui: “Guarda che da me tu non sia mozzo” (Purg. XVI, 15). Marco Lombardo riprende il tema rivolgendosi al poeta come a colui che fende il fumo col corpo e parla come se partisse, cioè dividesse, il tempo per mesi, come fanno i mortali (vv. 25-27). Le “unghie fesse”, cioè la discrezione (prerogativa dei dottori del terzo stato), non sono possedute dal pontefice, che invece congiunge la spada col pastorale (vv. 98-114: si tratta di ‘eretica’ congiunzione). Nel canto successivo si dice del rompersi dell’immaginazione estatica come frangersi di sonno (Purg. XVII, 31-33, 40-45). Il motivo del dividere (precipuo dei dottori dalla spada ancipite) compare ancora tre volte, nel giro di quattro versi, nella spiegazione data dall’“alto dottore” Virgilio circa l’ordinamento del purgatorio (vv. 109-112: nessun essere si può intendere “diviso” e per sé stante da Dio; ogni effetto, cioè ogni creatura, è “deciso”, ossia tagliato fuori, dall’odiare il primo essere; Virgilio argomenta “dividendo”, e conclude che il male che l’uomo ama è solo quello del prossimo). Nel canto successivo, chiedendo al suo dolce padre caro di dimostrargli cosa sia amore, Dante afferma: “Maestro, il mio veder s’avviva / sì nel tuo lume, ch’io discerno chiaro / quanto la tua ragion parta o descriva” (Purg. XVIII, 10-12): il chiaro lume, il discernere, il dividere argomentando razionalmente sono propri appunto dei dottori della Chiesa.
Il motivo del rompere, unito a quello del mettere in fuga (che è proprio della terza vittoria in cui i dottori mettono in fuga l’errore, ad Ap 2, 17; cfr. infra) è, nel precedente secondo girone (dove si purgano gli invidiosi), proprio delle parole di Sapìa che narra della sconfitta, nel 1269, dei ghibellini senesi da parte dei fiorentini guelfi a Colle Val d’Elsa: “Rotti fuor quivi e vòlti ne li amari / passi di fuga” (Purg. XIII, 118-119). Beatrice, vero dottore della Chiesa, volge in fuga la volpe (l’eresia) incuneatasi nel carro (Purg. XXXII, 118-123).
Fulcro del discorso di Marco Lombardo è un esempio di erronea congiunzione (che corrisponde all’eresia di Sabellio che unificò Padre e Figlio nella stessa persona, ma anche a quella di Ario che negava l’eternità e la consustanzialità del Verbo), l’unione cioè forzata della spada col pastorale, del potere temporale con quello spirituale nella persona del papa (il Padre), unico sole rimasto una volta spento l’imperatore (il Figlio), l’altro sole che mostrava la strada del mondo (Purg. XVI, 109-112). Questo punto, che richiama altri temi di rilievo, è stato trattato altrove.
La terza vittoria (la cui esegesi conclude l’istruzione data a Pergamo, la terza chiesa d’Asia) consiste nella vittoriosa ascesa al di sopra della fantasia che muove dal senso, che è causa di errore e di eresia. Questa salita avviene tramite la prudenza che mette in fuga le nebbie, gli errori e gli impulsi precipitosi e temerari. È propria dei dottori che vincono gli errori della fantasia eretica; ad essi spetta il premio del singolare apprendimento e del gusto dell’arcana sapienza di Dio. Così alla terza chiesa d’Asia (Pergamo) viene detto: “Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza lucida sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve” (Ap 2, 17). La fantasia erronea è pure il difetto che rende chiuso il terzo sigillo (ad Ap 5, 1).
I temi della fantasia e dell’errore, dalla terza vittoria, emergono con evidenza, accanto a quelli già considerati, nel terzo girone del purgatorio. Cessate le visioni estatiche di mansuetudine, che precedono l’episodio di Marco Lombardo, il poeta, tornato con l’anima “di fori / a le cose che son fuor di lei vere”, riconosce che le cose da lui viste erano “non falsi errori”, errori in quanto non esistenti nella realtà, non falsi come esperienza di visione soggettiva (Purg. XV, 115-117). Dopo l’uscita dal fumo degli iracondi (momento in cui il poeta si appella all’immaginazione del lettore, Purg. XVII, 1-9), è la volta delle visioni di ira punita. La loro descrizione è preceduta da un’apostrofe all’“imaginativa”, cioè alla fantasia, la facoltà dell’anima che media tra il sensibile e l’intelletto: chi la fa operare, si chiede il poeta, se la materia non è fornita dalle percezioni sensibili? Essa, in questo caso, viene stimolata da un lume che prende forma nel cielo, o per influsso celeste o perché mandato da Dio (Purg. XVII, 13-18). Nel caso delle visioni estatiche, pertanto, il poeta consegue la terza vittoria, cioè ascende al di sopra della fantasia che muove dal senso, causa di errore e di eresia: il lume celeste che muove l’“imaginativa” corrisponde al lume dei dottori (prologo, Notabile X). È l’“alta fantasia” (Par. XXXIII, 142), cioè la visione intellettuale che, come quella dell’Apocalisse avuta da Giovanni, non viene sminuita dal fatto di essere aiutata da figure (Ap 1, 2). È da notare, nell’apostrofe all’“imaginativa”, la presenza di un altro tema del terzo stato (la tuba dottorale: prologo, Notabile I) nel riferimento al suonar delle “mille tube” che non potrebbero impedire il rapimento dell’anima dalle impressioni del mondo esterno (l’espressione “ch’om non s’accorge” contiene il motivo dell’uomo razionale, sempre dal Notabile I). Il rapporto equivoco tra immagine vera e quella erronea (le cose vere fuori dell’anima e i “non falsi errori” all’interno) continua nelle visioni di ira punita, nell’immaginazione di Aman crocifisso, tra Assuero, Ester e il giusto Mardocheo, la quale si rompe da sola, come una bolla d’aria che viene meno al rompersi del velo d’acqua che l’avvolge (Purg. XVII, 31-33): il tema del rompere l’errore (in questo caso non falso) è proprio della terza chiesa (Pergamo), alla quale Cristo si presenta come colui che ha la rumphea, cioè la spada acuta che scinde e divide (Ap 2, 12). La fine delle visioni (vv. 40-45) corrisponde al cader giù dell’immaginare del poeta percosso nel volto dal lume dell’angelo della pace, come il sonno “si frange” (altro motivo appropriato alla chiesa di Pergamo) guizzando allorché il viso è percosso da “nova luce” (la pietruzza lucida che contiene il nome nuovo, premio della terza vittoria ad Ap 2, 17).
Ad Ap 5, 4 (nella parte radicale o proemiale della seconda visione, che è dei sette sigilli) viene descritto il pianto di Giovanni poiché nessuno è capace di aprire il libro segnato dai sette sigilli, finché Cristo, il leone della tribù di Giuda e la radice di David, gli dice di non piangere più e procede ad aprirlo (Ap 5, 5). Questo forte pianto, sostiene Olivi, è proprio dei momenti in cui i santi, inconsapevoli della ragione che permette le tribolazioni (le “pressure”) causate dalle eresie e il terrore provocato dall’imminenza dei pericoli, piangono e sospirano affinché il libro venga aperto, almeno per la parte che è consentito aprire in quel tempo.
Tre sono in particolare i periodi interessati. Il primo è il tempo degli apostoli antecedente la discesa dello Spirito Santo. Il secondo periodo è quello delle eresie, soprattutto di quella ariana. I filosofi convenuti al concilio di Nicea agitarono i corni della superbia contro la semplicità della Chiesa e impugnarono la fede cattolica con argomenti diabolici. Dall’eresia ariana nacquero altre sette, che causarono grande lutto alla Chiesa, consolato dal fiorire dei grandi dottori come Girolamo, Ilario, Ambrogio, Agostino. Il terzo periodo è quello dell’Anticristo.
Una fanciulla appare nel terzo girone del purgatorio tra le visioni di ira punita: è Lavinia che piange forte, nel lutto, la perdita di sua madre Amata, suicidatasi per ira credendo Turno morto (Purg. XVII, 34-39). Considerando che i suicidi, la cui anima feroce divide sé stessa dal proprio corpo, sono assimilati alle divisioni ereticali (Ario, condannato al concilio di Nicea, ritenne non consustanziale la persona umana di Cristo), il pianto di Lavinia per la morte della madre, della quale non comprende il motivo (“O regina, / perché per ira hai voluto esser nulla?”), esprime il dolore e il lutto della Chiesa divisa, e incorpora nel poema sacro la descrizione virgiliana: “filia prima manu floros Lavinia crinis / et roseas laniata genas” (Aen., XII, 605-606).
■ Possono dunque ritrovarsi, nella seconda cantica, due ‘zone’ o ‘regioni’ nelle quali i temi del terzo stato sono preminenti: una nell’“antipurgatorio” prima dell’apertura della porta, imperniata su Purg. III; l’altra nel terzo girone della montagna, con centro in Purg. XVI. Si tratta di zone precedute da altre che registrano la prevalenza dei temi dello stato che viene prima – il secondo (proprio dei martiri) – e seguite da quelle in cui prevalgono i temi dello stato successivo, cioè del quarto (proprio degli anacoreti).
■ Affinché non lo si creda condiscendente verso i vizi pensando che non abbia la spada a doppio taglio, Cristo fa seguire alla lode il rimprovero al vescovo della terza chiesa d’Asia di avere in Pergamo alcuni seguaci della dottrina dei Nicolaiti, assimilata alla dottrina di Balaam, che insegnò come attirare gli Israeliti all’idolatria fornicando con le figlie di Moab, cosicché mangiassero le carni immolate agli idoli. Olivi elenca quindi i casi nei quali è proibito mangiare tali carni: quando avviene in venerazione degli idoli, oppure contro la coscienza che, per il fatto che le carni sono offerte agli idoli, la mente possa essere in qualche modo contaminata; oppure allorché da ciò viene data occasione di scandalo ai più deboli, o quando ci si rende con tale atto intollerabili al collegio di quanti lo aborriscono, come avveniva fra i Giudei convertiti sia per la proibizione della legge sia per la consuetudine contraria. Nella Chiesa primitiva tale uso venne proibito ai Gentili convertiti per il pericolo di ricadere nelle colpe precedenti (Ap 2, 14-15).
|
■ A Purg. III, 16-24, la luce del sole è “rotta” dalla persona del poeta (terza chiesa, Ap 2, 12), e l’ombra rende oscura dinanzi a questi la terra (il cavallo nero all’apertura del terzo sigillo, Ap 6, 5). Vedere la propria ombra, constatando l’assenza di quella di Virgilio, provoca in Dante la paura di essere abbandonato, con la conseguente risposta della sua guida tessuta con fili tratti dal secondo stato, proprio dei martiri, che dopo aver prevalso nel canto precedente concorre ancora con il terzo. A Smirne, la seconda delle sette chiese d’Asia, Cristo dice che non deve diffidare ma anzi sperare di conseguire attraverso il martirio la vita eterna (Ap 2, 8; per più ampio esame cfr. altrove). Questo passo è da connettere con altro ad Ap 2, 10, dove Cristo conforta la medesima chiesa nell’attendere e nel sopportare in modo impavido le future passioni, dicendo: “Non temere ciò che soffrirai”, quasi volesse dire: patirai molto, ma non devi temere, perché io sarò sempre con te e ti proteggerò. Così Dante viene confortato da Virgilio a non diffidare («non diffidas … eius … confortatio … ego semper tecum ero – e ’l mio conforto: “Perché pur diffidi? … non credi tu me teco … ?”».
|
■ Come nella terza età del mondo, dopo che i Sodomiti furono sommersi nel Mar Morto e gli Egiziani nel Mar Rosso, venne data al popolo di Dio la legge, e l’ira divina fece sì che Core, Datan, Abiram e gli altri scismatici venissero inghiottiti (Numeri 16, 31-35), così nel terzo stato della Chiesa, sommersa la lussuria e l’idolatria delle genti per la morte e per il sangue di Cristo, venne data la legge costituita dai decreti ecclesiastici e dagli statuti regolari e l’ira divina ribollì sugli scismatici e sugli eretici per mezzo dei dottori, espositori della fede. Ancora (sempre, rispettivamente, nella terza età e nel terzo stato), come a causa della superba torre di Babele le lingue furono confuse e divise e la lingua prima e retta rimase nella casa di Eber e degli Ebrei, e poi, mentre le altre lingue precipitavano nell’idolatria diabolica, la fede e il culto di un solo vero Dio rimase nella casa di Abramo, così a causa della superbia di molti fedeli la lingua e la confessione della sola vera fede di Cristo venne divisa e confusa in più eresie, mentre la prima vera lingua e confessione rimase nella casa di Pietro (prologo, Notabile XIII). Dei dottori del terzo stato sono proprie la discrezione e la prudenza, acquisite con l’esperienza che viene dalle tentazioni (preminenti nel secondo stato, dei martiri), con cui si pongono a confronto le situazioni in modo da escludere quanto è stolto o erroneo (si tratta del terzo esercizio della mente esposto ad Ap 2, 1). La lingua, secondo l’interpretazione propria di Gioacchino da Fiore del “calamus” dato a Giovanni di cui si dice in apertura del capitolo XI (terza visione, sesta tromba), è la “lingua erudita” che corregge con la sua austerità i cuori degli uomini. Il “calamo simile alla verga”, con cui si misurano rettamente gli edifici o i panni – corrisponde al “duro camo / che dovria l’uom (nel senso di uomo razionale) tener dentro a sua meta” di Purg. XIV, 143-144 [5] – designa il potere di reggere, dirigere, correggere e volgere in dritta parte le bestie indomite, con discrezione, virtù e giustizia.
Esiste pertanto equivalenza tra la legge data dai dottori, l’unica vera e indivisa lingua da essi predicata e la loro autorità che regge con esperienza e discernimento la Chiesa. Tutti motivi che emergono nel colloquio con Marco Lombardo (Purg. XVI), dove le variazioni sui temi del terzo stato sono al sommo: la necessità di porre freno con legge, di avere re che discerna (vv.94-97); l’esempio della Chiesa di Roma, la quale unendo in sé la spada e il pastorale ha confuso due soli e “due reggimenti”, generando una ‘babilonia’ inversa rispetto a quella provocata nelle lingue dall’“ovra inconsummabile” cui attese “la gente di Nembròt” (vv. 127-129; cfr. Par. XXVI, 125-126). Nelle voci degli iracondi, che dicono “Agnus Dei”, “una parola in tutte era e un modo” (Purg. XVI, 7-9), ma si verifica l’incomprensione linguistica tra i due interlocutori sul “buon Gherardo” (vv. 136-138: «“O tuo parlar m’inganna, o el mi tenta”, / rispuose a me; “ché, parlandomi tosco, / par che del buon Gherardo nulla senta”»).
Il motivo della lingua vera, confessione dell’unica fede di Cristo di cui dovrebbe essere custode la casa di Pietro, sottolinea il duro rimprovero del poeta al simoniaco Niccolò III per “lo suon de le parole vere espresse” (Inf. XIX, 123). Alla stessa rosa tematica appartengono l’atteggiarsi di Dante, piegato col capo sul dannato confitto come palo nel foro della pietra, a frate confessore del “perfido assessin” (vv. 49-50); il suo restare scornato alle prime, incomprensibili parole di Niccolò che l’ha scambiato per Bonifacio VIII arrivato a prendere il suo posto prima del tempo (vv. 58-60); il riferimento a Clemente V come “pastor sanza legge” (vv. 82-84).
Con questa vera lingua Manfredi prega Dante di parlare: “ond’ io ti priego che, quando tu riedi, / vadi a mia bella figlia, genitrice / de l’onor di Cicilia e d’Aragona, / e dichi ’l vero a lei, s’altro si dice” (Purg. III, 115-117). |
In Inf. XXVIII Virgilio spiega a Maometto che Dante è ancora in vita, portato in giro per l’inferno “per dar lui esperïenza piena … e quest’ è ver così com’ io ti parlo” (vv. 46-51). Nel medesimo canto, fra i seminatori di scandalo e di scisma tagliati dalla spada di un diavolo (la spada è attributo dei dottori, che scindono l’eresia), il tema della lingua divisa prende forma di “contrapasso” in Curione, che con ardito parlare vinse l’esitazione di Cesare nel passare il Rubicone, dando avvio alla guerra civile, e che ora sta “sbigottito / con la lingua tagliata ne la strozza” (vv. 100-102). Nella bolgia dei ladri, la lingua dell’uomo che si trasforma in serpente, “ch’avëa unita e presta / prima a parlar, si fende” (Inf. XXV, 133-134) [6].
Di leggi parla Catone: “Son le leggi d’abisso così rotte? … quella legge / che fatta fu quando me n’usci’ fora” (Purg. I, 46, 89-90), nel primo caso accostando ad esse il verbo ‘rompere’, tipico della terza chiesa (Ap 2, 12: “qui habet rumpheam”) e l’aggettivo “nera” alla “valle inferna” (allusione al cavallo nero in apertura del terzo sigillo, Ap 6, 5).
■ “E il nome della stella è assenzio” (Ap 8, 11), poiché dopo la caduta dal cielo, al suono della terza tromba, la stella fu amarissima come l’assenzio e per questo restò famosa. “E molti uomini morirono nelle acque”, a causa cioè dell’erronea esposizione della Scrittura molti persero la vita della fede e della grazia per cadere in peccato mortale e nella morte eterna. Qui non parla di “terza parte degli uomini”, ma dice “molti uomini” per indicare che in tutto il mondo furono innumerevoli coloro che morirono a causa dell’eresia di Ario e degli altri eresiarchi, che in un primo tempo erano apparsi grandi stelle ardenti in cielo.
Il tema del morire nelle acque della fede erronea trova la sua metamorfosi in un episodio della propria biografia che Dante racconta in Inf. XIX, 16-21, nel canto dei simoniaci della terza bolgia, il cui ordito mostra in più punti il prevalere di fili del terzo stato. I fori della pietra in cui sono confitti i peccatori, dice il poeta, “non mi parean men ampi né maggiori / che que’ che son nel mio bel San Giovanni, / fatti per loco d’i battezzatori; / l’un de li quali, ancor non è molt’ anni, / rupp’ io per un che dentro v’annegava”. Dante, nel rompere la pietra del pozzetto battesimale per salvare dalle acque la persona che sta annegando, assume su di sé la veste del dottore che possiede la rumphea (Ap 2, 12), cioè la spada acuta da entrambi i lati, ed è terribile confutatore dell’erronea dottrina che conduce alla morte molti uomini. Quello che è forse l’unico episodio autobiografico della Commedia anticipa in tal modo le gravi parole di condanna usate nei confronti del simoniaco Niccolò III. Lo stesso pontefice, vero “figliuol de l’orsa”, conferma il tema dell’erronea interpretazione della Scrittura dicendo a Dante, da lui creduto Bonifacio VIII venuto a spingerlo più in fondo nel foro: “Di parecchi anni mi mentì lo scritto” (Inf. XIX, 54). Alla simonia sono dunque appropriati, tra molti altri, i motivi dell’eresia di Ario, e di avere avuto questa in Origene “fons et seminator errorum” (“Di sotto al capo mio son li altri tratti / che precedetter me simoneggiando”, vv. 73-74).
I “molti uomini” morti per l’errore sono ricordati due volte da Virgilio: la prima a proposito delle arche degli eresiarchi – “e molto / più che non credi son le tombe carche” (Inf. IX, 127-129) -; la seconda con le turbate parole dette in Purg. III, 34-45 nell’invitare l’“umana gente” a stare “al quia”, a non desiderare cioè di conoscere con la ragione le cose trascendenti (i limiti della ragione umana fondata sul senso, causa dell’errore, vengono sottolineati nel Notabile V del prologo), come fecero invece coloro ai quali questo desiderio inappagato è dato come pena eterna nel Limbo – “io dico d’Aristotile e di Plato / e di molt’ altri”. Ciò non significa, naturalmente, che Dante non distingua fra eretici ed erranti, ma che i motivi dei primi, recati dall’esegesi, invadono parzialmente l’ambito dei secondi. |
Il tema dell’assenzio è appropriato, in una zona come la nona bolgia dedicata al terzo stato, a Curione, il quale “con la lingua tagliata ne la strozza” ora non parla più dopo le ardite parole dette a Cesare per indurlo a varcare il Rubicone (cfr. supra), e vorrebbe non aver mai visto Rimini, terra che per lui è “veduta amara” (Inf. XXVIII, 93) [7].
■ “Ché, se potuto aveste veder tutto, / mestier non era parturir Maria” (Purg. III, 38-39).
Della donna vestita di sole, che tiene la luna sotto i piedi ed è cinta sul capo da una corona di dodici stelle (Ap 12, 1), si dice: “Era incinta e gridava partorendo e si doleva per partorire” (Ap 12, 2). Questa donna è per antonomasia la Vergine Maria genitrice di Dio; in generale designa la Chiesa, soprattutto quella primitiva. La Vergine, infatti, se concepì nell’utero del corpo e della mente Cristo, portò anche nell’utero del cuore l’intero corpo mistico di Cristo, come fosse la sua prole. Costei chiama gridando, sia col gemito dei sospiri sia col suono della predicazione, nel partorire Cristo che sarà crocifisso e che per la croce risorgerà manifestamente nella gloria del Padre, partorendo insieme con grave angustia il corpo mistico di Cristo che sarà rigenerato nella grazia e nella gloria di Dio, che è anche il Cristo che si formerà e nascerà nei cuori.
Nel girone degli avari e prodighi purganti, una voce, che si rivelerà essere quella di Ugo Capeto, propone esempi di povertà e di liberalità. È una voce che ‘chiama’ nel pianto, “come fa donna che in parturir sia”, e che loda la povertà di Maria, “unica sposa de lo Spirito Santo”, attributo che è proprio anche della Chiesa (Purg. XX, 19-24, 97-99). Nel girone successivo, i golosi piangono e cantano il salmo 50, 17, “‘Labïa mëa, Domine’ per modo / tal, che diletto e doglia parturìe” (Purg. XXIII, 10-12; cfr. Ap 10, 9, dove la passione di Cristo, equivalente agli effetti del libro dato a Giovanni, viene proposta come dolce e amara insieme).
La Vergine Maria, “chiamata in alte grida”, assistette la madre di Cacciaguida nelle doglie del parto (Par. XV, 133).
■ non ti maravigliar … non vi maravigliate
Nella terza parte della sesta visione l’angelo dice a Giovanni: “Perché ti meravigli?” (Ap 17, 7), e in tal modo designa i dottori perfetti che istruiscono i meno perfetti. Un tema che trapunta in questa zona nel rivolgersi di Virgilio al discepolo (Purg. III, 29) e alle anime degli scomunicati (v. 97) e nell’ammirare del poeta a Purg. IV, 14, 56.
[1] Nella Lectura oliviana confluiscono più periodizzazioni: quella tradizionale, delle sei età del mondo; quella dei sei tempi della triplice legge, naturale, scritta e della grazia; quella gioachimita dei tre stati generali; quella, anch’essa gioachimita e preponderante, dei sette stati della Chiesa, tutte aventi come fine i tre avventi di Cristo: nella carne, nello Spirito (cioè nei discepoli spirituali), nel giudizio. Per Cristo entrano dunque tutti i periodi della storia umana, essendo principio, mediatore e fine di essa, acqua di fonte che, nel sesto e nel settimo stato, sbocca nel lago o piscina dopo lo stretto condotto intermedio, oppure albero che si apre nelle foglie e nei frutti dopo che la linfa è passata dalla radice al tronco (prologo, Notabile VI). Nel Notabile XIII del prologo Olivi paragona i tre fini della storia umana, cioè i tre avventi di Cristo, a un grande monte con tre vette, contenente al proprio interno due grandi valli. A chi guarda dalla distanza, il monte appare uno, non trino: tale fu la prospettiva degli Ebrei che vennero prima dell’avvento di Cristo e dei profeti che non distinsero i tre fini. I cristiani che vivono nei primi cinque stati dopo la venuta di Cristo si trovano sulla prima vetta, in condizione di vedere la prima valle chiusa da due dossi: distinguono pertanto lo spazio temporale in cui, tra il primo e il secondo avvento, avviene la conversione delle genti ma non quello che sta tra il secondo avvento, proprio del sesto stato allorché verrà ucciso l’Anticristo, e l’ultimo. Coloro che si trovano a vivere nel sesto stato, o che lo vedono in spirito (come Gioacchino da Fiore, che altrove Olivi afferma aver visto per rivelazione in spirito, nella sua terza età, il sesto stato), hanno la visione compiuta, poiché trovandosi sulla mediana delle tre vette distinguono tra il primo e il terzo avvento, che alla fine dei tempi sarà segnato dalla conversione di Israele. Essi vedono chiaramente i tre fini nelle profezie, ove erano involuti, e si rendono conto che ogni novità intervenuta nel corso della storia umana è segno figurativo della mutazione e del rinnovamento operati dai tre avventi, verso i quali tutto corre.
[2] Cfr. R. MANSELLI, alla voce “seminatore” in Enciclopedia Dantesca, V, Roma 19842, p. 151.
[3] Ivi, nel canto più ermetico del poema (Inf. X), il tema centrale non è l’eresia, bensì la translatio del primato politico e della gloria della lingua: non sono i temi del terzo stato ad essere trasformati, ma quelli del primo e del sesto (le cui rispettive chiese, Efeso e Filadelfia, subentrano nel primato rispettivamente alla Sinagoga e alla chiesa del quinto stato).
[4] Tommaso d’Aquino (Summa theologiae, II/2, qu. C, a. 1) considera la simonia come una forma di eresia: “Ad primum ergo dicendum quod sicut religio consistit in quadam fidei protestatione, quam tamen interdum aliquis non habet in corde; ita etiam vitia opposita religioni habent quandam protestationem infidelitatis, licet quandoque non sit infidelitas in mente. Secundum hoc ergo, simonia haeresis dicitur secundum exteriorem protestationem: quia in hoc quod aliquis vendit donum Spiritus Sancti, quodammodo se protestatur esse dominum spiritualis doni; quod est haereticum. Sciendum tamen quod Simon Magus, praeter hoc quod ab Apostolis Spiritus Sancti gratiam ecunia emere voluit, dixit quod mundus non erat a Deo creatus, sed a quadam superna virtute: ut dicit Isidorus, in libro Etymol. [lib. VIII, cap. 5]. Et secundum hoc, inter alios haereticos Simoniaci computantur: ut patet in libro Augustini de Haeresibus”.
[5] “Camo” (freno, morso) in realtà deriva da “camus”e non da “calamus”, e come tale è nel Salmo 31, 9: “in camo et freno maxillas eorum constringe”, citato in Monarchia III, xv, 9. Ma il “calamus” di Ap 11, 1 è in realtà un “camus”, ed è accompagnato da motivi non contenuti nel Salmo 31, 9: la durezza, il discernere di colui che regge, l’uomo (razionale). Il modo con cui le citazioni dantesche dei Salmi concordano con la Lectura è mostrato in “In mensura et numero et pondere”. Nella fucina della Commedia: storia, poesia e arte della memoria (PDF), cap. 4.
[6] La lingua di Virgilio è di un reggitore: il poeta latino è colui che possiede la scienza della discrezione, in virtù della quale conosce luoghi e tempi per ammettere ed escludere i malvagi dannati, che fa a lui venire, che “adizza” a parlare e ai quali dà licenza di andar via. La sua “parola ornata” o “parlare onesto” (così dice Beatrice in Inf. II, 67, 113), con cui nel mondo scrisse “li alti versi”, corrisponde alla “lingua erudita-calamo” data a Giovanni (Ap 11, 1): è la sola che possa piegare gli “schivi” Greci; essa frena la lingua del discepolo (Inf. XXVI, 70-75), congeda in lombardo la fiamma che fascia Ulisse, fa drizzare la voce del “latino” Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 19-21). Equivale agli sproni e al freno con cui l’Imperatore dovrebbe correggere l’Italia, “costei ch’è fatta indomita e selvaggia”, dopo che la Chiesa (la “gente” che dovrebbe “esser devota”) si è impadronita della cavalcatura (Purg. VI, 91-99).
[7] Su Curione cfr. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno, 6 (Il dubbio di Cesare), tab. XXVIII-1.
Tab. 8
[LSA, cap. II, Ap 2, 12 (Ia visio, IIIa ecclesia)] Hiis autem premittuntur duo, scilicet preceptum de scribendo hec sibi et introductio Christi loquentis, cum subdit (Ap 2, 12): “Hec dicit qui habet rumpheam”, id est spatam, “ex utraque parte acutam”. Hec congruit ei, quod infra dicit: “pugnabo cum illis in gladio oris mei” (Ap 2, 16).
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 17 (IIIa victoria)] Tertia est victoriosus ascensus super phantasmata suorum sensuum, quorum sequela est causa errorum et heresum. Hic autem ascensus fit per prudentiam effugantem illorum nubila et errores ac impetus precipites et temerarios ac tempestuosos. Hoc autem competit doctoribus phantasticos hereticorum er-rores expugnantibus, quibus et competit premium singularis apprehensionis et degustationis archane sapientie Dei, de quo tertie ecclesie dicitur: “Vincenti dabo manna absconditum, et dabo ei calculum lucidum, et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo novit, nisi qui accipit” (Ap 2, 17).[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (III defectus] Tertius (defectus in nobis claudens intelligentiam huius libri) est nostre phantasie proterva et erronea cervicositas. |
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (Ia visio, IIIa ecclesia)] Tertium (exercitium) est discretio prudentie ex tempta-mentorum experientiis, et exercitiis acquisita providens conferentia et excludens stulta et erronea. […] Tertia autem commendatur de servando et confitendo fidem inter magistros erroris, in quibus quasi in cathedra pestilentie Sathanas sedet. Increpatur tamen quia ex quorundam suorum negligentia quosdam hereticos habebat. Competunt autem hec tempori tertio, scilicet doctorum. Tunc enim aliqui catholici nimis participabant cum aliquibus hereticis, quamvis ceteri essent con-stantissimi contra eos. Hec autem ecclesia congrue vocatur Pergamus, id est dividens cornua, quia superbam potentiam et scissuram hereticorum potentissime frangebat et dissolvebat.
|
Purg. XV, 115-117Quando l’anima mia tornò di fori
|
|
Inf. XII, 10-12cotal di quel burrato era la scesa;
|
Inf. XVIII, 16-18, 129-131
|
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (Ia visio, IIIa ecclesia)] […] Tertia autem commendatur de servando et confitendo fidem inter magistros erroris, in quibus quasi in cathedra pestilentie Sathanas sedet. Increpatur tamen quia ex quorundam suorum negligentia quosdam hereticos habebat. Competunt autem hec tempori tertio, scilicet doctorum. Tunc enim aliqui catholici nimis participabant cum aliquibus hereticis, quamvis ceteri essent constantissimi contra eos. Hec autem ecclesia congrue vocatur Pergamus, id est dividens cornua, quia superbam potentiam et scissuram hereticorum potentissime frangebat et dissolvebat.
|
||
Inf. VI, 18-21, 60-61 (cfr. XVIII, 131)graffia li spirti ed iscoia ed isquatra.
|
Inf. XXVIII, 17-24, 28-38, 64-66, 100-105, 121-125, 136-142………………………… e là da Tagliacozzo,
|
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (IIIa ecclesia)] Tertia autem commendatur de servando et confitendo fidem inter magistros erroris, in quibus quasi in cathedra pestilentie Sathanas sedet. Increpatur tamen quia ex quorundam suorum negligentia quosdam hereticos habebat. Competunt autem hec tempori tertio, scilicet doctorum. Tunc enim aliqui catholici nimis participabant cum aliquibus hereticis, quamvis ceteri essent constantissimi contra eos. Hec autem ecclesia congrue vocatur Pergamus, id est dividens cornua, quia superbam potentiam et scissuram hereticorum potentissime frangebat et dissolvebat.
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (IVa ecclesia)] Increpatur tamen, quia permittebat Iesabelem seducere servos suos ut fornicarentur et comessarentur de idolaticis. Solitarii enim et contemplativi negligere solent correctionem aliorum, tamquam iudicantes soli sibi esse vacandum. Quidam etiam ex eis, propter excessus contemplationis et macerationis corpore fracti, de facili solent a sociis suaderi ut indulgeant sue carni, ita quod ex hoc plus debito delicatis utantur.Inf. VII, 22-27Come fa l’onda là sovra Cariddi,
|
|
[LSA, prologus, Notabile XIII] Sicut etiam in quarta etate David, deiectis Siriis et Philisteis ceterisque hostibus suis, reduxit cum septem choris archam Dei in Iherusalem, et propter pestem populo suo immissam angelo sibi apparente statuit locum templi in monte Moria, sic in quarto statu ecclesie sub Iustiniano imperatore extirpati sunt heretici arriani de Grecia et de Africa et Italia, et paulo post sub Gregorio Magno extirpati sunt de Ispania, et propter pestem inguinariam Rome immissam ordinati sunt per Gregorium septem chori letaniarum seu rogationum, cessavitque plaga apparente angelo gladium tenente in loco qui adhuc Rome castrum sancti angeli appellatur, et restituit archam divini cultus in sede Petri ordinavitque ecclesiasticum officium sollempnius quam foret ante, sicut etiam David ordinavit officia cantorum et levitarum et pontificum sollempnius quam foret ante. |
||
Inf. VII, 22-24Come fa l’onda là sovra Cariddi,
|
Purg. X, 58-60, 64-66Dinanzi parea gente; e tutta quanta,
|
|
Tab. 9
[LSA, cap. II, Ap 2, 14-16 (Ia visio, IIIa ecclesia] Ne tamen ex hoc credat se palpaturum vitia ipsorum quasi non habeat gladium ex parte utraque scindentem, ideo subdit (Ap 2, 14-15): “Sed habeo adversum te pauca, quoniam habes illic”, scilicet in Pergamo, “tenentes doctrinam Balaam, qui docebat filios Israel edere”, de sacrificio idolorum, “et fornicari; ita habes et tu tenentes doctrinam Nicholaitarum”.
|
|
Inf. XXVIII, 34-36E tutti li altri che tu vedi qui,
|
Purg. II, 115-117, 124-133; III, 7-9Lo mio maestro e io e quella gente
|
Tab. 10
[LSA, cap. II, Ap 2, 8.10 (Ia visio, IIa ecclesia)] Hiis autem premittitur primo iussio de scribendo hec episcopo huius ecclesie. Et secundo Christi loquentis introductio, et hoc sub forma sequentibus congruente, ibi (Ap 2, 8): “Hec dicit primus et novissimus”, id est cuius eternitas antecedit et principiat omnia, et est ultra omnia etiam futura, et finit ac consumat omnia, quasi dicat: non diffidas te a tuis passionibus per me salvandum, quia ego sum omnium principium et consumator.
|
||
Purg. XV, 139, 142-143; XVI, 1-3, 13-15Noi andavam per lo vespero, attenti ……Ed ecco a poco a poco un fummo farsi
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (clausura IIIii sigilli)] Hec autem septem non solum dicuntur sigilla quia claudunt nobis librum sapientie Dei, sed etiam quia per punitivam iustitiam Dei et etiam per permissivam sunt sigillariter nobis impressa. Ipsa enim sunt caracter et imago bestie.
|
|
Tab. 11
[LSA, prologus, Notabile I] (III) Tertius (status) est confessorum seu doctorum, homini rationali appropriatus.[LSA, prologus, Notabile XIII] Sicut etiam in tertia (etate), submersis Sodomitis in mari mortuo et Egiptiis in mari rubro, data est lex populo Dei et Choree, Datan et Abiron cismaticos ceterosque de filiis Israel temptatores Dei absorbuit ira eius (Nm 16, 31-35), sic in tertio statu, luxuria et idolatria gentium per mortem et sanguinem Christi submersa, data est lex ecclesiasticorum decretorum et regularium statutorum populo Christi et contra cismaticos et hereticos efferbuit ira Dei.
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (septem virtualia exercitia)] (III) Tertium (exercitium) est discretio prudentie ex temptamentorum experientiis, et exercitiis acquisita providens conferentia et excludens stulta et erronea.[LSA, cap. XI, Ap 11, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] “Et datus est michi calamus” (Ap 11, 1). Hic ordini prefato datur potestas et discretio regendi ecclesiam illius temporis. Datio enim potestatis significatur [per] donationem calami, quo artifices domorum solent mensurare edificia sua. Discretio vero regendi sibi dari designatur, tum per regularem ipsius calami rectitudinem et mensuram, tum per hoc quod docetur quos debeat mensurare, id est regere, et quos relinquere. Dicit autem: “Et datus est michi”, supple a Deo, “calamus similis virge”, quasi dicat: non similis vacue et fragili canne seu arundini, sed potius recte et solide virge. Et certe tali communiter mensurantur panni et edificia. Per hanc autem designatur pontificalis vel magistralis seu guber-natoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei. Secundum Ioachim, calamus iste signat linguam eruditam, dicente Psalmo (Ps 44, 2): “Lingua mea calamus scribe”, qui est similis virge, quia sicut austeritate virge coarcentur iumenta indomita, ita lingue disciplina dura corda hominum corriguntur*.* Expositio, pars III, f. 145rb. |
|
Inf. XVII, 37-42Quivi ’l maestro “Acciò che tutta piena
|
Purg. I, 43-46, 85-90“Chi v’ha guidati, o che vi fu lucerna,
|
Purg. III, 112-117Poi sorridendo disse: “Io son Manfredi,
|
Purg. XVI, 19-21, 94-97, 127-141
Pur ‘Agnus Dei’ eran le loro essordia;
una parola in tutte era e un modo,
sì che parea tra esse ogne concordia.
“Onde convenne legge per fren porre;
convenne rege aver, che discernesse
de la vera cittade almen la torre.
Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? …”
“Dì oggimai che la chiesa di Roma,
per confondere in sé due reggimenti,
cade nel fango, e sé brutta e la soma”.
“O Marco mio”, diss’ io, “bene argomenti;
e or discerno perché dal retaggio
li figli di Levì furono essenti.
Ma qual Gherardo è quel che tu per saggio
di’ ch’è rimaso de la gente spenta,
in rimprovèro del secol selvaggio?”.
“O tuo parlar m’inganna, o el mi tenta”,
rispuose a me; “ché, parlandomi tosco,
par che del buon Gherardo nulla senta.
Per altro sopranome io nol conosco,
s’io nol togliessi da sua figlia Gaia.
Dio sia con voi, ché più non vegno vosco”.
Tab. 12
Tab. 13
3. Un passo fermo per l’erta montagna (il quarto stato)
La cura pastorale, che storicamente si divide in sette momenti, provvede nel terzo periodo a condurre all’esterno il gregge. Anche le età dell’uomo, severamente corrette dallo zelo, sono sette; la terza corrisponde all’adolescenza leggera e agitata dal vento dell’errore (prologo, Notabile III). Così le anime degli scomunicati “come le pecorelle escon del chiuso / a una, a due, a tre” (Purg. III, 79-80). Nel quarto periodo, la cura pastorale provvede alla pascuale refezione del gregge – il pastus -; corrisponde all’età virile, stabile e ferma (stabilis se firmantem … stans), ma difettosa nella sua pertinacia. Così nel gregge degli scomunicati, dopo le prime pecorelle che escono, “l’altre stanno / timidette atterrando l’occhio e ’l muso” (vv. 80-81). Questa tematica del quarto stato si registra con tono insistente nei versi circostanti: “fermando ’l passo … e tu ferma la spene … stetter fermi … stassi … s’arresta … restaro” (vv. 53, 66, 71-72, 83) [1].
La tematica ‘quarta’ fa segno dell’alta montagna che i due poeti devono ascendere, assimilata al quarto stato, proprio degli alti contemplativi (o anacoreti). Dalla loro altezza essi caddero (prologo, Notabile V), per cui nel canto successivo, all’inizio dell’erta salita, Virgilio ammonisce il discepolo: “Nessun tuo passo caggia; / pur su al monte dietro a me acquista” (Purg. IV, 37-38). Dante connette alla stabile fermezza del quarto stato il motivo del piede/passo, congiunzione d’altronde suggerita dall’esegesi dei piedi solidi dell’angelo di Ap 10, 1 e di quelli di Cristo simili all’oricalco (Ap 1, 15; 2, 18), designanti la perfezione della vita attiva, nella quale furono pure eccelsi i contemplativi del quarto stato, simbolo per antonomasia delle res gestae. Quando Virgilio, ai piedi della montagna, dice a Dante “e tu ferma la spene, dolce figlio” (Purg. III, 66), anticipa il volatus contemplationis che sarà descritto nel canto seguente: “ma qui convien ch’om voli; / dico con l’ale snelle e con le piume / del gran disio, di retro a quel condotto / che speranza mi dava e facea lume” (Purg. IV, 27-30) [2].
Il tema dello stare fermo, tipico del quarto stato assimilato all’età virile, si ritrova in molti luoghi del poema, sia come valore in sé, sia come oggetto di rimprovero (ad esempio “’l troppo star si vieta” a Inf. VII, 99; il “poco star” a Inf. XVII, 77; “volenci star di qua?” a Purg. XXVII, 44).
Purg. XXX inizia allorché i sette candelabri, che aprono la processione nell’Eden, si fermano. Essi sono definiti “il settentrïon del primo cielo, / che né occaso mai seppe né orto”, cioè l’Orsa dell’Empireo che, come l’Orsa terrestre (cfr. Par. XIII, 7-9), non viene mai meno e segna il cammino da percorrere. Il confronto è con l’esegesi di Ap 1, 4, dove si toccano i “sette spiriti che stanno dinanzi al suo trono”. Si precisa trattarsi dello Spirito increato, semplice per natura e settiforme per grazia, radice e forma esemplare dei sette stati della Chiesa che costituiscono l’oggetto principale del libro. Viene detto che i sette spiriti sono dinanzi al trono perché fanno stare nel cospetto di Dio e della sua sede coloro i quali ne sono pieni, secondo le parole di san Paolo ai Romani (Rm 8, 26): “è lo stesso Spirito che domanda per noi”, perché ci fa domandare (i seniori invocano l’arrivo di Beatrice) [3]. Il “settentrïon” rende ciascuno consapevole di quello che debba fare e, fermandosi, fa in modo che i ventiquattro seniori che lo seguono si volgano al carro (il carro-Chiesa militante tirato dal grifone-Cristo). I seniori si volgono al carro “come a sua pace”, e uno di loro invoca (cioè ‘postula’ per dettato interiore dello Spirito) l’arrivo di Beatrice cantando tre volte “Veni, sponsa, de Libano”, seguito da tutti gli altri.
Spirito, stare (fermo, immobile), postulare (cioè parlare per dettato interiore): dalla collazione di prologo, Notabile III (la stabile e ferma età virile) con Ap 1, 4 (stare di fronte al settiforme Spirito), 4, 3 (immutabilità di Dio giudice nella sua sede) e 8, 3 (immutabile stare della divinità di Cristo), gli elementi semantici travasano nei versi con le più singolari variazioni. Lo ‘stare’ si può analogicamente arricchire di altri motivi, come lo ‘stare fisso’, nella sesta vittoria, dell’uomo evangelico e spirituale, configurato in Cristo come una colonna nel tempio (Ap 3, 12). Questa colonna “firmiter fixa”, che sostiene gli ordini inferiori con umile semplicità (“humilis simplicitas et simplex spiritualitas”), è figurata dal settiforme Spirito: “come ’l più basso face (l’Orsa Maggiore) / qual temon gira per venire a porto, / fermo s’affisse” (Purg. XXX, 5-7). Nella salita al “dilettoso monte”, “’l piè fermo sempre era ’l più basso” (Inf. I, 30), era cioè il piede che sostiene, come una colonna, la spinta nel salire.
L’auricalcum, ad Ap 1, 15 e 2, 18, designa i piedi di Cristo, solidi e fiammeggianti nella sua vita attiva. I temi, scissi e variamente appropriati, fregiano l’episodio di Traiano: “Intorno a lui parea calcato e pieno / di cavalieri, e l’aguglie ne l’oro / sovr’ essi in vista al vento si movieno” (Purg. X, 79-81). “Calcato” fa segno anche della giustizia divina, che ‘calca’ i ribelli (Ap 19, 15), e di quella imperiale che si appresta a vendicare del figlio la vedovella. Il muoversi delle aquile al vento allude al vento dello Spirito, ad Ap 7, 1.
Le parole di Virgilio – “Or chi sa da qual man la costa cala … ditene dove la montagna giace” (Purg. III, 52, 76) mutano registro e fanno segno del quinto stato, del quale è tipico, dopo l’ardua e a lungo insostenibile solitudine dei contemplativi del periodo precedente, il pietoso condiscendere verso le moltitudini associate. Nel Notabile VII del prologo della Lectura super Apocalipsim si recano gli esempi di Cristo che condiscese agli infermi e del solitario Adamo al quale venne sottratta una forte “costa” (simbolo della solitudine austera degli anacoreti del quarto stato), che Dio nel creare Eva riempì di pietas. Più volte nel poema la “costa” della ripa infernale, o della montagna del purgatorio, che giace o che è corta o che cala o che pende, si abbina allo “scendere” in modo da far via in giù o in su, indicando la rottura della solitaria arditezza, del luogo “alpestro” a vantaggio del condiscendere pietoso, del dar via. I temi presenti nei versi di Purg. III, 49-52 – rotta, ruina, costa, cala – sono variazione di quelli già utilizzati in Inf. XII – ruina, fianco, rotta, ti cale, calar (vv. 4, 11, 27, 58, 62) -, ivi appropriati al discendere, ora invece al salire.
[1] Nei versi si intrecciano molteplici temi. Virgilio, il quale “tenendo ’l viso basso / essaminava del cammin la mente” (Purg. III, 55-56), svolge la funzione di esame circospetto propria del vescovo di Efeso, la prima chiesa d’Asia (Ap 2, 2), funzione già svolta da Minosse (Inf. V, 4-5). La schiera degli scomunicati, paragonata alle pecorelle “semplici e quete, e lo ’mperché non sanno” (Purg. III, 84), è da una parte tessuta con i temi offerti dall’esegesi del “fenum viride” (la semplicità di vita della verdeggiante Giudea ad Ap 8, 7, con un passo simmetrico ad Ap 9, 4), che a Purg. VII, 130-132 toccano anche “il re de la semplice vita”, Enrico III Plantageneto; dall’altra rinvia al non sapere proprio del vescovo di Laodicea, la settima chiesa (Ap 3, 17), nel senso positivo dell’umile riconoscimento della propria miseria, già impersonato nel villanello in principio di Inf. XXIV. A questa esegesi si riferisce anche il dar consiglio (Purg. III, 62), cioè la prudenza, significata pure dal lento muovere dei piedi delle anime verso i due poeti (vv. 58-60). I “mille passi”, come altrove nel poema il numero mille, fanno segno del millenario trattato ad Ap 20, 2-3. Gli scomunicati, i quali “si strinser tutti ai duri massi / de l’alta ripa, e stetter fermi e stretti / com’ a guardar, chi va dubbiando, stassi” (vv. 70-72), oltre ai temi del quarto stato (stetter fermi … stassi) registrano quelli del “certamen dubitationis” propri del martirio psicologico del sesto stato (si strinser … stretti … chi va dubbiando).
[2] I temi della quarta vittoria (Ap 2, 26-28) sono presenti all’inizio di Purg. IV, dove si registra la prima zona della seconda cantica dedicata ai temi del quarto stato. La quarta vittoria consiste nel vittorioso effetto, quando tutte le forze del corpo e della mente sono dedicate in modo assiduo e totale alle perfette opere di virtù, né si allentano per il lungo continuare, ma anzi intendono, si rafforzano e crescono nel salire a forti opere. Del concentrarsi dell’anima su una qualche virtù della sua potenza sensitiva, quando questa viene presa fortemente da un’impressione di diletto o di dolore, in modo da intendere solo ad essa, ha esperienza Dante udendo e ammirando Manfredi, mentre il sole sale di cinquanta gradi senza che egli se ne accorga (Purg. IV, 1-16). Il modello è il servo che da una mina (il dono della conoscenza) aveva guadagnato dieci mine, al quale Cristo dice: “avrai potere sopra dieci città” (Luca 19, 17). Così Virgilio si rivolge al discepolo nella faticosa salita al primo balzo: “Nessun tuo passo caggia; / pur su al monte dietro a me acquista” (Purg. IV, 37-38). Il premio dei forti anacoreti è la chiara intelligenza delle Scritture; più avanti, raggiunta la meta, Virgilio spiega il diverso corso del sole come appare in quel luogo, “se lo ’ntelletto tuo ben chiaro bada” (vv. 73-75). La salita mostra altri temi del quarto stato: la solitudine dei due poeti (v. 23); il desiderio di avere le ali per volare (vv. 27-30; ad Ap 12, 14 sono date alla donna due ali di una grande aquila perché voli al deserto dei Gentili, luogo per lei preparato per rimanervi tre giorni e mezzo o 1260 anni); l’uso delle mani e dei piedi (v. 33, entrambi motivi sviluppati nell’esegesi di Tiàtira, la quarta chiesa, ad Ap 2, 18: gli anacoreti eccellono anche nella vita attiva, designata dalle mani e dai piedi simili all’oricalco); il “restare” fermo, contro cui si appunta lo zelo del quarto stato (prologo, Notabile III), che si trova nell’invito di Dante al maestro affinché si fermi ad attenderlo (vv. 44-45); lo stare “sotto i piè” del balzo (v. 51), tratto dall’immagine della donna che tiene la luna sotto i piedi all’inizio della quarta visione (Ap 12, 1).
[3] Ap 1, 4 fa parte della “salutatio” di Giovanni: «Deinde specificat bonum quod eis optat, scilicet “gratia vobis et pax”. “Gratia” sumitur per respectum ad suam gratuitam originem, quia non ex debito sed gratis datur a Deo. Sumitur etiam per respectum ad formalem actum gratificandi, quia reddit nos gratos Deo. “Pax” vero sumitur per respectum ad obiectum fruibile, et ad statum quietum et finalem mentis et gratie, et ad mutuam confederationem Dei et suorum cum mente et mentis cum ipso et suis. Unde et “gratia” potest stare pro initio nondum perfecto, “pax” vero pro eius fine perfecto». Di qui il volgersi dei seniori al carro “come a sua pace”.
Tab. 14
Inf. II, 121-123; III, 76-78Dunque: che è? perché, perché restai,
|
Purg. IV, 37-43Ed elli a me: “Nessun tuo passo caggia;
|
|
[LSA, prologus, Notabile III] […] Patet enim hoc de primo dono. Nam pastoralis cura insistit primo ovium propagationi (I). Secundo earum defensioni ab imbribus et lupis et consimilibus (II). Tertio earum directioni seu deductioni ad exteriora (III). Quarto earum pascuali refectioni (IV). Quinto morborum et morbidarum medicinali extirpationi (V). Sexto ipsarum plene reformationi (VI). Septimo ipsarum in suum ovile reductioni et recollectioni (VII). […]
|
||
Inf. VII, 97-99, 109-111; XXIX, 1-3, 13-15Or discendiamo omai a maggior pieta;
|
Purg. IV, 44-45, 58-60, 103-105“O dolce padre, volgiti e rimira
|
|
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7; IIIa visio, Ia tuba] Per “terram” autem significatur hic Iudea, quia sicut terra habitabilis fuit segregata a mari et discooperta aquis, ut posset homo habitare in ea et ut ipsa ad usum hominis posset fructificare et herbas et arbores fructiferas ferre, sic Deus mare infidelium nationum et gentium separaverat a terra et plebe Iudeorum, ut quiete colerent Deum et facerent fructum bonorum operum, et ut essent ibi simplices in bono virentes ut herbe, et perfecti essent ut arbores grandes [et] solide et fructuose. […] Per “fenum” vero “viride” desi-gnantur simpliciores et imbecilliores, qui per bonam vitam virides videbantur et forsitan prius erant.
|
[LSA, cap. IX, Ap 9, 4 (IIIa visio, Va tuba)] 1. Deinde de cohibitione subdit: “et preceptum est illis ne lederent fenum terre neque omn[e] viride neque omnem arborem, nisi tantum homines, qui non habent signum Dei in frontibus suis” (Ap 9, 4). Per “fenum” et per ceteras herbas virentes designantur simplices, humilitatem et virorem fidei et vite honeste et pie servantes; per “arbores” vero perfectos et solidiores facientes magnos fructus.Purg. VII, 130-132Vedete il re de la semplice vita
|
|
Tab. 15
[LSA, prologus, Notabile III] Item (zelus) est septiformis prout fertur contra quorundam ecclesie primitive fatuam infantiam (I), ac deinde contra pueritiam inexpertam (II), et tertio contra adolescentiam levem et in omnem ventum erroris agitatam (III), et quarto contra pertinaciam quasi in loco virilis et stabilis etatis se firmantem (IV), quinto contra senectutem remissam (V), sexto contra senium decrepitum ac frigidum [et] defluxum (VI), septimo contra mortis exitum desperatum et sui oblitum (VII). Item est septiformis quia est contra initium mali intrinsecum (I) et extrinsecum (II); et contra medium terminum, scilicet ascendens (III) stans (IV) et declinans (V); et contra terminum intrinsecum (VI) et extrinsecum (VII).
|
|
Purg. XXX, 1-12Quando il settentrïon del primo cielo,
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 12 (VIa victoria)] Sumendo tamen templum pro ecclesia sustentata a perfectis quasi a columpnis eius, tunc sub alio respectu significatur duplex ingressus. Quia enim et Deum et eius cultum intramus primo per professionis statum, per quem quis in Dei ecclesia et religione statuitur; secundo per contemplationis actum, per quem Deus cum suis operibus apprehenditur, idcirco primum significat per immobilem statum columpne in templo; secundum vero per inscriptionem divinorum in animo.
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 18 (Ia visio, IVa ecclesia)] Hiis autem premittitur preceptum de scribendo hec huic episcopo et eius ecclesie et introductio Christi loquentis, cum subdit: “Hec dicit Filius hominis, qui habet oculos tamquam flamma[m] ignis et pedes eius similes auricalco” (Ap 2, 18). Quia episcopus et ecclesia cui Christus loquitur laudatur de fervore fidei et caritatis, et de humilitate ministrandi et patientie, et de perfectione operum sive vite active, ideo respectu primi Christus proponitur ut habens oculos lucidos et ardentes sicut est flamma ignis, respectu vero secundi proponitur ut Filius hominis, respectu vero tertii proponitur habere pedes similes auricalco, id est eri nitidissimo quod est simillimum auro. Correspondet etiam hoc quarto statui anachoritarum humillimorum et valde activorum multumque contemplativorum. Dictum est enim supra quod per Filium hominis designatur humilitas, per oculos autem flammeos fervor et lux contem-plationis ignite, per pedes vero similes auricalco perfectio vite active. |
[LSA, cap. I, Ap 1, 15 (radix Ie visionis)] Sexta (perfectio summo pastori condecens) est sue active seu suorum operum perfectio, unde subdit: “et pedes eius similes auricalco, sicut in camino ardenti” (Ap 1, 15). Auricalcum est es nitidissimum valde simile auro, et cum est in camino ardenti est ignitissimum ac scintillans liquefactum. Christi autem corporales seu exteriores et inferiores actus et processus fuerunt et sunt igne caritatis Dei et nostri ignitissimi et exemplariter scintillantes et etiam, dum hic viveret, in camino temptationum probati et auro sue interne et superne caritatis simillimi.
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 1 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Item per hos quattuor ventos intelliguntur omnes spirationes Spiritus Sancti, secundum illud Ezechielis XXXVII°: “A quattuor ventis veni, spiritus, et insuffla super interfectos istos et reviviscant” (Ez 37, 9).Inf. XIV, 13-15, 34-36Lo spazzo era una rena arida e spessa,
|
[LSA, cap. XIX, Ap 19, 15 (VIa visio)] “Et ipse reget eas in virga ferrea”, id est in inflexibili iustitia. Qui enim nolunt converti blanditiis et humilitate necesse est ut tunc temporis sentiant severitatem et fortitudinem discipline eius, ut saltem sero subi-ciantur sceptro ipsius. Rebelles autem sentient furorem eius, unde subditur: “Et ipse calcat torcular vini furoris ire Dei omnipotentis”, id est ipse premit impios penis mortiferis quas Deus Trinitas quasi furibundus et iratus propinat eis. |
4. L’insegna dei naviganti
Secondo Gioacchino da Fiore (quinto libro della Concordia, citato ad Ap 12, 14), come nel Genesi le opere del quarto giorno – il sole, la luna e le stelle – vengono chiamate “segni e tempi e giorni e anni” (Gn 1, 14), così nella quarta visione dell’Apocalisse la donna che sta nel cielo ed è adornata dal sole, dalla luna e dalle stelle viene detta “grande segno” (Ap 12, 1) e il suo tempo, che è il quarto della Chiesa, viene distinto in “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” (Ap 12, 14) [1]. Il medesimo tema compare nel quarto sigillo dell’Antico Testamento, nel quale Elia, Eliseo e i figli dei profeti furono come il sole, la luna e le stelle ed Elia venne nascosto lontano da Gezabele per tre anni e mezzo, periodo nel quale la pioggia della predicazione venne sottratta alla gente peccatrice (3 Rg 18, 1; Lc 4, 25; Jc 5, 17). Gioacchino si domanda per quale motivo questo numero mistico compaia sempre nel quarto tempo, e risponde che il quarto è il mediano di sette tempi, connesso ai tre tempi precedenti e agli altrettanti che seguono e di tutti partecipante. La donna – la Vergine che portò Cristo nel ventre, lo partorì e lo allattò – sta a significare la Chiesa delle vergini, madre e nutrice dei fedeli, formata da uomini e donne dalla giusta vita che, come le stelle del cielo segnano il cammino ai naviganti, sono segni ed esempi agli altri, in modo che sappiano dove andare coloro che li considerano.
Pier Damiani, nel settimo cielo, di Saturno (Par. XXI), si rivolge a Dante in tre riprese, corrispondenti a tre domande del poeta: la prima volta ai versi 61-72, per spiegare perché in quel cielo non si oda, come negli altri, il dolce canto e per chiarire cosa l’abbia spinto a scendere i gradini della scala santa per porsi vicino a lui; la seconda volta ai versi 79-102, per spiegare l’imperscrutabilità dei disegni provvidenziali; la terza volta – “il terzo sermo” – ricomincia ai versi 106-111 e continua ai versi 112-135. Questa divisione dei versi comporta che il ‘primo sermo’ occupi 12 versi (“un tempo”), il secondo 24 versi (“due tempi”, il doppio del primo) e l’inizio del “terzo sermo” 6 versi (“metà di un tempo”), per complessivi 42 versi, che corrispondono alle generazioni gioachimite. La restante parte del “terzo sermo” (vv. 112-135) occupa 24 versi che, aggiunti ai 6 del suo cominciare, fanno 30 (il numero che, moltiplicato per 42, dà 1260). Parlando de “lo abisso de l’etterno statuto … che da ogne creata vista è scisso”, Pier Damiani raccomanda al poeta di riferire al mondo mortale quanto gli viene detto, “sì che non presumma / a tanto segno più mover li piedi”, espressione che traduce il “signum magnum” della quarta visione apocalittica e del quarto tempo della Chiesa diviso in “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” (vv. 97-99). Nel cielo di Saturno si mostrano gli spiriti dei contemplativi e numerosi sono i temi provenienti dal quarto stato. Il cielo di Saturno, settimo in progressione, è anche il quarto a partire dal cielo del Sole, la prima delle “alte rote” a non venire toccata dal cono d’ombra proveniente dalla terra (cfr. Topografia spirituale della “Commedia”).
Le anime degli scomunicati riconciliati con Dio in fin di vita, che errano ai piedi della montagna trenta volte il tempo vissuto nella scomunica (cfr. infra), fanno “insegna” coi dossi delle mani a Dante e a Virgilio in modo che tornino indietro procedendo innanzi a loro: sono la trasposizione degli uomini e delle donne dalla giusta vita di cui parla Gioacchino da Fiore che, come le stelle del cielo, segnano il cammino ai naviganti (Purg. III, 100-102; cfr. VI, 60; XI, 42 e la similitudine dei delfini a Inf. XXII, 19-24). Il tema della Chiesa madre e nutrice dei fedeli è appropriato a Costanza, la “bella figlia” di Manfredi “genitrice / de l’onor di Cicilia e d’Aragona”, di Federico e Giacomo, alla quale il re svevo prega il poeta di andare, una volta ritornato al mondo, per spiegare il suo vero stato, che è di salvezza, nonostante la condanna della Chiesa (Purg. III, 114-117). Nell’espressione “bella figlia” è contenuto anche il tema della bellezza, che nell’esegesi del quinto stato definisce la Chiesa, la quale è come una regina ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei vari doni e nelle varie grazie delle diverse membra (cfr. infra). |
La precedente illuminazione di Virgilio – “de la divina fiamma / onde sono allumati più di mille” – ha operato su Stazio, al cui ardore poetico furono seme le faville dell’Eneide, “la qual mamma / fummi, e fummi nutrice, poetando” (Purg. XXI, 94-99). Stazio fascia Virgilio con parte del panno della Vergine madre e nutrice da Ap 12, 14 come, nel canto successivo, Virgilio farà con Omero, “quel Greco / che le Muse lattar più ch’altri mai” (Purg. XXII, 100-105).
La donna – la Vergine che portò Cristo nel ventre, lo partorì e lo allattò – sta a significare la Chiesa delle vergini, madre e nutrice dei fedeli, formata da uomini e donne dalla giusta vita i quali, come le stelle del cielo segnano il cammino ai naviganti, sono segni ed esempi agli altri, in modo che sappiano dove andare coloro che li considerano (considerare equivale a contemplare, come dice Tommaso d’Aquino di Riccardo di San Vittore, “che a considerar fu più che viro”, Par. X, 131-132).
Nella citazione di Gioacchino da Fiore, è proprio di Ulisse il ‘considerare’ dei naviganti, l’essere stato ‘sottratto’ da Circe “più d’un anno là presso a Gaeta, / prima che sì Enëa la nomasse”, prima cioè che Enea desse a quel luogo il nome della sua nutrice, che ripete pertanto, prefigurandolo, il tema della Chiesa nutrice dei fedeli (Inf. XXVI, 90-93, 118). La ‘sottrazione’ di Ulisse (unico caso del verbo ‘sottrarre’ nel poema), che corrisponde alla sottrazione della salutare pioggia della predicazione (cfr. il potere dato ai due testimoni, Enoch ed Elia, ad Ap 11, 6), concorda con l’immagine del greco dottore esperto dei vizi umani [2].
[1] Queste parole sono riferite al periodo (si tratta, nella quarta visione, dell’esegesi congiunta della terza e della quarta guerra) in cui la donna (la Chiesa) venne nutrita lontano dal serpente nel deserto dei Gentili, il luogo preparatole da Dio come suo, e dove le vennero date due ali di una grande aquila (Ap 12, 14; cfr. infra). Su tale inciso, secondo Olivi, Gioacchino da Fiore ha fondato tutta la sua Concordia. L’espressione indica un periodo di tre anni e mezzo, formati da quarantadue mesi (12 mesi x 3 anni + 6 mesi) nei quali i trenta giorni dei singoli mesi corrispondono a trenta anni: si ha così una permanenza della donna nel deserto di 1260 anni. “Tempus” sta per un anno, “tempora” per due anni e “dimidium temporis” per sei mesi. I “due anni” derivano dal duale greco, lingua nella quale scrisse Giovanni. Questo numero compare anche ad Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra) per indicare il periodo in cui la donna venne nutrita nel deserto (dove era fuggita dalla durezza dei Giudei), mentre in Daniele 7, 24-25 si dice che il re undicesimo distruggerà i santi dell’Altissimo che gli saranno dati in mano “per un tempo, due tempi e la metà di un tempo” e in Daniele 12, 6-7 che “fra un tempo, due tempi e la metà di un tempo si compiranno tutte queste cose meravigliose”.
[2] Si può anche intendere la ‘sottrazione’ di Ulisse come speculare a quella di Elia: questi fu sottratto a Gezabele, quello fu sottratto da Circe “più d’un anno”. La figura di Gezabele, moglie di Achab re di Israele e fautrice dei quattrocento profeti di Baal, svolge un ruolo importante nell’istruzione data a Tiàtira, quarta delle sette chiese d’Asia alle quali scrive Giovanni nella prima visione apocalittica (Ap 2, 18-25). I temi che le vengono appropriati (concentrati attorno all’ipocrisia falsa e seducente) subiscono multiformi variazioni nei versi. Cfr. Il sesto sigillo, 7c (La «bestia saracena»), tab. LIII-LV; Dante e Gioacchino da Fiore, VIII, cap. 5.
Tab. 16
Par. X, 130-132Vedi oltre fiammeggiar l’ardente spiro
|
Inf. XXVI, 90-93, 118 …………………………Quando
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 14 (IVa visio, III-IVum prelium)] Nota etiam quod, secundum Ioachim, libro V° Concordie, sicut de opere quarte diei, scilicet de sole et luna et stellis, dicitur quod “sint in signa et tempora et dies et annos” (Gn 1, 14), sic in quarta visione huius libri, in qua describitur mulier in celo existens et adornata sole et luna et stellis, proponitur fuisse in “signum magnum” et distinguitur tempus eius in “tempus et tempora”, signanterque hoc reperitur ubi agitur de quarto statu ecclesie. Consimiliter enim sub quarto signaculo Veteris Testamenti fuit Helias et Heliseus et filii prophetarum quasi sol et luna et stelle, ubi et idem numerus ponitur, scilicet tres anni et dimidius absconsionis Helie a facie Iesabel (3 Rg 17-19) et subtractionis pluvie a gente peccatrice *. Et subdit: «quare hic misterialis numerus potius est scriptus sub quarto tempore quam sub alio, nisi quia quartum tempus est tribus temporibus precedentibus totidemque sequentibus veluti ex equo coniunctum, ita ut utrique participare videatur? Nempe et ecclesia ipsa virginum, que in muliere significatur, est mater et nutrix fidelium, quia Virgo portavit Christum in utero, Virgo peperit et lactavit?** Tales etiam viri et mulieres in signa fuere, quia sicut stelle celi in signa sunt navigantibus, ita et vita iustorum est in exemplum fidelium data, ut sciant quo ire debeant omnes qui considerant eos»***. Hec Ioachim.* Concordia, V 1, c. 12; Patschovsky 3, pp. 556, 12-18, 22-25; 557, 1-3.** Ibid., p. 557, 15-21.*** Ibid., p. 556, 19-22. |
|
Inf. XXII, 10-12, 19-24né già con sì diversa cennamella
|
Purg. III, 100-102, 112-117Così ’l maestro; e quella gente degna
|
5. Volgersi e ricordare nel “libro della vita”
Purg. III, 103-106E un di loro incominciò: “Chiunque
|
■ Ap 1, 10-12 (et audivi post me vocem magnam tamquam tubae dicentis: quod vides scribe in libro … et conversus sum ut viderem vocem quae loquebatur mecum).
All’inizio della parte narrativa della sua esposizione, Giovanni precisa sette circostanze generali e degne di lode proprie delle visioni successivamente descritte. La sesta circostanza (Ap 1, 10-11) consiste nel fatto che all’evangelista viene ingiunto solennemente di scrivere la visione e di inviarla alle chiese d’Asia, come intendesse dire: non per mia iniziativa, ma per speciale comando divino ho scritto ed invio. Per cui soggiunge: “E udii una voce dietro di me”.
Il comando proviene da una voce udita dietro le spalle. Stare dietro può essere inteso nel senso che Giovanni era in quel momento dedito alla quiete della contemplazione, lontano dalla sollecitudine derivante dall’attività pastorale, che aveva lasciata alle spalle: la voce dunque lo richiama dalla visione delle cose supreme, che gli stanno dinanzi, alla cura d’anime che sta dietro (è l’interpretazione di Riccardo di San Vittore). Oppure (è l’interpretazione di Olivi), considerando che le cose che ci stanno dietro sono invisibili e pertanto superiori, si può intendere che Giovanni ascolti una voce alle spalle che lo elevi e riconduca verso l’alto, mentre con il volto è rivolto in basso, verso cose inferiori. In questo senso, nel Vangelo di Giovanni, si dice che Maria Maddalena, volta indietro, vide Gesù (Jo 20, 14).
Ricevuto il comando di scrivere il libro e di mandarlo alle sette chiese, delle quali viene specificato il nome, Giovanni si volta per vedere attentamente da quale persona provenga la voce (è la settima circostanza, Ap 1, 12). Questo vedere può essere inteso come un apprendimento totale: sebbene abbia già appreso la voce al momento del suo primo ascolto, ora si converte più fortemente ad essa per apprenderla in modo compiuto.
Il parlare dietro le spalle, di cui si tratta ad Ap 1, 10-12, è anche quello che proviene dalla propria guida, che sta dietro come custode e conducitrice della sua cavalcatura, per cui in Ezechiele si dice: “uno spirito mi sollevò e dietro a me udii una voce” (Ez 3, 12). È “vox magna”, in quanto il suono esce da una persona di grande virtù, eccitando mirabilmente Giovanni; è “come una tromba”, sia perché esorta alla guerra contro i vizi e contro l’esercito dei reprobi, sia perché invita a banchetti di gloria. La tromba designa inoltre la predicazione, la quale fu come occulta fino al tempo dei profeti, più manifesta nel periodo che va da Isaia a Giovanni Battista e infine consumata nel coro degli apostoli, per cui, secondo san Paolo ai Romani, “in ogni terra uscì il loro suono” (Rm 10, 18; cfr. Ps 18, 5).
L’esegesi di questi passi si mostra fondamentale per le agnizioni nel poema; è inoltre collazionabile con altri luoghi parzialmente analoghi.
Per due terzine risuona la voce del magnanimo Farinata, che invita Dante a restare presso di lui (Inf. X, 22-27). Nella terzina successiva si precisa trattarsi di un suono improvviso, uscente “d’una de l’arche”, che suscita timore nell’ascoltatore, per cui questi si stringe alla sua guida (vv. 28-30). I temi derivano per una parte da Ap 11, 11 (sesta tromba), dove si tratta della sùbita resurrezione dei due testimoni uccisi dall’Anticristo, i quali, eretti e vivi, suscitano timore negli osservatori; per l’altra da Ap 14, 17 (settima guerra), dove l’angelo con la falce esce repentinamente dagli ‘arcani’ dei cieli verso gli uomini, scuotendone di timore i cuori.
Al richiamo del maestro Dante si volge, e come Maria vide Cristo risorto, così vede “Farinata che s’è dritto”, anch’egli a suo modo risorto, e questo vedere, come dice Virgilio, è “tutto” dalla cintola in su (Inf. X, 31-33). Anche Dante, come Giovanni, ha prima ascoltato il suono della “vox magna” e si è poi voltato per apprenderla in modo totale. Una conversione a chi parla che si ripete nel volgere il viso verso Manfredi (Purg. III, 103-106) e verso la voce di Beatrice che nell’Eden chiama il poeta con il proprio nome (Purg. XXX, 62-63). Un nome pregno di significato, che qui viene specificato come vengono specificati i nomi delle sette chiese alle quali deve essere inviata la visione.
Il tema della guida (“dux”) che richiama e riconduce si trova ancora verso la fine dell’episodio di Farinata (Inf. X, 115). Un altro esempio è nell’incontro con Beatrice, che asserisce di aver cercato, dopo la morte, di richiamare Dante a sé ispirandolo in sogno o altrimenti (Purg. XXX, 133-135). Connesso con il tema del volgere le spalle, si presenta nelle spiegazioni date a Brunetto Latini sul viaggio: l’avere il poeta volto le spalle alla selva per salire il “dilettoso monte” (che può corrispondere al lasciarsi alle spalle da parte di Giovanni le sollecitudini pastorali per dedicarsi alla contemplazione), il ricondurre a casa da parte di Virgilio (Inf. XV, 52-54).
I motivi da Ap 1, 10-12 si ritrovano, con varia appropriazione, in apertura di Purg. V (prima il riferimento alla guida, poi il rivolgersi al suono di parole che provengono da dietro) e di Purg. XXI (l’apparizione di Stazio, paragonata a quella di Cristo risorto ai due discepoli sulla via di Emmaus, ma commista con quella di Cristo alla Maddalena perché Virgilio e Dante sentono la voce alle spalle e subitamente si volgono).
Matelda rimprovera il poeta intento a guardare con sì ardente affetto le vive luci dei candelabri aurei, che nell’Eden aprono la processione, da non considerare quello che viene dietro ad essi, cioè i ventiquattro seniori (Purg. XXIX, 61-65; non c’è il tema del volgersi ma, in variazione, quello dello stare dietro e della guida).
■ Ap 20, 12: “Furono aperti dei libri. Fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto nel libro, secondo le proprie opere”. Secondo Agostino (De civitate Dei, XX, 14), i libri indicati per prima designano i santi del Vecchio e del Nuovo Testamento, poiché i malvagi verranno giudicati nel paragone coi giusti. Secondo Riccardo di San Vittore, i “morti” qui designano i reprobi. Il “libro della vita”, secondo Agostino, è una forza divina per cui avviene che a ciascuno siano richiamate alla memoria tutte le proprie opere, buone o cattive, e che siano riconosciute con mirabile celerità dall’intuito della mente in modo che la consapevolezza accusi o scusi la coscienza. Questa forza divina ha preso il nome di “libro” perché in essa, in un certo senso, si legge tutto quello che per suo mezzo viene ricordato. Olivi aggiunge che con l’apertura dei libri viene pure designato l’aprirsi della coscienza o della memoria di tutti coloro che devono essere giudicati, che avviene con una forza o un potere divino che riconduce ogni cosa alla chiara e quasi visibile memoria, e anzi dimostra in modo tanto chiaro a tutti ogni bene o male operato da chiunque, come se tutti vedessero leggendo nei cuori di ciascuno ogni male o bene mai compiuto. Il “libro della vita” è l’increata scienza e giustizia divina, che allora verrà aperto alla vista di tutti i predestinati alla vita eterna per il conferimento finale della gloria, e verrà aperto ai dannati per l’evidenza dell’effetto esteriore e del giudizio. Secondo questo libro, cioè secondo l’eterna e inerrabile scienza divina, verranno principalmente giudicati tutti; secondariamente lo saranno attraverso il giudizio della propria coscienza e di tutte le altre che saranno contestimoni, lo vogliano o meno, insieme al principale libro della giustizia di Dio. Pertanto i libri indicati per prima si porranno come accusatori e testimoni, il “libro della vita” si porrà come “sententiator”, cioè come quello che contiene ed esprime le sentenze giudiziarie e le loro motivazioni.
Il “libro della vita” di Ap 20, 12 è il “libro che ’l preterito rassegna” di Par. XXIII, 54 e, assai più indietro nel tempo, il “libro della mia memoria” nell’incipit della Vita Nova. Nel cielo di Giove, dove albergano gli spiriti giusti, il tema dell’apertura del “libro della vita”, in cui ciascuno verrà giudicato secondo le proprie opere, è premesso dall’aquila all’elenco dei cattivi principi cristiani: tutti, anche l’infedele etiope o persiano, potranno condannare i falsi cristiani, “come vedranno quel volume aperto / nel qual si scrivon tutti suoi dispregi”, nel quale si potranno vedere le opere di costoro, come quella per cui Alberto d’Asburgo renderà nel 1304 “diserto” il regno di Boemia (Par. XIX, 112-117).
La forza che promana dal libro della vita, che apre la coscienza e la memoria, è la stessa lingua, la “chiara favella” del poeta che fa “sovvenir del mondo antico” il ruffiano Venedico dei Caccianemici incontrato nella prima bolgia; la parlata bolognese dei tanti che piangono con lui è testimonianza fedele che fa tornare alla mente l’avarizia dei propri concittadini (Inf. XVIII, 52-63).
Che il fiume della memoria possa scendere chiaro, “se tosto grazia resolva le schiume / di vostra coscïenza”, è augurio che Dante rivolge agli invidiosi che si purgano nel secondo girone della montagna (Purg. XIII, 88-90).
Nelle metamorfosi poetiche, il passo relativo alla settima visione è quasi sempre collazionato con altri simmetrici. È il caso di Ap 3, 3, dove il vescovo di Sardi (la quinta delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione) viene invitato a ricordare con la mente quale fosse la “prima grazia” e il suo stato e a conservarla, cioè la grazia ricevuta da Dio e ascoltata tramite la predicazione evangelica. Da quanto gli viene detto, si deduce che costui era tanto intorpidito nell’ozio da non ricordare più il primo stato di grazia e di perfezione, che fu di edenica bellezza e di pienezza stellare. Se non si ravvedrà vigilando, il giudizio divino verrà da lui come un ladro [1] (cfr. anche infra). La tematica offerta insieme da Ap 3, 3 e Ap 20, 12 percorre, in Inf. XI, la descrizione dell’ordinamento dell’inferno data da Virgilio: aver chiaro qualcosa alla mente – «E io: “Maestro, assai chiara procede / la tua ragione …”» (vv. 67-68) -; richiamare alla mente o ricordarsi – “Non ti rimembra di quelle parole … e rechiti a la mente … se tu ti rechi a mente / lo Genesì dal principio” (vv. 79, 86, 106-107: è da notare l’espressione “dal principio”, che allude alla “prima grazia” o al “bel principio”) -; il verso “Se tu riguardi ben questa sentenza” (v. 85), che richiama il “libro della vita” contenente le sentenze giudiziarie, che in questo caso coincide con l’Etica nicomachea, la quale “pertratta / le tre disposizion che ’l ciel non vole, / incontenenza, malizia e la matta / bestialitade” (vv. 80-84). È un esempio, fra i tanti, di conciliazione della filosofia di Aristotele con la teologia dell’Olivi, entrambe presenti alla mente del poeta.
I motivi dell’“apertio conscientiarum” e del ricondurre alla memoria ritornano di fronte al muro di fuoco che il poeta deve attraversare prima di compiere l’ascesa della montagna sulla cui cima è Beatrice (Purg. XXVII, 16-42). Dante, spaventato, sta “pur fermo e contra coscïenza”. Virgilio prima gli richiama alla mente l’averlo già guidato salvo nel volo sulla groppa di Gerione – “Ricorditi, ricorditi!” -, poi gli fa il nome di Beatrice, dalla quale il fuoco lo separa, e allora, “udendo il nome / che ne la mente sempre mi rampolla”, la durezza del poeta si fa molle, e si apre come si aprirono gli occhi morenti di Piramo al nome di Tisbe. Nei versi si riscontra, congiunto con quelli di Ap 20, 12, il tema del riguardare con la mente proprio della quinta chiesa (Ap 3, 3).
Beatrice, nell’accingersi a spiegare “come giusta vendetta giustamente / punita fosse”, come cioè la giusta vendetta divina del peccato originale, operata per mezzo dei Giudei che crocifissero Cristo, fosse poi punita negli stessi Giudei con la distruzione di Gerusalemme compiuta da Tito, parla tramite i motivi del “libro della vita”, che esprime l’inerrabile scienza divina e contiene le sentenze della sua giustizia: “Secondo mio infallibile avviso / … ché le mie parole / di gran sentenza ti faran presente” (Par. VII, 19-24).
La congiunzione dei due gruppi tematici (ripensare a quanto ascoltato, revocare alla mente e vedere) si mostra nel parlare di Tommaso d’Aquino, in fine di Par. XI (vv. 133-139) e nella conclusione del suo discorso (Par. XIII, 130-132, 139-142), dove è citato, dall’esegesi di Ap 20, 12, l’invito di san Paolo ai Corinzi ad essere prudenti nel giudicare (1 Cor, 4, 5), citazione ripresa dall’aquila nel cielo di Giove (Par. XX, 133-135).
Si mostra, ancora, in Par. XXIII, 46-54, quando Beatrice dice a Dante di guardarla: «“Apri li occhi e riguarda qual son io (la prima grazia da Ap 3, 3); / tu hai vedute cose, che possente / se’ fatto a sostener lo riso mio”. / Io era come quei che si risente / di visïone oblita (rende l’essere “torpens” di Ap 3, 3) e che s’ingegna / indarno di ridurlasi a la mente (si insinua il tema del ricondurre alla mente da Ap 20, 12), / quand’ io udi’ questa proferta, degna / di tanto grato, che mai non si stingue / del libro che ’l preterito rassegna (cioè il libro della vita, tema principale di Ap 20, 12)».
Un’altra variazione è a Par. XXVIII, 10-12: “così la mia memoria si ricorda (tema del libro della vita) / ch’io feci riguardando ne’ belli occhi / onde a pigliarmi fece Amor la corda” (tema del “principium pulchritudinis”, secondo l’interpretazione del nome Sardi, la quinta chiesa d’Asia). Il tema del libro della vita è poi appropriato al Primo Mobile, definito equivocamente, sfera corporale girante e anche libro, “quel volume” (v. 14).
■ Un terzo gruppo tematico si aggiunge ad Ap 20, 12 (il libro della vita) e 3, 3 (il ricordare del torpido vescovo di Sardi). Si tratta dell’esegesi di Ap 1, 10-12 – il volgersi di Giovanni all’ascolto di una voce come una grande tromba -, sopra considerata.
Volgersi (Ap 1, 10), porre mente a un ‘prima’ (Ap 3, 3), vedere il mai visto (Ap 20, 12, con accentuazione dell’avverbio unquam / unqua, unquanco, unque, mai) sono variamente e liberamente appropriati: dalle quattro stelle viste sul “lito diserto” del purgatorio (Purg. I, 22-24) al volgersi verso Manfredi (Purg. III, 103-106, 109-110), dall’incontro con Ciacco (Inf. VI, 43-45) a quello con le anime purganti dei morti per violenza (Purg. V, 49, 133) all’agnizione di Forese, con il successivo, grave reciproco aprirsi delle coscienze (Purg. XXIII, 40-48, 115-117)[2]; dalla risposta data a Virgilio a Purg. IV, 76-78, dopo la spiegazione sull’essere Gerusalemme e il purgatorio agli antipodi, a quella data a Beatrice a Purg. XXXIII, 91-93, segnata dall’oblio indotto dall’aver bevuto l’acqua del Lete; all’appello al lettore in principio di Purg. XVII; all’incontro con Piccarda, dove il ricordare un ‘prima’ (i “primi concetti”, corrispondenti alla “prima grazia”) è reso più lento dal divino che li trasmuta (Par. III, 47-49, 58-63; cfr. infra).
Si tratta solo di alcuni punti, tutti suscettibili di sviluppo. Ad esempio, nell’incontro con Forese, i temi sopra citati si intrecciano con quelli provenienti dall’esegesi di Ap 9, 16-17 (terza visione, sesta tromba), dove si distingue tra l’ascoltare il numero dei cavalieri e il vedere i cavalli dell’esercito sciolto al suono della sesta tromba, nel senso che l’ascoltare viene riferito ai più sapienti (i cavalieri), mentre il vedere alle plebi sensuali (i cavalli), perché con l’udito percepiamo ciò che è sottile, segreto e intelligibile senza vederlo o palparlo. Così Dante riconosce Forese, disseccato nella pelle dalla fame e dalla sete che lo purgano del peccato di gola, solo attraverso la voce udita – “mai non l’avrei riconosciuto al viso” -: l’essere ‘sottile’, appropriato alla magrezza di Forese, partecipa del tema dell’apprendimento con l’udito di ciò che è più sottile e segreto (Purg. XXIII, 43-45, 61-63). Forese è paragonato nel suo dipartirsi a un cavaliere (Purg. XXIV, 94-97); al suono della sesta tromba vengono seccate le acque del fiume Eufrate, cioè di quanto è umano e babilonico (Ap 9, 14).
[1] Sull’esegesi di Ap 3, 3 cfr. Il sesto sigillo, cap. 2b.
[2] Considerato il contesto del panno esegetico, maggior senso assume, rispetto a quanto affermato dal Petrocchi, la variante “coscienza” al v. 47.
Tab. 17
Tab. 18
Inf. XVIII, 52-63Ed elli a me: “Mal volontier lo dico;
|
Par. XIX, 112-117Che poran dir li Perse a’ vostri regi,
|
[LSA, cap. XX, Ap 20, 12 (VIIa visio)] Tertio describitur apertio librorum secundum quos sunt iudicandi, cum subdit: “Et libri aperti sunt, et alius liber apertus est, qui est liber vite; et iudicati sunt mortui ex hiis que scripta erant in libro, secundum opera [ipsorum]”.
|
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 3 (Ia visio, Va ecclesia)] “In mente ergo habe” (Ap 3, 3), id est attente recogita, “qualiter acceperis”, scilicet a Deo priorem gratiam, “et audieris”, ab homine scilicet per predicationem evangelicam, “et serva”, scilicet illa que per predicationem audisti et per influxum gratie a Deo primitus accepisti. Vel recogita qualiter per proprium consensum accepisti fidem et gratiam et statum eius, prout a me et a ceteris tibi predicantibus audivisti. “Et serva” ea “et penitentiam age”, scilicet de tuis malis, quasi dicat: si digne recogitaveris gratiam tibi prius impensam et qualiter prius accepisti eandem, servabis eam et penitentiam ages.
|
Par. XI, 133-139; XIII, 130-132, 139-142Or, se le mie parole non son fioche,
|
Purg. XXVII, 22, 33, 37-42Ricorditi, ricorditi! ………E io pur fermo e contra coscïenza.Come al nome di Tisbe aperse il ciglio
|
Par. XXIII, 46-54“Apri li occhi e riguarda qual son io;
|
Tab. 19
[LSA, cap. I, Ap 1, 10.12 (VI-VIIa circumstantia visionum)] Sexta circumstantia est sollempnis iussio sibi facta ut visiones has sollempniter scribat et septem ecclesiis Asie mittat, quasi dicat: non meo motu, sed Dei speciali iussu hec scripsi et mitto. Unde subdit: “et audivi post me vocem” (Ap 1, 10).
|
||
[LSA, cap. III, Ap 3, 3 (Ia visio, Va ecclesia)] “In mente ergo habe” (Ap 3, 3), id est attente recogita, “qualiter acceperis”, scilicet a Deo priorem gratiam, “et audieris”, ab homine scilicet per predicationem evangelicam, “et serva”, scilicet illa que per predicationem audisti et per influxum gratie a Deo primitus accepisti. Vel recogita qualiter per proprium consensum accepisti fidem et gratiam et statum eius, prout a me et a ceteris tibi predicantibus audivisti. “Et serva” ea “et penitentiam age”, scilicet de tuis malis, quasi dicat: si digne recogitaveris gratiam tibi prius impensam et qualiter prius accepisti eandem, servabis eam et penitentiam ages.
|
[LSA, cap. XX, Ap 20, 12 (VIIa visio)] “Liber” autem “vite”, secundum Augustinum, idem est «quedam vis divina, qua fiet ut unicuique cuncta opera sua bona vel mala in memoriam revocentur et mentis intuitu mira celeritate cernantur, ut scientia accuset vel excuset conscientiam. Que quidem vis divina libri nomen accepit, quia in ea quodammodo legitur quicquid ea faciente recolitur»*.
|
|
Inf. VI, 43-45E io a lui: “L’angoscia che tu hai
|
Purg. I, 22-24I’ mi volsi a man destra, e puosi mente
|
|
Purg. III, 103-106, 109-111E un di loro incominciò: “Chiunque
|
Purg. IV, 76-78
“Certo, maestro mio”, diss’ io, “unquanco
non vid’ io chiaro sì com’ io discerno
là dove mio ingegno parea manco …”
Purg. V, 49-50, 133
Guarda s’alcun di noi unqua vedesti,
sì che di lui di là novella porti
ricorditi di me, che son la Pia
Purg. XXIII, 40-48, 61-63, 115-117
ed ecco del profondo de la testa
volse a me li occhi un’ombra e guardò fiso;
poi gridò forte: “Qual grazia m’è questa?”.
Mai non l’avrei riconosciuto al viso;
ma ne la voce sua mi fu palese
ciò che l’aspetto in sé avea conquiso.
Questa favilla tutta mi raccese
mia conoscenza a la cangiata labbia, coscienza
e ravvisai la faccia di Forese.
Ed elli a me: “De l’etterno consiglio
cade vertù ne l’acqua e ne la pianta
rimasa dietro, ond’ io sì m’assottiglio”.
Per ch’io a lui: “Se tu riduci a mente
qual fosti meco, e qual io teco fui,
ancor fia grave il memorar presente”.
6. Poi sorridendo disse: “Io son Manfredi …”
“Quel ‘sorridendo’ […] è un’espressione vista, nella creazione del personaggio: una espressione di regalità, consapevole, naturalmente, consapevole e perciò serenamente distaccata. Il sorriso, quel sorriso, fa lontane le piaghe della fine violenta […]” [1]. Il sorriso rinvia a una delle pagine più alte della Lectura, all’esegesi del volto di Cristo che irradia, nel sesto stato, più luce e più rivelazione della Scrittura (Ap 1, 16), i cui temi si registrano in molti luoghi del poema e percorrono tutta la terza cantica. Questa esegesi è stata compiutamente esaminata altrove.
[1] Frugoni, Il canto III del “Purgatorio”, pp. 105-106 [287-288].
7. Bellezza e nobiltà
Biondo era e bello … vadi a mia bella figlia
Ad Ap 3, 3 il vescovo di Sardi, la quinta chiesa d’Asia, viene invitato a ricordare con la mente quale fosse la “prima grazia” e il suo stato e a conservarla, cioè la grazia ricevuta da Dio e ascoltata tramite la predicazione evangelica. Da quanto gli viene detto, si deduce che costui era tanto intorpidito nell’ozio da non ricordare più il primo stato di grazia e di perfezione. Se non si ravvedrà vigilando, il giudizio divino verrà da lui come un ladro. Cos’è questo ‘prima’ che il vescovo di Sardi viene invitato a ripensare? Sta nel suo nome, Sardi, interpretato come “principio di bellezza”, sia perché nei pochi rimasti integri consegue la singolare gloria della bellezza, essendo cosa ardua e difficile mantenersi mondi tra tanta lussuria, sia per lo zelo mostrato dai primi istitutori del quinto stato. Costoro ordinarono le diverse membra e i diversi offici dei propri collegi con una regola ispirata all’unità ma anche condiscendente in modo proporzionato alle membra stesse, conseguendo una forma di mirabile bellezza che è propria della Chiesa, la quale è come una regina ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei vari doni e nelle varie grazie delle diverse membra (ad Ap 2, 1).
Cristo si propone alla chiesa di Sardi (Ap 3, 1) come “colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle”, possiede cioè lo spirito increato di Dio, semplice per natura e settiforme nella grazia partecipata e corrispondente ai sette stati della Chiesa, e insieme ‘tiene’ (cioè ha in sua potestà) i prelati di tutte le chiese, designati con le “sette stelle”. Questa universalità di spiriti, doni, stelle, rettori, offici viene proposta perché il quinto stato si pone come generale rispetto ai precedenti, affinché il vescovo della quinta chiesa abbia chiaro che tali doni erano stati preparati dal divino provvedere per lui e per la sua discendenza nel caso fossero risultati degni. Il quinto stato, che è assimilato alla Chiesa romana (storicamente inizia con l’incoronazione di Carlo Magno o con il soccorso recato da suo padre Pipino al papa contro i Longobardi; dura circa cinquecento anni, cioè perviene fino al 1300), fu dunque bello nel suo principio, in cui ebbe la pienezza delle perfezioni, condiscendente secondo le esigenze delle moltitudini e del vivere associato rispetto all’arduo, alto e solitario stato degli anacoreti che lo precedette, ma si è poi corrotto per rilassatezza, tanto che il suo vescovo ha una fama usurpata di essere buono. Così, secondo Riccardo di San Vittore, l’interpretazione di Sardi come “principio di bellezza” significa che essa ha avuto solo il principio buono, ma non anche la fine. Il vescovo di Sardi viene pertanto invitato a ricordare con la mente quale fosse la “prima grazia” e a conservarla (Ap 3, 3). Bisogna anche aggiungere che, proprio per questa rilassatezza, il primato del quinto stato viene traslato al sesto, stato del nuovo avvento di Cristo nei discepoli di Francesco, come il primato della vecchia Sinagoga venne traslato alla Chiesa di Cristo e degli apostoli (questa “translatio”, applicata da Dante alla propria poetica rispetto a quella che si “ritenne / di qua dal dolce stil novo” [Purg. XXIV, 49-63], e in generale a “la gloria de la lingua” [Purg. XI, 97-99], assume tale importanza da richiedere una trattazione separata).
Il tema della bellezza, unito ad altri del quinto stato nel suo inizio – condiscendere, contemperare, esser mondo, il mirabile variare – percorre in Purg. XXVIII la descrizione dell’Eden, al quale, in quanto luogo di felicità dell’umana radice da esso poi sbandita, si addice il significato della chiesa di Sardi come “principium pulchritudinis”: la “divina foresta spessa e viva” che tempera agli occhi lo splendore del nuovo giorno, l’acqua monda del Lete, il mirabile variare dei “freschi mai”, cioè dei rami fioriti; l’apparizione della “bella donna”, il volgersi di Matelda come vergine che “avvalli” con condiscendenza gli occhi onesti.
Ricordare ciò che venne ‘prima’, congiunto con il tema della bellezza degli inizi di uno stato poi corrottosi, si trasforma nel ricordo di quella che per i poeti antichi fu “l’età de l’oro e suo stato felice” (Purg. XXVIII, 139-144), de “lo secol primo, quant’ oro fu bello”, di cui dice la voce entro le fronde dell’albero che taglia la strada sulla soglia del sesto girone della montagna (Purg. XXII, 148-150). Così l’apparizione di Matelda nell’Eden fa ricordare a Dante quale era Proserpina allorché, rapita da Plutone, perdette la “prima-vera”, cioè i fiori raccolti assimilati alla prima grazia (Purg. XXVIII, 49-51; da notare la corrispondenza tra “qualiter” e “qual era”). È questo un uso della parola “primavera” che Dante ha già proposto nella Vita Nova, applicandola a Monna Vanna, la donna del suo “primo amico” Guido Cavalcanti, la quale nell’incedere viene prima della sua donna, Monna Bice, come Giovanni Battista venne prima di Cristo. Nella figura di Matelda la presenza del “perpetuum ver” della regione di Enna di cui canta Ovidio nelle Metamorfosi (V, 391) è innegabile ma, come sempre nel poema, qualunque ricordo classico si armonizza con la teologia che lo consacra. Matelda è creazione di fantasia, non legata ad alcun personaggio storico (anche se non può non ricordare Monna Vanna: Matelda precede nel poema l’avvento di Beatrice). La bella donna è vestita, oltre che con quello qui esaminato, con altri temi offerti dalla Lectura. Notabile è che i versi “Quelli ch’anticamente poetaro / l’età de l’oro e suo stato felice”, di cui dice Matelda, corrispondano nella prosa a “fidem et gratiam et statum eius, prout a me et a ceteris tibi predicantibus audivisti”: gli antichi poeti, antesignani dei predicatori della fede e di un prossimo novum saeculum nella storia della Chiesa, sono forse l’espressione più alta raggiunta da Dante nello sforzo di conciliare la “felicitas” aristotelica con il Cristianesimo.
Prefigurazione di Matelda è Lia (la vita attiva), sognata da Dante poco prima dell’alba del “novo giorno” in cui gli appaiono Matelda e poi Beatrice: le sono appropriati i motivi del ‘prima’, riferito al raggiare di Venere nella montagna, e della bellezza (Purg. XXVII, 94-99).
Ricordare un ‘prima’ bello che non si ritrova più perché mutato in meglio si verifica nel riconoscimento di Piccarda. Nel rivelarsi, la donna invita il poeta a ricordare con mente attenta i “primi concetti” che ebbe di lei, cioè la prima immagine conosciuta in terra, e Dante replica che questi “primi” sono tanto trasfigurati dallo splendore divino da non avergli consentito un immediato riconoscimento senza l’aiuto delle parole del suo interlocutore (Par. III, 47-49, 58-63).
Il ricordare (‘porre mente’) e la bellezza sono motivi congiunti anche nell’incontro con Manfredi: “pon mente … biondo era e bello … vadi a mia bella figlia” (Purg. III, 103-108, 115-116). Le prerogative della Chiesa, edenica nel suo principio, sono estese alle curie regali.
Un altro esempio di un ‘prima’ legato a uno stato di innocenza originaria, con l’inserimento del tema del vegliare proposto al vescovo di Sardi ma con l’esclusione del ritornare alla mente, è l’immagine della donna fiorentina del tempo antico rimpianto da Cacciaguida, che vegliava la culla usando il giocoso linguaggio infantile, “l’idïoma / che prima i padri e le madri trastulla” (Par. XV, 121-123; vegliare è motivo proprio dello stesso Cacciaguida, v. 64). Il “bello / viver di cittadini” della Firenze antica è assimilato alla vita dell’uomo nell’Eden, bella nei suoi inizi e poi corrottasi (vv. 130-131).
Il discendere (tema tipico del quinto stato) e la bellezza sono nella Lavagna, la “fiumana bella” che “intra Sïestri e Chiaveri s’adima”, vantata da Adriano V, tardo nella conversione come il quinto vescovo (Purg. XIX, 100-101, 106: si è appunto nel ‘quinto’ girone della montagna).
Belacqua, il pigro liutaio “che mostra sé più negligente / che se pigrizia fosse sua serocchia”, nel momento in cui si volge a Dante e a Virgilio “puose mente”, cioè riguardò con la mente come deve fare l’intorpidito vescovo di Sardi (Purg. IV, 109-112); fu anch’egli tardivo nella conversione (v. 132).
Biondo era e bello e di gentile aspetto
■ La sede divina descritta nella seconda visione apocalittica – i cui temi sono appropriati agli “spiriti magni”, che stanno nel nobile castello del Limbo – è circondata dall’iride, simile allo smeraldo, cioè alla gemma incomparabilmente più verde (Ap 4, 3). In essa il colore verde supera in intensità quello delle erbe e delle fronde e impregna l’aria ripercossa, riempie gli occhi al solo sguardo e non lo sazia, tanto è grazioso a vedersi. Per quanto il colore verde sia più appariscente e grazioso, l’iride ha vari colori, secondo la densità o rarità della nube acquosa percossa dai raggi del sole: nella densa è rosso, nella più densa ceruleo (verde e nero, è il colore del mare profondo) oppure di colore livido oppure purpureo (commisto di nero e rosso), nella densissima nero; nella rara verde, nella più rara croceo, nella rarissima bianco [1]. L’iride designa la grazia che preesiste causalmente ed esemplarmente in Dio e che si diffonde in giro a ornamento della sede della Chiesa celeste e subceleste: essa ha il colore della fiamma per la carità, il nero o il livido per l’umiltà, il verde per la sobrietà, il bianco per la chiarezza che proviene dalla sapienza.
Il tema dello smeraldo che impregna l’aria intorno di color verde fa parte della spiegazione che Matelda dà sull’origine del vento che spira nel Paradiso terrestre (Purg. XXVIII, 103-120). L’aria si muove in cerchio con il Primo Mobile (la “prima volta”, che corrisponde all’essere “in circuitu”) e percuote l’alta selva (l’“alta eminentia” della sede) facendone stormire le fronde, cosicché le piante impregnano del loro seme l’aria che lo diffonde nell’altra terra, cioè nel mondo abitato dagli uomini, il quale, secondo disposizione, concepisce e produce da diversi semi diverse piante [2]. Anche se nessun colore viene indicato, non è difficile scorgere in questo circuire dell’aria a percuotere la selva e nel suo secondo girare, impregnata di riflesso dai semi delle piante percosse che essa diffonde, un valore assai simile a quello dell’iride, multiforme grazia che preesiste in Dio causa ed esempio e da lui emana su tutta la sede celeste e subceleste attorno alla quale gira.
Una variazione dei temi dell’iride è nella spiegazione che Stazio dà dei corpi aerei, per cui l’aria che circonda l’anima assume la figura in essa impressa dalla virtù formativa che raggia intorno, come l’aria pregna di umidità, riflettendo i raggi del sole, si adorna dei colori dell’iride (Purg. XXV, 88-96).
L’iride, del quale dice Matelda senza nominarlo, è esplicitato nel corso della successiva processione, allorché le sette fiammelle dei candelabri, quasi “tratti pennelli”, lasciano “dietro a sé l’aere dipinto … sì che lì sopra rimanea distinto / di sette liste, tutte in quei colori / onde fa l’arco il Sole e Delia il cinto”, colori che designano, come nell’esegesi della sede divina, i sette doni dello Spirito (Purg. XXIX, 73-78).
Sempre nel Paradiso terrestre, di smeraldo sembrano fatte le carni e le ossa della speranza, seconda delle tre donne che vengono danzando dalla destra ruota del carro, simboleggianti le virtù teologali (Purg. XXIX, 124-125). “Li smeraldi / ond’ Amor già ti trasse le sue armi” sono gli occhi di Beatrice, ai quali viene condotto il poeta dalle quattro virtù cardinali (Purg. XXXI, 115-117). In questo caso il significato dello smeraldo proprio dell’iride (saziare lo sguardo con il grazioso verdeggiare) si accompagna ai motivi che appartengono al diaspro, sia ad Ap 4, 3 (riferiti a colui che siede) come nei passi simmetrici ad Ap 21, 11-12 (riferiti al lume della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione). Il diaspro incorpora in modo fermo e incancellabile, al modo di uno specchio, la luce, come la città celeste e i cuori dei beati incorporano la luce che è gloriosa forma e immagine di Dio (Ap 21, 11). Così gli “occhi rilucenti” di Beatrice stanno saldi sul grifone-Cristo che li irradia e lo riflettono “come in lo specchio il sol” (Purg. XXXI, 119-123). Il diaspro sta a indicare la solida virtù dei santi che difendono la Chiesa contro i nemici (sono il muro della città celeste, Ap 21, 12), ed è a questo tipo di armi, promotrici di virtù, che alludono gli strali di Amore.
Il colore livido della pietra compare nel secondo girone del purgatorio, dove gli invidiosi ‘siedono’ con manti anch’essi color pietra (il manto è tema della terza perfezione di Cristo come sommo pastore, Ap 1, 13). La durezza, che è motivo appropriato alla pietra, si stempera nella compassione del poeta allorché si rende conto della pena che li affligge (Purg. XIII, 8-9, 47-48, 52-54).
Nella bolgia dei ladri, “livido e nero (altro colore dell’iride) come gran di pepe” è il serpentello (Francesco dei Cavalcanti) che trafigge Buoso (Inf. XXV, 84).
I colori dell’iride si ritrovano pure nei tre gradini che precedono la porta del purgatorio: bianco il primo come marmo pulito e terso da specchiarvisi (cfr. Ap 21, 11), il secondo nero di pietra “ruvida e arsiccia”, di porfido fiammeggiante come sangue il terzo. L’angelo che siede “in su la soglia” sembrava a Dante “pietra di diamante”, come Colui che siede “quasi sub specie regis sedentis super solium” sembrava a Giovanni pietra di diaspro (Purg. IX, 94-105).
■ L’apocalittica sede divina, circondata dai colori dell’iride fra i quali prevale il verde, si invera nella valletta dove siedono i principi negligenti. Verdi in veste percossa da verdi penne sono i due angeli che scendono con due spade tronche e prive di punte per mettere in fuga il serpente (Purg. VIII, 28-30); il loro capo biondo (v. 34) fa segno dei colori dell’iride, in particolare del croceo, che è il colore delle spighe mature. Sordello conduce Virgilio e Dante fra le ombre giù nella valle, perché “grazïoso fia lor vedervi assai” (v. 45): nessun colore è più grazioso alla vista del verde.
Intorno alla verdeggiante sede siedono ventiquattro seniori – si tratta dei “nobili assessori” di Dio -; secondo Gioacchino da Fiore, dodici sono ‘gentili’ (gli apostoli per i quali la Chiesa delle genti entrò in Cristo), dodici sono i futuri ‘evangelici’ che convertiranno Israele e l’orbe intero [3]. Le ombre che siedono nella valletta sono un “essercito gentile” (v. 22); fra esse Dante incontra Nino Visconti, “giudice Nin gentil” (v. 53); la giustizia è attributo di Colui che siede (Ap 4, 3).
Nel purgatorio, “regno” dei Gentili, Manfredi attende di transitare per la “porta di san Pietro”. “Biondo era e bello e di gentile aspetto” (Purg. III, 107). Se i primi due aggettivi si rispecchiano nelle testimonianze delle fonti contemporanee, Ricordano Malispini e Saba Malaspina, e il ritmo dell’endecasillabo muove dalla descrizione di Davide unto da Samuele [1 Sm (1Rg) 16, 12], il terzo aggettivo “è tutto dantesco” [4]. Dante poteva concordare tutti e tre con l’esegesi apocalittica di Olivi. “Bello” corrisponde al bel principio di Sardi, la quinta chiesa dalla pienezza stellare (Ap 2, 1), tema di cui si fregiano luoghi e personaggi del poema, dall’“Italia bella” a Matelda, la “bella donna” che nell’Eden rammenta al poeta “l’età de l’oro e suo stato felice”; alla Firenze antica, “così bello / viver di cittadini”, come rimpiange Cacciaguida. La bellezza nell’esegesi appartiene alla Chiesa, nel poema è diffusa su più soggetti, non escluse le aule regie.
Il colore biondo si registra nella sede del soglio divino circuita dall’iride: fra i diversi colori, gli si avvicina il croceo, giallo oro (Ap 4, 2-3). Sulla sede il verde si staglia più degli altri colori: esso accompagna Manfredi in vita (“mentre che la speranza ha fior del verde”) e in morte (“di fuor del Regno, quasi lungo ’l Verde”).
Il trono divino è circondato dai seggi dei ventiquattro seniori, dodici dei quali designano i dodici apostoli dei Gentili; essi sono nobili dalle bianche stole con auree corone sul capo. Con la nobiltà gentile della sede divina, che ha già fornito panno per gli “spiriti magni” che albergano nel “nobile castello” del Limbo, concorda l’aspetto “gentile” di Manfredi.
Viene in tal modo reso sacro quanto affermato nel De vulgari eloquentia I, xii, 4, di Federico II e del suo “benegenitus” Manfredi, “illustres heroes”, i quali avevano fatto in modo che quanti erano nobili di cuore e dotati di grazie aderissero loro e, poiché la sede del trono regale era la Sicilia, tutto ciò che gli Italiani di animo eccellente producevano a quel tempo vedeva dapprima la luce in quella reggia e di conseguenza quanto è stato finora prodotto in volgare viene chiamato siciliano, “nec posteri nostri permutare valebunt”. I posteri hanno poi mutato questa sentenza, ma il ricordo di quei magnanimi vive ancora nel poema.
[1] Cfr. UGUCCIONE DA PISA, Derivationes, E 112 [3-5], edizione critica princeps a cura di E. Cecchini, II, Firenze 2004 (Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini, II, Serie I, 6), p. 390: “Et nota quod iris nichil aliud est quam nubes soli opposita, radiis solis multipliciter informata; ea enim est natura luminosi corporis ut semper in oppositam partem radios dirigat; sol ergo, cum sit luminosum corpus, radios suos mittit in partem oppositam, in qua quandoque nubem invenit que in una sui parte est densa, in alia densior, in alia densissima, item in aliqua sui parte est rara, in alia rarior, in alia rarissima. In illa que est densa solares radii, tamquam in utre conclusi, rubrum colorem faciunt, in densiori ceruleum, in densissima nigrum; item in rara faciunt viridem, in rariori croceum, in rarissima album; et ita, secundum maiorem densitatem illius nubis, magis accedit ad colores nigredini affines, secundum maiorem raritatem magis accedit ad colores albedini affines. Preterea nubes illa quoddam corpus est compositum ex quattuor elementis et aquosum, que, radiis solaribus accensa, a quattuor elementis et quadripertitum contrahit colorem, ab igne rubrum, ab aere ceruleum sive lucidum vel purpureum, ab aqua viridem, a terra nigrum”.
[2] L’Eden è figura del quinto stato nel suo bel principio, dotato della pienezza delle stelle e dei vari doni dello Spirito, assimilato alla quinta chiesa d’Asia, Sardi, che fu già “principium pulchritudinis”. Al quinto vescovo e alla sua semenza gli stellari doni dello Spirito sono preparati da Dio, qualora si mantengano degni.
[3] Sono dodici i personaggi nominati con i quali comunicano Virgilio o Dante prima di entrare per la “porta di san Pietro”: Catone, Casella, Manfredi, Belacqua, Iacopo del Cassero, Buonconte da Montefeltro, Pia, Sordello, Nino Visconti, Corrado Malaspina, Lucia, angelo portiere. Se si escludono Virgilio e Stazio, sono dodici gli interlocutori diretti nominati nei sette gironi della montagna: Omberto Aldobrandesco, Oderisi da Gubbio, Sapia senese, Guido del Duca, Marco Lombardo, l’abate di San Zeno, Adriano V, Ugo Capeto, Forese Donati, Bonagiunta da Lucca, Guido Guinizzelli, Arnaut Daniel.
[4] FRUGONI, Il canto III del “Purgatorio”, p. 96 [278].
Tab. 20
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (Va ecclesia)] Vocatur autem congrue hec ecclesia Sardis, id est principium pulchritudinis, tum quia in suis paucis incoinquinatis habet singularem gloriam pulchritudinis, quia difficillimum et arduissimum est inter tot suorum luxuriantes se omnino servare mundum; tum quia primi institutores quinti status fuerunt in se et in suis omnis munditie singulares zelatores, suorumque collegiorum regularis institutio, diversa membra et officia conectens et secundum suas proportiones ordinans sub regula unitatis condescendente proportioni membrorum, habet mire pulchritudinis formam toti generali ecclesie competentem, que est sicut regina aurea veste unitive caritatis ornata et in variis donis et gratiis diversorum membrorum circumdata varietate.[LSA, cap. III, Ap 3, 3 (Ia visio, Va ecclesia)] “In mente ergo habe” (Ap 3, 3), id est attente recogita, “qualiter acceperis”, scilicet a Deo priorem gratiam, “et audieris”, ab homine scilicet per predicationem evangelicam, “et serva”, scilicet illa que per predicationem audisti et per influxum gratie a Deo primitus accepisti. Vel recogita qualiter per proprium consensum accepisti fidem et gratiam et statum eius, prout a me et a ceteris tibi predicantibus audivisti. “Et serva” ea “et penitentiam age”, scilicet de tuis malis, quasi dicat: si digne recogitaveris gratiam tibi prius impensam et qualiter prius accepisti eandem, servabis eam et penitentiam ages.
|
||
Purg. XXVII, 94-99, 136-138Ne l’ora, credo, che de l’orïente
|
Purg. XXII, 148-150Lo secol primo, quant’ oro fu bello,
|
|
Purg. III, 103-108, 115-116, 136-141E un di loro incominciò: “Chiunque
|
Par. III, 1-3, 47-49, 58-63
Quel sol che pria d’amor mi scaldò ’l petto,
di bella verità m’avea scoverto,
provando e riprovando, il dolce aspetto
e se la mente tua ben sé riguarda,
non mi ti celerà l’esser più bella,
ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda
Ond’ io a lei: “Ne’ mirabili aspetti
vostri risplende non so che divino
che vi trasmuta da’ primi concetti:
però non fui a rimembrar festino;
ma or m’aiuta ciò che tu mi dici,
sì che raffigurar m’è più latino”.
Par. XV, 64-66, 121-123, 130-133
ma perché ’l sacro amore in che io veglio
con perpetüa vista e che m’asseta
di dolce disïar, s’adempia meglio
L’una vegghiava a studio de la culla,
e, consolando, usava l’idïoma
che prima i padri e le madri trastulla
A così riposato, a così bello
viver di cittadini, a così fida
cittadinanza, a così dolce ostello,
Maria mi diè, chiamata in alte grida
Purg. XIX, 100-102, 106-108
Intra Sïestri e Chiaveri s’adima
una fiumana bella, e del suo nome
lo titol del mio sangue fa sua cima.
La mia conversïone, omè!, fu tarda;
ma, come fatto fui roman pastore,
così scopersi la vita bugiarda.
Tab. 21
Purg. XXVIII, 103-114Or perché in circuito tutto quanto
|
Purg. XXV, 88-93Tosto che loco lì la circunscrive,
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 2-4 (radix IIe visionis)] Dicit ergo (Ap 4, 2): “Et ecce sedes posita erat in celo, et supra sedem sedens”, scilicet erat. Deus enim Pater apparebat ei quasi sub specie regis sedentis super solium. […] “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id est aspectibili seu visibili forme, “lapidis iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dicitur similis, quia Deus est per naturam firmus et immutabilis et in sua iustitia solidus et stabilis, et firmiter regit et statuit omnia per potentiam infrangibilem proprie virtutis.
|
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 11 (VIIa visio)] Formam autem tangit tam quoad eius splendorem quam quoad partium eius dispositionem et dimensionem, unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et sub igne et ab igne caloratur et ignis speciem sumit, non autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar speculi polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide incorporata et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter representans et omnium virtutum temperie virens. Est etiam perspicua et transparens non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim lune humilitatem celestium men-tium designat. |
[LSA, Ap 21, 12 (VIIa visio)] Dicit ergo: “Et habebat murum magnum et altum” (Ap 21, 12). Per magnum intelligit longum et latum, seu totum eius circuitum. Sicut autem murus opponitur exterioribus et defendit et abscondit interiora, sic sancti martires et zelativi doctores et pugiles, qui opposuerunt se hostibus et eorum impugnationibus in defensionem fidei et ecclesie, fuerunt murus ecclesie magnus et altus. Virtutes etiam hiis officiis dedicate sunt murus animarum sanctarum, qui quidem murus est ex lapide propter solidam virtutem sanctorum, et “ex lapide iaspide” (cfr. Ap 21, 18) propter virorem vive fidei, propter quam sunt zelati et passi et fortes effecti.
|
Purg. IX, 94-105Là ne venimmo; e lo scaglion primaio
|
Purg. XXIX, 73-78, 124-125; XXXI, 115-123e vidi le fiammelle andar davante,
|
Tab. 22
[De vulgari eloquentia, I, xii, 4] Siquidem illustres heroes, Fredericus Cesar et benegenitus eius Manfredus, nobilitatem ac rectitudinem sue forme pandentes, donec fortuna permisit humana secuti sunt, brutalia dedignantes. Propter quod corde nobiles atque gratiarum dotati inherere tantorum principum maiestati conati sunt, ita ut eorum tempore quicquid excellentes animi Latinorum enitebantur primitus in tantorum coronatorum aula prodibat; et quia regale solium erat Sicilia, factum est ut quicquid nostri predecessores vulgariter protulerunt, sicilianum vocetur: quod quidem reti-nemus et nos, nec posteri nostri permutare valebunt. |
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (Va ecclesia)] Vocatur autem congrue hec ecclesia Sardis, id est principium pulchritudinis, tum quia in suis paucis incoinquinatis habet singularem gloriam pulchri-tudinis, quia difficillimum et arduissimum est inter tot suorum luxuriantes se omnino servare mundum; tum quia primi institutores quinti status fuerunt in se et in suis omnis munditie singulares zelatores, suorumque collegiorum regularis institutio, diversa membra et officia conectens et secundum suas proportiones ordinans sub regula unitatis condescendente proportioni membrorum, habet mire pulchritudinis formam toti generali ecclesie competentem, que est sicut regina aurea veste unitive caritatis ornata et in variis donis et gratiis diversorum membrorum circumdata varietate. |
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 2-4 (radix IIe visionis)] Dicit ergo (Ap 4, 2): “Et ecce sedes posita erat in celo, et supra sedem sedens”, scilicet erat. Deus enim Pater apparebat ei quasi sub specie regis sedentis super solium. […] “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id est aspectibili seu visibili forme, “lapidis iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dicitur similis, quia Deus est per naturam firmus et immutabilis et in sua iustitia solidus et stabilis, et firmiter regit et statuit omnia per potentiam infrangibilem proprie virtutis.
|
||
Purg. XXVIII, 103-114Or perché in circuito tutto quanto
|
Purg. VIII, 22-24, 28-30, 34-36, 43-45, 53-54Io vidi quello essercito gentile
|
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
||
8. Il ciglio diviso e la piaga pettorale
■ “Ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso” (Purg. III, 108). Se dividere, rompere, scindere sono motivi propri dei dottori che nel terzo stato della Chiesa combattono con la spada le eresie, le ciglia sono appropriate allo stato successivo, il quarto, dei contemplativi dall’alto volo: “altivolum supercilium vite anachoritice” (prologo, Notabile VI). Ma al quarto stato appartiene anche la superbia, che la morte, designata dal cavallo pallido all’apertura del quarto sigillo (Ap 6, 8 [5, 1]), doma e frange. Dunque dividere il ciglio equivale a piegare la superbia.
Lucifero, bello nel principio come Sardi, la quinta chiesa d’Asia (cfr. supra), “contra ’l suo fattore alzò le ciglia” (Inf. XXXIV, 34-35); Farinata, udito dei ‘maggiori’ di Dante, “levò le ciglia un poco in suso” (Inf. X, 45); i Malebranche, che nella quinta bolgia “con le ciglia ne minaccian duoli”, volgono i loro “runcigli” contro Virgilio, ma alle parole di questi “li fu l’orgoglio sì caduto” (Inf. XXI, 71, 75, 85, 132). Sordello, la romita anima lombarda che prima se ne stava “sola soletta … altera e disdegnosa”, al rivelarsi del suo concittadino Virgilio “poi chinò le ciglia, / e umilmente ritornò ver’ lui, / e abbracciòl là ’ve ’l minor s’appiglia” (Purg. VII, 13-15). Anche al mantovano cade l’orgoglio proprio degli alti anacoreti. Chinare è tema proprio del quinto stato – “declinans” -, pietoso e aperto ai bisogni delle moltitudini associate, dopo l’alta, ardua e a lungo insostenibile vita dei solitari contemplativi, dei quali è tipico il pertinace ‘stare’ (prologo, Notabile III; cfr. supra). All’alto monte subentra il piano, la “costa” pietosa tratta dal solitario Adamo (prologo, Notabile VII), figurata da Assisi e Cassino, rispettivamente “costa” del Subasio e del Cairo, dove nacque Francesco e operò Benedetto. Nel quinto, declinante periodo, la cura pastorale estirpa il morbo con la medicina; la Chiesa è limitata alla terra latina: temi sacri che rivestono, nella nona bolgia, Pier da Medicina, originario del “dolce piano / che da Vercelli a Marcabò dichina” (Inf. XXVIII, 70-75).
Il quinto periodo declina però anche in rilassatezza. Di questo pernicioso chinare è esempio lo stesso Dante. Ad Ap 3, 3 il vescovo di Sardi viene invitato a ricordare con la mente quale fosse la “prima grazia” e a conservarla, cioè la grazia ricevuta da Dio e ascoltata tramite la predicazione evangelica. Da quanto gli viene detto, si deduce che costui era tanto intorpidito nell’ozio da non ricordare più il primo stato di grazia e di perfezione. Se non si ravvedrà vigilando, il giudizio divino verrà da lui come un ladro (“sicut fur”; cfr. supra).
È la situazione di Dante, tanto “pien di sonno” al momento di abbandonare la verace via da non saper ripetere come fosse entrato nella selva oscura, la cui immagine, tuttavia, ritornandogli alla memoria (cfr. il “si digne recogitaveris» detto al torpido e tardo vescovo di Sardi e l’inciso scritturale “et horam nescies qua veniam ad te”), “rinova la paura” (Inf. I, 6, 10-12). Il tema del tardare è appropriato a Beatrice, la quale mossa da Lucia perché soccorra Dante, teme di essersi “tardi al soccorso levata”, “sì smarrito” (cfr. “sic fuit otiosus et torpens”) pare il suo amico (Inf. II, 64-66).
Altro luogo fasciato dall’esegesi teologica qui considerata è il risvegliarsi di Dante dal sonno della prima notte passata nel purgatorio (Purg. IX, 34ss.). Se i motivi dello svegliarsi o del dormire non possono certo, presi da soli, essere connessi al testo della Lectura, tuttavia l’introduzione del tema del fuggire, appropriato al sonno (prefigurato dal trafugamento di Achille sottratto a Chirone dalla madre Teti, che recita la parte del “fur”, e portato a Sciro per impedirgli di prendere parte alla guerra di Troia) e dello scuotersi per lo spavento conducono all’apertura del sesto sigillo ad Ap 6, 15 (lo scuotersi corrisponde alla “fortis concussio” causata dal terremoto che allora si verifica, che non è solo scuotimento fisico, ma anche interiore). Come pure svegliarsi volgendo gli occhi attorno senza sapere il luogo in cui ci si trova è un filo tratto dal torpore che rende inconsapevoli dell’ora del giudizio di cui si parla ad Ap 3, 3. È da notare che i versi sono segnati dalla reminiscenza dell’Achilleide (I, 247-250), ma mentre Stazio sottolinea la meraviglia dell’eroe nel vedere, svegliandosi, cose sconosciute, Dante insiste sul terrore provocato dal risveglio, che è proprio quanto suggerito dall’esegesi del “fur”.
In questo spavento viene confortato da Virgilio, il quale gli dice che all’alba è venuta Lucia, ha preso il suo fedele che dormiva e, come il giorno è stato chiaro, lo ha portato presso la porta del purgatorio. Il passo paolino dalla lettera ai Tessalonicesi, incastonato nell’esegesi di Ap 3, 3, distingue tra coloro che dormono e che vengono sopraffatti dal ladro, e quelli che vigilano e che sono “filii lucis et diei”. La similitudine con Achille trafugato nel sonno dalla madre consente di dare il valore di madre anche a Lucia che prende Dante, il quale è veramente il “figlio della luce e del giorno” di cui dice san Paolo. L’“intrata aperta” (la fenditura nel balzo al là della quale è la porta del purgatorio) corrisponde alla “porta aperta” data alla sesta chiesa, Filadelfia (Ap 3, 8) e alla sesta vittoria, che è ingresso in Cristo (Ap 3, 12). Ultima variazione nel poema sul tema dell’assonnato declinare, nell’Empireo san Bernardo indica Lucia, “che mosse la tua donna / quando chinavi, a rovinar, le ciglia” (Par. XXXII, 136-138), ciglia che, nel rovinare “in basso loco” ascendendo il “dilettoso monte” (Inf. I, 61), avrebbero dovuto invece essere levate alla vita contemplativa, come quella degli alti anacoreti del quarto stato della Chiesa.
■ “e mostrommi una piaga a sommo ’l petto” (Purg. III, 111). Mostrare le piaghe del mondo “ricenti e vecchie” è proprio dei due testimoni, Enoch ed Elia (Ap 11, 6; cfr. Inf. XVI, 10-11). La piaga pettorale non può non ricordare quella inferta dalla lancia nel costato di Cristo, tema caro a Olivi, che è stato esaminato altrove.
Tab. 23
[LSA, Ap 3, 2-3 (Ia visio, Va ecclesia)] “Esto vigilans” (Ap 3, 2), id est non torpens vel dormiens, sed attente sollicitus de salute tua. Ille enim dormit, qui in peccatis quiescit quasi sopitus et negligit curare de salute anime sue. Quia vero iste, tamquam episcopus, tenebatur sollicite curare non solum de sua salute sed etiam subditorum suorum, ideo pro utroque monetur ut vigilet. […] Sunt enim nonnulli qui ea quibus apud homines videntur magni magis diligunt, et ea sine quibus in conspectu Dei iustificari non possunt parvipendunt, querentes de minimo crescere et de maximo minui. Qui autem maiora coram Deo negligit, minora etiam coram hominibus iuste perdit. […]
|
||
Inf. I, 1-6, 10-12; II, 64-66, 127-129Nel mezzo del cammin di nostra vita
|
Par. XXXII, 136-141e contro al maggior padre di famiglia
|
|
[LSA, prologus, Notabile III; de quinto dono (zelus severus in phialis designatus est septiformis)] Item est septiformis quia est contra initium mali intrinsecum (I) et extrinsecum (II); et contra medium terminum, scilicet ascendens (III) stans (IV) et declinans (V); et contra terminum intrinsecum (VI) et extrinsecum (VII). Initium autem mali intrinsecum fuit in Iudeis adversantibus Christo et apostolis, extrinsecum vero fuit in Paganis apostolos et ceteros martires persequentibus. Et consimiliter terminus intrinsecus erit in finali malitia quorundam de ecclesia, extrinsecus vero in finali persecutione ab exteris infligenda.
|
[LSA, prologus, Notabile III] Patet enim hoc de primo dono. Nam pastoralis cura insistit primo ovium propagationi (I). Secundo earum defensioni ab imbribus et lupis et consimilibus (II). Tertio earum directioni seu deductioni ad exteriora (III). Quarto earum pascuali refectioni (IV). Quinto morborum et morbidarum medicinali extirpationi (V). Sexto ipsarum plene reformationi (VI). Septimo ipsarum in suum ovile reductioni et recollectioni (VII).
|
|
Inf. XXVII, 31-33Io era in giuso ancora attento e chino,
|
Inf. XXVIII, 70-75e disse: “O tu cui colpa non condanna
|
|
[LSA, prologus, Notabile V] Quia vero ecclesia Christi usque ad finem seculi non debet omnino extingui, ideo oportuit eam in quibusdam suis reliquiis tunc specialiter a Deo defendi et in unam partem terre recolligi, qua nulla congruentior sede Petri et sede romani imperii, que est principalis sedes Christi. Ideo in quinto tempore, quod cepit a Karolo, facta est defensio et recollectio ista, tuncque congrue instituta est vita condescensiva, ut nequeuntibus in arduis perdurare daretur locus gratie in mediocri statu. |
[LSA, prologus, Notabile XIII] Sicut etiam in quinta etate, destructa Iudea et Iherusalem per Caldeos et prius decem tribubus per Assirios, restitutus est populus Iuda in terram suam, nec ex tunc pullulavit in eis spina idolatrie sicut ante, sic destructis orientalibus ecclesiis per Sarracenos et latina ecclesia fere vastata per eos et etiam per Longobardos prius paganos et factos postmodum arrianos, restitutus est latinus populus per Karolum imperantem, nec ex tunc idola [priorum] magnarum heresum inundaverunt in eis sicut inundaverunt ante, quamvis sicut tunc circa finem fuit secta heresis Saduceorum, sic circa finem huius quinti temporis [serpit] secta heresis Manicheorum. |
|
Inf. XXI, 70-75, 85-87, 100-102, 130-132; XXII, 13-15usciron quei di sotto al ponticello,
|
||
Purg. III, 106-108Io mi volsi ver’ lui e guardail fiso:
|
[LSA, prologus, Notabile VI] […] ac altivolum supercilium vite anachoritice (IV), et conde-scensivum contubernium vite domestice seu cenobitice (V) […]
Inf. X, 45-48
ond’ ei levò le ciglia un poco in suso;
poi disse: “Fieramente furo avversi 13, 18
a me e a miei primi e a mia parte,
sì che per due fïate li dispersi”.
Inf. XV, 20-21
e sì ver’ noi aguzzavan le ciglia
come ’l vecchio sartor fa ne la cruna.
Inf. XXXIV, 34-36
S’el fu sì bel com’ elli è ora brutto,
e contra ’l suo fattore alzò le ciglia,
ben dee da lui procedere ogne lutto.
Purg. VII, 13-15, 43
tal parve quelli; e poi chinò le ciglia,
e umilmente ritornò ver’ lui,
e abbracciòl là ’ve ’l minor s’appiglia.
Ma vedi già come dichina il giorno
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (Va ecclesia)] Vocatur autem congrue hec ecclesia Sardis, id est principium pulchritudinis, tum quia in suis paucis incoinquinatis habet singularem gloriam pulchritudinis, quia difficillimum et arduissimum est inter tot suorum luxuriantes se omnino servare mundum; tum quia primi institutores quinti status fuerunt in se et in suis omnis munditie singulares zelatores, suorumque collegiorum regularis institutio, diversa membra et officia conectens et secundum suas proportiones ordinans sub regula unitatis condescendente proportioni membrorum, habet mire pulchritudinis formam toti generali ecclesie competentem, que est sicut regina aurea veste unitive caritatis ornata et in variis donis et gratiis diversorum membrorum circumdata varietate.
[LSA, prologus, Notabile VII] Rursus sicut omnis dies habet mane, meridiem et vesperam, sic et omnis status populi Dei in hac vita. Nam in eterna erit semper meridies absque nocte. Ergo tempus plenitudinis gentium sub Christo debuit ante conversionem alterius populi, scilicet iudaici, habere mane et meridiem et vesperam. Et sic quasi iam vidimus esse completum et a Iohanne in hoc libro descriptum. Nam eius mane commixtum tenebris idolatrie fuit ab initio conversionis gentium usque ad Constantinum (I-II). Eius vero meridies fuit in preclara doctrina et contemplatione et vita doctorum et anachoritarum (III-IV). Eius vero vespera circa finem quinti temporis nimis apparet (V).
Tab. 24
[LSA, cap. XI, Ap 11, 6 (IIIa visio, VIa tuba)] […] monstrando eis plagas mundi preteritas et presentes et etiam futuras, quas ipsi carnales non attendunt nec sapientialiter sentiunt nisi cum ab istis aperiuntur. |
Inf. XVI, 10-12Ahimè, che piaghe vidi ne’ lor membri,
|
9. Beatus qui legit
Essere stato rivelato è la causa formale del libro, che meglio si definisce “rivelazione” piuttosto che “visione”, a sottolineare il dono e la grazia di colui che rivela e il suo arcano celarsi se il velo non venga tolto o aperto per dono divino. È nome greco (από = re, κάλυψις = velo) che è rimasto non interpretato in latino, come le parole ebraiche “amen” e “alleluia”, in segno di sacra riverenza verso l’arditezza della rivelazione (Ap 1, 1).
La causa efficiente del libro dell’Apocalisse è quadruplice. La principale è Dio, la secondaria Cristo in quanto uomo, l’intermedia l’angelo, la prossima Giovanni. Così si dice della “rivelazione di Gesù Cristo”, cioè fatta da Cristo, “che Dio gli diede”, che gli fu cioè data dal Padre e da tutta la Trinità non solo per sua conoscenza ma “per render noto”, ossia per manifestare, “ai suoi servi le cose che è necessario avvengano presto”.
Si soggiunge la causa intermedia e poi quella prossima, dicendo: “e che egli”, cioè Cristo, “manifestò”, cioè rivelò o mostrò per mezzo di segni figurali, “inviando il suo angelo”, per annunziarle, “al servo suo Giovanni”. La completa esegesi del Titolo dell’Apocalisse è stata considerata altrove.
È da notare che il poema non viene definito “rivelazione”. Cacciaguida, nell’invitare il suo discendente a non essere timido amico del vero, parla di “visione”: “tutta tua visïon fa manifesta” (Par. XVII, 128). Si tratta però di una visione mostrata da altri, come dice lo stesso Cacciaguida: “Però ti son mostrate in queste rote, / nel monte e ne la valle dolorosa / pur l’anime che son di fama note” (vv. 136-138). L’autore del libro dell’Apocalisse è colui che “questa revelazion ci manifesta”, come afferma il poeta di fronte al fratello di Giovanni, san Giacomo, con riferimento alle “bianche stole” (Ap 3, 4-5; 7, 9; Par. XXV, 94-96). Il verbo “revelare” ricorre solo altre tre volte nel poema. A Par. XXIX, 133, circa il numero degli angeli nella ‘rivelazione’ di Daniele (“ ’n sue migliaia”, cfr. Dn 7, 10), entro cui “si cela” un numero “determinato” ma inconcepibile per la mente umana: da notare la variante, perché Daniele rivela celando. A Par. XXI, 120, Pier Damiani lamenta la decadenza di Fonte Avellana: “Render solea quel chiostro a questi cieli / fertilemente; e ora è fatto vano, / sì che tosto convien che si riveli”, dove il rivelare è accostato alla necessità (“convien”) e al presto apocalittico (“tosto”). A Purg. III, 142-143, Manfredi, del cui destino eterno non si dice il vero tra i vivi, prega Dante che, una volta tornato, vada dalla figlia “revelando a la mia buona Costanza / come m’hai visto” (da intendere come un rivelare il mirabile giudizio divino sul padre, che ha stravolto il giudizio degli umani pastori).
La causa finale del libro dell’Apocalisse, ciò che si consegue attraverso la sua intelligenza e osservanza, è la beatitudine: “Beato chi legge e chi ascolta” (Ap 1, 3). L’intelligenza si ottiene tramite la lettura e l’ascolto; la prima spetta ai dottori o ai letterati, il secondo ai laici. Per la salvezza non basta tuttavia apprendere o sapere senza conservare nell’affetto – con fede, speranza, carità e timore – e nelle opere, per cui si dice: “e chi conserva”.
Vari versi rinviano al medesimo punto esegetico: Purg. III, 124-126 (“Se ’l pastor di Cosenza, che a la caccia / di me fu messo per Clemente allora, / avesse in Dio ben letta questa faccia”, quella misericordiosa: “et sic omnia sunt a nobis servanda vel agendo illa vel credendo ea cum caritate et spe vel timore”); Par. X, 125-126 (“l’anima santa che ’l mondo fallace / fa manifesto a chi di lei ben ode”, cioè Boezio; il manifestare è verbo tipico della rosa offerta dall’esegesi dei primi versetti apocalittici); Inf. XIV, 16-18 (“O vendetta di Dio, quanto tu dei / esser temuta da ciascun che legge / ciò che fu manifesto a li occhi miei!”: senza l’avverbio “ben”, ma con l’accostamento del leggere il lato temibile del libro – “cum caritate et spe vel timore” – e del manifestare).
Il passo tratto da Ap 1, 3 può essere collazionato con quello da Ap 3, 3, in cui alla quinta chiesa, e al suo intorpidito vescovo, viene raccomandato di avere sempre in mente, ripensandola con attenzione, la prima grazia ricevuta da Dio, ascoltata nella predicazione e dimenticata per torpore: una volta tornata alla mente, la prima grazia – che corrisponde a un principio di bellezza e di pienezza stellare – deve essere conservata. Da questo difetto sono esclusi “pochi nomi”, cioè quelle persone i cui nomi sono “noti” a Cristo per la loro santità (Ap 3, 4).
Il tema del “beatus qui audit … et servat” costituisce il tessuto delle parole di Virgilio a Dante “sì smarrito” (rende il “sic torpens” di Ap 3, 3; cfr. quanto dice Beatrice allo stesso Virgilio a Inf. II, 64), che volge i passi da Farinata “ripensando / a quel parlar che mi parea nemico” in quanto gli aveva predetto sciagure (Inf. X, 121-132). Come il vescovo della quinta chiesa, Dante viene invitato a conservare nella mente quello che ha ascoltato (anche se non si tratta della “prima grazia”, ma di profezie contrarie). Il motivo dell’attenzione sta nel drizzare il dito da parte di Virgilio, per affermare che solo quando sarà dinanzi a Beatrice, “al dolce raggio / di quella il cui bell’ occhio tutto vede”, potrà conoscere il corso della propria vita. Il fine di chi ascolta, ripensa attentamente e conserva ciò che ha ascoltato è la beatitudine.
Altro esempio di variazione di questo gruppo tematico è il ‘serbare’ alle chiose di Beatrice quanto narrato al poeta sul proprio destino da Brunetto Latini: la donna saprà spiegare la profezia circa il conseguimento dell’infallibile glorioso porto insieme a quanto oscuramente dettogli da Farinata sul peso dell’arte del rientrare in patria (Inf. XV, 88-90). Anche l’espressione di Virgilio “Bene ascolta chi la nota” (v. 99) sembra derivare dai medesimi temi, se interpretata nel senso che solo chi “nota”, cioè ha in mente e conserva, ascolta bene. Virgilio interviene dopo che per due terzine Dante ha dichiarato di essere pronto ai colpi della Fortuna: “però giri Fortuna la sua rota / come le piace” (vv. 91-96). La Fortuna, così come presentata a Inf. VII, 94-96, per quanto ministra di Dio, è il contrario del “beatus qui audit”: “ma ella s’è beata e ciò non ode” (nel senso che non ascolta il biasimo e la mala voce datale dai mondani; cfr., a Inf. X, 97, le parole di Dante a Farinata: “El par che voi veggiate, se ben odo …”). In presenza di Brunetto, per le parole di Virgilio, Dante le si oppone come colui che bene ascolta e conserva.
Ancora variante dell’ascoltare e del serbare “in affectu et opere”, da Ap 1, 3, è quanto il poeta dice ai tre fiorentini sodomiti: “e sempre mai / l’ovra di voi e li onorati nomi / con affezion ritrassi e ascoltai” (Inf. XVI, 58-60), dove il nominare è precipuo tema della quinta chiesa (Ap 3, 4) e, più in generale (nel senso di fama), di tutto il quinto stato. Serbare “ad salutem … in affectu” dopo aver visto (“beatus qui legit”) è nella preghiera alla Vergine di san Bernardo: “Ancor ti priego … che conservi sani, / dopo tanto veder, li affetti suoi” (Par. XXXIII, 34-36).
Stazio, iniziando la lezione sulla generazione umana, invita Dante a ricevere e a conservare nella mente le sue parole (Purg. XXV, 34-36; da Ap 3, 3). Un’ulteriore variante è l’inciso contro la gente che dovrebbe “esser devota” (gli ecclesiastici) in Purg. VI, 93: “se bene intendi ciò che Dio ti nota”. Ancora, l’attenzione e l’ascoltare sono propri di Virgilio, che in Inf. IX, 4 attende l’arrivo del messo celeste.
Ricordare un ‘prima’ bello che non si ritrova più perché mutato in meglio si verifica nel riconoscimento di Piccarda. Nel rivelarsi (“non mi ti celerà”), la donna invita il poeta a ricordare con mente attenta i “primi concetti” che ebbe di lei, cioè la prima immagine conosciuta in terra, e Dante replica che questi “primi” sono tanto trasfigurati dallo splendore divino da non avergli consentito un immediato riconoscimento senza l’aiuto delle parole del suo interlocutore (Par. III, 47-49, 58-63).
Trasposizione quasi letterale del testo teologico è l’invito di Beatrice ad aprire la mente per fermarvi dentro quanto il poeta ascolterà da lei sull’essenza del voto religioso, “ché non fa scïenza, / sanza lo ritenere, avere inteso” (Par. V, 40-42; cfr. Par. XIII, 1-3). Si tratta certo di un modo comune di dire: “il concetto ritorna frequente nelle raccolte medievali di massime, sulle orme di analoghe sentenze di Seneca e di Cicerone” (Sapegno). Ma anche questo concetto trova rispondenze nella Lectura che lo armino (è Beatrice ad esprimerlo, il cui nome coincide la causa finale dell’Apocalisse), e si tratta proprio di quelle parole che avrebbero convinto Machiavelli a notare le conversazioni da lui intrattenute “nelle antique corti delli antiqui huomini” e a comporre un opuscolo De principatibus, come scrisse a Francesco Vettori il 10 dicembre 1513.
Tab. 25
[LSA, cap. I, Ap 1, 1] “Apocalipsis Ihesu Christi” (Ap 1, 1). Nota etiam quod potius dicit revelatio quam visio, quia magis significat donum et gratiam revelantis et archanam occultationem eius, nisi dono Dei eius velamen auferatur seu aperiatur. […]
|
||
Inf. XIV, 16-18O vendetta di Dio, quanto tu dei
|
Par. X, 124-126Per vedere ogne ben dentro vi gode
|
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 3 (prohemium, titulus)] Ostensa igitur causa formali et effectiva et materiali, subdit de causa finali, que est beatitudo per doctrine huius libri intelligentiam et observantiam obtinenda. Unde subdit (Ap 1, 3): “Beatus qui legit” et cetera. Quantum ad ea que proprio visu vel per propriam investigationem addiscimus, dicit: “qui legit”; quantum vero ad ea que per auditum et alterius eruditionem addiscimus, dicit: “qui audit”. Primum etiam magis spectat ad litteratos vel ad doctores, qui aliis legunt et exponunt; secundum vero ad laicos vel auditores.
|
||
Inf. IX, 4Attento si fermò com’ uom ch’ascoltaInf. X, 97-99, 121-132El par che voi veggiate, se ben odo,
|
Purg. VI, 93se bene intendi ciò che Dio ti notaPurg. XXV, 34-36Poi cominciò: “Se le parole mie,
|
|
10. In co del ponte presso a Benevento,
sotto la guardia de la grave mora
L’“equalitas” è la misura della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione, dove lunghezza, larghezza e altezza si equivalgono (Ap 21, 16). La misura della città è di 12.000 stadi. Lo stadio è lo spazio al cui termine si sosta o “si posa” per respirare e lungo il quale si corre per conseguire il premio. Esso designa il percorso del merito che ottiene il premio in modo trionfale, secondo quanto scrive san Paolo ai Corinzi: “Non sapete che tutti corrono nello stadio, ma di costoro uno solo prende il premio?” (1 Cor 9, 24) [1]. Ciò concorda con il fatto che lo stadio è l’ottava parte del miglio, e in questo senso designa l’ottavo giorno di resurrezione. L’ottava parte del miglio corrisponde a 125 passi, rappresentanti lo stato di perfezione apostolica che adempie i precetti del decalogo (12 apostoli x 10 comandamenti), cui si aggiunge la pienezza dei cinque sensi e delle cinque chiese patriarcali. L’arrivo al cielo della Luna è tanto veloce quanto il ‘posarsi’ di una freccia (“un quadrel”, per concordare con l’ambito tematico della città: «“Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum»: Dante stesso pone sé “in quadro”, per sentirsi “ben tetragono ai colpi di ventura”, Par. XVII, 23-24), la quale vola dopo essersi staccata dalla balestra (Par. II, 23-25). Dal momento in cui inizia la descrizione dell’ascesa al cielo (con il verso 43 del primo canto del Paradiso), fino al congiungersi “con la prima stella” (che coincide con il 25° verso del secondo canto), sono esattamente 125 versi (100 nel primo canto, 25 nel secondo), come i passi dello stadio. La navigazione, della quale il poeta ha premesso in principio di Par. II, è dunque un correre al premio paolino (“L’acqua ch’io prendo già mai non si corse”), un solcare l’acqua (la Scrittura) verso Dio, “la prima equalità” (Par. XV, 74).
Gli angoli delle dodici porte della città (Ap 21, 12; tre per ciascuno dei quattro lati) designano la forza e l’ornato, perché nelle case le pareti si congiungono agli angoli. In tal senso si dice di Cristo che è pietra angolare, oppure in Zaccaria si afferma la futura forza del vittorioso regno di Giuda definendolo angolo, palo e arco, cioè capace di sostenere (Zc 10, 4; qui Olivi si discosta dall’interpretazione di Riccardo di San Vittore, secondo il quale gli angoli designano coloro i quali si distinguono per meriti più occulti). Il tema degli angoli si annida dietro al “congiungersi”: l’arrivo al cielo della Luna è appunto una congiunzione (“giunto mi vidi … che n’ha congiunti con la prima stella”) che avviene velocemente: “e forse in tanto in quanto un quadrel (“et civitas in quadro posita est”) posa (tema del posarsi o dello stadio, che è misura della città) / e vola e da la noce si dischiava …” (Par. II, 23-30).
I motivi del posarsi e del congiungersi tornano uniti a Par. IV, 127-128, riferiti all’intelletto umano che si riposa nel vero divino “come fera in lustra, / tosto che giunto l’ha; e giugner puollo”, e a Par. VI, 25-27, dove Giustiniano ricorda come i successi militari di Belisario contro i Goti, “cui la destra del ciel fu sì congiunta”, furono segno che dovesse tutto dedicarsi (‘posarsi’) all’alto lavoro di trarre “d’entro le leggi … il troppo e ’l vano”.
In simmetria con quanto Dante avrebbe poi scritto a Par. IV sul dubbio, congiungersi (angolo, che designa la forza) e posarsi (premio, lo stadio che misura la città) sono insieme nell’arrivo presso la porta del purgatorio, nel confortante racconto di Virgilio dopo il dubitoso risveglio di Dante dal primo dei tre sogni effettuati sulla montagna prima di pervenire all’Eden, mentre Lucia è intervenuta a portarlo dalla valletta a destinazione: “Tu se’ omai al purgatorio giunto … Qui ti posò …” (Purg. IX, 49, 61). Dante è stato ‘posato’ accanto all’“intrata aperta”, che gli occhi belli di Lucia hanno ‘mostrato’ a Virgilio prima di sparire (vv. 61-63). L’“intrata aperta” (la porta del purgatorio), come già ricordato, corrisponde alla “porta aperta” data alla sesta chiesa, Filadelfia (Ap 3, 8) e alla sesta vittoria, che è ingresso in Cristo (Ap 3, 12).
Bonagiunta Orbicciani da Lucca, che nel sesto girone della montagna riconosce la differenza fra il dolce stil novo e la poetica precedente, propria del Notaro, di Guittone e di lui stesso, è nome significante la congiunzione del vecchio rimare col nuovo (Purg. XXIV, 19-20, 55-63).
In precedenza, la tematica relativa allo “stadio” è stata osservata in Inf. XV e Par. XXV. All’opposto infernale, un degradante correre senza posa è proprio dell’insegna dietro alla quale vengono gli innumerevoli ignavi (Inf. III, 52-54).
Mentre il regno superno “pausa / in tanto amore e in tanto diletto” (Par. XXXII, 61-62), Firenze, un tempo “così riposato … viver di cittadini” (Par. XV, 131-132) – figura della Gerusalemme celeste, “civium unitas” -, è “somigliante a quella inferma / che non può trovar posa in su le piume, / ma con dar volta suo dolore scherma” (Purg. VI, 148-151). Negazione del riposo dopo il trionfo nella corsa per lo stadio paolino, e della pace che pervade la Gerusalemme discesa in terra (Ap 3, 12), ha come sua pietra angolare, che dovrebbe darle forza nel congiungersi ad arco, non Cristo ma Marte, “quella pietra scema / che guarda ’l ponte” (Par. XVI, 145-147).
Correre e posare, i motivi dello stadio paolino, si intrecciano con la tematica della sesta vittoria (Ap 3, 12): la pace (la Gerusalemme celeste, interpretata come “visio pacis”); la contemplazione la quale, iniziata da Dio, per la città ascende in Cristo suo re e torna e rientra circolarmente nella gloria divina. Temi che si registrano nelle parole rivolte da parte degli scomunicati, i quali ai due poeti fanno “insegna” come ai naviganti: «redit et reintrat in Deum – “Tornate”, disse, “intrate innanzi dunque”» (Purg. III, 100-102). Una variazione è già stata percepita nell’uscita “a riveder le stelle”: “Lo duca e io per quel cammino ascoso / intrammo a ritornar nel chiaro mondo” (Inf. XXXIV, 133-134). Il ritorno della mente a Dio per la sua città avviene “per suavitatem amoris”; tali le parole di Manfredi: “che non possa tornar, l’etterno amore” (Purg. III, 134).
|
Gli angoli designano anche l’ornato, come fu l’opera, di discreta e sottile congiunzione, voluta da Salomone negli stipiti del Tempio, menzionata nell’esegesi degli angoli della città (3 Rg 6, 31; Ap 21, 12). Tale opera può essere accostata alla porta del purgatorio: “E quando fuor ne’ cardini distorti / li spigoli di quella regge sacra, / che di metallo son sonanti e forti” (Purg. IX, 133-135). Gli “spigoli” indicano, come sostenuto dal Porena, la parte acuta che sporge della linea d’incontro fra due facce di un solido, sono cioè le “angulares prominentie” delle porte infisse nei “postes” (i cardini). L’essere “forti” degli spigoli contiene in sé anche il motivo del ruggire proprio dell’angelo della sesta tromba, che ha la faccia come il sole (Ap 10, 3).
Un esempio di ornato sottile e discreto, ma estraneo e difforme, appartiene alla natura la quale, per quanto non si penta di continuare a produrre elefanti e balene, almeno non genera più animali come i giganti, nei quali la ragione si congiunge (tema dell’angolo) con il volere il male e con il potere di farlo (Inf. XXXI, 52-57).
Poiché i lati della città celeste sono virtù, oppure stati di tensione in questa vita verso Dio (la lunghezza è la visione, la larghezza la carità, l’altezza l’alta lode), anche gli angoli (il congiungersi, la forza, il sostentare) sono appropriati agli uomini in terra. Virgilio che ‘sostiene’ Dante (Inf. XVII, 94-96), il quale è con lui “congiunto” (Par. XVII, 19-21), sono variazioni sul tema dei “robusti duces qui erunt aliorum sustentatores sicut angulus et paxillus” dall’esegesi di Zaccaria 10, 4.
Nella bolgia dei simoniaci, Virgilio ‘congiunge’ Dante, portandolo vicino, con il foro dove sta fitto a testa in giù Niccolò III, “anima trista come pal commessa” (Inf. XIX, 43-48). Finito l’incontro con il papa simoniaco, lo riconduce per la via onde era disceso nel fondo della bolgia fino al sommo dell’“arco”, cioè del ponte che consente il passaggio dalla quarta alla quinta bolgia (vv. 127-129). In tre punti diversi sono inseriti i motivi dell’angolo (il congiungere), del palo e dell’arco (il ponte) contenuti nella citazione di Zaccaria 10, 4. La “fortitudo” e l’“archus prelii” sono congiunti nei “ponticelli” che attraversano i fossati dalle soglie delle “fortezze” alla ripa esterna, simili ai ponti di roccia che recidono i fossati di Malebolge (Inf. XVIII, 14-15).
Il tema degli angoli, che congiungono per rafforzare, si combina con quello della città a forma di quadrato, che designa la solida quadratura delle virtù (Ap 21, 16), nella visione della croce greca che appare nel cielo di Marte, “il venerabil segno / che fan giunture di quadranti in tondo” (Par. XIV, 100-102; da accostare all’espressione “che quattro cerchi giugne con tre croci” di Par. I, 39, per cui il sole, “la lucerna del mondo … con miglior corso e con migliore stella / esce congiunta, e la mondana cera / più a suo modo tempera e suggella”).
Al termine del viaggio, fattosi “più ardito … a sostener”, Dante congiunge lo sguardo con l’infinita essenza di Dio (Par. XXXIII, 79-81). Si trova ad essere pietra angolare, che congiunge e sostiene, come i “robusti duces” sorreggono gli altri. La luce divina si congiunge al vedere naturale di Pier Damiani, elevandolo alla visione della somma essenza (Par. XXI, 83-87).
Gli angoli della Gerusalemme celeste sono in figura sia di persone come di parti strutturali, quali i ponti i quali, come gli angoli definiti “archus prelii”, hanno funzione di congiungere. Il lombardo co rende “caput anguli”, qualità di Cristo presente nei forti e unitivi angoli della Gerusalemme celeste (Ap 21, 12), con tutto il significante che l’esegesi comporta.
|
[1] Passo ben noto a Dante, che lo cita in Convivio IV, xxii, 6: “Molti corrono al palio, ma uno è quelli che ’l prende”.
[2] Cfr. « In mensura et numero et pondere ». Nella fucina della Commedia: storia, poesia e arte della memoria (PDF, 2014), cap. 3.
[3] FRUGONI, Il canto III del “Purgatorio”, pp. 98-100 [280-282].
Tab. 26
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] In scripturis tamen sepe angulus sumitur pro fortitudine et ornatu, quia in angulis domorum, in quibus parietes coniunguntur, est fortitudo domus. Unde Christus dicitur esse factus in caput anguli et lapis angularis; et Iob I° dicitur “ventus” [concussisse] “quattuor angulos domus” ut dirueret ipsam domum (Jb 1, 19), et Zacharie X°, ubi agitur de futura fortitudine et victoria regni Iude, dicitur quod “ex ipso” erit “angulus et paxillus et archus prelii” (Zc 10, 4), id est robusti duces qui erunt aliorum sustentatores sicut angulus et paxillus; et Sophonie I° dicitur quod “dies ire” erit “super civitates munitas et super angulos excelsos” (Sph 1, 15-16), et capitulo III° dicitur: “Disperdidi gentes et dissipati sunt anguli earum” (Sph 3, 6), id est robusti duces earum; et I° Regum XIIII°: “dixit Saul: Applicate huc universos angulos populi” et cetera (1 Rg 14, 38).
|
[Ap 21, 16] “Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum. […] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia” (Ap 21, 16). Stadium est spatium in cuius termino statur vel pro respirando pausatur, et per quod curritur ut bravium acquiratur, secundum illud Apostoli Ia ad Corinthios, capitulo IX°: “Nescitis quod hii, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium?” (1 Cor 9, 24), et ideo significat iter meriti triumphaliter obtinentis premium. Cui et congruit quod stadium est octava pars miliarii, unde designat octavam resurrectionis. Octava autem pars miliarii, id est mille passuum, sunt centum viginti quinque passus, qui faciunt duodecies decem et ultra hoc quinque; in quo designatur status continens perfectionem apostolicam habundanter implentem decalogum legis, et ultra hoc plenitudinem quinque spiritualium sensuum et quinque patriarchalium ecclesiarum.Purg. III, 127-129l’ossa del corpo mio sarieno ancora
|
Inf. XXI, 64-66, 103-105Poscia passò di là dal co del ponte;
|
Inf. XXIII, 85-87; XXIV, 43-45, 67-69, 79-81
|
Tab. 27
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12-13 (VIIa visio)] Item murus habebat “portas duodecim et in portis angulos duodecim [et] nomina scripta, que nomina sunt duodecim tribuum filiorum Israel. Ab oriente porte tres, ab aquilone porte tres, ab austro porte tres et ab occasu porte tres” (Ap 21, 12-13). […]
|
[Ap 21, 16] “Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum. […]
|
Par. I, 37-42; II, 23-30 (Par. I, 43-142 + II, 1-25 = 125); IV, 127-129; VI, 25-27Surge ai mortali per diverse foci
|
Par. X, 28-33Lo ministro maggior de la natura,
|
Tab. 28
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] In scripturis tamen sepe angulus sumitur pro fortitudine et ornatu, quia in angulis domorum, in quibus parietes coniunguntur, est fortitudo domus. Unde Christus dicitur esse factus in caput anguli et lapis angularis; et Iob I° dicitur “ventus” [concussisse] “quattuor angulos domus” ut dirueret ipsam domum (Jb 1, 19), et Zacharie X°, ubi agitur de futura fortitudine et victoria regni Iude, dicitur quod “ex ipso” erit “angulus et paxillus et archus prelii” (Zc 10, 4), id est robusti duces qui erunt aliorum sustentatores sicut angulus et paxillus; et Sophonie I° dicitur quod “dies ire” erit “super civitates munitas et super angulos excelsos” (Sph 1, 15-16), et capitulo III° dicitur: “Disperdidi gentes et dissipati sunt anguli earum” (Sph 3, 6), id est robusti duces earum; et I° Regum XIIII°: “dixit Saul: Applicate huc universos angulos populi” et cetera (1 Rg 14, 38). |
[Ap 21, 16] “Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum. […] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia” (Ap 21, 16). Stadium est spatium in cuius termino statur vel pro respirando pausatur, et per quod curritur ut bravium acquiratur, secundum illud Apostoli Ia ad Corinthios, capitulo IX°: “Nescitis quod hii, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium?” (1 Cor 9, 24), et ideo significat iter meriti triumphaliter obtinentis premium. Cui et congruit quod stadium est octava pars miliarii, unde designat octavam resurrectionis. Octava autem pars miliarii, id est mille passuum, sunt centum viginti quinque passus, qui faciunt duodecies decem et ultra hoc quinque; in quo designatur status continens perfectionem apostolicam habundanter implentem decalogum legis, et ultra hoc plenitudinem quinque spiritualium sensuum et quinque patriarchalium ecclesiarum. |
|
[LSA, cap. II, Ap 3, 12 (VIa victoria)] Vocat autem eam novam propter novitatem glorie vel gratie, unde et precipue significat hic civitatem beatorum, et post hoc illam que erit in sexto et septimo statu, et post hoc illam que reiecta vetustate legalium fuit in quinque primis statibus Christi, et post hoc totam universaliter ab initio mundi. Vocatur etiam Iherusalem, id est visio pacis, quia vel ipsa fruitur vel ad ipsam suspiratur.
|
||
Purg. V, 58-63, 130-133E io: “Perché ne’ vostri visi guati,
|
Par. XVI, 40-42, 145-150Li antichi miei e io nacqui nel loco
|
|
Tab. 29
Inf. XIX, 127-129 (43)Né si stancò d’avermi a sé distretto,
|
Purg. III, 127-129l’ossa del corpo mio sarieno ancora
|
Par. IV, 127-129Posasi in esso, come fera in lustra,
|
Purg. V, 130-132 (44)“Deh, quando tu sarai tornato al mondo
|
Par. XV, 130-132A così riposato, a così bello
|
Par. XXXII, 130-132siede lungh’ esso, e lungo l’altro posa
|
Purg. VI, 148-151 (50)
E se ben ti ricordi e vedi lume,
|
Par. XVI, 145-150 (49-50)Ma conveniesi, a quella pietra scema
|
Tab. 30
Par. XXV, 67-69, 91-96, 124-129“Spene”, diss’ io, “è uno attender certo
|
Purg. III, 73-75, 124-135
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 9.11 (IIa visio, apertio Vi sigilli)] Quia vero sufficiens numerus electorum, secundum eternam Dei predestinationem et secundum Christi redemptoris condignam honorificentiam et secundum congruentiam consumationis civitatis celestis et secundum promissionem factam patribus de plena reductione Israelis ad Christum, nondum erat completus, sufficiebatque interim sanctis animabus gloria ipsarum ante resumptionem et glorificationem suorum corporum eis dat[a], ideo primo premittitur primus ordo iustitie, cum dicitur: “vidi subtus altare Dei” et cetera (Ap 6, 9).
|
|
Inf. XXI, 58-66Lo buon maestro “Acciò che non si paia
|
Purg. III, 124-129Se ’l pastor di Cosenza, che a la caccia
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] In scripturis tamen sepe angulus sumitur pro fortitudine et ornatu, quia in angulis domorum, in quibus parietes coniunguntur, est fortitudo domus. Unde Christus dicitur esse factus in caput anguli et lapis angularis; et Iob I° dicitur “ventus” [concussisse] “quattuor angulos domus” ut dirueret ipsam domum (Jb 1, 19), et Zacharie X°, ubi agitur de futura fortitudine et victoria regni Iude, dicitur quod “ex ipso” erit “angulus et paxillus et archus prelii” (Zc 10, 4) […] |
|
11. L’instabilità delle vicende e dei giudizi umani
Donec fortuna permisit
“Vespero è già colà dov’ è sepolto / lo corpo dentro al quale io facea ombra; / Napoli l’ha, e da Brandizio è tolto” – “Di fuor dal regno, quasi lungo ’l Verde, / dov’ e’ le trasmutò a lume spento” (Purg. III, 25-27, 134-135). Ottaviano fece trasferire il corpo di Virgilio da Brindisi a Napoli; Bartolomeo Pignatelli, il “pastor di Cosenza” inviato da Clemente IV alla caccia di Manfredi, ne fece trasferire il corpo fuori dal Regno di Sicilia. Per quanto l’intento sia stato onorifico nel primo caso, di maledizione nel secondo, si tratta di due translationes. La prima, relativa alla sepoltura di Virgilio, designa la perdita di un primato, come quello che passa di chiesa in chiesa ed è considerato nell’esegesi di Ap 2, 5. Entrambe fanno segno dell’instabilità delle vicende umane, sotto il regime della Fortuna, che permuta e trasmuta a suo piacimento (Inf. VII, 78-80). Delle continue mutazioni, che apparentemente procedono nello stesso giudizio divino, tratta il passo sulla “commutatio pontificatus” che Olivi inserisce come “figurale exemplum” nel VII Notabile del prologo della Lectura.
Se le perfezioni dei periodi precedenti predispongono all’ultima e suprema perfezione rappresentata dal sesto stato, anche la corruzione che precede è utile per contrapposizione, in quanto l’esempio delle rilassatezze passate e dei giudizi terribili su di esse inflitti giova ad assumere e a mantenere l’altezza del sesto stato, a causa dei sentimenti di timore, umiltà, fervore e prudenza istillati dall’esperienza degli altri casi. Nell’Antico Testamento si registrò un continuo mutare delle stirpi sacerdotali, nonostante i patti stabiliti da Dio con alcune di esse. Qualcosa di simile si registra nel Nuovo. Con Pietro e con gli apostoli il sacerdozio fu infatti dato alla stirpe evangelica, quindi venne utilmente e ragionevolmente commutato a uno stato fondato sul possesso dei beni temporali, la cui durata va da Costantino al termine del quinto stato. In questo periodo, i pontefici che preferirono la povertà evangelica ai beni temporali segnarono di nuovo, e in modo raddoppiato, il prevalere del primo ordine, quello del sacerdozio apostolico. Alla fine di queste mutazioni, il pontificato dovrà ritornare al primo ordine, al quale spetta per diritto di primogenitura e per la maggiore perfezione derivante dalla conformità con Cristo. Questo ritorno sarà agevolato non solo dall’imperfezione insita nel possesso dei beni temporali, ma pure da quegli enormi difetti – superbia, lussuria, simonie, liti, frodi e rapine – da cui la Chiesa, divenuta alla fine del quinto stato quasi una nuova Babilonia, risulterà macchiata e confusa dai piedi al capo [1].
Questi temi vengono liberamente variati da Dante. Nell’Inferno, si comincia con la Fortuna, che Dio “ordinò general ministra e duce / che permutasse a tempo li ben vani / di gente in gente e d’uno in altro sangue” (Inf. VII, 78-80).
È ancora la trasmutante Fortuna a entrare nel dialogo con Brunetto Latini. Le è associato il motivo del patto non compiuto nelle parole di Dante: “Non è nuova a li orecchi miei tal arra”, cioè la predizione sul corso della propria vita, che è come un contratto non perfezionato (Inf. XV, 94) [2]. Poi, il tema della “commutatio” del pontificato è appropriato al vescovo di Firenze Andrea de’ Mozzi, macchiato dalla “tigna” della sodomia, che Bonifacio VIII, nel 1287, trasferì alla sede di Vicenza (“fu trasmutato d’Arno in Bacchiglione”, vv. 110-114).
Richiamato da Virgilio dopo la “baratta” coi diavoli, Dante, che s’era acquattato dietro a una roccia, torna dalla sua guida temendo che i diavoli non mantengano il patto come, nell’agosto 1289, temettero i fanti ghibellini “ch’uscivan patteggiati di Caprona / veggendo sé tra nemici cotanti” (Inf. XXI, 93-96; tema del timore indotto dagli esempi precedenti).
Il consiglio che Guido da Montefeltro avrebbe dato al papa per prendere Palestrina nel 1299 – “lunga promessa con l’attender corto / ti farà trïunfar ne l’alto seggio” (Inf. XXVII, 110-111) -, nel senso: ‘patteggia col nemico, prometti molto e mantieni poco’, è sarcastica memoria del celebre passo sulla “commutatio pontificatus” del notabile VII del prologo della Lectura, dove si dice che, nell’Antico Testamento, Dio non serbò il patto di mantenere per sempre una stessa stirpe nel sommo sacerdozio, e di un altro luogo (ad Ap 5, 1) dove si aggiunge che, nel Nuovo Testamento, Cristo non mantenne tutte le promesse fatte dai profeti.
Nella bolgia dei ladri, il poeta vede “la settima zavorra / mutare e trasmutare” (Inf. XXV, 142-143): ivi i dannati arrivano a scambiarsi le forme, per cui i serpenti si trasformano in uomini e gli uomini in serpenti. Nel sesto giorno della creazione, dopo i rettili e le bestie irrazionali, venne creato l’uomo, cui è assimilato l’ordine evangelico del sesto stato della Chiesa (prologo, Notabile XIII): nel caso dei ladri non si assiste a un ritorno a qualcosa di stabile e di conforme a Cristo, ma a una perenne mutazione e a un ritorno indietro, dell’uomo nella bestia.
I falsari dell’ultima bolgia si trasmutano carponi “per lo tristo calle” e, quali lebbrosi, sono macchiati di croste dal capo ai piedi, al modo della Chiesa, al termine del quinto stato “quasi nova Babilon effecta” (Inf. XXIX, 69, 75; cfr. il fiammeggiare che si muove sulle piante dei piedi dei simoniaci, nella terza bolgia, “dai calcagni a le punte”: Inf. XIX, 28-30). Come pure, tra le tribolazioni del carro della Chiesa (la “nova belva”) viste da Dante nell’Eden, c’è il gigante che flagella la prostituta “dal capo infin le piante” (Purg. XXXII, 154-160).
Molti sono i luoghi del poema dove affiora il tema del trasmutare. Il giusto zelo di Nino Visconti censura la moglie Beatrice d’Este per aver trasmutato “le bianche bende” della vedovanza col passare a seconde nozze con Galeazzo Visconti (Purg. VIII, 73-75).
Nel passaggio dal cielo della Luna a quello di Mercurio, Beatrice muta sembiante e la stella si cambia e ride, come il poeta, “trasmutabile … per tutte guise” (Par. V, 88, 97-99).
L’aquila, “l’uccel di Dio”, ha governato il mondo cambiando mano nei vari successori di Costantino prima di pervenire a Giustiniano, ma Dio non trasmuterà il proprio segno per i gigli di Francia (Par. VI, 8-9, 110-111).
Nel cielo ottavo, alle parole irate di san Pietro contro “quelli ch’usurpa in terra il luogo mio …” tutti trascolorano arrossendo dietro al principe degli apostoli. Lo stesso san Pietro procede nell’invettiva mutando tanto la voce, mentre l’aspetto resta immutabile (Par. XXVII, 21, 34-39) [3].
Un esempio tutto particolare di variazione dei temi offerti dal passo della “commutatio” è nell’argomentare di Beatrice contro la soluzione data da Averroè al problema delle macchie lunari, fondata sulle differenze materiali dei corpi celesti, sulla loro rarità e densità (Par. II, 73-90). Se le macchie provenissero dal raro, cioè dalla minore densità – sostiene la donna -, o il pianeta sarebbe raro per tutto il suo spessore in quanto scarso (“digiuno”) di materia; ovvero alternerebbe nella sua massa strati densi e radi, come gli strati del grasso e del magro di un corpo o come carte in un volume. Nel primo caso, la rarità della materia lunare sarebbe manifesta nell’eclissi di sole per il trasparirvi della luce solare. Nel secondo caso, l’alternarsi degli strati rari e densi avrebbe comunque un termine al di là del quale il denso non lasci più passare il raro e che rifletta i raggi, come fa il piombo che sta dietro lo specchio da cui ‘tornano’ i raggi colorati che formano l’immagine degli oggetti. In questo presunto alternarsi di strati rari e densi si annida il tema della “commutatio” tra stato povero ed evangelico (il pianeta “di sua materia sì digiuno”) e stato dotato di beni temporali (“lo grasso” del corpo) cui è soggetto il pontificato, come, nel “termine da onde / lo suo contrario più passar non lassi”, da cui “l’altrui raggio si rifonde / così come color torna per vetro / lo qual di retro a sé piombo nasconde”, è presente il motivo del ritorno del pontificato, alla fine delle mutazioni, al primo ordine, allorché la densità della materia è tanta, come la corruzione della Chiesa al termine del quinto stato, da non lasciar più passare la luce [4].
Nell’invettiva contro l’“antica lupa”, che nel quinto girone degli avari e prodighi precede l’incontro con Ugo Capeto, Dante invoca il cielo, il cui girare nelle sfere si ritiene trasmuti le condizioni umane, affinché venga il Veltro che la farà discedere [5]. Subito dopo la voce di Ugo parla della povertà di Maria e del “buon Fabrizio”, che preferì la povertà alle ricchezze offertegli dai nemici di Roma (Purg. XX, 13-15, 19-27).
Sullo stesso panno (il Notabile VII del prologo) è tessuto quanto Cacciaguida dice di Cangrande, che disprezzerà le ricchezze e trasmuterà molta gente facendo cambiare condizione a ricchi e poveri (Par. XVII, 82-84, 89-90).
Girolamo Arnaldi ha sottolineato come i versi di Par. XVII, 89-90 meritino maggiore attenzione di quanta non ne abbiano avuta, in genere riferiti a un’attività di Cangrande nel settore della pubblica beneficenza o a una politica di riforme sociali [6].
Dante applica alla storia umana la legge che regola, secondo l’Olivi, la storia della Chiesa, fatta di traslazioni, trasmutazioni, patti non mantenuti da Dio stesso (secondo il giudizio umano), prima del ritorno alla stabilità. Questa legge non vale più soltanto per il papato, povero nel cominciare con san Pietro e poi, dopo Costantino, ricco, in vista del ritorno al primo tempo. Questa legge diventa universale, il papato è solo una parte del tutto.
La scomunica condannava Manfredi con i reprobi nel fuoco eterno; le sue ossa furono trasferite “di fuor dal regno”. Letteralmente si tratta del Regno di Sicilia che il re svevo, secondo la Chiesa, aveva usurpato. Spiritualmente, l’espressione “di fuor dal regno” fa segno del “lacus inferni”, calcato dall’ira divina, dove stanno i dannati «“extra civitatem”, id est extra locum et collegium beatorum» (Ap 14, 20), fuori cioè dal regno dei beati. Ivi sono le “tenebre exteriores” (Matteo 8, 12; 22, 13); l’anatema era confermato gettando a terra i ceri e calpestandoli, “a lume spento”, come avvenne per Manfredi.
|
[1] Il passo del Notabile VII sulla “commutatio” del pontificato fa parte dell’armatura che cinge la citazione fatta da Stazio della IV egloga virgiliana (Purg. XXII, 70-72).
[2] Commenta Benvenuto: “tal arra, idest talis praenuntiatio; et est conveniens methaphora, nam arrha est argumentum emptionis et venditionis contractae nondum perfectae”. Il tema del “pactum sacerdotii eterni” non ancora perfezionato si ritrova anche nelle parole di Matelda sull’Eden: “e questo loco / diede per arr’ a lui d’etterna pace”, mentre l’umana colpa “in pianto e in affanno / cambiò onesto riso e dolce gioco” (Purg. XXVIII, 91-96). Da notare come il tema del patto si registra sulla 30a e 31a terzina, a Inf. XXI, 93, XV, 94 e Purg. XXVIII, 93.
[3] Il tema della sembianza immutabile è nell’esegesi di Ap 4, 3, dove si tratta dell’“aspetto” di Colui che siede sul trono, simile a pietra di diaspro e di cornalina, cioè di colore verde e rosso sangue. Dio è simile a una pietra poiché per sua natura è fermo e immutabile, solido e stabile nella giustizia, tutto governa e stabilisce con la potenza infrangibile della propria virtù. Il diaspro è di colore verde come l’erba, e rappresenta l’immarcescibile verdeggiare di Dio, assai dilettevole e grazioso agli eletti. La cornalina è invece rossa sia per la carità e la pietà verso gli eletti come – è il caso di san Pietro – per l’ira e l’odio verso i reprobi.
[4] Al suono della quinta tromba (Ap 9, 1-2), il grave e grosso fumo che esce dal pozzo dell’abisso punge e confonde gli occhi di chi guarda e diffama e oscura presso fedeli e infedeli la solare chiarezza della fede, della Chiesa e della religione che conduce al culto di Cristo vero sole, come l’aere perspicuo permette alla nostra facoltà visiva di raggiungere il sole e ai suoi raggi di pervenire all’occhio. Il ‘tornare’ della città dei contemplativi a Dio è inoltre tema della sesta vittoria (Ap 3, 12); i motivi dello specchio (il “vetro”) e dei colori sono congiunti nella settima visione, che descrive la città dei beati (Ap 21, 11.18.21). Tutti si ritrovano nel canto successivo, allorché i beati nel cielo della Luna appaiono come immagini riflesse che “… per vetri trasparenti e tersi, / o ver per acque nitide e tranquille … tornan”, alla parvenza come “specchiati sembianti” (Par. III, 10-20). Il ‘tornare’ a Dio dei beati è dunque prefigurato dal raggio di sole che “si rifonde” a partire dal termine oltre il quale la materia densa non lo lascia più passare. Cfr. La settima visione, cap. I.1 (La luce della città).
[5] Ad Ap 13, 18, Olivi riporta l’opinione di alcuni, secondo i quali l’Anticristo mistico nascerà dal seme di Federico II. Provocherà la ‘caduta’ del regno di Francia, in coincidenza con il terremoto che segna l’apertura del sesto sigillo. Allora si verificherà quanto dice l’Apostolo ai Tessalonicesi sul fatto che l’apostasia, il discedere dall’obbedienza del vero papa per seguire un falso papa non eletto canonicamente, scismatico ed errante contro la verità della povertà e della perfezione evangelica, dovrà venire prima del ritorno di Cristo nella parusia (2 Th 2, 3). Dell’espressione paolina – “nisi venerit discessio primum” – è contesto il verso di invettiva contro la lupa – “quando verrà per cui questa disceda?” -, nel quale il ‘discedere’ è appropriato alla lupa e il ‘venire’ al Veltro. L’invettiva è collocata all’inizio di Purg. XX (vv. 13-15), canto che si chiude con il terremoto sentito “come cosa che cada” e che fa tremare la montagna (vv. 124-141). Stazio spiegherà che il terremoto si verifica quando un’anima purgante si sente monda e libera nella sua volontà di salire al cielo (Purg. XXI, 58-72). Tra l’invettiva contro la lupa e il terremoto sta Ugo Capeto, il quale chiede vendetta a Dio sulla “mala pianta” di cui fu radice. Il terremoto – che assume testualmente, comunque, le caratteristiche dell’apertura del sesto sigillo –, al di là dei motivi dati da Stazio (anch’essi propri del sesto stato), è allusione alla futura caduta del regno di Francia.
[6] G. ARNALDI, alla voce Della Scala, Cangrande, in Enciclopedia Dantesca, II, 19842, p. 359: «[…] si mostra di non tenere conto del fatto che, in If VII 79-81, la funzione di ‘permutare’ a tempo li ben vani / di gente in gente e d’uno in altro sangue, / oltre la difension d’i senni umani, è riserbata alla Fortuna, ordinata da Dio general ministra e duce agli splendor mondani, proprio per mettere a nudo la loro caducità. Un accostamento questo che consente di reinserire idealmente l’episodio di C. nel contesto, cui di fatto appartiene, del gruppo di canti (Pd XV, XVI, XVII) “più unitario” di tutta la Commedia. In Pd XVI, “le permutazioni incessanti per ascensioni e cadute, estinzioni e nuovi nascimenti” di famiglie fiorentine (Figurelli) vengono prospettate come il riflesso municipale di una legge che regola tutta la storia umana e messe in conto alla Fortuna, che, nonostante la metafora naturalistica (E come ’l volger del ciel de la luna / cuopre e discuopre i liti sanza posa, / così fa di Fiorenza la Fortuna, vv. 82-84), è sempre, per D., la ministra della Provvidenza. Solo mediante questa difficile e aspra pedagogia, l’amor di cosa che non duri (Pd XV 11), quell’attaccamento al mondo fallace, che molt’anime deturpa (vv. 146-147) ed era la causa prima del disordine e dell’ingiustizia presenti, potevano infatti venire sradicati dal cuore degli uomini. Non è escluso che la diretta constatazione dei numerosi mutamenti di fortune individuali e familiari che la signoria scaligera aveva prodotti, e stava producendo, in Verona, abbia indotto D. ad attribuire a C., nel contesto ideale dei canti di Cacciaguida, il merito di quel rapido e frequente ‘trasmutamento’ di genti che in realtà apparteneva solo alla dinamica sociale messa in moto dal regime signorile».
Tab. 31
Inf. VII, 78-80ordinò general ministra e duce
|
Inf. XV, 94-96, 110-113
Non è nuova a li orecchi miei tal arra:
|
Inf. XXI, 93-96sì ch’io temetti ch’ei tenesser patto;
|
Purg. XXVIII, 91-96Lo sommo ben, che solo esso a sé piace,
|
[LSA, prologus, Notabile VII] Tertia (ratio) est quia non solum priores perfectiones disponunt ad ultimam et supremam, immo etiam ipsarum remissiones et casus enormes ac iudicia terribilia pro istis inflicta, licet hec non ita disponant per se sicut prima, sed per accidens. Ex hoc enim commendabilior apparet gratia donationis ultimi finis, et exemplo preteritorum casuum et iudiciorum timoratius et humilius et celerius et ferventius ac prudentius et firmius assumitur et servatur altitudo status supremi. Ea etiam ratione qua opposita iuxta se [posita] magis elucescunt mutuusque eorum conflictus promovet et exercet electos, confert contrapositio prioris remissionis et casus clarificationi status supremi, et ideo status sequens communiter non introducitur vel non plene clarificatur nisi in defectu prioris.
|
|
Inf. XIX, 28-30, 94-96Qual suole il fiammeggiar de le cose unte
|
Purg. XXXII, 154-160Ma perché l’occhio cupido e vagante
|
Purg. XX, 13-15, 25-27, 49-51, 127-128O ciel, nel cui girar par che si creda
|
[LSA, cap. XIII, Ap 13, 18 (IVa visio, VIum prelium)] Prefatum autem cleri et regni Francie casum et aliquem alium illi annexum vel previum dicunt designari per terremotum in initio apertionis sexti sigilli tactum, quamvis etiam preter hoc designet spiritalem subversionem et excecationem fere totius ecclesie tunc fiendam. Quid autem horum erit vel non erit, dispensationi divine censeo relinquendum. Addunt etiam predicti quod tunc in parte implebitur illud Apostoli [IIa] ad Thessalonicenses II° (2 Th 2, 3), scilicet “nisi venerit discessio primum”. Dicunt enim quod tunc fere omnes discedent ab obedientia veri pape et sequentur illum pseudopapam, qui quidem erit pseudo quia heretico modo errabit contra veritatem evangelice paupertatis et perfectionis, et quia forte ultra hoc non erit canonice electus sed scismatice introductus. |
Par. XVII, 82-84, 88-90ma pria che ’l Guasco l’alto Arrigo inganni,
|
Purg. VIII, 73-75Non credo che la sua madre più m’ami,
|
Tab. 32
[LSA, prologus, Notabile VII] Huius autem figurale exemplum precessit in Veteri Testamento. Nam Eleazarus primogenitus Aaron factus est post ipsum pontifex summus, ac deinde Finees filio eius statuit Deus pactum sacerdotii eterni propter zelum Dei quem habuit contra Madianitas. Et tamen circa tempus Helii erant summi pontifices non de stirpe Eleazari, sed de stirpe Itamar fratris sui; sub David autem prelata est usque ad duplum stirps Eleazari. Nam ex tunc habuit sedecim pontifices et sedecim sortes, quarum Sadoc fuit princeps. Stirps vero Itamar non habuit nisi octo, quarum Abiatar princeps fuit, quem Salomon de pontificatu reiecit et Sadoc omnibus prefecit. Deus autem Ezechielis XLIIII° promittit quod in templo futuro, de quo ibi agitur, soli filii Sadoc erunt sacerdotes in Dei sanctuario ministrantes, reliquis vero sufficiat quod sint editui templi et ianitores portarum eius et ministri sacerdotum (Ez 44, 10-16). Constat autem quod hoc non fuit impletum usque ad tempus Christi. Nam Zacharias, pater Iohannis, fuit pontifex de octava sorte stirpis Itamar. |
|
Inf. XXVII, 106-111Allor mi pinser li argomenti gravi
|
Purg. VI, 10-12Tal era io in quella turba spessa,
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (clausura VIi sigilli)] Tertia ratio septem sigillorum quoad librum Veteris Testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. […]
|
|
Tab. 33
[LSA, prologus, Notabile VII] Consimiliter autem pontificatus Christi fuit primo stirpi vite evangelice et apostolice in Petro et apostolis datus, ac deinde utiliter et rationabiliter fuit ad statum habentem temporalia commutatus, saltem a tempore Constantini usque ad finem quinti status. Pro quanto autem multi sanctorum pontificum fuerunt regulares et in suis scriptis et in habitu sui cordis preferentes paupertatem Christi et apostolorum omnibus temporalibus ecclesie datis, pro tanto quasi usque ad duplum preeminuit primus ordo sacerdotii apostolici. Congruum est ergo quod in fine omnino redeat et assurgat ad ordinem primum, ad quem spectat iure primogeniture et perfectionis maioris et Christo conformioris. |
|
Par. II, 73-90Ancor, se raro fosse di quel bruno
|
Par. III, 10-16Quali per vetri trasparenti e tersi,
|
[LSA, cap. V Ap 5, 1] Tertia ratio septem sigillorum quoad librum Veteris Testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. […] Quintum est severitas preceptorum et iudiciorum, quia precipit “non concupisces” et “diliges Deum ex toto corde” (Dt 5, 21; 6, 5), et multa alia infirmitati humani generis ex se impossibilia, et tamen dat sententiam maledictionis omnibus qui non permanserint in omnibus verbis legis. Hanc autem temperat et exponit condescensiva Christi pietas indulgens multa infirmitatibus nostris, sicut mater infantulo suo. Et hoc notatur in quinta apertione, cum expetentibus iustitiam respondetur “ut requiescerent adhuc” per “tempus modicum, donec compleantur conservi eorum et fratres” (Ap 6, 11), id est ut propter pietatem fraterne salutis patienter differant et prolongent iudicia ultionis. |
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 19-20 (IVa visio, VIIum prelium) De quo lacu subditur (Ap 14, 19): “Et misit in lacum ire Dei magnum”. Lacus inferni dicitur lacus ire Dei, quia ibi in penis impletur effectus ire et vindicte Dei. Magnus vero dicitur, quia omnes dampnatos, qui erunt quasi innumerabiles, intra se capiet.“Et calcatus est lacus extra civitatem” (Ap 14, 20), id est extra locum et collegium beatorum, propter quod et a Christo Matthei VIII° et XXII° (Mt 8, 12; 22, 13) tenebre huius laci vocantur tenebre exteriores. Et Matthei XIII° (Mt 13, 49-50) dicitur: “Exibunt angeli et separabunt malos de medio iustorum et mittent eos in caminum ignis”. Sequitur autem tropum civitatis Iherusalem quia extra ipsam est vallis Iosaphat, que secundum Ieronimum est inter montem Sion et montem Oliveti, in qua stabunt impii in die iudicii. Et etiam Isaie XXX° (Is 30, 33) dicitur quod vallis Tophet, que est extra Iherusalem, “est preparata, profunda et dilatata”, in qua est “ignis et ligna multa” et “flatus Domini sicut torrens sulphuris”, in qua incendi debebat rex Assiriorum cum exercitu suo. |
Tab. 34 [cfr. nota espositiva]
[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 10-12.14.17.19 (VIa visio)] Et ideo convertentur ad luctum “dicentes”, scilicet plangendo : “Ve, ve, ve” (Ap 18, 10), id est summa et summe stupenda et lugenda maledictio et dampnatio est ista, scilicet “civitas illa magna Babilon, civitas illa fortis, quoniam una hora venit iudicium tuum”, id est tota dampnatio tua! Loquuntur autem primo de ea in tertia persona et postea in secunda secundum modum plangentium et stupentium, qui primo stupent secum et mox vertunt considerationem suam quasi ad personam quam plangunt. Triplicatio autem dolorose interiectionis, scilicet ipsius “ve”, significat vehementiam stuporis et planctus et casus quem plangunt et etiam consuetum modum graviter plangentium. Et potest legi: Ve, ve, ve, civitas illa magna, quomodo sic cecidit vel cecidisti! […]
|
||
Inf. I, 52-60questa mi porse tanto di gravezza
|
||
Purg. III, 133-135Per lor maladizion sì non si perde,
|
Inf. IV, 31-42
Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi 7, 13
che spiriti son questi che tu vedi?
Or vo’ che sappi, innanzi che più andi,
ch’ei non peccaro; e s’elli hanno mercedi,
non basta, perché non ebber battesmo,
ch’è porta de la fede che tu credi;
e s’e’ furon dinanzi al cristianesmo,
non adorar debitamente a Dio:
e di questi cotai son io medesmo.
Per tai difetti, non per altro rio,
semo perduti, e sol di tanto offesi
che sanza speme vivemo in disio”.
Inf. V, 126, 139-140; XXXIII, 9
dirò come colui che piange e dice ……
Mentre che l’uno spirto questo disse,
l’altro piangëa …………………………..
parlare e lagrimar vedrai insieme
Par. XXVI, 118-120
Quindi onde mosse tua donna Virgilio,
quattromilia trecento e due volumi
di sol desiderai questo concilio
[LSA, cap. V, Ap 5, 4 (radix IIe visionis)] Item fletus hic quantus fuit in sanctis patribus ante Christum; cum etiam essent in limbo inferni, quanto desiderio suspirabant ut liber vite aperiretur eis et omnibus cultoribus Dei!
Par. XXIII, 133-135; XXVII, 40-42
Quivi si vive e gode del tesoro
che s’acquistò piangendo ne lo essilio
di Babillòn, ove si lasciò l’oro.
Non fu la sposa di Cristo allevata
del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto,
per essere ad acquisto d’oro usata
Purg. XIII, 151-154
Tu li vedrai tra quella gente vana
che spera in Talamone, e perderagli
più di speranza ch’a trovar la Diana;
ma più vi perderanno li ammiragli.
12. Il lavacro pluviale e il vento dello Spirito
“Or le bagna la pioggia e move il vento” (Purg. III, 130). L’accanimento dei pastori d’anime sul corpo morto di Manfredi dissacrato, sbandito e oltraggiato dalle intemperie non è molto diverso dal governo che il vendicativo diavolo fa del cadavere di Buonconte da Montefeltro caduto a Campaldino, anch’egli come il re svevo tardivo nel pentimento, travolto dall’“Archian rubesto” gonfio per la pioggia e sospinto in Arno (Purg. V, 94-129). La citazione virgiliana relativa all’insepolto Palinuro, che impregna le parole di Manfredi – “nunc me fluctus habet versantque in litore venti” (Aen. VI, 363) -, ribadisce l’assenza di pietas da parte degli uomini di Chiesa e la sventura di chi in morte non può placidamente riposare. Ma il governo dei pastori non ha coinciso con il giudizio di Dio: “la bontà infinita ha sì gran braccia, / che prende ciò che si rivolge a lei” (Purg. III, 122-123).
La pioggia, nel caso di Manfredi, non è quella “sì spiacente” che batte in eterno Ciacco (Inf. VI, 46-48); è piuttosto un lavacro purgativo. Il sangue di Cristo ha lavato i peccati, come i lebbrosi vengono sanati nel bagno di sangue caldo (Ap 1, 5). La dottrina di Cristo è pioggia che irriga, come la “voce di molte acque” che distilla nel cuore e reca refrigeranti lacrime e sospiri (Ap 1, 15; 14, 2). La pioggia, fraternamente caritatevole, feconda la terra, la cui fertilità prepara il solare terzo stato generale del mondo, l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore (Ap 10, 1; 14, 14-17). Gli stessi martìri sono purgativi, agiscono contro il torpore mentale (Ap 2, 1).
Il vento, che muove le ossa di Manfredi, è anche quello dello Spirito, di cui parla Ezechiele citato ad Ap 7, 1: “Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano” (Ez 37, 9).
Pioggia in assenza di vento è componente delle pene infernali (Inf. XIV, 28-30: “Sovra tutto ’l sabbion, d’un cader lento, / piovean di foco dilatate falde, / come di neve in alpe sanza vento”, dove la neve fa segno della rigida giustizia, designata dai capelli di Cristo ad Ap 1, 14).
Il soffiare del vento dello Spirito, congiunto con il tema del fiato che procede dalle trombe dei dottori che si apprestano a emettere l’intelligenza spirituale (Ap 8, 6), ha la sua metamofosi in versi che cantano il farsi strada del linguaggio, il passaggio di fuori, spesso faticoso, della voce. I dottori che si preparano all’opera fanno seguito ai tuoni, alle voci, ai lampi e al terremoto che ad Ap 8, 5 si dice causati dal “mettere in terra” il fuoco da parte dell’angelo col turibolo, cioè dall’invio degli apostoli alla predicazione delle genti. La sequenza folgore-voce-tuono-terremoto, che compare anche in altri luoghi dell’Apocalisse, significa che l’ascolto dell’eloquio folgorante, alto (proprio del tuono) e discreto (proprio della “voce”, moderata e razionale, come quella umana) dei dottori muove i cuori degli uomini alla penitenza e alla conversione a Cristo, per cui mutano la precedente vita, scossi da un forte terremoto interiore (la “fortis concussio et commotio terrenorum cordium” ad Ap 11, 19). Il vento soffia forte dal tronco che incarcera Pier della Vigna e si converte in voce (Inf. XIII, 91-92). La fiamma di Ulisse, al richiamo fatto da Virgilio ai propri “alti versi”, “cominciò a crollarsi mormorando, / pur come quella cui vento affatica”, gettando voce di fuori “come fosse la lingua che parlasse” (Inf. XXVI, 85-90). Come l’alto eloquio dei dottori genera un terremoto di conversione a Cristo verso il quale si muovono i cuori, così per un momento la fiamma di Ulisse subisce un terremoto interiore e, agitata dal vento dello Spirito, parla. Parlare appartiene al sesto stato, il momento storico nel quale il mondo e le coscienze si rinnovano; esso libera la favella, grazie alla poesia che rinfresca la fama e conforta la memoria. Non diversamente da Ulisse, si scuote convertendosi (“in suo linguaggio / si convertïan le parole grame”) la fiamma di Guido da Montefeltro, nel dare fiato dopo molto rugghiare (Inf. XXVII, 13-15, 58-63).
Tab. 35
[LSA, cap. I, Ap 1, 5 (septem notabiles primatus Christi secundum quod homo)] Quinto primatum nostre iustificationis et redemptionis, quam iustificationem tangit dicendo: “et lavit nos a peccatis nostris”; redemptionem vero cum subdit: “in sanguine suo”, id est in merito sue passionis et mortis cuius modum et speciem exprimit sanguis effusus. Servat autem methaforam leprosorum, qui per balneum sanguinis mundi et calidi expurgantur et sanantur. Premisit autem “qui dilexit nos”, ad monstrandum quod ipse nos redemit et lavit non ex sua necessitate vel utilitate, vel ex debito vel ex timore aut ex coactione, sed ex sua sola misericordia et gratuita caritate. |
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 15 (Ia visio)] Septima (perfectio summo pastori condecens) est sue doctrine celebris resonantia et irrigatio fecunda, unde subdit: “et vox illius tamquam vox aquarum multarum”, id est sicut vox pluviarum inundantium et impetus fluminum et marinorum fluctuum et rugituum, sic enim ab ipso et ab eius scripturis et doctoribus manat vox predicationis irrigantis et comminantis.[LSA, Ap 10, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] Habuit etiam “irim in capite”, id est arcualem refulgentiam solis, quia viscerosa caritas Christi ad nostras inferiores miserias aperta et arcualiter dilatata fuit assidue et intime impressa menti Francisci. […] Sicut enim nubes est supra inter nos et celum suscipiens solis radios et contemperans nobis eos, et est purgans aquis pluvialibus et fecundis ipsasque ad fructificationem terre nascentium moderate effundens, sic est hec scriptura sacra spiritualiter; in caritate etiam et sapientia Dei erit ut sol ad irradiandum finaliter totum orbem et ad formandum solarem diem tertii generalis status mundi.
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 1-2 (IVa visio)] Tertium est fidei et amoris et contemplationis Dei Patris et Filii humanati in istorum corde et ore singularis et patens inscriptio et expressio, unde subditur: “habentes nomen eius et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis”.
|
Par. XXIV, 91-93 ………… E io: “La larga ploia
|
Purg. XXX, 85-87, 91-99; XXXI, 19-21Sì come neve tra le vive travi
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 14-17.20 (IVa visio, VIIum prelium)] “Et vidi et ecce nubem candidam et super nubem sedentem similem Filio hominis, habentem in capite suo coronam auream et in manu sua falcem acutam” (Ap 14, 14). […] Item (Ioachim) post dicit quod in duobus angelis habentibus falces designantur aliqui ordines, quorum primus (cfr. Ap 14, 14) erit mitior et suavior ad colligendas segetes electorum quasi in spiritu Moysi, secundus (cfr. Ap 14, 17) vero erit ardentior et ferocior ad secandam vindemiam reproborum ac si in spiritu Helie, dicitque quod in primo intelligendus est aliquis ordo futurus perfectorum virorum servantium vitam Christi et apostolorum, in secundo vero aliquis ordo heremitarum emulantium vitam angelorum, unde et dicitur egressus esse “de templo quod est in celo”. Primus enim manifestus apparet, quia illi qui militant Deo ad utilitatem et eruditionem plebium sunt in conspectu ips[arum] dati, ut accipiant ab illis salutis monita et pie conversationis exempla. Alius vero de celo, ubi manebat occultus, est repente egressus, quia qui solitudinis remotiora et secretiora petunt, si quando egrediuntur ad homines, veluti de archanis celorum advenisse putantur, adeo ut multorum corda timore concutiantur admirantium tam perfectionem vite quam novitatem presentie. Et subdit: «Puto quod in tempore illo vita priorum erit quasi imber ad irrigandum superficiem terre in omni perfectione caritatis fraterne; vita autem anachoritarum seu secundorum erit quasi ignis ardens in amore et zelo Dei ad comburendum tribulos et spinas, ne mali abutantur amplius patientia Dei. Et fortassis isti duo erunt illi qui occidentur a bestia (cfr. Ap 11, 7)». […]
|
|
Inf. XIV, 28-30Sovra tutto ’l sabbion, d’un cader lento,
|
Purg. XXXII, 109-111Non scese mai con sì veloce moto
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 14 (radix Ie visionis)] Quarta (perfectio summo pastori condecens) est reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas per senilem et gloriosam canitiem capitis et crinium designata, unde subdit: “caput autem eius et capilli erant candidi tamquam lana alba et tamquam nix” (Ap 1, 14). Per caput vertex mentis et sapientie, per capillos autem multitudo et ornatus subtilissimorum et spiritua-lissimorum cogitatuum et affectuum seu plenitudo donorum Spiritus Sancti verticem mentis ador-nantium designatur.
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 1 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] “Post hec vidi” et cetera (Ap 7, 1). Hic ostenditur quomodo, post prefatum iudicium et exterminium carnalis ecclesie, nitentur demones et homines impii impedire predicationem fidei et conversionem gentium ad fidem et etiam conservationem fidelium in fide iam suscepta. Unde ait: “Post hec”, id est post predictum iudicium, “vidi quattuor angelos stantes super quattuor angulos terre”. […]
|
Tab. 36
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 5-6 (IIIa visio, radix)] “Et accepit angelus turibulum” aureum (Ap 8, 5), id est in resurrectione resumpsit seu reunivit sue anime corpus suum, “et implevit illud de igne altaris”. […] Vel prout per turib[u]lum intelligitur apostolicus cetus, quia sicut per auctoritatem apostolicam et per Spiritus Sancti gratiam eis copiosius datam fecit eos pontifices ad offerendum Deo electorum preces, sic eos ad zelum predicationis et inflammationis animarum accendit et ignivit et spiritali et ignita sapientia illustravit, quando de igne Spiritus Sancti, quo ipse erat fontaliter plenus, eos implevit. Et secundum hoc ipsemet est altare de quo ignem derivavit in illos, “et misit in terram”, scilicet per eos predicantes, et non solum per verba sed per miracula et per sanctitatis exempla et caritatis beneficia corda gentium inflammantes. Vel secundum primum modum, “misit in terram” quando in ipsos prius idiotas et animales Spiritum effudit, et per eorum ministerium in ceteros.
|
||
Inf. XIII, 40-44, 91-92, 136-138Come d’un stizzo verde ch’arso sia
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 1 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Item per hos quattuor ventos intelliguntur omnes spirationes Spiritus Sancti, secundum illud Ezechielis XXXVII°: “A quattuor ventis veni, spiritus, et insuffla super interfectos istos et reviviscant” (Ez 37, 9). Unus enim ventus est ab oriente humilis incarnationis Christi et nostre vilis originis. Alius vero est ab occidente mortis Christi et nostre miserabilis mortis. Alius vero ab aquilone temp-tationum Christi et nostrarum. Quartus vero est a meridie caritatis et glorie Christi nobis promisse.[Olivi, Postilla in Isaiam, ed. D. Flood – G. Gál, St Bonaventure, New York 1997, p. 220: «Unde et mentes spiritu isto alte afflatae vix possent se subicere et coartare legibus et limitibus humani sermonis. Tanta enim est libertas affectus eorum et tanta agilitas et vivacitas in internis sensibus eorum quod instar venti aut faculae flammeae subitissime hinc inde moventur, nunc ad hoc, nunc ad illud, et hinc manat illa divina et supereminens eloquentia prophetarum et apostolorum […]»][LSA, cap. XI, Ap 11, 19 (radix IVe visionis)] “Et terremotus”, id est fortis concussio et commotio terrenorum cordium ad penitentiam et ad im-mutationem status in melius.
Inf. XXV, 7-9, 79-81e un’altra a le braccia, e rilegollo,
|
|
13. Quasi lungo ’l Verde
La terza e la quarta guerra vengono da Olivi trattate congiuntamente (a differenza di Gioacchino da Fiore), in quanto si tratta di due stati della Chiesa concorrenti.
La guerra è condotta contro la donna (la Chiesa), fuggita nel deserto dei Gentili dal drago che voleva divorarne il figlio, dove rimane per 1260 anni, un periodo corrispondente all’espressione “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” (Ap 12, 3-6; cfr. infra). Alla donna sono date due ali di una grande aquila (Ap 12, 14), cioè la dottrina dei dottori del terzo stato e la devota vita dei contemplativi del quarto, due stati di solare sapienza, interpretati da Olivi anche come intelletto e affetto, Impero e Papato. Ad Ap 12, 15 viene specificato il modo della persecuzione: “Allora il serpente emise dalla sua bocca come un fiume d’acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle acque”. Con l’acqua serpentina viene indicata la dottrina erronea (nella terza guerra diretta contro la sincera e sana dottrina dei santi dottori) e anche la copiosa e voluttuosa affluenza dei beni temporali (nella quarta guerra condotta contro l’austera e povera vita dei santi anacoreti).
Secondo Gioacchino da Fiore, la violenta acqua del fiume non designa in generale le eresie, perché non tutte operarono con violenza, ma in modo specifico la perfidia ariana, la quale tramite imperatori e re perseguitò atrocemente la Chiesa. Così non tutti i beni temporali necessari al sostentamento arrecarono violenza come i possessi, le città, i castelli e i beni preziosi che con Costantino cominciarono a essere dati in offerta alla Chiesa. Poiché il diavolo effuse dolosamente il veleno dell’errore e l’abbondanza delle ricchezze sotto l’apparenza del vero e del bene e quasi fossero in ossequio della Chiesa, per la dottrina della fede e del culto divino, viene detto che il serpente emise il fiume non dinanzi ma dietro alla donna. Lo stare dietro dell’acqua indica anche che il diavolo non poté impedire che quanto essa portava venisse disprezzato dalla santa Chiesa, come cosa che sta dietro e che si lascia dietro le spalle.
“Ma la terra venne in aiuto della donna, aprì la sua bocca e inghiottì il fiume” (Ap 12, 16). Secondo Gioacchino da Fiore, la terra designa il complesso degli uomini peccatori i quali, assorbendo le eresie o i beni temporali, aiutarono la Chiesa in quanto i buoni, di fronte alle gravi cadute dei reprobi, divennero più discreti, cauti e zelanti: la caduta di alcuni scuote infatti di timore gli altri, che cercano di evitare di cadere nella medesima colpa di cui i reprobi sono accusati.
Secondo Riccardo di San Vittore, la moltitudine terrena di quanti assorbono le tentazioni del diavolo aiutò la Chiesa come un dolce fiume, perché il diavolo, impegnato a tentare, attrarre e conservare a sé quella moltitudine, poté dedicarsi meno a tentare gli eletti.
Oppure, sempre secondo Riccardo, l’unione di quanti sono perfetti e stabili nella fede è la terra umile e solida che prega all’unisono contro le tentazioni del diavolo e così con la bocca quasi assorbe o distrugge il fiume.
Olivi aggiunge che se il fiume viene interpretato come l’abbondanza dei beni temporali, allora la terra, cioè gli avari e i cupidi di cose terrene, aiutò la Chiesa perché a causa dell’avarizia diminuì l’offerta di beni e di conseguenza si ridusse il loro possesso. Se il fiume viene interpretato come la dottrina erronea, la terra fu di aiuto in quanto la Chiesa, accortasi che il fiume dell’errore veniva inghiottito solo dai terrestri assai lontani dal cielo e dalla sapienza e dalla vita celeste, fu assai aiutata ad aborrire tale fiume, il cui bere rendeva aridi, terreni, idropici, inflati, lebbrosi e fedi.
Il diavolo che effonde dolosamente l’abbondanza delle ricchezze, sotto l’apparenza del vero e del bene e quasi fossero in ossequio della Chiesa, per la dottrina della fede e del culto divino, è tema che ritorna due volte nel poema a proposito della donazione costantiniana: nella piuma lasciata dall’aquila che soffoca il carro-Chiesa militante, “offerta / forse con intenzion sana e benigna” (Purg. XXXII, 137-138), e nella “buona intenzion che fé mal frutto”, per cui l’aquila giustifica la salvezza di Costantino, nonostante il male dedotto dal suo bene operare abbia distrutto il mondo (Par. XX, 55-60). Sulla donazione costantiniana Olivi non concorda del tutto con Gioacchino da Fiore, in quanto nel Notabile VII del prologo della Lectura ritiene utile e ragionevole la condizione temporale della Chiesa a partire da Costantino, dopo il periodo iniziale, apostolico e subapostolico, di povertà (in attesa del ritorno, nel sesto stato, alle origini povere): “[…] pontificatus Christi fuit primo stirpi vite evangelice et apostolice in Petro et apostolis datus, ac deinde utiliter et rationabiliter fuit ad statum habentem temporalia commutatus, saltem a tempore Constantini usque ad finem quinti status”. Dante è, come noto, di tutt’altro avviso, che si rispecchia nella citazione di Gioacchino.
Delle varie interpretazioni offerte dall’esegesi di Ap 12, 16 – la terra che venne in aiuto della donna aprendo la bocca e inghiottendo il fiume – la traccia più evidente sta nell’atto di Virgilio che, di fronte alle bocche aperte di Cerbero, “distese le sue spanne, / prese la terra, e con piene le pugna / la gittò dentro a le bramose canne”: al gesto le facce lorde del demonio si racquetano come quella di un cane tutto inteso e affaticato nel divorare il pasto per il quale ha prima abbaiato (Inf. VI, 25-33). Il gesto di Virgilio riecheggia certo quello della Sibilla che getta nelle gole di Cerbero una focaccia soporifera (Aen. VI, 417-425), ma il prendere la terra da parte del poeta pagano e la similitudine del cane sono immagini che trasformano in poesia l’interpretazione data da Riccardo di San Vittore, secondo il quale la terra, cioè la moltitudine terrena di quanti assorbono le tentazioni, aiutò la Chiesa perché il diavolo, impegnato a tentare, ad attrarre e conservare a sé quella moltitudine poté dedicarsi meno a tentare gli eletti, che nel caso sono Virgilio e Dante. Virgilio si aiuta con la stessa terra nauseabonda (che “pute”; la terra è umile, dunque ‘soffre’: cfr. Purg. V, 119-120) la quale assorbe la pioggia che percuote i golosi [1]. I golosi sono topograficamente collocati nella zona dedicata al terzo stato nel primo dei cinque cicli settenari dell’Inferno.
L’altra interpretazione, quella di Gioacchino da Fiore, per cui la terra designa i peccatori che aiutarono la Chiesa poiché i buoni, di fronte alla loro grave caduta, furono scossi da timore nell’evitare di cadere nella medesima colpa, si trova nello stare di Dante “come l’uom che teme” dopo aver fatto cadere la scheggia rotta dal gran pruno che incarcera Pier della Vigna, dalla quale escono insieme parole e sangue (Inf. XIII, 43-45). Anche in questo caso c’è una presenza virgiliana – il “frigidus horror” provato da Enea nell’episodio di Polidoro (Aen. III, 29-30, 47-48) -; il tema della terra che aiuta è utilizzato nei suoi sviluppi esegetici, non però nel nucleo scritturale, non essendoci nei versi alcun riferimento alla terra o all’aiutare. I suicidi sono topograficamente collocati nella zona dedicata al terzo stato nel secondo dei cinque cicli settenari dell’Inferno.
Secondo Riccardo di San Vittore, l’unione di quanti sono perfetti e stabili nella fede è la terra umile e solida che prega all’unisono contro le tentazioni del diavolo e così con la bocca quasi assorbe o distrugge il fiume. Questa interpretazione del Vittorino è vestita con l’immagine della Terra che devota prega perché Giove intervenga sul carro del Sole ‘sviato’ da Fetonte (fattosi ‘eretico’, Purg. XXIX, 119). E non solo di eresia si tratta, perché la quarta guerra è condotta per mezzo delle ricchezze: le due guerre si rispecchieranno, tre canti più avanti, nella volpe e nella “piuma” lasciata dall’aquila al carro della Chiesa, “offerta / forse con intenzion sana e benigna” (Purg. XXXII, 118-120, 124-129, 137-138).
L’aiutare da parte della terra potrebbe pure ritrovarsi nel grido “Buon Vulcano, aiuta, aiuta!” da parte di Giove impegnato nella battaglia di Flegra contro i giganti i quali, come i Ciclopi che lavoravano “in Mongibello a la focina negra”, erano “figli della terra” (Inf. XIV, 57; cfr. XXXI, 121). La terra ‘aiutò’ il cielo non inviando Anteo ai campi di Flegra, come ricordato da Lucano (Phars. IV, 596-597).
Il motivo della terra che aiuta la Chiesa degli eletti, “quasi dulce flumen”, conduce alle parole di Manfredi sul proprio corpo trasmutato “a lume spento”, per l’eccesso di zelo da parte del vescovo di Cosenza verso un morto scomunicato, dall’originaria sepoltura: “l’ossa del corpo mio sarieno ancora / in co del ponte presso a Benevento, / sotto la guardia de la grave mora. / Or le bagna la pioggia e move il vento / di fuor dal regno, quasi lungo ’l Verde”, in un luogo sconosciuto presso il Liri (Purg. III, 124-132; il canto si colloca’topograficamente’ nel terzo stato della Chiesa). Al di là della sua identificazione geografica, il “Verde” allude al colore verde, graziosissimo agli eletti, che nel quarto capitolo è tema della sede, circondata dall’iride simile allo smeraldo, su cui siede Dio dall’aspetto di pietra di diaspro (Ap 4, 3). L’inciso “quasi lungo ’l Verde”, dopo il riferimento alle ossa bagnate dalla pioggia e mosse dal vento, sembra posto a contrastare gli effetti di una dannazione voluta dal papa e dal vescovo ma non dalla misericordia divina. Il nome del fiume anticipa pertanto il motivo della celebre terzina seguente, in cui il re svevo afferma che la scomunica dei pastori non impedisce il ritorno dell’“etterno amore, / mentre che la speranza ha fior del verde”. |
[1] Cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, cap. 2. 10. Olivi sottolinea il modo di procedere dell’autore dell’Apocalisse, il quale nella bestia che sale dal mare di Ap 13, 1-2 ha concentrato elementi propri di tutte le bestie della visione di Daniele 7, 3-7. Un metodo che si ritrova già nelle tre fiere che impediscono a Dante la salita del “dilettoso monte”. Nella figura di Cerbero (Inf. VI, 13-18) sono riunite qualità di differente provenienza. Il mostro infernale è collocato in una zona in cui prevalgono temi propri del terzo stato della Chiesa, dei quali è quasi emblema nel graffiare, iscoiare e isquatrare le anime. Esso tuttavia contiene elementi che caratterizzano l’apertura di tutti e tre sigilli in cui compaiono eserciti contrari a Cristo. Gli occhi “vermigli” e le mani “unghiate” sono propri del secondo sigillo (il cavallo rosso, l’orso), la “barba unta e atra” del terzo (il cavallo nero), il “ventre largo” è qualità dei Saraceni dei quali, nell’esegesi della quarta chiesa (Ap 2, 22) si dice con san Paolo che “hanno il ventre per loro Dio e per loro gloria” (Ph 3, 19). Inoltre Cerbero, che latra con “tre gole”, è “fiera crudele e diversa”, cioè “dissimilis”, come la quarta bestia di Daniele lo è dalle altre tre precedenti (“Uomini diversi / d’ogne costume” sono pure definiti i Genovesi a Inf. XXXIII, 151-152).
I tre eserciti contrari a Cristo, designati rispettivamente all’apertura del secondo, del terzo e del quarto sigillo con il cavallo rosso, il cavallo nero e il cavallo pallido, si trasformano nelle tre facce di Lucifero (Inf. XXXIV, 39-45): la prima vermiglia, la seconda nera, la terza tra bianca e gialla.
Tab. 37
[LSA, cap. XII, Ap 12, 13.15-16 (IVa visio, III–IVum prelium)] Sequitur de tertio prelio, in quo diabolus contra ecclesiam effudit flumina errorum seu heresum, et etiam de quarto, in quo ad eam submergendam effudit flumina temporalium divitiarum. Unde subdit: “Et postquam vidit dracho quod proiectus esset in terram, persecutus est mulierem que peperit masculum” (Ap 12, 13). […] Deinde subditur modus quo diabolus tunc persecutus est eam, cum subditur: “Et misit serpens ex ore suo post mulierem aquam tamquam flumen, ut eam faceret trahi a flumine” (Ap 12, 15). Per aquam serpentinam designatur hic doctrina erronea, et etiam temporalium copiosa et voluptuosa affluentia. Primum autem est directius contra sinceram et sanam doctrinam sanctorum doctorum, secundum autem contra austeram et pauperem vitam sanctorum anachoritarum. Secundum autem Ioachim, quia aqua fluminis est violenta, non omnes autem heretici violentiam in sanctam ecclesiam facere potuerunt; ideo hic proprie per aquam fluminis designatur Arrianorum perfidia*, que habens multos imperatores et reges et regna maxima[m] atrocis persecutionis violentiam intulit ecclesie Dei. Sic etiam non quecumque temporalia ad victum necessaria inferunt talem violentiam sicut faciunt ample possessiones et urbes et castra et multa ac pretiosa mobilia, que utique a tempore Constantini ceperunt ecclesie offerri et dari. Quia vero sub quadam specie veri et boni, et quasi in obsequium ecclesie quoad doctrinam fidei et quoad cultum Dei, diabolus latenter et dolose effudit venenum errorum et multorum vitiorum copie temporalium annexorum, ideo non dicitur serpens misisse flumen ante faciem mulieris, sed post mulierem. Dicitur etiam hoc quia non potuit diabolus facere quin a sancta ecclesia spernerentur, quasi posteriora et quasi post tergum reiecta.
|
||
Purg. XXXII, 136-141; Par. XX, 55-57Quel che rimase, come da gramigna
|
Inf. VI, 10-12, 25-33Grandine grossa, acqua tinta e neve
|
|
Purg. III, 124-132Se ’l pastor di Cosenza, che a la caccia
|
Inf. VII, 7; XII, 40; XIV, 13; XXIX, 124; XXX, 52, 112, 119: (hapax)
Poi si rivolse a quella ’nfiata labbia
da tutte parti l’alta valle feda
Lo spazzo era una rena arida e spessa
Onde l’altro lebbroso, che m’intese
La grave idropesì ……………………….
E l’idropico: “Tu di’ ver di questo”
rispuose quel ch’avëa infiata l’epa
[Ap 12, 16] […] reddidit eos aridos et terrestres et ydropicos et inflatos ac leprosos et fedos
Tab. 37 bis
[LSA, cap. XIII, Ap 13, 1-2] Sequendo autem primum modum, dicit Ioachim quod primum caput bestie, respectu septem statuum ecclesie Christi, fuit plebs iudaica, iuxta sextam visionem Danielis assimilata le[e]ne habens Phariseos et Scribas quasi alas aquile (cfr. Dn 7, 4).
|
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 3] Notandum autem quod in prima apertione non expressit aliquem ducem et exercitum malum Christo et eius exercitui oppositum, sed solum Christum et eius exercitum in equo albo designatum; in tribus vero sequentibus, secundum omnes expositores, principaliter exprimit duces et exercitus oppositos Christo. Cuius ratio, secundum Ioachim, est quia id ipsum quod Danielis septimo (Dn 7, 5-7) designatur per pardum et ursum et per bestiam quartam dissimilem ceteris, designatur hic per equum rufum et per nigrum et per pallidum. |
Nam sicut per equum rufum designatur paganorum populus sanguine martirum cruentatus, et per eius sessorem imperator romanus et etiam diabolus quem in idolis colebant, sic per ursum designatur idem paganorum regnum habens tres ordines dentium, scilicet pontifices ido-lorum et eorum opifices et paganorum principes, qui princi-palius insanierunt contra martires et ceteros instigaverunt contra eos, unde et dicebant urso: “Surge et comede carnes plurimas”, scilicet sanctorum martirum (Dn 7, 5). |
Sicut vero per equum nigrum designatur hereticorum cetus astutia profunda obscurus et errore perfidie obtenebratus, sic et per pardum variis maculis, id est variis fraudibus, infectum. |
Sicut etiam per equum pallidum, cuius sessor est mors, designatur Sarracenorum populus et eius propheta mortiferus, sci-licet Mahomet, sic et per quartam bestiam dissimilem ceteris. |
Nam primus (exercitus), scilicet paganicus, per potentiam et violentiam impugnavit martires. […]
|
Secundus vero, scilicet hereticorum, non cum tanta potentia, sed potentie malignam adiungens malitiam, impugnavit fideles. […]
|
Tertius vero, scilicet sarracenic[us] vel secundum alios ypocritarum cuneus, per legem fictam et carnalem vel per simulationem sanctitatis dolosam impugnavit sanctam legem et vitam. […]
|
Inf. XXXIV, 39, 55-57L’una dinanzi, e quella era vermigliaDa ogni bocca dirompea co’ denti
|
Inf. XXXIV, 44-45la sinistra a vedere era tal, quali
|
Inf. XXXIV, 43e la destra parea tra bianca e gialla |
Inf. VI, 13-18Cerbero, fiera crudele e diversa,
|
||
[LSA, cap. II, Ap 2, 22 (Ia visio, IVa ecclesia)] Potest tamen per hanc Iesabelem intelligi gens sarracenica, que gloriatur se habere Mahomet pro propheta, cuius lex carnalia promittit et docet, que utique surrexit quarto tempore ecclesie. Nota etiam quod omnes hereses, de quibus fit in istis ecclesiis mentio, leguntur dedite voluptati et carnalitati. Nam et de pseudoapotolis dicitur ad Philippenses III° quod “venter est eorum deus et gloria” (Ph 3, 19). Quamvis enim quedam secte hereticorum fingant ad tempus magnam castitatem et austeritatem, finaliter tamen occulte vel publice ad carnalia currunt. Unde IIa ad Timotheum III° dicitur de eis quod erunt “se ipsos amantes” et “voluptatum amatores” (2 Tim 3, 2/4). Et IIa Petri II° de ipsis dicitur quod “multi sequentur eorum luxurias, per quos via veritatis blasphemabitur” (2 Pt 2, 2), et infra eodem dicit multa plura de hoc, et idem dicitur in epistula Iude (Ju 1, 12). Nec mirum, quia qui veras et spiritales delicias in Deo et ex Deo non gustant nec hauriunt oportet eos in terrenis et carnalibus querere voluptatem, quamvis propter ambitionem inanis glorie sepe exterius se affligant. |
||
14. “Un tempo, due tempi e la metà di un tempo”
Nell’esegesi della terza e quarta guerra si dice che la donna (la Chiesa), volata nel luogo per lei preparato (il deserto dei Gentili; cfr. supra), venne ivi nutrita “per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente” (Ap 12, 14). L’espressione “per un tempo, due tempi e la metà di un tempo” indica un periodo di tre anni e mezzo, formati da quarantadue mesi (12 x 3 + 6) nei quali i trenta giorni corrispondono a trenta anni: si ha così un periodo di permanenza della donna nel deserto di 1260 anni. “Tempus” sta per un anno, “tempora” per due anni (corrisponde al duale greco) e “dimidium temporis” per sei mesi.
Fra i vari significati, i tre anni e mezzo designano la perfezione che deriva dalla fede, dalla speranza e dalla carità unita alla pregustazione non completa della gloria eterna. Coincidono con il periodo in cui Cristo esercitò il suo magistero e la sua predicazione. Essi sono anche distinti in “un anno” (“tempus”) e “due anni” (“tempora”), in quanto nel secondo e nel terzo anno Cristo predicò da solo dopo l’incarcerazione di Giovanni Battista e in modo più solenne. Con Giovanni Battista, come dice Cristo in Matteo 11, 11-12 e in Luca 16, 16, inizia il tempo in cui i violenti si impadroniscono del regno dei cieli (cfr. quanto dice l’aquila a Par. XX, 94: “Regnum celorum vïolenza pate”).
Questa numerologia mistica subisce numerose metamorfosi. Una è nella spiegazione data da Manfredi della penitenza impostagli come scomunicato: chi muore in contumacia di Santa Chiesa, ancorché si penta in fin di vita, “per ognun tempo” (qui inteso non nel senso di “un anno”, ma di periodo complessivo) che è stato “in sua presunzïon”, ostinato cioè nel non volersi sottomettere all’autorità ecclesiastica, deve restare fuori del purgatorio trenta volte (il numero trenta fa parte del numero mistico 1260; Cristo fu battezzato a trent’anni, nel Nuovo Testamento nessuno può assumere il sacerdozio e generare figli spirituali prima di aver raggiunto questa età), a meno che questo decreto (il tema della legge o dei decreti ecclesiastici appartiene allo stato dei dottori, Notabile XIII) non venga abbreviato (la “metà di un tempo”) per l’intervento delle buone preghiere (Purg. III, 136-141). Il re svevo deve dunque attendere, fuori della “porta di san Pietro”, l’età per rapire il regno dei cieli. Manfredi venne scomunicato il 10 aprile 1259, morì a Benevento il 26 febbraio 1266; visse con l’anatema poco meno di sette anni.
Tab. 38
[LSA, cap. XII, Ap 12, 14 (IVa visio, III-IVum prelium)] Dicit autem “per tempus et tempora et dimidium temporis”, id est per tres annos et dimidium ex quadraginta duobus mensibus triginta annorum, id est mille ducentis sexaginta annis constantes. Eundem enim numerum sub aliis verbis intendit hic ponere, quem posuit paulo ante (cfr. Ap 12, 6). Per “tempus” enim intelligitur unus annus, et per “tempora” duo ann[i]. Nam Greci, in quorum lingua iste liber est editus, habent tres numeros in suis articulis, scilicet singularem et dualem et pluralem. Quod autem “tempus et tempora et dimidium temporis” sumatur alibi pro tribus annis et dimidio, patet quia Danielis VII° dicitur quod rex undecimus, designatus per undecimum cornu, “sanctos Altissimi conteret et tradentur in manu eius usque ad tempus et tempora et dimidium temporis” (Dn 7, 25). In hoc autem libro et infra, XIII° capitulo, dicitur quod “data est illi potestas facere malum per menses quadraginta duos” (Ap 13, 5) et idem dicitur supra, XI° (Ap 11, 2.9.11). Quod autem “tempus et tempora”, id est tres anni, non sumantur hic pro annis dierum seu mensium ex solis triginta diebus constantium, se[d] potius pro annis duodecim mensium ex triginta annis quasi ex triginta diebus constantium, patet non solum ex supradictis, sed etiam quia in tertio et quarto statu ecclesie non apparuit talis persecutio vel mansio in deserto per solos tres annos dierum perdurans. Preterea hic non dicit ‘ubi aletur per tempus et tempora’, sed “ubi alitur”, tamquam monstrans se loqui de toto tempore pastus eius, de quo supra dixerat quod “habet” in deserto “locum paratum a Deo, ut ibi pascat eam mille ducentis sexaginta diebus” (Ap 12, 6).
|
||
Inf. XXXIV, 22-24, 37-45, 55-67Com’ io divenni allor gelato e fioco,
|
||
Purg. III, 136-141Vero è che quale in contumacia more
|
Purg. VI, 139-144
Atene e Lacedemona, che fenno
l’antiche leggi e furon sì civili,
fecero al viver bene un picciol cenno
verso di te, che fai tanto sottili
provedimenti, ch’a mezzo novembre
non giugne quel che tu d’ottobre fili.
Purg. XII, 43-45
O folle Aragne, sì vedea io te
già mezza ragna, trista in su li stracci
de l’opera che mal per te si fé.
Inf. XI, 79-84
Non ti rimembra di quelle parole
con le quai la tua Etica pertratta
le tre disposizion che ’l ciel non vole,
incontenenza, malizia e la matta
bestialitade? e come incontenenza
men Dio offende e men biasimo accatta?
Inf. XXVIII, 7-24
S’el s’aunasse ancor tutta la gente
che già, in su la fortunata terra
di Puglia, fu del suo sangue dolente
per li Troiani e per la lunga guerra
che de l’anella fé sì alte spoglie,
come Livïo scrive, che non erra,
con quella che sentio di colpi doglie
per contastare a Ruberto Guiscardo;
e l’altra il cui ossame ancor s’accoglie
a Ceperan, là dove fu bugiardo
ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo,
dove sanz’ arme vinse il vecchio Alardo;
e qual forato suo membro e qual mozzo
mostrasse, d’aequar sarebbe nulla
il modo de la nona bolgia sozzo.
Già veggia, per mezzul perdere o lulla,
com’ io vidi un, così non si pertugia,
rotto dal mento infin dove si trulla.
Inf. XIX, 79-84
Ma più è ’l tempo già che i piè mi cossi
e ch’i’ son stato così sottosopra,
ch’el non starà piantato coi piè rossi:
ché dopo lui verrà di più laida opra,
di ver’ ponente, un pastor sanza legge,
tal che convien che lui e me ricuopra.
Par. XIX, 133-138
e a dare ad intender quanto è poco,
la sua scrittura fian lettere mozze,
che noteranno molto in parvo loco.
E parranno a ciascun l’opere sozze
del barba e del fratel, che tanto egregia
nazione e due corone han fatte bozze.
Par. XXXIII, 73-75, 106-108, 115-123
ché, per tornare alquanto a mia memoria
e per sonare un poco in questi versi,
più si conceperà di tua vittoria.
Omai sarà più corta mia favella,
pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante
che bagni ancor la lingua a la mammella
Ne la profonda e chiara sussistenza
de l’alto lume parvermi tre giri
di tre colori e d’una contenenza;
e l’un da l’altro come iri da iri
parea reflesso, e ’l terzo parea foco
che quinci e quindi igualmente si spiri.
Oh quanto è corto il dire e come fioco
al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi,
è tanto, che non basta a dicer ‘poco’.
[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio, III-IVum prelium)] Notandum autem quod Ioachim totum librum suum Concordie Veteris et Novi Testamenti fundavit super numero hic posito. Unde libro V° Concordie, circa finem pertractans verba illa angeli dicta Danieli, quod “in tempus et tempora et dimidium temporis” erit “finis horum mirabilium” (Dn 12, 6-7), dicit: «Verba hec Danielis ita a lectore huius operis pensari debere vellem, ut quicquid a principio huius operis usque huc late et diffuse contulimus sub uno quam brevi coart[ar]emus sermone. Nichil enim aliud nos intimasse credimus, nisi hoc quod sonat versiculus iste: ‘in tempus et tempora et dimidium temporis omnium istorum mirabilium esse finem’. Quia sicut iam per multas vices nos dixisse meminimus, in hiis quadraginta duabus generationibus septem signacula continentur, nichilque aliud est dicere “in tempus et tempora et dimidium temporis” complebuntur quam illud quod, sub sexto angelo tuba canente, alter angelus aut forte unus et idem ait: “tempus iam non erit amplius, sed in voce septimi angeli, cum ceperit tuba canere” (Ap 10, 6-7)»*.
* Concordia, V 6, c. 4 § 8; Patschovsky 3, pp. 1009, 10-17–1010, 1-6.
15. Pregare perché altri preghino
Per abbreviare la sua attesa, Manfredi prega Dante di rivelare “a la mia buona Costanza / come m’hai visto, e anco esto divieto; / ché qui per quei di là molto s’avanza” (Purg. III, 142-145). Il motivo dell’offerta e del pregare altri perché offrano o preghino, tema ricorrente nella seconda cantica, rinvia ad Ap 8, 3, nell’esegesi della “radice” della terza visione, dove a Cristo, angelo che sta dinanzi all’altare, “furono dati molti incensi”, cioè molte orazioni a Dio piacenti. Gli vengono dati da quanti pregando commettono sé e i propri voti a lui come nostro mediatore e avvocato e gli chiedono di offrirli a Dio.