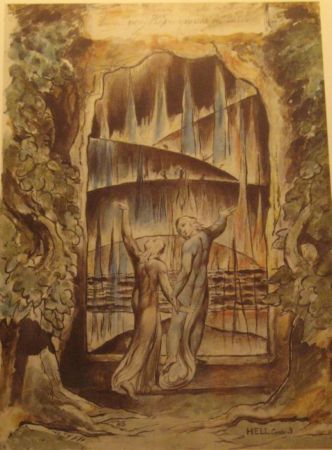La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuori [EN]Canti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX; XXXI; XXXII, 124-XXXIII, 90Purgatorio: III; XXVIII
|
E penso pure che la poesia italiana è stata poco felice nella rappresentazione della donna, e che Francesca rimane unica e sola. Da tante liriche non è uscita una sola donna viva. Nell’Ariosto ti commovono i dolci lamenti di Olimpia e Isabella, schizzi superficiali, anzi che serii ritratti. Nel Tasso Armida è raffinata, Sofronia è astratta, Erminia è insignificante, Clorinda è chiusa e fredda. Le donne di Raffaello vivono nelle tele, ma invano ne cerchi i vestigi nelle nostre poesie. Noi abbiamo le donne “sparenti”, in cui la vita balena in quel punto che sparisce: vivono nel momento della morte, come Clorinda, Ermengarda. Le donne del Leopardi sono creature iniziali, sparite prima ancora che fosse gustata la vita e l’amore: tale è Silvia o Nerina. Salvo queste poche creature fuggitive, ideali ondeggianti, e straniere alla vita, invano cerchiamo la donna. Dell’Alfieri nessuna donna è sopravvissuta. Manzoni stesso, così potente creatore d’individui, ha messo nella sua Lucia non so che artificiale e oltrepassato. Raggi divini di donna balenano in Beatrice e Laura, ma il sole manca. Se alcuna cosa trovar vogliamo comparabile a Francesca, dobbiamo cercarla in Shakespeare, in Byron, in Goethe, nelle letterature straniere, primo e immortale tipo Francesca.FRANCESCO DE SANCTIS [1]Dante, come teologo, come credente, come uomo etico, condanna quei peccatori; ma sentimentalmente non condanna e non assolve: si sente interessato, turbato, gli occhi si gonfiano di lagrime, e infine vien meno dalla commozione. La tragedia dell’amore-passione, che è il significato poetico dell’episodio di Francesca, ha quest’unica pagina nel poema di Dante, che scopre per un istante e mostra nella sua forza indomabile e travolgente quella ebbrezza dei sensi e della fantasia, e non rimuove più il velo che vi si stende sopra. Egli è troppo umano da ignorarla e non intendere e non sentire vivamente quella sorta di affetto: troppo virile, con tanti altri ed elevati pensieri, con tanto fervore di opere, da rimanere, come altri poeti, affascinato e prigioniero nella cerchia di Eros, invincibile in battaglia.BENEDETTO CROCE [2] |
INDICE
Introduzione. 1. Minosse, il metropolita delle chiese infernali. 2. Il tempo dei martiri. 3. La pace tolta dalla terra. 4. Il cuore tempestoso dei Gentili. 5. Andar per mare. 6. Liberalità e cortesia. 7. L’impossibile schiera degli amici di Dio. 8. La via al “doloroso passo”. 9. Il dubbio ingannatore. 10. Il “disïato riso” di Ginevra. Appendice. La “riviera del sangue”, ovvero la grande sineddoche della storia pagana e cristiana. Testi e commento.
INTRODUZIONE
“Francesca: Nessuna parola poteva sonar più pia a quella sventurata. Chiamandola a nome non ha bisogno di protestarle né la compassione, né il dolore che prova: dice qualcosa di più, che egli cioè pensava a lei e se ne commoveva anche prima di incontrarla laggiù”. Così scriveva Luigi Pietrobono, commentando il quinto canto dell’Inferno [3]. I commossi pensieri che Dante provò, il turbamento, la pietà contro la quale dovette combattere, sentimenti che trasmise ai posteri, i quali sempre hanno prediletto quel canto, appaiono più vivi confrontando i versi con la Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi, vademecum e quasi diario intimo dell’intero “poema sacro”. Come avviene in tutta la Commedia, anche in Inferno V, con un procedimento di arte della memoria, sono incardinate nel senso letterale parole-chiave che rinviano alla Lectura oliviana, parole che sono segni di dottrina e inseriscono persone e realtà del mondo umano nella storia dei disegni provvidenziali espressa dall’Apocalisse e dalla sua esegesi. In tal modo la particolare umanità di Francesca, con le sue passioni terrene, è assunta a paradigma universale, profetico; tale è il senso del “poema sacro, / al quale ha posto mano e cielo e terra” (Par. XXV, 1-2). Questo poema, come lo definisce lo stesso autore nell’Epistola a Cangrande (Ep. XIII, 20), è “polisemos, hoc est plurium sensuum”, cioè ha più significati. Dunque doveva essere destinato a un pubblico diversificato. Il rapporto fra Commedia e Lectura super Apocalipsim, prescelto da Dante come sacra parodia a vantaggio di un preciso pubblico di predicatori e riformatori della Chiesa – gli Spirituali francescani -, fu storicamente la parte perdente e caduca del poema. Il destino degli Spirituali (non un gruppo organizzato, ma di sensibilità comune), che dovevano conoscere la Lectura oliviana, non era ancora segnato nel primo decennio del Trecento, quando Dante iniziò a scrivere la Commedia; furono poi perseguitati e il loro libro-vessillo, censurato nel 1318-1319 e condannato nel 1326, fu votato alla clandestinità e quasi alla sparizione. Con il papato avignonese cessarono le speranze di riforma della Chiesa. Il confronto del poema con l’esegesi apocalittica oliviana, le cui risultanze sono un fatto scientifico che i testi dimostrano, non una teoria o un’ipotesi ad essi applicata, consente allo studioso di valutare lo spessore spirituale delle parole portate dai versi, di far rivivere pensieri e sentimenti del poeta, di constatare il laborioso passaggio dall’umile latino dell’esegesi scritturale al volgare, nuova lingua universale.
■ Il mondo poetico di donne e cavalieri che aveva dilettato la gioventù di Dante si trova, con Francesca, di fronte alla sua nuova coscienza morale e cristiana. Questa osservazione di Bruno Nardi [4] può essere concretamente verificata esaminando il modo in cui il romanzo oitanico, le “Arturi regis ambages pulcerrime” che Dante esalta nel De vulgari eloquentia (I, x, 2), viene trasformato nel confronto con la Lectura super Apocalipsim, vero liber concordiae di ogni fonte e reminiscenza.
La presenza semantica e concettuale della tradizione oitanica, sottolineata da Michelangelo Picone [5], rinvia ai significati recati dall’esegesi apocalittica e da essi viene amplificata e superata. Non si tratta di una concezione dell’amore trascendente che si oppone a quello immanente [6], ma del procedere da quest’ultimo, come primo stadio, verso l’altro, termine e causa finale. Quel mondo poetico appartiene all’adolescenza dell’uomo razionale, agitata dal vento dell’errore e dell’irrazionalità secondo Olivi, proprio come “quei due che ’nsieme vanno, / e paion sì al vento esser leggeri”. Non a caso l’episodio di Francesca è principalmente permeato dai temi del secondo stato della Chiesa, quello dei martiri, che corrisponde all’adolescenza della sua storia. I topos della letteratura romanzesca, presenti in Inferno V con specularità testuale, vengono armati dalle maglie della Lectura di Olivi e nella dottrina di questa si riscontrano con altrettanta e più alta specularità: il mare in tempesta, che designa il fol’amor, nel mare che fa segno del tumultuoso cuore dei Gentili (i pagani); mener, “verbo spesso in congiunzione col termine riassuntivo della quête dei cavalieri arturiani, cioè aventure”, connesso con la mutevole Fortuna nel Roman de Tristan in prosa [7], si rispecchia nel regere e deducere di Cristo alle fonti della vita, cioè a un termine certo e durevole; i lai, i tristi canti d’amore di Tristano e Isotta, si ritrovano nelle lamentationes sulla caduta di Babylon; i puvers del congedo della versione poetica del Roman de Tristan, cioè gli amanti che deviano dalle leggi morali, nel “mal perverso” di cui dice Francesca [8], ma le parole della donna esprimono il tormento inusitato inflitto nel martirio psicologico dei tempi moderni, dove si viene ingannati da una falsa immagine di bene.
■ Il termine gentile, nella Commedia, ha cambiato senso rispetto alla Vita Nova. Accanto al significato di ‘nobile’, ‘cortese’ o ‘liberale’ si fa sempre più forte il senso di ‘gente’ alla stregua degli antichi pagani tumultuosa e affannata nel cuore per brutali passioni e conflitti intestini, la cui vita non sta senza guerra, fluttuante come il mare in tempesta. A questo nuovo e negativo valore appartiene “la bufera infernal, che mai non resta” che porta in eterno Francesca e Paolo, la cui vita spense “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende”. Dietro la trina dell’amore che è una cosa col cuore gentile, tessuta da Guinizzelli e dallo stesso primo Dante, sta una concezione dell’amore sensibile e irrazionale che si avvicina a quella cantata da Cavalcanti in Donna me prega. Il modo di questo amore sorprende gli amanti ratto, fulmineo e furtivo; prende come un ladro, non perdona, conduce a morte. Amore scolora il viso, ma è omicida come l’antica macerata lupa. In un poema scritto perché il mondo si penta e converta a Cristo, la figura di Francesca non doveva suscitare un romantico senso di delicata poesia del peccato, esaltata da De Sanctis, bensì porsi come terribile ammonimento contro le insidie riservate agli eletti dei tempi moderni.
Beatrice, la “gentilissima” del “libello” giovanile, non è fregiata nella Commedia con tale prerogativa, riservata, fra le donne, alla Vergine madre, “Donna è gentil … nel ciel” (Inf. II, 94), e a Matelda, “anima gentil” (Purg. XXXIII, 130). Il mutato valore della “gentilezza”, che accanto ai significati già cari a Dante acquista uno spessore storico proprio della Gentilità idolatra e irrazionale applicato ai contemporanei, segna come la ‘linea d’ombra’ di Dante verso la cultura letteraria del tempo, pregna di “donne antiche e ’ cavalieri” dannati in eterno a causa di Amore.
La “gentilezza” veramente nobile, liberale e cortese – quella dei ‘gentili’ romagnoli nostalgici de “le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi / che ne ’nvogliava amore e cortesia / là dove i cuor son fatti sì malvagi” (Purg. XIV, 109-111) – trova però anch’essa nella Lectura i suoi punti di riferimento. Sta nel gratuito e liberale invito dello Spirito di Cristo a venire, con desiderio e con volontario consenso, alla cena delle nozze dell’Agnello (Ap 22, 17). È con disio e con velle, che aderisce all’invito dello Spirito, il venire di Francesca e Paolo, “quali colombe dal disio chiamate .. vegnon per l’aere dal voler portate” (Inf. V, 82-87), all’appello di Dante che li chiama a parlare in nome del loro amore che li affanna in eterno, in un attimo di pace dalla pena eternamente data. In tal modo, con la Lectura oliviana concorda anche quella che “è forse la più famosa delle più che cinquecento similitudini della Commedia, che costituiscono la punta più alta dell’orchestrazione del grande poema” [9].
Termini come disio, dolce, “così squisitamente dominanti nello stilnovismo di Dante e dei suoi amici”, percorrono Inferno V come Leitmotive per designare il desiderio dei sensi e la dolcezza di amore passionale” [10]. Sono però termini che, nella nuova semantica spirituale adottata dal “novo peregrin”, rinviano a un diverso e più alto oggetto, quello costituito dal dolce e desiderabile bere dalle fonti delle acque della vita, alle quali Cristo conduce le schiere dei suoi amici dopo le tribolazioni patite nelle battaglie contro la concupiscenza (Ap 7, 17).
■ Se un lettore ‘spirituale’ avesse affrontato l’episodio di Paolo e Francesca, avrebbe trovato un segno della Lectura super Apocalipsim in quasi ogni parola di Inferno V. L’intenso travaso semantico dalla Lectura nella Commedia, nella parodia che la seconda elabora sulla prima, si accompagna a un fatto strutturale. La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati o periodi della storia della Chiesa, cioè alle categorie con cui Olivi organizza la materia esegetica. È un ordine registrabile per zone progressive del poema dove prevale la semantica riferibile a un singolo stato, ordine dirompente i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ogni stato, che ha differenti inizi, è concatenato per concurrentia, come le maglie di un’armatura, con quello che precede e con quello che segue. Ciascuno stato ha in sé una grande ricchezza di motivi e contiene inoltre temi di tutti gli altri stati, consentendo innumerevoli intrecci e variazioni. Si possono in tal modo redigere mappe che comprendano l’ordine spirituale della Commedia. La ricerca è pervenuta a una Topografia spirituale della Commedia, dove per quasi ogni verso, o gruppo di versi, collegamenti ipertestuali conducono al “panno” esegetico fornito dalla Lectura super Apocalipsim, sul quale il “buon sartore” ha fatto “la gonna”, per usare la similitudine proposta da san Bernardo nell’Empireo (Par. XXXII, 139-141).
Francesca e Paolo si collocano in una zona dedicata ai martiri (secondo stato) non nel senso che sono assimilabili ai martiri dei primi tempi cristiani, ma perché, di fronte al martirio psicologico dei tempi moderni, furono ingannati da una falsa immagine di bene.
Quel lettore ‘spirituale’ si sarebbe ben accorto che il poeta, con un’intima parodica metamorfosi, aveva travasato la storia sacra della Chiesa nello stato umano, sull’“aiuola che ci fa tanto feroci”. Quanto Olivi scrive della Chiesa e della gloria di Cristo viene infatti nella Commedia diffuso su tutte le persone e le forme, antiche e nuove, del nostro mondo. Antichi cittadini erano entrati in “quella Roma onde Cristo è romano”; venivano stabilite concordanze semantiche fra Virgilio, Ovidio o Lucano e l’Apocalisse; il viaggio andava dall’infima illuminazione del luogo più chiuso a quella più aperta.
Avrebbe così riconosciuto in Minosse, che esamina e giudica i peccatori, l’esame circospetto dei mali operato dal vescovo di Efeso, il metropolita delle sette chiese d’Asia, e anche la controfigura dell’arcangelo Michele. Leggendo di Virgilio che nomina “le donne antiche e ’ cavalieri”, morti e perduti in eterno per amore – Semiramide, Didone, Cleopatra, Elena, Achille, Paride, Tristano -, si sarebbe ricordato dei sette diaconi, dai quali uscì la setta dei libidinosi Nicolaiti. Il poeta che visita con pietà i cerchi infernali gli avrebbe rammentato Cristo pio pastore che visita le chiese presenti e future; nell’“affettuoso grido” rivolto ai due amanti avrebbe ritrovato l’affetto generato dal richiamo dello Spirito a convivare. Considerando la figura di Semiramìs e le parole di Francesca: “noi che tignemmo il mondo di sanguigno”, gli sarebbe occorsa alla mente la prostituta apocalittica, tinta di sangue, la quale dominò e domina su molte genti pagane e cristiane scorrendo come un fiume dall’acqua, antica e moderna, colorata in rosso.
Dalle similitudini con il volo degli uccelli (Inf. V, 40-41, 46-47), per cui le anime dei lussuriosi vengono prima paragonate agli stornelli che volano “a schiera larga e piena” e poi alle gru le quali, volando in schiera stretta rispetto agli stornelli, “van cantando lor lai, / faccendo in aere di sé lunga riga”, il medesimo lettore avrebbe tratto un’altra similitudine, quella con la Sacra Scrittura, le cui figure, per la loro intima forza e varietà, possono essere assunte talora in un senso largo e talora in uno stretto; ora coartate, cioè ristrette rispetto al loro pieno senso, ora estese oltre quanto consenta la lettera (e di questa similitudine si sarebbe ricordato leggendo le parole di Bonaventura sulle false interpretazioni della Regola a Par. XII, 124-126).
L’Apocalisse si divide in sette visioni: le sette chiese d’Asia, i sette sigilli, le sette trombe, la donna vestita di sole (le sette guerre sostenute dalla Chiesa), le sette coppe, il giudizio di Babylon nelle sette teste del drago, la Gerusalemme celeste. Le prime sei visioni possono essere a loro volta divise in sette momenti, ciascuno dei quali riferibile a uno dei sette stati della storia della Chiesa. Assembrando, per le prime sei visioni, tutti i primi elementi (chiesa, sigillo, tromba, guerra, coppa, momento del giudizio di Babylon), tutti i secondi, i terzi e così di seguito, si ottengono sette gruppi di materia teologica, corrispondenti al complesso dei temi afferenti a ciascuno dei sette stati [11]. A questi sette gruppi se ne aggiungono altri due: l’esegesi della settima visione (senza articolazioni interne) e l’esegesi di capitoli del testo scritturale, o di parti di essi, introduttivi delle successive specificazioni delle singole visioni per settenari, che Olivi definisce “radicalia” o “fontalia”. Si ottengono in tal modo nove gruppi: le parti proemiali, i sette assembramenti di settenari e la settima visione. Il grande prologo della Lectura, articolato in tredici notabilia, può essere anch’esso riaggregato secondo i sette stati.
Scorrendo i versi di Inferno V, zona dedicata al secondo stato, ai martiri che sostennero e sostengono le tentazioni, il lettore accorto avrebbe dunque ritrovato temi della seconda chiesa, Smirne (Ap 2, 8-11): il non diffidare, il conforto, la rovina, la rapina, il danno, il cantico, i motivi connessi con la “seconda morte”. Temi variati rispetto al testo di esegesi, con esso consonanti o dissonanti, parodicamente appropriati in diversi modi a differenti soggetti, posti a spirituale contrappasso nella pena inferta ai dannati.
Le parole di Francesca sulla terra natìa, Ravenna, – “Siede la terra …” -, avrebbero fatto ricordare al nostro spirituale quanto avviene all’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 4), allorché a chi siede sul cavallo rosso è concesso di togliere la pace dalla terra, perseguitando non solo gente estranea e lontana ma anche i propri parenti e vicini, come avvenne con il Malatesta che uccise moglie e fratello. Avrebbe in tal modo ricondotto un particolare fatto cittadino, di “una terra”, alla “terra” universale, procedendo secondo il modo dello spirito profetico.
All’esegesi della seconda tromba (Ap 8, 8-9) appartengono il mare tempestoso, che designa l’affannato cuore dei Gentili che mai stanno senza guerra, e ancora, segnati da insistenti parole-chiave, i temi del leggere e del portare (propri dei diaconi, che leggono la Scrittura e portano sulle spalle la passione di Cristo), dell’essere vinti perché incapaci di sostenere una tentazione troppo grande, dell’apostatare dalla fede, dell’animalità.
Tutti temi che si ripresentano, variati, in altre zone del poema ‘topograficamente’ dedicate al secondo stato, dai violenti contro il prossimo a Guido da Montefeltro, a Guido del Duca, altro romagnolo che purga l’invidia nel secondo girone della montagna.
■ Chi leggeva dell’incontro con Francesca sarebbe passato con la memoria dal secondo al sesto stato della Chiesa, dagli antichi martiri al proprio tempo. Nel sesto stato viene inflitto agli uomini spirituali un martirio di nuovo tipo. Non è corporale, come quello sostenuto dagli antichi testimoni della fede contro i pagani, ma è psicologico, tocca la pietà dei nuovi martiri, i quali soffrono nel dubbio sulle stesse verità di fede, di fronte ai carnefici che operano miracoli e si presentano con una falsa immagine di autorità e con false Scritture. Un “certamen dubitationis” in cui anche i più esperti vengono vinti. Tale fu il martirio sostenuto dai “due cognati” in vita i quali, ingannati, non furono capaci di sostenerlo fino in fondo. Al momento della prova, i due vennero sospinti dalla lettura di un libro (“Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse”) verso un punto che li vinse, non diversamente da come i nuovi martiri vengono sospinti dagli “intorta testimonia scripturarum sanctarum”. Tale il martirio di Dante, “tristo e pio” di fronte ai “martìri”, al “mal perverso” dato loro in pena eterna [12]. Ma la mente, chiusa per la pietà, torna in sé e il viaggio prosegue. La pietà come martirio, grande motivo che percorre Inferno V, era stata già sperimentata nel “desiderio malvagio e vana tentatione” suscitata dalla Donna Gentile o Pietosa, l’avversaria di Beatrice nella Vita Nova: lo stesso passo dei Moralia di Gregorio Magno sui perversi martìri degli ultimi tempi, allora tratto dall’Expositio in Canticum Canticorum di Olivi come ora dalla Lectura super Apocalipsim, ne era stato il panno esegetico.
Quanto avviene nei tempi moderni, che Olivi fa coincidere con il sesto stato della storia della Chiesa – la nuova età dell’oro che tanto s’aspetta -, caratterizzato dal libero parlare per dettato interiore che apre i cuori, è singolarmente consonante con la poetica di Dante. Tale viene definita nel sesto girone del purgatorio nell’incontro con Bonagiunta da Lucca: una poetica fondata sullo spirare di Amore, interno “dittator”, e sul notare significando in modo stretto i suoi dettati, quasi fossero quelli di una regola evangelica imposta e accettata. La Vita Nova è la storia di un nuovo avvento di Cristo, del “miracolo” Beatrice, venuta in tanta grazia delle genti da operare mirabilmente in esse, lodata dal poeta la cui lingua “parlò quasi come per sé stessa mossa”. Un miracolo non corporale ma intellettuale, visibile a quanti hanno “intelletto d’amore”. Non sarà casuale che l’uscita delle “nove rime” dantesche sia contemporanea all’insegnamento di Olivi a Santa Croce tra il 1287 e il 1289, subito prima della morte di Beatrice, nel 1290.
Questo spiega lo straordinario rapporto parodico, fondato su precise e verificabili norme, che nel periodo dell’esilio Dante volle creare fra il “poema sacro” e la Lectura super Apocalipsim, arrivata presto in Italia dopo la morte del suo autore.
Ogni stato, sostiene Olivi, ha in sé qualcosa degli altri, dunque anche del sesto, che è lo stato cristiforme per eccellenza, coincidente con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Far parlare liberamente, per dettato interiore – la principale prerogativa del sesto stato – è tema che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo, anche nella vecchia roccia infernale. Appartiene alla sesta chiesa il parlare liberamente di Cristo – ad essa è dato l’“ostium apertum”, che è “ostium sermonis” –, la porta aperta alla favella, il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà. Appartiene alla sesta chiesa anche far venire quelli che si dicono Giudei senza esserlo, mutati nel cuore e disposti a farsi battezzare e governare. Questo far venire a parlare equivale all’invito dello Spirito di Cristo a convivare, a venire con desiderio e volontario consenso, in una pausa di pace nell’eterna dannazione. All’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono “dal voler portate” verso un momento di mutazione e quasi di conversione, sebbene limitata al successivo colloquio. Tutto l’Inferno è un contrappunto fra la durezza del giudizio, le bestemmie dei peccatori e l’apertura al ricordo della vita per la parola dirompente, finché essa dura, la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi per poi ricadere, sollevarsi da atti bestiali per ritornare ad essi dopo aver parlato, come nel conte Ugolino. In tante lingue, che parlano anch’esse ‘come per sé stesse mosse’, sta un solo desiderio, il vivere ancora nel libro che è stato altrui aperto.
All’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3-4) vengono segnati gli amici di Dio; separati dalla volgare schiera dei fanti, votati a più alta milizia e destinati al martirio, guidano come cavalieri e decurioni la turba innumerevole. I due amanti sono anch’essi separati (“cotali uscir de la schiera ov’ è Dido”), ma impossibile è la preghiera che Francesca vorrebbe dire (“se fosse amico il re de l’universo, / noi pregheremmo lui de la tua pace”). “Pace” rima con “tace”: ogni stato, e quindi ogni momento della storia umana, i cui valori ricadono sui singoli individui, ha una sua “quietatio”, una pausa di pace, di quiete, di silenzio propria del settimo e ultimo degli stati. Così Francesca parla e ascolta “mentre che ’l vento, come fa, ci tace” (intendendo ci come avverbio di luogo; nell’esegesi il silentium pacis è proprio di un momento storico). Il vento – “la bufera infernal, che mai non resta” – designa il fluttuare tempestoso delle passioni nel cuore dei ‘gentili’.
■ “O lasso, / quanti dolci pensier, quanto disio / menò costoro al doloroso passo!” (Inf. V, 112-114). In queste parole del poeta che sgorgano dalla riflessione su quanto ha detto Francesca della potenza di Amore, compare il tema di Cristo che conduce alle fonti delle acque dolci e desiderabili con la conseguente cancellazione di ogni dolore passato e di ogni penale memoria (Ap 7, 17). Il “passo”, cioè il patire dei due cognati nella tentazione che li vinse, è stato “doloroso” non solo perché a causa di esso la loro vita corporale è stata spenta, ma perché ora, nella miseria, essi ricordano con dolore il tempo felice. Le parole di Francesca che tanto piacquero ai romantici – “Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / ne la miseria” (vv. 121-123) – sono, pur memori di Boezio, la consapevole negazione della gloria cui Cristo mena, in dolcezza e desiderio, coloro che hanno patito nelle tentazioni vincendole. I due amanti, vinti da “un punto” della lettura del libro galeotto, ora hanno come pena, al di là della “bufera infernal, che mai non resta”, la memoria dolorosa, che Cristo terge invece a coloro che nel sangue lavarono le loro vesti, cioè, come si afferma nell’esegesi oliviana, hanno combattuto e vinto le concupiscenze.
■ “Ma solo un punto fu quel che ci vinse” (v. 132). Arrivato al “punto”, nel quale i due amanti leggono di Lancillotto che bacia Ginevra, il lettore ‘spirituale’ avrebbe inteso che il “disïato riso” della consorte di Artù corrisponde falsamente all’ardua visione dello splendore del volto di Cristo, che riluce come il sole in tutta la sua virtù e che nel sesto stato, quando la conoscenza della Scrittura è aperta, deve raggiare in tutta la sua chiarezza, imprimendo in chi guarda tremore e oblio (Ap 1, 16-17: decima e undecima perfezione di Cristo come sommo pastore).
«“Et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. […] Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et <divine> faciei <in ea, que> in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2). […] ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” – Quando leggemmo il disïato riso / esser basciato da cotanto amante, / questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto tremante. … E caddi come corpo morto cade» (Inf. V, 133-136, 142).
Il sesto stato è il tempo dell’amore fraterno, del bacio della sposa allo sposo di cui è scritto nel Cantico dei Cantici (8, 2), interpretato come il desiderio della Chiesa verso Cristo [13]. I due amanti ebbero un’ardua visione; per essa Amore “concedette” loro di conoscere i “dubbiosi disiri” (vv. 118-120). Il verbo concedere, nell’esegesi apocalittica, è proprio della visione concessa dal Padre al Figlio affinché la renda nota tramite la rivelazione fatta dall’angelo a Giovanni. Tale concessione fu dai due male interpretata, nel senso dell’amore carnale. Nel martirio psicologico loro inflitto in vita, furono ingannati da una falsa Scrittura, come dice Francesca: “Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse” (v. 137). Il nome di Galehoz, intermediario d’amore tra Lancillotto e Ginevra, che in questo caso designa il libro che sospinse gli amanti al punto che li vinse, concorda pure con “galeotto” nel senso di nocchiero, di cui è esempio Flegiàs in Inf. VIII, 17 e in Purg. II, 27 l’angelo che porta le anime dalla foce del Tevere alla riva del purgatorio. Il sintagma leggere e portare, nell’esegesi della seconda tromba (Ap 8, 9), è appropriato ai diaconi, una parte dei quali creò la setta dei lussuriosi Nicolaiti. Nel mare dei ‘gentili’ perì la terza parte delle navi, di quanti cioè portavano per quel mare di tentazioni, che non seppero vincere. Fra tanti che sono vestiti di tal panno, c’è Venedico Caccianemico, mezzano come Galehoz (Inf. XVIII, 55-57).
■ “Quel giorno più non vi leggemmo avante” (v. 138), tanta è l’intensità con cui Amore, sopravvenuto come un ladro, ha stretto i due amanti. Ma il senso è anche quello di non aver letto tutto il libro, di essersi fermati al primo stadio. Proseguendo con Dante il viaggio nel libro della vita, il nostro spirituale si sarebbe accorto che i signacula dell’esegesi del volto di Cristo che irradia, nel sesto stato, più luce e più rivelazione della Scrittura (Ap 1, 16-17), percorrono tutta la terza cantica a partire dal principio, con la gloria della divina virtù che risplende, con l’essere il poeta disceso dal “ciel che più de la sua luce prende” (Par. I, 1-2, 4, 22). Quello che nell’esegesi è concentrato unicamente su Cristo viene frantumato, secondo l’avvertenza dell’Olivi, su più soggetti. Lo splendor faciei di Cristo, che si incarna nel sorriso di Beatrice, discorre per tutto il Paradiso, con variazioni della rosa semantica che lo costella: l’essere più lucente, la troppa luce, il mettere in oblio, l’intimo accorgersi di una più ardua visione. All’esegesi della decima e undecima perfezione di Cristo sommo pastore rimandano le parole incastonate nei versi come pietre miliari, a ricordare una dottrina poeticamente rivestita. Le variazioni non sono solo interne al ristretto passo esegetico (Ap 1, 16-17), ma coinvolgono altri luoghi della Lectura. Di fronte al ridere di Beatrice, quel lettore avrebbe senz’altro rammentato l’esegesi del volto solare di Cristo. Non nel senso di una reale identificazione, ma della conformità che nasce dal seguirlo.
La centralità di Ap 1, 16-17 in tanti luoghi del poema, da Francesca a Beatrice, è trasposizione di quello che è il tema fondamentale della Lectura super Apocalipsim – che non si ritrova in altra opera contemporanea -, cioè la centralità di Cristo, il cui splendore aumenta nella storia procedendo verso il sesto stato della Chiesa, allorché il libro, non Galeotto ma vero, sarà tutto aperto. Da “ma solo un punto fu quel che ci vinse” di Francesca (Inf. V, 132), al “punto che mi vinse” nel Primo Mobile e al vittorioso sorriso di Beatrice sulla soglia dell’Empireo (cfr. Par. XXX, 11, 22-24), al finale “punto solo” (Par. XXXIII, 94): sono diversi stadi di un medesimo processo storico di epifania del Cristo dio e uomo, il primo come vano desiderio e malvagia tentazione provata nel subdolo martirio degli ultimi tempi; il secondo nello spazio e nel tempo degli uomini (il tempo ha nel Primo Mobile le sue radici); il terzo, non più per specula, di fronte al divino.
Il compimento della “scrittura” d’Amore, iniziata con l’inganno di Francesca e Paolo vinti da “solo un punto”, avverrà con le parole dette dal poeta a san Giovanni che lo esamina sulla carità (Par. XXVI, 16-18), dove la terzina contiene anche il riferimento ad Ap 1, 8; 21, 6 e 22, 13 (“Ego sum A et Ω, principium et finis”): “Lo ben che fa contenta questa corte, / Alfa e O è di quanta scrittura / mi legge Amore o lievemente o forte”. In tutt’altro contesto, ‘Amore’ e ‘leggere’ sono uniti. I due “cognati” avevano letto da soli, a Dante viene letto per dettato interiore (“Noi leggiavamo … quel giorno più non vi leggemmo avante /… mi legge Amore …”). Il poeta ha lasciato “dietro a sé mar sì crudele” (Purg. I, 3), il tempestoso mare degli affannati cuori ‘gentili’ nel quale hanno fatto naufragio Tristano con le donne e i cavalieri amorosi, e si è rivolto a Dio per mezzo dei morsi della carità, che “tratto m’hanno del mar de l’amor torto, / e del diritto m’han posto a la riva” (Par. XXVI, 55-63). Si è convertito, come “lo cavaliere Lanzalotto”, che dopo la morte di Artù “a questo porto … non volse intrare colle vele alte” (cfr. Convivio IV, xxviii, 7-8).
Tanto alti significati avrebbe potuto percepire, oltre il senso letterale dei versi in volgare, un lettore ‘spirituale’ conoscitore della Lectura super Apocalipsim in latino. E forse non è casuale che il nome della donna – Francesca -, reale nella sua storicità ma significante, sia cantato con versi che danno “e piedi e mano” all’esposizione teologica del martirio proprio dei tempi moderni, che affligge l’animo con il dubbio ingannatore più che il corpo con i tormenti, e che dovrà essere sostenuto dagli eletti degli ultimi tempi, i segnati dell’esercito di Cristo, i quali per Olivi altri non sono che i Francescani. Il nome di Francesco ricorre solo una volta nell’Inferno, quando viene a prendere l’anima di Guido da Montefeltro morto cinto del saio penitenziale, ma inutilmente, come gli spiega il diavolo “loico”, perché ha dato a Bonifacio VIII il consiglio fraudolento su come conquistare Palestrina, facendosi recidivo nelle precedenti colpe (Inf. XXVII, 112-123). Il canto è orchestrato con gli stessi temi di Inferno V; come Francesca, il francescano Guido ha sostenuto il moderno martirio; come la donna è stata ingannata da una falsa Scrittura, così il vecchio uomo d’arme si è fidato di una falsa immagine papale che gli garantiva l’assoluzione.
■ In Dante non è possibile distinguere, come intendeva Croce, il teologo, che condanna i due peccatori, dal poeta che sentimentalmente non condanna e non assolve ma è umanamente turbato, commosso, e tuttavia votato a più elevati pensieri e fervore d’opere. Il “panno”, sul quale è stata cucita parodicamente la “gonna”, è sempre il medesimo per il teologo e poeta, e non solo al fine tecnico di mantenere unite le parti del poema, ma per l’intento profetico di inserire l’individuo nella storia universale marcata dai segni provvidenziali.
Come i Gentili appartennero all’adolescenza della Chiesa, così l’episodio di Francesca appare come una fase della vita umana, da superare nel corso del viaggio. Il dramma di Francesca, “donna e non altro che donna” come la vedeva De Sanctis [14], dramma individuale e al tempo stesso universale, nasce dalla metamorfosi di opposti temi di una teologia della storia. Da una parte sta la brutale e sensuale vita amorosa dei Gentili, passionati, bellicosi, uccisori dei propri parenti e vicini, assimilata all’amore carnale e irrazionale dei Saraceni, designati dalla quarta bestia del profeta Daniele, irresistibile, diversa e conducente a morte e dal quarto cavallo dell’Apocalisse, pallido, magro e ipocrita. Dall’altro l’amore cristiano, liberale e gratuito, dello Spirito di Cristo, desiderio di grazia volontariamente accettata. Da una parte “la schiera ov’è Dido”, per la quale non c’è amicizia con Dio (“se fosse amico il re de l’universo”, dice Francesca), dall’altra quella dei veri amici di Dio (“l’amico mio, e non de la ventura”, dice Beatrice di Dante), ascritti alla sua milizia, i segnati all’apertura del sesto sigillo. Ma questa milizia è votata al martirio degli ultimi tempi, quell’agone del dubbio che ha ingannato Francesca e Paolo e che il poeta deve vincere, nonostante la pietà che ingenera, se vuole avanzare nel viaggio.
Auerbach osservava che l’opera di Dante fu il punto di arrivo di uno sviluppo che si interruppe con lui: “Nessuno ha potuto continuare o completare la costruzione del mondo e della storia contenuta nella sua opera, perché quella costruzione crollò”. Venne a mancare il giudizio di Dio che attualizza, ordina e rende eterna la tragicità con cui Dante aveva inserito l’individuo nell’ordine universale: “Più tardi l’individuo è solo, e la sua tragedia finisce con la sua vita” [15]. Crollò, in quell’‘autunno del Medioevo’, anche la Lectura super Apocalipsim, portatrice dei sensi interiori della Commedia, perché oggetto di una persecuzione senza pari, e perché venne meno il senso di una storia della salvezza collettiva.
[1] F. DE SANCTIS, Francesca da Rimini (1869), in Saggi critici, a cura di L. RUSSO, II, Bari 1965, pp. 275-293: 292-293.
[2] B. CROCE, La poesia di Dante (1920), Bari 19527, pp. 72-73.
[3] La Divina Commedia di Dante Alighieri commentata da L. PIETROBONO, I, Torino 1952 (1949), p. 63, nt. a v. 116.
[4] Cfr. B. NARDI, Dante e la cultura medievale. Nuovi saggi di filosofia dantesca, Bari 1942 (Biblioteca di cultura moderna), pp. 84-88.
[5] Cfr. M. PICONE, Canto V, in Lectura Dantis Turicensis, a cura di G. GÜNTERT e M. PICONE, Inferno, Città di Castello 2011, pp. 75-89.
[6] Ibid., pp. 86-87.
[7] Ibid., pp. 79-80.
[8] Ibid., pp. 83-84.
[9] Cfr. I. BALDELLI, Inferno, canto V, in ID., Studi Danteschi, a cura di L. SERIANNI e U. VIGNUZZI, Spoleto 2015 (Medioevo Francescano. Saggi, 16), pp. 289-313: 290.
[10] Cfr. ibid., p. 301.
[11] Il principio è chiaramente affermato nel notabile VIII del prologo: “[…] si omnia prima membra visionum ad invicem conferas et consimiliter omnia secunda et sic de aliis, aperte videbis omnia prima ad idem primum concorditer referri et consimiliter omnia secunda ad idem secundum et sic de aliis. Et hoc in tantum quod plena intelligentia eiusdem primi multum clarificatur ex mutua collatione omnium primorum, et idem est de omnibus secundis et tertiis et sic de aliis” (Par. lat. 713, ff. 12vb-13ra).
[12] Cfr. PIETROBONO (cfr. nt 3), p. 63, nt a v. 116: “i tuoi martìri: Più delicato che se avesse detto: la tua pena: questa avrebbe lasciato sottintendere la colpa; mentre lui ora vede solo il tormento a cui Francesca soggiace”.
[13] Cfr. PETRI IOHANNIS OLIVI Expositio in Canticum Canticorum, ed. J. SCHLAGETER, Ad Claras Aquas Grottaferrata 1999 (Collectio Oliviana, II), pp. 296-302.
[14] DE SANCTIS (cfr. nt. 1), Francesca da Rimini, p. 281.
[15] E. AUERBACH, Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e nel Medioevo, Milano 19743, pp. 286-287.

Anselm Feuerbach, Paolo und Francesca (1864); Monaco di Baviera, Sammlung Schack
Inferno V |
Legenda [3] : numero dei versi; 1, 7 : collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]; Not. I : collegamento ipertestuale all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. [ecc.: ecclesia]; [sig.: sigillum]; [tub.: tuba]; [prael.: praelium]. Varianti rispetto al testo del Petrocchi.Qui di seguito viene esposto il quinto canto dell’Inferno con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim ai quali i versi si riferiscono. Nell’esame dei primi quattro canti dell’Inferno, i colori che evidenziano il testo dato all’inizio corrispondono, per quanto possibile, a quelli delle tabelle. A partire dal canto V, primo nel quale la semantica si riferisce in modo sistematico e prevalente alla materia esegetica riguardante uno status o periodo della Chiesa, i colori seguono quelli attribuiti a ciascuno stato [*]; tuttavia nel testo riportato nelle tabelle, per maggiore evidenza, potranno talora essere utilizzati in forma diversa. Ciò consente di registrare separatamente i singoli gruppi tematici sui quali si esercita la variazione parodica e di evidenziare come, ad esempio, nel V canto prevalga il secondo stato, nel VI il terzo, nel VII il quarto e così via (tenendo presente, da una parte, che la regione tematica principale è più ampia dei limiti dati al singolo canto e, dall’altra, che in essa si intrecciano temi propri di altri stati). |
Così discesi del cerchio primaio 12, 6
|
■ Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, Olivi suggerisce, nel prologo della Lectura, un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato sui sette stati (status), cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, prefigurate nell’Antico Testamento.
|
Abbreviazioni e avvertenze
Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.
LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.
Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).
Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.
Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.
In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.
Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.
Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994. Si tiene anche conto della recente edizione a cura di G. INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA.
Dall’esame delle tabelle sinottiche, si noterà come a un medesimo luogo esegetico della Lectura conducono, tramite la compresenza delle parole, più luoghi della Commedia. Per spiegare i significati spirituali dei versi di Inferno V si dovrà fare riferimento anche ad altri canti, più o meno numerosi, del poema. Ciò significa che la medesima esegesi di un passo dell’Apocalisse è stata utilizzata, parodicamente variata, in momenti diversi della stesura del poema, ed è questa una delle norme che regolano il rapporto fra le due opere. Nella spiegazione premessa alle tabelle, è stata evidenziata, premettendo al paragrafo il simbolo ■, la parte effettivamente relativa al canto in esame.
1. Minosse, il metropolita delle chiese infernali
“Così discesi del cerchio primaio / giù nel secondo, che men loco cinghia” (Inf. V, 1-2; tab. 1.1).
■ La brevità delle generazioni del secondo stato generale del mondo, rispetto a quelle del primo, è tema di Gioacchino da Fiore (citato ad Ap 12, 6) applicato alla seconda cornice del purgatorio, simile alla prima ma con raggio più stretto (Purg. XIII, 4-6: il piegare “più tosto” dell’arco allude a una brevità temporale oltre che spaziale). Più avanti si dice che Virgilio e Dante hanno percorso un miglio “con poco tempo” per la volontà di purificarsi (vv. 22-24).
Il medesimo tema è appropriato anche al secondo cerchio dell’inferno, che “men loco cinghia / e tanto più dolor, che punge a guaio” rispetto al primo (Inf. V, 1-3). Scendere e risalire per gradi è uno dei temi principali dell’istruzione data al vescovo di Efeso (cfr. infra).
■ Nel sesto e settimo stato della Chiesa, che corrispondono all’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore, le generazioni e le sofferenze saranno abbreviate per gli eletti: “[…] ne nimis immoderata tribulatio absorbeat electos. Unde et veritas ait quod propter electos breviabuntur dies illi […]” (prologo, Notabile XII). È quanto chiesto con desiderio “da tutte quante / quell’ ombre che pregar pur ch’altri prieghi, / sì che s’avacci lor divenir sante” (Purg. VI, 25-27). Si tratta di “spiriti eletti” che s’aspettano “pace” prima di entrare nella porta (Purg. III, 73-75), ai quali con le preghiere si può abbreviare il tempo dell’afflizione e della fatica nel purgarsi come giurato dall’angelo ad Ap 10, 5-7 (cfr. le parole di Cacciaguida sul bisnonno di Dante a Par. XV, 95-96).
Con l’apertura della porta del purgatorio, che dà accesso ai sette gironi della montagna, inizia il sesto stato.
“Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia” (Inf. V, 4; tab. 1.2).
L’angelo del sesto sigillo (Ap 7, 2) rimuove l’impedimento di cui si dice al versetto precedente (Ap 7, 1). Ivi quattro angeli “stanno” sopra i quattro angoli della terra: designano i demoni e gli uomini empi che, dopo il giudizio e lo sterminio della Chiesa carnale intervenuti con il terremoto nell’apertura del sigillo (Ap 6, 12-17), cercano di impedire ai quattro venti di soffiare, sono cioè intenti a impedire la predicazione della fede, la conversione delle genti e anche il conservarsi dei fedeli nella fede già accolta. Secondo Riccardo di San Vittore, sono i principali demoni cupidi di possedere tutto il mondo nei suoi quattro angoli, che stanno fissi nel considerare quanti possano divorare. Secondo Gioacchino da Fiore, i quattro angeli possono essere interpretati anche in senso positivo, come i quattro generi di predicatori ai quali è concesso di nuocere cessando dalla predicazione a causa dei peccati. L’impedimento viene rimosso dalla proibizione di un angelo diverso dagli altri quattro, che ostacolano il bene, e contrario ad essi. Si tratta appunto dell’angelo del sesto sigillo, che sale da oriente: come afferma Gioacchino da Fiore, affinché non si tema il tramonto di questa vita, predicherà i sicuri indizi dell’avvento del vero sole e la prossima resurrezione di tutti i giusti. Di fronte alla virtù del suo grido il potere degli avversari si acquieterà.
■ Nella salita del “dilettoso monte”, il poeta è impedito dalle tre fiere: la lonza “’mpediva tanto il mio cammino” (il tempo, al principio del mattino, è il medesimo nel quale interviene l’angelo del sesto sigillo), la vista del leone gli incute paura, la lupa “non lascia altrui passar per la sua via, / ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide” (Inf. I, 35, 44-45, 95-96). Virgilio viene mandato da Beatrice a rimuovere l’impedimento (Inf. II, 61-63, 94-96).
Entrato Dante “per lo cammino alto e silvestro”, dapprima Caronte si rifiuta di traghettarlo, “anima viva”, al di là dell’Acheronte, ma le parole di Virgilio rendono “quete le lanose gote / al nocchier de la livida palude” (Inf. III, 88-99).
Sulla soglia del secondo cerchio, “stavvi Minòs orribilmente, e ringhia” (Inf. V, 4; cfr. “stavvi”, con accento sulla prima sillaba, con i quattro angeli “stantes”): anch’egli cerca di impedire il “fatale andare” del poeta, ma Virgilio, con le stesse parole dette a Caronte, rimuove l’impedimento (vv. 22-24).
Nel terzo cerchio Cerbero, alla vista dei due poeti, “le bocche aperse e mostrocci le sanne”, ma lo racqueta la terra gettata da Virgilio dentro le bramose canne (Inf. VI, 22-33).
Con Pluto, quarto dei demoni, le parole del poeta pagano sono diverse da quelle pronunciate verso Caronte e Minosse, ma l’effetto è il medesimo perché il demonio sta lì per nuocere e per impedire la discesa “ne la quarta lacca”. Nel confortare il discepolo, Virgilio si comporta ancora come l’angelo del sesto sigillo che acquieta ciò che può nuocere da parte dei quattro angeli di Ap 7, 1: “Non ti noccia / la tua paura; ché, poder ch’elli abbia, / non ci torrà lo scender questa roccia” (Inf. VII, 4-6).
Completa il quadro il forte terremoto che scuote la “buia campagna” al momento del passaggio dell’Acheronte, che corrisponde al terremoto che si verifica all’apertura del sesto sigillo (Inf. III, 130-132).
“essamina le colpe ne l’intrata” (Inf. V, 5; tab. 1.3).
Come Omero è “poeta sovrano” fra i quattro poeti che albergano nel “nobile castello” del Limbo, prima dell’arrivo di Virgilio e Dante che rendono “sesta” la “compagnia”, così Minosse, l’antico re di Creta, è sovrano fra i quattro antichi demoni che cercano di impedire l’andata di Dante. Ancor più, si fregia delle prerogative arcivescovili, in quanto i versi che descrivono il suo operare rinviano all’esegesi dell’istruzione data al vescovo di Efeso, il primate delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione apocalittica. A questa esegesi (Ap 2, 1-7), come accade normalmente nel rapporto parodico fra Commedia e Lectura, si riferiscono semanticamente molti altri luoghi del poema oltre ai versi relativi a Minosse, per cui l’esame che segue – limitato ad Ap 2, 2-3 [1] – sarà effettuato in modo diffuso, anche a conferma della non casualità dei riscontri.
L’istruzione del metropolita inizia con parole di lode, sia per elevarlo con queste a cose migliori e confortarlo a perseverare con fermezza nel bene, sia perché venga disposto nell’animo a ricevere il successivo rimprovero, come il chirurgo prudente prima palpa in modo soave le membra sane cosicché il malato sopporti poi in modo più tranquillo l’intervento sulla parte inferma.
La lode consta di sette motivi, dei quali i primi due riguardano rispettivamente il bene inteso in senso assoluto e il bene in quanto cosa difficile.
Per il primo si dice: “Conosco le tue opere” (Ap 2, 2), cioè approvo le tue buone opere, ad esempio quelle derivanti dalla pietà verso il prossimo. Con questa espressione viene qui intesa la scienza per cui Dio vede, ama, accetta, governa, compatisce, remunera.
Per il secondo si aggiunge: “e la tua fatica”, cioè il travaglio del corpo e il faticoso esercitare la mente [2].
I restanti cinque motivi di lode riguardano il male. Dapprima la sua quieta tolleranza, per cui viene lodata in terzo luogo la pazienza del vescovo nel sopportare i mali inferti (“e la tua pazienza”).
Poi il male in quanto è da respingere e da fuggire, per cui in quarto luogo viene detto: “e non puoi sopportare i malvagi”, intendendo che questo vescovo li detesta, rimprovera e separa segregandoli e allontanandoli dalla comunione.
La prima delle tre azioni, detestare il male, è sempre buona; le altre due richiedono l’apprezzamento delle circostanze, poiché non tutti i malvagi sono da rimproverare sempre e da chiunque e in ogni luogo e tempo, né sono sempre e comunque da allontanare immediatamente. Per questo il quinto motivo di lode concerne il male in quanto sospetto e da esaminare. Si dice infatti: “li hai tentati”, cioè li hai messi alla prova ed esaminati, “quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi”, nella vita falsa e nella dottrina erronea. Si tratta dei falsi apostoli di cui si discorre nelle lettere di san Paolo, che predicavano più per il favore e la gloria temporale, per il guadagno e la gola che per l’onore di Dio, i quali, ipocriti per dolo e simulazione, suscitavano persecuzioni contro Paolo e quanti contrastavano la loro frode e il loro errore. Così fecero contro il vescovo di Efeso, del quale viene ancora lodata la pazienza: “e hai pazienza e hai sopportato per il mio nome e non sei venuto meno” (Ap 2, 3).
Così al terzo motivo di lode, dovuto alla pazienza come pace del cuore nel sopportare i mali inferti, se ne aggiungono altri due: il fine alto e santo per cui ha sopportato (il sesto), e la perseveranza, cioè il non venir mai meno alla fede, speranza, carità (il settimo).
■ Una parte di questo gruppo di temi viene utilizzato nella descrizione della discesa lungo il corpo di Lucifero, che fa da scala per cui “conviensi dipartir da tanto male”, cioè dal male dell’inferno (Inf. XXXIV, 70-84). Con Dante avvinghiato al collo, Virgilio prende “di tempo e loco poste”: nel fuggire il male esamina le circostanze (tema del quinto motivo di lode). Quando le ali sono “aperte assai”, il poeta pagano si aggrappa alle “coste” scendendo giù “di vello in vello” [3]. Arrivato all’anca di Lucifero, al “punto” [4] in cui la coscia si curva e che è anche il centro della terra, Virgilio, “con fatica e con angoscia” (tema del secondo motivo di lode, il travaglio corporale), si capovolge e risale, sempre aggrappato al pelo. Ansima “com’ uom lasso”, dove l’aggettivo, che ripete il motivo della fatica, concorda con il significato del nome ‘Efeso’ (“lapsus”, ossia “caduta”, e quindi stanchezza rispetto al fervore originario). Nella descrizione si ritrovano altri temi della prima chiesa. Scendere per gradi dal culmine della carità e delle virtù al fondo (“di vello in vello”), perdendole progressivamente per poi recuperarle risalendo sempre gradualmente, è tema principale della successiva esegesi di Ap 2, 4-5.
Una situazione in parte analoga si è già verificata nella discesa verso Malebolge in groppa a Gerione, sul quale Virgilio, figura di Cristo che ad Ap 2, 1 sta in mezzo per proteggere il gregge, è medio fra Dante e la coda velenosa, in modo che questa non possa far male (Inf. XVII, 82-84; cfr. la coincidenza numerica dei versi – la 28a terzina – con Inf. XXXIV). Virgilio cinge con le braccia il discepolo e lo ‘sostiene’, come “altra volta mi sovvenne / ad altro forse” (vv. 94-96; cfr. Inf. IX, 8, dove Virgilio dice di Maria: “Tal ne sofferse”, cioè ci sostenne fin qui, oppure di Beatrice, che sopportò di scendere al Limbo per salvare Dante): qui sarebbe da accogliere la lezione del Barbi “ad alto forse”, cioè in alto pericolo precedente, poiché si loda il vescovo di Efeso che “sostenne” il male, “sospetto” e dunque dubbio, con pazienza per un fine “alto” e santo, cioè per il nome di Cristo (Ap 2, 3).
Il terzo motivo di lode – detestare e fuggire il male – è nelle parole con le quali Dante dichiara di voler seguire Virgilio in modo da vedere la porta di san Pietro, “acciò ch’io fugga questo male e peggio” (Inf. I, 132) [5].
■ Chi vaglia le circostanze del male (quinto motivo di lode) è Minosse. Il giudice dei morti dell’Ade virgiliano, che cumula anche le funzioni del fratello Radamanto, giudice dei dannati, “essamina le colpe ne l’intrata”, e in quanto “conoscitor de le peccata” vede qual luogo d’inferno sia da assegnare all’ “anima mal nata”. Come il presule di Efeso giudica il male prima di segregare i malvagi, così le anime vanno dinanzi a lui prima di essere “giù volte” (Inf. V, 4-15) [6]. All’opposto di Minosse, Francesca e Paolo non valutarono il male che stava per travolgerli: “soli eravamo e sanza alcun sospetto” (v. 129).
■ Il tema della pazienza nel sostenere quietamente i mali (terzo motivo di lode) è appropriato ai superbi del primo girone del purgatorio (Purg. X, 130-139), curvi con le ginocchia al petto sotto il peso di macigni, come le mensole a forma di uomo poste a sostenere solaio o tetto. Colui che mostrava più pazienza negli atti, “piangendo parea dicer: ‘Più non posso’” (quarto motivo di lode: “et non potes sustinere malos”) [7]. Le anime dei superbi sono, a seconda dei pesi imposti, “disparmente angosciate … e lasse” (Purg. XI, 28-29): tema del secondo motivo di lode, il travaglio corporale, unito al significato del nome “Efeso”. Si tratta di motivi già appropriati a Virgilio nell’uscita dall’inferno. Chi non sostiene il male con pazienza è Pier Damiani, il quale invoca l’intervento divino contro i prelati corrotti: “O pazïenza che tanto sostieni!” (Par. XXI, 135).
Il tema del sopportare con perseveranza (settimo motivo di lode) si ritrova spezzato in Par. XVI, 10-12, allorché Dante si rivolge a Cacciaguida dandogli del “voi”, un uso del pronome onorifico che Roma tollerò per prima nei confronti di Cesare trionfatore e nel quale oggi persevera meno delle altre città d’Italia. Il contrasto “prima … sofferie / men persevra” può essere ricondotto al tema della “minoratio” della “prima” carità rimproverata in seguito al vescovo di Efeso (Ap 2, 4), intesa nel senso di perdita dell’originaria devozione verso l’imperatore. La vicinanza, nel testo teologico, di “sostenere” e di “perseverare” sembra escludere la lezione del Petrocchi “a Roma s’offerie”, cioè venne offerto in omaggio a Cesare. È da ricordare quanto detto ad Ap 2, 1 dei vescovi (le stelle) soggetti a Cristo (di cui Cesare è in parte figura), i quali debbono temere le sue minacce e i giudizi e rispettare i suoi moniti e precetti, amarlo e sperare in lui serbando ogni sua parola. “Sofferie” non deve essere necessariamente collegato con un ‘male’ (anche se l’esegesi teologica a questo può indurre), quanto al sopportare qualcosa per un fine alto e santo.
Al tema della pazienza nel tollerare il male con il cuore in pace (terzo motivo di lode) fa riferimento anche l’espressione di Farinata sul parlamento di Empoli, “là dove sofferto / fu per ciascun di tòrre via Fiorenza” (Inf. X, 91-92). L’equivalenza tra ‘sostenere’ e ‘soffrire’ è presente altrove nella Lectura, in relazione alle persecuzioni.
■ (tab. 1.4) Sempre a quanto viene scritto al metropolita di Efeso appartiene, per l’odio nutrito da costui contro di essa, la figura del lussurioso Nicola, uno dei sette diaconi ordinati dagli Apostoli, che aprì la porta a ogni promiscuità per giustificarsi (Ap 2, 6). Colui che si riteneva il fondatore della setta dei Nicolaiti ricorda da vicino Semiramìs, nella descrizione che ne fa Orosio (Hist. I, 4), ricalcata nei versi: “A vizio di lussuria fu sì rotta, / che libito fé licito in sua legge, / per tòrre il biasmo in che era condotta”, per legittimare cioè il suo amore incestuoso per il figlio (Inf. V, 55-57).
È da notare che ai versi relativi alla sposa di Nino fanno seguito altri in cui compaiono ancora due temi dell’esegesi di Ap 2, 6-7. Il primo è il “nominare”, contenuto nel precetto di san Paolo ai Corinzi (1 Cor 5, 11) di non mescolarsi a quanti sono “nominati”, hanno cioè fama di essere impudichi, avari, o ubriaconi: questa “nominatio” è segno di scomunica. Essa diventa propria di Virgilio che nomina “le donne antiche e ’ cavalieri”, anime castigate nella loro lussuria dall’aura nera che le porta: Semiramide, Didone, Cleopatra, Elena, Achille, Paride, Tristano e tanti altri che l’amore condusse a morte (Inf. V, 67-72; i nominati sono sette, come i sette diaconi) [8].
Il secondo tema è l’“affettuoso grido” rivolto da Dante alle due anime affannate di Francesca e Paolo affinché vengano a parlare, avvicinabile all’invito ad ascoltare “affectuose” quello che lo Spirito dice alle chiese (vv. 85-87; cfr. infra).
■ (tab. 1.5; Inf. V, 7-12) Minosse è armato anche da temi del sesto stato. La prima delle dodici tribù d’Israele da cui provengono i 144.000 segnati all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 5) è quella di Giuda, interpretato come “colui che confessa”. A questa si aggiunge la “visione” timorosa, la considerazione della maestà del Figlio di Dio e dei suoi giudizi, designata dalla seconda tribù, di Ruben, interpretato come “figlio che vede” o “figlio della visione”. Dopo questo si esige la virtù dell’astinenza che macera la carne per espugnare virilmente le concupiscenze, designata dalla terza tribù, di Gad, interpretato come “cinto”, ossia armato. Queste caratteristiche delle prime tre tribù – che corrispondono, nel secondo mistero, per coloro che iniziano la via della salvezza e del pentimento, alla confessione, alla contrizione e alla soddisfazione – si ritrovano in Minosse: le anime mal nate si confessano di fronte a questo conoscitore dei peccati – “dicono e odono” -, il quale poi “vede” quale sia il luogo dell’inferno corrispondente alla colpa e ‘si cinge’ quindi con la coda tante volte quanti sono i cerchi che l’anima deve scendere. L’espressione “quantunque gradi” (Inf. V, 12) conduce ancora all’esegesi relativa alla chiesa di Efeso, gradualmente discesa in basso dalla sua carità originaria (Ap 2, 5).
“lasciando l’atto di cotanto offizio” (Inf. V, 18; tab. 1.6.1).
La seconda delle sette guerre sostenute dalla Chiesa (descritte nella quarta visione) viene condotta da Michele – del quale si sottolinea l’ufficio supremo -, duca delle schiere dei martiri assimilati agli angeli buoni che combattono contro quelli malvagi condotti dal drago (Ap 12, 7-12). Non è chiaro – afferma Olivi – se Michele, che nel sacro testo è proposto come principe degli angeli, indichi una sola persona corrispondente a un solo spirito angelico oppure, a seconda dell’ufficio svolto, indichi ora una persona ora un’altra, e se designi solo gli spiriti del penultimo ordine (gli arcangeli) oppure qualsiasi spirito degli ordini supremi in quanto esercitano e reggono gli uffici degli arcangeli o dei principi della milizia celeste nelle sue guerre. L’opinione comune di molti fedeli è che sia uno spirito del penultimo ordine dato alla Chiesa come duce, come nell’Antico Testamento fu duce della Sinagoga (Ap 12, 7; cfr. Daniele, 10, 21; 12, 1).
L’offizio supremo svolto da Michele, “princeps angelorum”, è nel poema appropriato a più persone.
■ Minosse, re dei demoni che impediscono l’andata agli inferi, è pure, nel “cotanto offizio” che gli è commesso, figura infernale dell’arcangelo Michele (citato due canti più avanti, a Inf. VII, 11-12).
■ Bonifacio VIII, “lo principe d’i novi Farisei”, nel combattere una guerra “presso a Laterano” contro soli cristiani, non ebbe riguardo al proprio “sommo officio” o agli “ordini sacri” di cui era investito; “rimise ne le prime colpe” Guido da Montefeltro, come gli angeli malvagi combattuti da Michele (impersonati nell’imperatore Giuliano l’Apostata) cercarono di ripristinare il culto pagano (Inf. XXVII, 70-71, 85-99).
Frate Alberigo asserisce che l’anima di “Michele” Zanche, ucciso a tradimento dal genero Branca Doria, non era ancora giunta fra i barattieri che il traditore aveva lasciato un diavolo in sua vece nel proprio corpo, così da continuare ad apparire vivo su nel mondo (Inf. XXXIII, 142-147). Frate Alberigo, oltre a sapere del diavolo che governa il corpo facendo le veci dell’anima caduta nella Tolomea prima della morte (parodia della questione se Michele appartenga al penultimo ordine o all’ordine supremo in quanto fa le veci degli arcangeli), si rivolge in tema ai due poeti, chiamandoli “anime crudeli / tanto che data v’è l’ultima posta”, che è variazione dello “spiritus penultimi ordinis datus ecclesie” ad Ap 12, 7 (vv. 110-111). Il corpo di chi tradisce, tolto e governato da un demonio, trova riferimento nell’ingresso dei diavoli nei porci (cioè in quanti sono terreni) una volta usciti dagli indemoniati gadareni di cui si dice in Matteo 8, 28-34, citato ad Ap 12, 9 a proposito del diavolo “gettato in terra” in conclusione della seconda guerra. Frate Alberigo usa nel parlare gli stessi motivi che nella quinta bolgia sono propri di Ciampolo nel suo dire beffardo di frate Gomita, barattiere di Gallura, che fu “ne li … offici … non picciol, ma sovrano” e che non si sente mai stanco di parlare sardo con “donno Michel Zanche” (Inf. XXII, 86-90).
Al centauro Chirone Virgilio chiede uno dei suoi che porti Dante sulla groppa nell’attraversare la “riviera di sangue” (portare sulle spalle è tema dalla seconda tromba, ad Ap 8, 9): la domanda del poeta pagano e le parole del centauro a Nesso – “danne un de’ tuoi … e sì li guida” – coincidono con l’esegesi di Michele “unus spiritus … datus … in ducem” (Inf. XII, 91-99). L’esegesi si diffonde sulla “conformitas officii” di Michele, e per restare in tema Virgilio assume su di sé la prerogativa dell’arcangelo dicendo: “Tal si partì da cantare alleluia / che mi commise quest’ officio novo” (vv. 88-89).
All’esegesi di Ap 12, 7 – l’avvicendarsi nell’ufficio di Michele e degli altri angeli – fanno riferimento anche gli angeli preposti ai gironi della montagna del purgatorio, “siffatti officiali” (cfr. Purg. II, 28-30), nonché la Provvidenza, “che quivi comparte / vice e officio, nel beato coro” (Par. XXVII, 16-18).
“dicono e odono e poi son giù volte” (Inf. V, 15).
(tab. 1.6.2 e nota) Al drago, sconfitto nella seconda delle sette guerre sostenute dalla Chiesa (descritte nella quarta visione), viene tolto il dominio e il potere: “E fu gettato in terra quel grande drago, il serpente antico, che è chiamato diavolo e satana e che seduce tutta la terra” (Ap 12, 9). Fra i vari nomi attribuitegli, viene definito “colui che cade giù” (“deorsum fluens”), sia perché cadde giù dal celeste stato nel quale fu creato, sia perché cerca di precipitare tutti all’inferno accusandoli dinanzi al sommo giudice in modo che vengano condannati.
■ Il tema del cadere in giù (l’interpretazione di “diabolus” come “deorsum fluens”) è proprio, oltre che di Lucifero, il quale “cadde giù dal cielo” (Inf. XXXIV, 121), delle anime le quali, dopo il giudizio dinanzi a Minosse, “son giù volte” (Inf. V, 15).
“che visitando vai per l’aere perso … poi c’hai pietà del nostro mal perverso” (Inf. V, 89, 93; tab. 1.7).
Al vescovo di Efeso Cristo si presenta come “colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro” (Ap 2, 1; cfr. i passi della Lectura nei quali compare “in medio”). Le stelle designano i vescovi, i candelabri le chiese. Cristo intende dire in primo luogo che egli conosce bene ogni atto o pensiero, come colui che tiene tutti i vescovi sotto di sé, e come colui che sta in mezzo, visita, scruta, penetra subitamente, esamina. In secondo luogo, vuole mostrare che a ragione essi debbono temere le sue minacce e i giudizi e rispettare i suoi moniti e precetti, amarlo e sperare in lui serbando ogni sua parola. Egli è infatti il loro giudice e signore onnipotente che li tiene e li esamina con circospezione. È il pio pastore che protegge e custodisce, e per questo li tiene e li visita. In terzo luogo, Cristo si propone come tale perché Efeso è chiesa metropolitana, che ha potestà e cura su tutte le altre chiese. “Tenere” indica infatti la potestà; “camminare” la cura d’anime.
■ Il tema del “perambulare”, del visitare con la pietà del pastore che cura il proprio gregge, affiora nelle prime parole di Francesca, che si rivolge al poeta: “pius pastor eos … semper tenens et visitans – O animal grazïoso e benigno / che visitando vai per l’aere perso / noi che tignemmo il mondo di sanguigno … poi ch’hai pietà del nostro mal perverso” (Inf. V, 88-93).
Fra coloro che morirono di morte violenta e che con l’attesa purgano il tardivo pentimento, Buonconte da Montefeltro prega Dante di aiutare il proprio desiderio di pace “con buona pïetate”, procurandogli lui le preghiere che abbrevino la pena, poiché “Giovanna o altri non ha di me cura” (Purg. V, 85-90; da notare, al verso 89, il termine cura, simmetrico a visitando, posto al medesimo verso di Inf. V). L’accorata tristezza di Buonconte, che non ha più nessuno in terra che voglia pregare per lui, è memore delle parole di Matteo 9, 35-36 (citate ad Ap 22, 2 con riferimento al Lignum vitae di Bonaventura) su Cristo pietoso che “andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando e curando ogni languore, e vedendo le folle ne provò compassione, poiché erano come pecore senza pastore”.
■ Beatrice, apparsa nel Paradiso terrestre, viene paragonata a un “ammiraglio” di una flotta, che passa di nave in nave confortando chi opera bene e rimproverando i pigri e i tardi (Purg. XXX, 58-60): nel venire, vedere e visitare imita pertanto Cristo anche nella sollecitudine del “pastor bonus” [9]. Per salvare l’amico, come lei stessa afferma, è scesa al Limbo da Virgilio: “Per questo visitai l’uscio d’i morti” (v. 139).
Il verbo tenere è, nelle parole di Virgilio che evocano Marzia, appropriato a Catone, custode dei “sette regni”, come Cristo tiene e custodisce le sette chiese (Purg. I, 78-82).
L’immagine di Cristo che conosce bene ogni atto o pensiero si incarna in Virgilio (Inf. X, 4-6, 16-18; XVI, 118-120; XXIII, 25-30; Purg. XV, 127-129, collazionato con l’esegesi dell’istruzione data a Tiàtira, la quarta chiesa d’Asia: Ap 2, 23) e in Beatrice (Par. I, 85; II, 26-27; IV, 16-18).
***
[1] Per un esame completo, cfr. “Lectura super Apocalipsim” e “Commedia”. Le norme del rispondersi, cap. 2 (Scendere e risalire per gradi: l’istruzione al vescovo di Efeso (Ap 2, 2-7) secondo Riccardo di San Vittore e Pietro di Giovanni Olivi).
[2] Secondo quanto scritto ad Ap 2, 1: “Ut ergo via allegoriis et etiam litterali sensui et ratio iam predictorum pateat, sciendum quod ea que tanguntur in informationibus harum ecclesiarum coaptantur septem virtualibus exercitiis mentis ordinate ad perfectionem ascendentis, que et proprie correspondent septem statibus ecclesiasticis, propter quod sensus moralis et allegoricus concordant et clare refulgent in sensu litterali”.
[3] La “costa” e lo “scendere” sono temi del quinto stato, il momento della pia condescensione che frange l’ardua e ripida altezza dello stato precedente, proprio degli anacoreti.
[4] Sull’intenso significato da attribuire al termine “punto” cfr. infra.
[5] Fuggire alle ‘pietre’, nelle spelonche dei monti, è anche tema precipuo dell’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12).
[6] Questo vestire di panni vescovili i personaggi, imitatori di Cristo, è sintomo di come il “saeculum humanum” e il sapere classico abbiano conquistato la propria autonomia partecipando alla storia sacra e appropriandosi di sacre prerogative prima di separarsene. Non solo Virgilio, per il quale Beatrice riporterà lodi a Dio (Inf. II, 73-74), ma, per converso, anche “l’anime più nere” fra le quali è Farinata (cfr. Inf. VI, 85-87). Ad Ap 2, 1 si dice che i sette vescovi d’Asia vengono lodati, rimproverati o istruiti non solo per sé ma anche per le chiese sulle quali sovraintendono. Ciò è reso evidente sia dall’espressione, che si applica a ogni chiesa e non è rivolta solo ai vescovi, “chi ha orecchio ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese” (cfr. Ap 2, 7), sia dal fatto che nella quinta chiesa si eccettuano pochi nomi di buoni (Ap 3, 4), sia dal rivolgersi alla quarta chiesa – “dico questo a voi e agli altri che siete di Tiàtira” (Ap 2, 24) -, sia perché la pena del trasferimento del candelabro minacciata al primo vescovo, di Efeso, cioè di passare ad altra chiesa il primato, riguarda tanto il vescovo quanto la chiesa che partecipa della colpa attribuita al suo primate (Ap 2, 5). Il tema della compartecipazione della chiesa con il vescovo, che non è il solo a operare il bene o il male, è nelle parole di Farinata a Dante che gli ha spiegato come le spietate leggi fiorentine contro gli Uberti siano conseguenza del ricordo della strage di Montaperti, “lo strazio e ’l grande scempio / che fece l’Arbia colorata in rosso”: non fu solo lui, capo della parte ghibellina, a muovere, lo fece con gli altri. Non fu un muovere senza ragione, e in questo il magnanimo forse recita il tema che ad Ap 16, 1 è proprio degli angeli ministri del giudizio divino, che si muovono all’esecuzione del proprio ufficio di versare le coppe, per punire o purgare, non per propria volontà o animosità ma per compiere un mandato superiore (Inf. X, 88-90), come nel caso di Cesare, che si mosse “per voler di Roma” (Par. VI, 55-57).
In precedenza, il tema si trova nelle parole di Ciacco, che non è la sola “anima trista” ad essere fiaccata dalla pioggia, “ché tutte queste a simil pena stanno / per simil colpa”, espressione probabilmente memore della bestia ottava di Ap 17, 11, la quale “similter peccat et similiter punietur” come le altre sette (Inf. VI, 55-57; cfr. Inf. IX, 130-131: “Simile qui con simile è sepolto”). Una variazione del tema è in Ugo Capeto, che tra gli avari purganti non è il solo a dire del bene, cioè degli esempi virtuosi ripetuti nel girone durante il giorno (Purg. XX, 121-123).
[7] Cfr. anche il significato di sostentare ad Ap 3, 12 (sesta vittoria). La collazione dei significati portati dagli elementi semantici presuppone un lessico organizzato analogicamente sulla Lectura.
[8] L’esegesi (Ap 2, 6) si sofferma sulle parole di Cristo, che dice al vescovo di Efeso “odisti facta Nicholaitarum”, non ‘odisti eos’, perché è da odiare la malizia, non la natura delle persone. Il confronto è con Inf. XI, 22-23 e anche con Convivio IV, i, 4-5. Sia Olivi che Dante avevano probabilmente presente la Summa theologiae di Tommaso d’Aquino (IIa IIae, q. 34, a. 3).
[9] “Ammiraglio” (cfr. gli “ammiragli” dei quali parla Sapìa senese a Purg. XIII, 154) nella Lectura corrisponde alla “scientia gubernativa” dei vescovi “ad regendum sollicita et intenta” (ad Ap 2, 2; 3, 8; 11, 1), che discende dal sommo rettore (ad Ap 4, 4); alla “gubernatio discursiva” dei quattro animali che stanno “in mezzo e intorno alla sede” (Ap 4, 6), alla “gubernatio future ecclesie” su cui gli Apostoli vennero informati e confermati nella resurrezione di Cristo, come i discepoli di Francesco lo saranno nella sua resurrezione (ad Ap 7, 2), al futuro governo dell’orbe da parte dei sommi rettori che staranno con Cristo sul monte Sion (Ap 14, 1-5), al governo degli spiriti angelici nel versare le coppe (ad Ap 16, 1-17), ai mercanti (“gubernatores” o “naute”) che commerciano per mare con Babilonia (Ap 18, 17-19), agli abati e ai prelati (“per gubernatores designantur abbates seu prelati cenobiorum. Monasteria enim sunt naves spirituales”, ibid.). Beatrice, che è figura di Cristo, ne ricopre le funzioni indicate ad Ap 2, 1. Resta “arditissima similitudine”, per usare un’espressione di L. PERTILE, La puttana e il gigante. Dal “Cantico dei Cantici” al Paradiso Terrestre di Dante, Ravenna 1998, pp. 74ss.
Tab. 1.1
Tab. 1.2
Tab. 1.3
Inf. XXXIV, 70-81Com’ a lui piacque, il collo li avvinghiai;
|
Inf. XXXIV, 82-84“Attienti ben, ché per cotali scale”, gradatim
|
|
[Ap 2, 1.5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Unde et congrue vocatur Ephesus, id est voluntas mea in ea; vel lapsus, quia dum ferveret fuit voluntas Christi in ea ut matris in tenera et novella prole, cum vero lapsa est recte dicitur lapsus. […] “Hec dicit qui tenet septem stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum” (Ap 2, 1). […] In gratia enim accepta nimis secure vixerat et quedam negligenter egerat, et ideo de culmine sue perfectionis ceciderat ad minorationem sue perfectionis. Sed Dominus eum consulendo admonet ut penitendo gradum amissum recuperet, dicens (Ap 2, 5): “Memor esto itaque unde excideris, et age penitentiam et prima opera fac”. […] Item Ricardus, super Danielem, in expositione sompnii Nabucodonosor, ostendit quod sicut statua Nabucodonosor gradatim descendebat ab auro in argentum, deinde in es ac deinde in ferrum et ultimo in testam luteam, sic aliquando gradatim descenditur a supremo virtutum ad ima. Unde ibidem ait: «Puto quod nemo repente fit turpissimus, sed qui minima negligit paulatim defluit. Sicut enim quibusdam profectuum gradibus ad alta conscenditur, sic rursus gradatim ad ima descenditur»*.* RICHARDI A SANCTO VICTORE De eruditione hominis interioris, I, xxiii (PL 196, col. 1270 B). |
||
|
Aen. VI, 431-433, 566-569Nec vero hae sine sorte datae, sine iudice, sedes:
|
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 2-3 (Ia visio, Ia ecclesia)] In sua autem allocutione primo incipit a commendatione, tum ut laudando erigat ipsum ad meliora et confortet ad firmius perseverandum in bonis commendatis, tum ut sequens increpatio meliori animo suscipiatur, sicut prudens surgicus primo palpat suaviter membra sana ut infirmus quietius tolleret percussionem membri infirmi.
|
||
Inf. VIII, 97-99; IX, 7-9
|
Purg. X, 130, 138-139Come per sostentar solaio o tettoe qual più pazïenza avea ne li atti,
|
|
Tab. 1.4
[LSA, cap. II, Ap 2, 6-7 (Ia visio, Ia ecclesia)] Deinde redit ad ipsum episcopum laudandum, ne ex priori increpatione nimium terreretur et ut facilius trahat eum ad spem venie et emende ac per consequens et ad actum penitentie, et etiam ut in sancto zelo et odio contra malos et precipue contra apostatas et hereticos fortius inardescat et ne in tali odio credat esse peccatum, unde et hic dicit ei Christus quod ipse odit facta talium. Dicit ergo (Ap 2, 6): “Sed hoc habes bonum, quod odisti facta Nicholaitarum, que et ego odi”. Augustinus, libro de heresibus, capitulo quinto, dicit quod Nicholaite nominati sunt a Nicholao, uno, ut perhibetur, ex septem diachonis quos apostoli ordinaverant, qui cum de zelo pulcherrime coniugis culparetur, velut purgandi se causa, permisisse fertur ut qui vellet ea uteretur. Quod factum eius versum est in sectam turpissimam, ut esset indifferens feminarum usus. Hii etiam utuntur cibis immolatis idolis, nec adversantur alios ritus gentilium superstitionum. Hec Augustinus*. Facta ergo Nicholaitarum vocat heresim et abhominabiles luxurias et comessationes eorum.
|
||
OROSII Historiarum adversus paganos, lib. I, 4Haec, libidine ardens, sanguinem sitiens […] tandem filio flagitiose concepto impie exposito inceste cognito privatam ignominiam publico scelere obtexit. Praecepit enim, ut inter parentes ac filios nulla delata reverentia naturae de coniugiis adpetendis ut cui libitum esset liberum fieret.
|
Inf. XI, 22-23D’ogne malizia, ch’odio in cielo acquista,
|
|
Tab. 1.5
Tab. 1.6.1
[LSA, cap. XII, Ap 12, 7-8 (IVa visio, IIum prelium)] Sequitur (Ap 12, 7): “Et factum est prelium magnum in celo”, id est in sancta ecclesia. “Michael et angeli eius preliabantur cum drachone, et dracho pugnabat et angeli eius”, scilicet contra exercitum Michaelis. […]*
|
||
Inf. XII, 88-99, 136-138“Tal si partì da cantare alleluia
|
Inf. XXII, 81-90Ed ei rispuose: “Fu frate Gomita,
|
|
*[LSA, cap. XII, Ap 12, 7-8 (IVa visio, IIum prelium)] Sequitur (Ap 12, 7): “Et factum est prelium magnum in celo”, id est in sancta ecclesia. “Michael et angeli eius preliabantur cum drachone, et dracho pugnabat et angeli eius”, scilicet contra exercitum Michaelis.
|
||
Inf. VII, 10-12; XII, 11-13, 118-120; XIII, 7-9Non è sanza cagion l’andare al cupo:
|
Purg. XIII, 19-21, 49-51Tu scaldi il mondo, tu sovr’ esso luci;
|
|
Tab. 1.6.2 (cfr. nota)
[LSA, cap. XII, Ap 12, 9 (IVa visio, IIum prelium)] “Et proiectus est” (Ap 12, 9), scilicet a predicta dominatione et potestate, “dracho ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur Diabolus et Sathanas”.
|
||
Purg. XIV, 37-39, 43-45, 61-66, 94-96, 103-105, 118-120, 124-126, 145-147; XVI, 136-138vertù così per nimica si fuga
|
||
Inf. V, 13-15Sempre dinanzi a lui ne stanno molte:
|
Purg. XI, 67-69
Io sono Omberto; e non pur a me danno 2, 10
superbia fa, ché tutti miei consorti 6, 4
ha ella tratti seco nel malanno.
Purg. XIX, 58-63
“Vedesti”, disse, “quell’antica strega
che sola sovr’ a noi omai si piagne;
vedesti come l’uom da lei si slega.
Bastiti, e batti a terra le calcagne;
li occhi rivolgi al logoro che gira
lo rege etterno con le rote magne”.
Inf. X, 22-24; XXIII, 76-77, 91-93; XXVIII, 108; XXXII, 65-66; Purg. XI, 58-60
O Tosco che per la città del foco
vivo ten vai così parlando onesto,
piacciati di restare in questo loco.
E un che ’ntese la parola tosca,
di retro a noi gridò: …………………
Poi disser me: “O Tosco, ch’al collegio
de l’ipocriti tristi se’ venuto,
dir chi tu se’ non avere in dispregio”.
che fu mal seme per la gente tosca.
e fu nomato Sassol Mascheroni;
se tosco se’, ben sai omai chi fu.
Io fui latino e nato d’un gran Tosco:
Guiglielmo Aldobrandesco fu mio padre;
non so se ’l nome suo già mai fu vosco.
[Ap 12, 7] Secundo quia sancti martires principaliter certabant ad expellendum de mundo culturam demonum et idolorum in quibus colebantur, et e contra pagani et demones principaliter certabant ad destruendum celestem et angelicum cultum Christi seu Dei unius et trini.
Inf. XII, 11-12, 44-45; XXIV, 112-114, 121-123
e ’n su la punta de la rotta lacca
l’infamïa di Creti era distesa ……
e in quel punto questa vecchia roccia,
qui e altrove, tal fece riverso.
E qual è quel che cade, e non sa como,
per forza di demon ch’a terra il tira,
o d’altra oppilazion che lega l’omo ……
Lo duca il domandò poi chi ello era;
per ch’ei rispuose: “Io piovvi di Toscana,
poco tempo è, in questa gola fiera”.
Inf. XXVII, 100-102, 110-111
E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti;
finor t’assolvo, e tu m’insegna fare
sì come Penestrino in terra getti”.
lunga promessa con l’attender corto
ti farà trïunfar ne l’alto seggio.
[LSA, cap. XII, Ap 12, 12] “Propterea”, id est propter proiectionem demonum et propter tam triumphalem virtutem sanctorum martirum, “letamini, celi et qui habitatis in eis”. Celos vult letari, tum illo modo affectus quo res inanimatas alloquimur et nobiscum quasi coexaltare vel condolere appetimus; tum ut celi sumantur pro sanctis habitantibus in eis unde, secundum Ricardum, quod premittit: “celi” exponit cum subdit: “et qui habitatis in eis”; tum quia per celos possunt intelligi superiores sancti sub quorum ali<s> inferiores habitant, vel sumuntur pro toto collegio in quo unusquisque stat sicut pars in suo toto.
Inf. XXXIII, 130-132
come fec’ ïo, il corpo suo l’è tolto
da un demonio, che poscia il governa
mentre che ’l tempo suo tutto sia vòlto.
Purg. XIII, 148-150
E cheggioti, per quel che tu più brami,
se mai calchi la terra di Toscana,
che a’ miei propinqui tu ben mi rinfami.
Par. XXII, 115-117
con voi nasceva e s’ascondeva vosco
quelli ch’è padre d’ogne mortal vita,
quand’ io senti’ di prima l’aere tosco
[Nota alla tab. 1.6.2]
Il diavolo, sconfitto da Michele e dalle sue schiere (Ap 12, 9; quarta visione, seconda guerra), viene chiamato “serpente” per la malizia e l’errore con cui intossica il mondo, che seduce con dolosa astuzia. Viene detto “antico” perché, creato all’inizio del mondo, fin da principio si allontanò dalla verità e divenne omicida, come affermato in Giovanni 8, 44 (cfr. il passo simmetrico ad Ap 20, 2). Con parola greca viene definito “diavolo”, cioè “accusatore”; oppure, secondo altri, “colui che cade giù” (“deorsum fluens”), sia perché cadde giù dal celeste stato nel quale fu creato, sia perché cerca di precipitare tutti all’inferno accusandoli dinanzi al sommo giudice in modo che vengano condannati. In ebraico viene chiamato “satana”, cioè “avversario”, poiché sempre avversa gli eletti. “Seduce tutta la terra”, in quanto sedusse in Adamo tutto il genere umano, che trae quasi tutto a sé, tanto che, ad eccezione di Cristo e di sua madre, non vi è adulto che non venga sedotto a commettere qualche peccato, sia pure veniale. Il diavolo “fu gettato in terra”, ovvero nell’infimo grado, calpestato dai santi come si calca la terra. Oppure “in terra”, in quanto gli venne concesso di penetrare con più forza negli aderenti alle cose terrene, come entrò rapido nei porci allorché venne espulso dai due indemoniati ad opera di Cristo (Matteo 8, 28-34).
I temi tratti dalle interpretazioni dei nomi del diavolo percorrono nel secondo girone del purgatorio, dedicato agli invidiosi, la descrizione che Guido del Duca fa della valle dell’Arno. Questa è semanticamente intrecciata di vari temi, come quelli che accompagnano ad Ap 17, 6 la similitudine del fiume di sangue dall’acqua prima pagana e poi cristiana che ridonda per sineddoche storica sulla moderna meretrice [1]. Lo stesso nome del fiume maledetto, che meglio è tenere nascosto, contiene in sé una parte di uno dei tre nomi che si ricavano dal 666, cioè dal numero del nome della bestia [2]. Ma, come in più luoghi del poema la pur tanto rimproverata Firenze veste i panni della santa e pacifica Gerusalemme celeste descritta nella settima visione [3], così il ricordo dei bei tempi di Romagna è da Guido del Duca indotto trasformando anche l’esegesi del cortese invito dello Spirito di Cristo al serotino convivio (Ap 22, 17) [4].
In quella valle (Purg. XIV, 37-38) la virtù viene da tutti fuggita “come biscia” (“serpens”) e “per nimica” (il diavolo ad Ap 12, 10 è detto pure “Dei et suorum omnium martirum inimicus”). Lungo il suo corso iniziale, nel Casentino, il fiume scorre “tra brutti porci, più degni di galle / che d’altro cibo fatto in uman uso” (vv. 43-45; cfr. Matteo, 8, 28-34). Sempre nelle parole di Guido (v. 62), Fulcieri da Calboli, il feroce podestà di Firenze nel 1303, viene definito “antica belva” che uccide i lupi fiorentini (corrisponde all’ “antiquus … factus est homicida”: “antica belva”, secondo questa interpretazione, è riferito a Fulcieri, ed esclude l’altro senso di ‘bestia vecchia mandata a macellare’). Fulcieri esce sanguinoso dalla “trista selva” fiorentina, lasciandola in tali condizioni che non basterebbero mille anni per farla tornare al pristino stato (vv. 64-66): anche il riferimento ai “mille anni”, che può apparire generico, fa parte del gruppo tematico che concerne il diavolo, del quale ad Ap 20, 3 (settima visione) si dice che venne gettato e chiuso nell’abisso in modo da non sedurre più fino al compimento dei mille anni. Guido piange quindi la decadenza della Romagna, piena di “venenosi sterpi” al punto di rendere tardivo ogni tentativo di coltivarla (vv. 94-96: il veleno è proprio del serpente; il coltivare, in senso equivoco con ‘culto’, è nel “colere” di Ap 12, 7, dove è descritta la seconda guerra che vede contrapposte la ‘coltura’ dei demoni e il ‘culto’ di Cristo). Sostiene Guido che i Pagani, signori di Faenza, faranno bene a non rifigliare “da che ’l demonio / lor sen girà”, cioè dopo che sarà morto (nel 1302) l’ultimo di loro, Maghinardo, ma di essi non rimarrà più “puro … testimonio” (vv. 118-120): nella terzina sono presenti i temi dell’espulsione del demonio (Ap 12, 7.9) e della vittoria sul diavolo per opera della testimonianza della fede (Ap 12, 11: “vicerunt illum … propter verbum testimonii sui”), mentre il nome della famiglia romagnola concorda coi “pagani” che nella seconda guerra combattono a fianco dei demoni contro il culto di Cristo. Guido del Duca chiude il suo ragionare con la mente stretta dal desiderio di piangere più che di parlare, e licenzia Dante equivocando sul suo essere “Tosco” («“serpens” dicitur per venenum malitie et erroris quo mundum extoxicat»; vv. 124-126). Non diversamente si esprime alla fine del canto precedente Sapia senese, la quale chiede al poeta di rimetterla in buona fama presso i propri parenti, “se mai calchi la terra di Toscana”, che è variazione sul tema del diavolo gettato in terra e ‘calcato’ (Purg. XIII, 148-150). Il parlar “tosco” è sinonimo di inganno e tentazione per Marco Lombardo (Purg. XVI, 136-138). Da notare, a Purg. XIX, 58, 61, la giustapposizione: «“Vedesti”, disse, “quell’antica strega (hapax: la “femmina balba”) … Bastiti, e batti a terra le calcagne”», ‘antica’ come il diabolo e virtualmente ‘calcata’ dal poeta.
È da notare ancora, nelle parole di Virgilio in fine di Purg. XIV (vv. 145-147), il motivo del trarre al peccato seducendo il genere umano, da Ap 12, 9, combinato con un passo da Ap 12, 4 (prima guerra), dove è il demonio, inconsapevole della divinità della persona che l’avrebbe trafitto, ad essere ingannato con l’esca offerta dall’amo dell’inferma umanità di Cristo. Il tema svolge un ruolo importante nell’incontro di Dante con Beatrice nel Paradiso terrestre [5].
Il tema del diavolo – «“proiectus est in terram” et cetera, id est in infimam deiectionem» – è appropriato al Minotauro: “e ’n su la punta de la rotta lacca / l’infamïa di Creti era distesa” (Inf. XII, 11-12), in simmetria con la “vecchia roccia” infernale che “tal fece riverso” (hapax: espressione vicina al “deorsum fluens”) per il terremoto che accompagnò la morte del Redentore, della quale in seguito dice Virgilio (vv. 44-45). È messo in bocca a Bonifacio VIII, “il gran prete” che domandò consiglio al francescano Guido da Montefeltro affinché gli insegnasse “sì come Penestrino in terra getti” (Inf. XXVII, 101-102). Si tratta di due zone – quella dei violenti contro il prossimo e la bolgia dei consiglieri fraudolenti latini – che si riferiscono in prevalenza al secondo stato.
Il medesimo tema, unito al motivo della penetrazione demoniaca nei corpi, è presente nella metamorfosi di Vanni Fucci il quale, piovuto “di Toscana”, si accende trafitto da un serpente, arde e cade a terra distrutto in cenere per poi ritornare nella forma primitiva: il ladro viene, tra l’altro, paragonato all’epilettico, “… quel che cade … / per forza di demon ch’a terra il tira” (Inf. XXIV, 112-113: ‘cadere’ e ‘tirare’ sono anch’esse qualità proprie del diavolo).
Come racconta frate Alberigo, memore degli indemoniati gadareni di Matteo 8, 28-34, le anime dei traditori degli ospiti cadono nella Tolomea (altra zona riferibile al secondo stato) prima della morte dei corpi, che vengono governati da demoni in essi penetrati (Inf. XXXIII, 121-147).
[1] L’esegesi di Ap 17, 6, di eccezionale importanza per il connubio tra tempo pagano e tempo cristiano, è esaminata infra.
[2] Cfr. “Un cinquecento diece e cinque”, 11.4.4, tab. CXVI, e infra.
[3] Cfr. La settima visione, I.4.
[4] Cfr. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno (Francesca e la «Donna Gentile»), 7 (Gentilezza, Gentilità, affanni, cortesia), tab. XXXI e infra.
[5] Cfr. Ibid., 8 (Beatrice ritrovata e subito perduta).
Tab. 1.7
2. Il tempo dei martiri
“Quali colombe, dal disio chiamate / con l’ali alzate e ferme al dolce nido” (Inf. V, 82-83; tab. 2.1)
Lo stato dei martiri, il secondo dei sette nei quali si sviluppa la storia della Chiesa, corrisponde al secondo giorno della creazione, nel quale venne fatto in cielo, ovvero nella Chiesa celeste, il firmamento della pazienza e della costanza dei martiri per cui i desideri della vita superna furono divisi dai desideri della vita terrena, come le acque superiori da quelle inferiori; così nella seconda età del mondo l’arca di Noè fu levata sopra altissimi monti (prologo, Notabile XIII). Qui Olivi sembra trasporre sul piano esegetico l’opposizione risalente al Timeo platonico fra il movimento erratico dei pianeti e dei corpi terrestri e il movimento razionale del firmamento e dei corpi celesti [1].
■ Nel secondo girone della montagna, segnato in prevalenza da temi del secondo stato, Virgilio si rivolge a “gente sicura” di vedere Dio (la seconda vittoria sta nell’essere ‘sicuri’ della vita eterna: Ap 2, 11), “l’alto lume / che ’l disio vostro solo ha in sua cura”, parole da porre in relazione, per contrasto, con gli “anxii fluctus curarum” contro i quali suona la seconda tromba (cap. XI; Purg. XIII, 85-87). Nel medesimo girone, il poeta pagano, spiegando una frase di Guido del Duca sul possesso dei beni terreni che generano invidia se posseduti in compagnia, afferma che questo timore non sussisterebbe “se l’amor de la spera supprema / torcesse in suso il disiderio vostro” (Purg. XV, 52-54), che è variazione del tema della separazione dei desideri proposto dal Notabile XIII. Levare “in sù” il mento, come fanno i ciechi aspettando le parole, oppure in procinto di parlare, è atteggiamento rispettivamente di Sapìa senese e di Guido del Duca e Rinieri da Calboli (Purg. XIII, 102; XIV, 9): corrisponde anch’esso al levarsi del desiderio e fa coincidere il “firmamento”, che divide le acque superiori da quelle inferiori, con il “mento”, che è parte del corpo che divide in su o in giù, come in altri luoghi del poema (levare il mento al comando di Beatrice è proprio di Dante in Purg. XXXI, 73, dopo il rimprovero di aver desiderato cose mortali e fallaci invece di levarsi in su dietro alla sua donna, salita di carne a spirito e cresciuta in bellezza e virtù).
■Il tema del firmamento, inteso come fermezza nel desiderare i beni superni divisi da quelli terreni, levandosi come l’arca di Noè, si trova nell’uscire di Paolo e Francesca dalla schiera dov’è Didone all’affettuoso grido di Dante, venendo per l’aere maligno “quali colombe, dal disio chiamate / con l’ali alzate e ferme al dolce nido”: ma il loro desiderio “mai … non fia diviso” (Inf. V, 82-85, 135). I due amanti, travolti in vita dalla passione, non raggiunsero mai il firmamento; dannati, lo conseguono solo per il tempo dell’incontro con Dante, tornando poi a essere travolti dalla “bufera infernal, che mai non resta”. Alla fonte virgiliana – “dulces […] nidi […] neque commovet alas – dolce nido … ali … ferme” (Aen. V, 214.217) – si aggiunge alzate (levaturque archa per diluvium: è da escludere la variante aperte), unitamente a quei termini disio e dolce i quali “così squisitamente dominanti nello stilnovismo di Dante e dei suoi amici, sono qui risemantizzati nel senso di desiderio dei sensi e di dolcezza di amore passionale. Le due parole si distendono attraverso tutto il canto e lo legano in maniera alta e complessa” [2]. Sono parole che per semantica spirituale rinviano a un diverso e più alto oggetto, quello costituito dal dolce e desiderabile bere dalle fonti delle acque della vita, alle quali Cristo conduce le schiere dei suoi amici dopo le tribolazioni patite (Ap 7, 17). Anche il sintagma disio / voler, qui inteso come impulso sensuale, è solo il grado iniziale di un termine finale spirituale, che si realizzerà nel disio e ’l velle della visione finale, nel desiderio e volontario consenso all’invito dello Spirito (Ap 22, 17).
L’angelo nocchiero ha invece le ali “dritte verso ’l cielo … sen venne a riva / con un vasello snelletto e leggero, / tanto che l’acqua nulla ne ’nghiottiva” (Purg. II, 34, 40-42).
Sarcastica è la variazione del tema appropriata a Giovanni XXII, il quale può ben dire di aver “fermo … disiro” al fiorino, in Par. XVIII, 133-136.
“… quei due che ’nsieme vanno, / e paion sì al vento esser leggeri” (Inf. V, 74-75; tab. 2.1)
■ Fra le età dell’uomo, il secondo stato corrisponde alla puerizia inesperta (prologo, Notabile III). Il tema, congiunto con quello del combattimento, è nella visione estatica del martirio di santo Stefano, “un giovinetto … in tanta guerra”, che compare nel terzo girone del purgatorio tra gli esempi di mansuetudine (Purg. XV, 106-114). Il tema è anticipato all’inizio del canto con l’immagine della sfera del sole che nelle prime tre ore del giorno “sempre a guisa di fanciullo scherza” (vv. 1-3), che è sviluppo della puerizia inesperta del III Notabile. È un passo rimasto sempre oscuro ai commentatori, “uno dei rari luoghi … che avrebbero avuto bisogno di qualche ulteriore cura per riuscire perspicui, e forse l’avrebbero avuta, se la morte non avesse impedito al poeta di ritornare sull’opera sua” (Scartazzini). L’elemento che mancava ai commentatori è la connessione tra lo scherzare del fanciullo e la sua inesperienza, che costituisce il motivo principale dell’inizio del canto. Nel purgatorio in quel momento inizia il vespero e mancano alla sera tre ore, tanto tempo quanto quello percorso dal sole, che scherza a guisa di fanciullo, tra il principio del giorno e la fine dell’ora terza. Camminando verso occidente, i due poeti vengono colpiti di fronte dai raggi del sole, quando ad un tratto Dante si sente la fronte gravata da uno splendore maggiore che lo costringe a farsi “’l solecchio” con le mani per riparare la vista. Di questo aumento improvviso della luminosità del sole Dante non aveva prima mai avuto esperienza (“e stupor m’eran le cose non conte”, v. 12). Al poeta pare di essere percosso da luce del sole riflessa, “sì come mostra esperïenza e arte”, ma Virgilio gli spiega che la luce proviene dall’angelo: non si deve meravigliare del restare abbagliato da parte della “famiglia del cielo”, poiché al termine della salita la luce non gli sarà grave ma dilettevole, per quanto la natura umana è capace di sentire (vv. 16-33). Si tratta dunque di credenza dovuta a inesperienza oppure di falsa esperienza che è già materia del terzo stato, ai cui temi si rapporta principalmente tutta la zona del terzo girone del purgatorio. Lo scherzare “inesperto” del sole a guisa di fanciullo nelle prime tre ore del giorno, oltre che riferimento astronomico alle oscillazioni del suo moto apparente fra i due tropici, sarà pertanto da intendere nel senso di un’allusione alla luminosità non ancora matura, “quae semper tremulat et est in motu, ut puer, ludendo” come intendeva Pietro di Dante, oppure che cresce via via fino al meriggio (all’arrivo alla spiaggia del purgatorio, nell’ora in cui il sole “sempre a guisa di fanciullo scherza”, l’inesperienza è propria di Virgilio e Dante: “Voi credete / forse che siamo esperti d’esto loco”: Purg. II, 61-62). L’immagine è ripresa da Marco Lombardo a proposito dell’ “anima semplicetta che sa nulla”, la quale appena creata esce di mano a Dio “a guisa di fanciulla / che piangendo e ridendo pargoleggia” e a partire dai piccoli beni, dei quali sente il sapore, inizia a desiderare sempre di più, se una guida o un freno non torce il suo amore al vero bene (Purg. XVI, 85-93).
■ Se la puerizia appartiene al secondo stato, l’adolescenza è propria del terzo, l’età dei dottori che confutano con la spada della ragione le eresie, età assimilata per antonomasia all’uomo razionale (prologo, Notabile I). In questo periodo adolescenziale, lo zelo dei dottori contrasta la leggerezza della Chiesa, agitata da ogni vento dell’errore (prologo, Notabile III). Così, dannati fra “i peccator carnali, / che la ragion sommettono al talento”, i due “’nsieme vanno, / e paion sì al vento esser leggeri” (Inf. V, 38-39, 74-75).
■ Lo stato dei martiri si conforma, fra i sacramenti, alla cresima che col segno della croce impresso sulla fronte conferma e rafforza nel combattimento (prologo, Notabile XIII). Alle anime che ha condotto alla spiaggia del purgatorio l’angelo nocchiero fa il segno della croce prima di ripartire (Purg. II, 49); “la nova gente” poi “alzò la fronte” per chiedere ai due poeti la via della montagna (vv. 58-60). Ai martiri appartiene per antonomasia il superamento delle tentazioni. La seconda tromba suona contro gli ansiosi flutti dell’amore, costituiti dagli affanni e dalle sollecitudini, il cui eccesso forma quasi un mare tempestoso (cfr. tab. 4.1). Il tema degli affanni d’amore è presente nell’episodio di Casella (vv. 106-117; cfr. infra).
Cacciaguida, martire combattendo contro i Saraceni, è segnato da molti temi del secondo stato: il suo lume discende da una croce dove lampeggia Cristo, “chi prende sua croce e segue Cristo” potrà scusare l’impossibilità di trovare, da parte del poeta, un’immagine degna che lo rappresenti (Par. XIV, 103-108: “nichilque ita profuit ad radicationem prime plantationis sicut imitatio crucis Christi” [prologo, Notabile V]); Dante (anch’egli ‘martire’ per l’esilio) domanda alla sua “radice” (Par. XV, 89; cfr. le parole di Francesca a Inf. V, 124-125) “quai fuor li anni / che si segnaro in vostra püerizia” [Par. XVI, 23-24: “signo crucis insigniuntur in fronte (prologo, Notabile XIII) … zelus … fertur … contra pueritiam inexpertam (prologo, Notabile III)”].
“guarda com’ entri e di cui tu ti fide / non t’inganni l’ampiezza de l’intrare!” (Inf. V, 19-20; tab. 2.2).
All’informazione data alla chiesa dei martiri, Smirne, seconda delle sette chiese d’Asia, è premessa un’introduzione in cui Cristo si presenta come antecessore e principio di tutte le cose, le quali hanno anche in Lui termine: “Queste cose dice il primo e l’ultimo” (Ap 2, 8). Egli intende dire: non devi diffidare che io possa salvarti dalle tue passioni, perché io sono l’inizio e la fine di tutto. È infatti primo per dignità e ultimo per umiltà fino a morire in croce. Per cui soggiunge: “che era morto e vive”, come intenda dire: ‘l’esempio della mia morte, e la speranza della mia vita che mi sono meritata con la morte, e il mio potere debbono animarti ai martìri, e in essi non devi diffidare ma anzi sperare di conseguire la vita eterna’. Cristo poi conforta il vescovo di Smirne a sostenere impavido i futuri patimenti: “Nichil horum timeas, que passurus es”, quasi intenda dire: ‘patirai molto, ma non devi temere, perché io sarò sempre con te per proteggerti in quel che non è dato per tuo danno, ma per tua prova e affinché tu consegua in ciò maggior merito e premio’. Prevedere i dardi, infatti, ferisce meno.
■ Al momento di cominciare il viaggio, un Dante timoroso e diffidente della propria virtù si rivolge a Virgilio, sua guida, perché consideri se essa sia sufficiente – “guarda la mia virtù s’ell’è possente, / prima ch’a l’alto passo tu mi fidi” (Inf. II, 10-12, 34-35), dove l’espressione “alto passo”, qui come nel caso di Ulisse (Inf. XXVI, 132), non indica solo il limite fra l’umano e il divino, fra il tempo e l’eterno [3], ma contiene in sé il valore del patire per un fine alto. Dante fa l’esempio di san Paolo, che come Enea fece il viaggio prima di lui, con le parole dell’esegesi di quanto Cristo dice al vescovo di Smirne: “Andovvi poi lo Vas d’elezïone, / per recarne conforto a quella fede / ch’è principio a la via di salvazione – non diffidas te a tuis passionibus per me salvandum, quia ego sum omnium principium … ad futuras passiones impavide expectandas et tolerandas confortatio” (Inf. II, 28-30).
Virgilio è di conforto al discepolo nel metterlo “dentro a le segrete cose”; l’atto ripete la dodicesima prerogativa di Cristo in quanto sommo pastore (Ap 1, 17): «E poi che la sua mano a la mia puose / con lieto volto, ond’ io mi confortai – Duodecima est humiliatorum et tremefactorum familiaris confortatio et sublevatio … ideo pro primo dicit: “et posuit dexteram suam super me”, pro secundo autem subdit: “dicens: noli timere”» (Inf. III, 19-21; cfr. IV, 13-18; XXXI, 28-29).
■ Nel secondo cerchio, Minosse ammonisce il poeta a diffidare – “guarda com’ entri e di cui tu ti fide; non t’inganni l’ampiezza de l’intrare!” –, ma viene messo a tacere da Virgilio (Inf. V, 16-24). Le parole del mitico re sono memori di Aen. VI, 126-127: “facilis descensus Averno: / noctes atque dies patet atri ianua Ditis”, e di Matteo 7, 13: “lata porta et spatiosa via est, quae ducit ad perditionem”. Ma tali reminiscenze sono incastonate nell’esegesi apocalittica (Ap 11, 8) che tratta della grande città, la Gerusalemme terrena chiamata “Sodoma” perché muta ed “Egitto” perché tenebrosa, cioè il regno di questo mondo secondo Gioacchino da Fiore, sulle cui piazze giaceranno i corpi dei due testimoni, Elia ed Enoch, uccisi dall’Anticristo. Proprio Gioacchino interpreta le piazze della città dei reprobi come gli uomini “qui sibi elegerunt vias latas ducentes ad perditionem”. Nello stesso canto, poco dopo, è presente il tema di Sodoma-città muta e del tenebroso Egitto: “Io venni in loco d’ogne luce muto” (v. 28).
■ I motivi tratti da Ap 2, 8.10 – non diffidare o temere, confortare, animare alla speranza –, che Cristo propone a Smirne, sono evidenti nei versi con i quali Virgilio rassicura il discepolo al momento di lasciarlo solo, per recarsi a parlare coi diavoli piovuti sulle porte della città di Dite: Dante non deve temere, ma confortare e cibare di buona speranza lo spirito lasso. Nessuno può impedire il passaggio, concesso da Dio: il “passo”, come il “passar” nelle precedenti parole di Dante, rientra nella tematica della tribolazione imminente (Inf. VIII, 103-108). Virgilio è “duca” che ha reso “sicurtà” più di sette volte (vv. 97-98): il tema dell’essere sicuri è proprio della seconda vittoria (Ap 2, 11; cfr. Inf. XVI, 32-33; XXI, 64-66, 81, dove la “sicura fronte” di Virgilio verso i Malebranche allude in più al sacramento della cresima, tipico del secondo stato), mentre quello del “dux” lo si trova ad Ap 1, 10-12, passo in cui Giovanni sente una voce dietro le spalle, quasi proveniente da una guida che custodisce o che conduce una cavalcatura, e si volge ad essa. Non è l’unico caso, nel poema, in cui si combinano temi della seconda chiesa con quelli di Ap 1, 10-12 (volgersi e guidare). A Purg. III, 19-24, Virgilio, che è sempre con Dante, svolge ancora l’ufficio di Cristo verso Smirne (“ego tecum semper ero et protegam – non credi tu me teco”); a Par. XVIII, 7-12 i motivi sono appropriati a Beatrice. All’esegesi dell’istruzione data a Smirne rinviano ancora i versi di Purg. IX, 43-48, al risveglio, pieno di spavento, dal primo sonno sulla montagna, e di Par. XXV, 34-48, nelle parole di san Giacomo, che designa per antonomasia la speranza, precipuo tema della seconda chiesa. Infine, anche l’espressione “ché saetta previsa vien più lenta” (Par. XVII, 27), per quanto assai comune negli scrittori medievali, è tessuta con i fili tratti dall’esegesi della chiesa di Smirne, che viene preparata e animata al martirio come Dante, dal suo avo Cacciaguida, agli strali dell’esilio (Ap 2, 10).
■ Quanto Bonifacio VIII dice a Guido da Montefeltro, cinto del capestro francescano – «E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti; / finor t’assolvo, e tu m’insegna fare / sì come Penestrino in terra getti. / Lo ciel poss’ io serrare e diserrare, / come tu sai; però son due le chiavi / che ’l mio antecessor non ebbe care”» (Inf. XXVII, 100-105) – per indurlo a dare “’l consiglio frodolente” su come prendere Palestrina ai Colonna, rinvia sinistramente a due precisi passi della Lectura. Papa Caetani, nelle sue parole ebbre, ripete l’invito dato da Cristo alla seconda chiesa, quella dei martiri, a non diffidare poiché egli è Colui che tutto precede e conclude (Ap 2, 8): “Tuo cuor non sospetti; / finor t’assolvo” (cfr. le parole di Francesca: “soli eravamo e sanza alcun sospetto”, Inf. V, 129). La potestà delle chiavi, in virtù della quale il papa può sciogliere e legare – “Lo ciel poss’ io serrare e diserrare” –, è perfezione di Cristo sommo pastore di cui ad Ap 1, 18, passo simmetrico ad Ap 2, 8 per la comune espressione con la quale Cristo dice di essere “primus et novissimus”. Il presentarsi di Cristo alla chiesa di Smirne come “Colui che antecede” viene appropriato in tono beffardo a Celestino V, “’l mio antecessor”, che rinunciando “non ebbe care”, cioè non si curò delle chiavi che aprono e chiudono la salvezza. Figura perversa di Cristo in quanto sommo pastore: tale l’immagine di Bonifacio VIII che avrebbe dovuto imprimersi nella mente degli Spirituali francescani, riformatori della Chiesa.
Come Guido da Montefeltro non sospettò di Bonifacio VIII, così il conte Ugolino dell’arcivescovo Ruggieri (“fidandomi di lui”, Inf. XXXIII, 17).
■ Fra i temi propri dell’esegesi della seconda chiesa (Ap 2, 10) c’è la “prova” contrapposta al “danno”, nel senso che i martìri non sono diretti a danneggiare o a rovinare ma a provare. Nel secondo ciclo settenario dell’Inferno, che si snoda da Inf. X, la tematica del secondo stato dei martiri è appropriata ai violenti contro il prossimo (nel primo ciclo è Inf. V ad esserne il fulcro). Guardati da centauri “armati di saette” (Inf. XII, 56, 77, motivo comune alla seconda chiesa e al primo sigillo, ad Ap 6, 2), i tiranni “che dier nel sangue e ne l’aver di piglio” (cfr. Ap 2, 9) piangono “li spietati danni” (vv. 104-106); Virgilio chiede a Chirone di darne uno dei suoi (cfr. Ap 12, 7: seconda guerra), “a cui noi siamo a provo” (letteralmente ad prope, ‘accanto’, ma variazione sull’inciso: “quia ego tecum semper ero et protegam, tum quia non sunt ad tuum dampnum, sed potius ad probationem”), che porti Dante “in su la groppa” (cfr. Ap 8, 9: seconda tromba); Nesso, “scorta fida”, compie l’ufficio (vv. 93-96, 100). A Inf. XXVII, 43, nella zona dedicata al secondo stato del quarto ciclo settenario della prima cantica, Forlì è “la terra che fé già la lunga prova”, nel 1282, contro i francesi inviati da papa Martino IV.
“Sanza danno di pecore o di biade” sarà, come profetizza Beatrice a Purg. XXXIII, 49-51, l’intervento di “un cinquecento diece e cinque”, il messo divino che ucciderà la prostituta e il gigante. Nelle parole della donna (v. 42) entra anche il tema dello star sicuri, proprio della seconda vittoria (Ap 2, 11; cfr. Purg. XXXII, 99).
“mena li spirti con la sua rapina” (Inf. V, 32; tab. 2.3).
Cristo si rivolge al vescovo della chiesa di Smirne, dicendo (Ap 2, 9): “Conosco”, in virtù della scienza posseduta da un pastore compassionevole e attento nel governare e remunerare, “la tua tribolazione”, ad opera dei tuoi persecutori, “e la tua povertà”, cioè la penuria di beni temporali e necessari al tuo sostentamento, che forse non gli era stata causata solo da una scelta volontaria, ma anche dalla rapina inflittagli, secondo quanto san Paolo dice agli Ebrei: “Infatti avete compatito i carcerati e avete accettato con gioia la rapina dei vostri beni, sapendo di possedere beni migliori e duraturi” (Heb 10, 34). Per questo dice: “ma tu sei ricco”, cioè di grazie, meriti e opere virtuose. Viene quindi specificato un tipo di persecuzione: “sei calunniato da parte di quelli che si dicono Giudei e non lo sono”, cioè da parte dei Giudei secondo la carne ma non secondo lo spirito, che non avevano questo nome nel suo vero significato (Giudeo significa infatti “colui che confessa”, che cioè glorifica Dio). Costoro “appartengono alla sinagoga di Satana”, ossia alla comunità dell’avversario, dal cui istinto e suggestione sono adunati per perseguitare Cristo e i suoi.
■ I lussuriosi vengono trascinati dalla “rapina” de “la bufera infernal, che mai non resta” (Inf. V, 31-33). L’allusione alla furia della passione propria di coloro “che la ragion sommettono al talento” non è contenuta nell’esegesi di Ap 2, 9, dove per rapina si intende la sottrazione violenta dei beni temporali, ma in quella della seconda tromba, che suona contro il mare tempestoso, figura dei fluttuosi cuori dei gentili (Ap 8, 8; cap. XI). La “rapina” però, per contrappasso, spinge nella bufera le anime che in vita non seppero sottrarsi dai beni temporali (e fra questi rientra la passione amorosa) per indirizzarsi a quelli spirituali. Esse non seppero dividersi da ciò che è terreno, non raggiunsero mai il proprio firmamento.
I martìri purgano senza requie, non lasciano intorpidire la mente (Ap 2, 1); così i martirizzati lussuriosi, portati dalla bufera, non hanno speranza di posa (Inf. V, 44-45, 116; ma a Inf. XXVIII, 52-54 i dannati della nona bolgia, si fermano a guardare Dante “per maraviglia, oblïando il martiro”). La seconda chiesa sarà oggetto di blasfemia (Ap 2, 9), i lussuriosi “bestemmian quivi la virtù divina” (Inf. V, 36; cfr. Ap 17, 3).
■ Nel secondo ciclo settenario dell’Inferno, come sopra ricordato, la tematica del secondo stato dei martiri è appropriata ai violenti contro il prossimo. Fra i vari motivi, i tiranni “che dier nel sangue e ne l’aver di piglio” (Inf. XII, 104-105) rinviano alla rapina dei beni temporali di Ap 2, 9.
Nel secondo girone del purgatorio vengono proposti agli invidiosi esempi di carità per mezzo di voci che passano volando. La prima voce pronuncia le parole “Vinum non habent”, dette da Maria a Gesù alle nozze di Cana (Jo 2, 1-11), fa cioè riferimento a una carenza di beni temporali necessari al sostentamento (Purg. XIII, 28-30). La terza voce ripete le parole del discorso della montagna (Mt 5, 43-44): “Amate da cui male aveste” (vv. 35-36): il motivo dell’accettare con gioia la sottrazione dei propri beni, amando pertanto i propri persecutori, è presente ad Ap 2, 9. Il tema paolino del compatire i carcerati è proprio di Dante (“per compassion di quel ch’i’ vidi poi”, hapax) nei confronti della pena degli invidiosi accigliati con fil di ferro: coperti di vile panno, si appoggiano reciprocamente sulla spalla e tutti sono sorretti dalla ripa (“sofferia … sofferti”; il vescovo di Smirne viene invitato ad essere fedele “usque ad sufferentiam martirii interfectivi tui corporis”: Ap 2, 10; cfr. Purg. III, 31-33); sembrano ciechi ai quali manchi il necessario come quelli che “stanno a’ perdoni a chieder lor bisogna” (Purg. XIII, 52-66). Sapìa senese, che si presenta con le parole “Savia non fui, avvegna che Sapìa / fossi chiamata” (vv. 109-110), è personificazione del tema del Giudeo secondo la carne ma non secondo lo spirito, il cui nome non corrisponde nella realtà al vero significato. Lieta “de li altrui danni” (come il diavolo, che cerca il danno e la rovina di quanti tenta), Sapìa, l’8 giugno 1269, quando i suoi concittadini erano presso Colle Val d’Elsa “in campo giunti co’ loro avversari”, i guelfi fiorentini, pregò Dio “di quel ch’e’ volle”, che cioè venissero sconfitti, “vòlti ne li amari / passi di fuga” (vv. 110-119). Desiderò sperimentassero i patimenti annunciati a Smirne, la chiesa dei martiri interpretata come l’amara “mirra” (Ap 2, 1): quel giorno Sapìa appartenne alla “sinagoga Sathane, id est adversarii”. Ma ora sa, e lo dice con le parole tratte dalla settima visione, che la città celeste è “civium unitas”, unità concorde dei cittadini: “ciascuna è cittadina / d’una vera città (vv. 94-96).
“ch’a la seconda morte ciascun grida” (Inf. I, 117; tab. 2.4).
La seconda vittoria (le “vittorie” sono la conclusione delle istruzioni date alle singole chiese) consiste nel vittorioso scontro con il mondo e con le sue tentazioni, e corrisponde alla lotta dei martiri contro l’idolatria pagana. Di essa si dice: “Chi avrà vinto non sarà leso dalla seconda morte” (Ap 2, 11), in quanto chi avrà sostenuto vittoriosamente i mortali dardi delle tentazioni e delle mortificazioni sarà degno di non essere leso dalla morte eterna. La “prima morte”, quella per cui si estingue la vita naturale, percuote i corpi; la “seconda morte” consiste invece nella tristezza del cuore, nel terrore, nella disperazione e costernazione provocati dalla persecuzione del corpo o dal suo incombere. La seconda è anche la morte indotta dalla pena eterna, che viene così chiamata perché in essa è estinto ogni diletto o riposo: ivi è dolore perpetuo peggiore della morte e che la morte fa continuamente desiderare (Ap 20, 5). I martiri trionfatori, sicuri del regno della vita eterna, non temono la seconda morte e non la sentono, nel senso che da essa non vengono lesi. Per questo la chiesa di Smirne, oltre che “amara” come la mirra, viene interpretata anche come “cantico”, poiché i santi esultano e si gloriano nelle passioni, come dichiara san Paolo ai Romani: “Ci gloriamo nelle tribolazioni” (Rm 5, 3).
■ Il tema della “seconda morte” è congiunto con il motivo della disperazione e del dolore perpetuo nelle parole con cui Virgilio descrive l’inferno, luogo eterno ove Dante udrà “le disperate strida”, vedrà “li antichi spiriti dolenti, / ch’a la seconda morte ciascun grida” (Inf. I, 115-117; cfr. III, 46-48). Il dubbio del Buti, su quello che debba intendersi per la “seconda morte”, se cioè designi la dannazione ultima, che gli spiriti vorrebbero per invidia in modo da avere più compagni, oppure il desiderio di annullamento dell’anima, va risolto per questo secondo significato. Il senso di una morte che fa desiderare la morte appare chiaramente ad Ap 20, 5: “ibi [in secunda morte] est dolor perpetuus peior morte et faciens continue appetere mortem”. Un’altra interpretazione, per la quale gli spiriti lamenterebbero gridando la propria condizione di dannati, offre un senso già contenuto nell’espressione “disperate strida”, poiché la disperazione è parte della “seconda morte” [4].
■ I motivi che si aggregano attorno al tema della “seconda morte” percorrono Inf. V: le dolenti note incominciano a farsisi sentire; il pianto percuote il poeta, la bufera i dannati; i “martìri” di Francesca rendono “tristo” Dante (v. 117), confuso di “trestizia” per la “pietà d’i due cognati” (Inf. VI, 1-3), che viene meno “così com’ io morisse”, cadendo “come corpo morto cade”: tutto concorre a descrivere il martirio interiore di Dante, che prova su di sé gli effetti della seconda morte senza esserne leso [5]. Un tormento dello spirito che è proprio dei perseguitati degli ultimi tempi, che soffrono nel dubbio, un agone non fisico che i primi testimoni della fede non provarono per l’evidenza dell’errore dell’idolatria pagana (cfr. infra).
La “tristezza”, oltre ad essere propria del cuore oppresso dalla disperazione, designa anche, secondo un senso comune ai teologi, il riconoscimento dei propri peccati, cioè la contrizione (come spiegato ad Ap 3, 15, nell’esegesi della chiesa di Laodicea) [6]: così l’esser tristo e confuso del poeta di fronte ai due amanti segna, nella sofferenza che sperimenta in sé la passione dei dolci pensieri e sospiri, il pentito contristarsi della propria miseria.
■ “Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli / pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava; / e se non piangi, di che pianger suoli?” (Inf. XXXIII, 40-42). In questi “fieri accenti … usciti dalla sincerità di un dolore impaziente e sdegnoso” (De Sanctis) [7], l’annunzio del cuore deriva dall’esegesi della seconda chiesa, propria dei martiri, alla quale Cristo predice le future passioni e la tribolazione in carcere (Ap 2, 10). Il cuore del conte Ugolino, carcerato nella Muda al quale il “mal sonno” squarciò il velo del futuro, è gravido di tristezza, sperimenta il “disperato dolor” proprio della seconda morte. I temi sono già presenti nelle Arpie che fanno i loro nidi nella selva dei suicidi, “che cacciar de le Strofade i Troiani / con tristo annunzio di futuro danno” (Inf. XIII, 10-12) [8]. I vittoriosi martiri non provano la tristezza del cuore (Ap 2, 11), le tentazioni non sono ordinate a loro danno (Ap 2, 10); ma Pier della Vigna, spirito incarcerato, è “anima lesa” dalla seconda morte. Di questa prova gli effetti, senza venirne leso, l’anima di Rinieri da Calboli, che nel secondo girone del purgatorio si fa trista “a l’annunzio di dogliosi danni” fatto dal suo compagno di pena Guido del Duca (Purg. XIV, 67-72).
Quando viene meno il dubbio che con Dante ci sia anche il figlio Guido, Cavalcante formula la sua prima domanda: «piangendo disse: “Se per questo cieco / carcere vai per altezza d’ingegno, / mio figlio ov’ è? e perché non è teco?”» (Inf. X, 58-60). Nelle parole c’è un motivo tratto dall’esegesi della chiesa di Smirne, alla quale Cristo promette di esserle sempre accanto – “ego semper tecum ero” -, anche nel carcere delle passioni (Ap 2, 10).
“E come i gru van cantando lor lai” (Inf. V, 46; tab. 2.4).
L’interpretazione del nome della seconda chiesa – Smirne – come “cantico” trova riscontro nella seconda schiera dei peccatori carnali che vengono emettendo gemiti come le gru che “van cantando lor lai”. Non si tratta però di un canto glorioso pur nelle tribolazioni, ma triste e privo di conforto. Nel Notabile XI del prologo, Olivi, per spiegare come le visioni dell’Apocalisse, o parte di esse, possano essere adattate a tempi diversi, paragona la Scrittura sacra a una mano o a una veste che vengano ora ristrette ora allargate: come il significato di un termine può essere assunto talora in un senso largo e talora in uno stretto, così la Scrittura e le sue figure possono essere ora coartate, cioè ristrette rispetto al loro pieno senso, ora estese oltre quanto consenta la lettera. Ciò non avviene per falsa interpretazione, ma a motivo della forza e della varietà della Scrittura. Questo passo si può accostare a quanto viene detto, in apertura del capitolo XIII, sulla capacità dello spirito profetico di dilatarsi e di espandersi dal particolare all’universale, riconducendo questo al proprio particolare. Il motivo è variamente presente nelle figure del poema. Le anime dei lussuriosi del secondo cerchio infernale (Inf. V, 40-41, 46-47) vengono prima paragonate agli stornelli che volano “a schiera larga e piena” e poi alle gru che, volando in schiera stretta rispetto agli stornelli, “van cantando lor lai, / faccendo in aere di sé lunga riga”. Nel “poema sacro”, che imita la Scrittura, le due similitudini corrispondono alla varietà con cui il sacro testo si estende e si ritrae. Si tratta della prima delle molteplici applicazioni di tale prerogativa. È da intendere che il volo largo degli stornelli riguarda tutti i peccatori carnali, portati dalla “bufera infernal, che mai non resta”; quello in riga delle gru un particolare gruppo di essi, cioè i morti a causa di amore. L’interpretazione ‘larga’ (o rilassata: gli stornelli) contrapposta a quella ‘stretta’ (o rigorista: le gru) della Scrittura sarà nel cielo del Sole condannata in ugual misura da Bonaventura, che l’applicherà alla Regola francescana (Par. XII, 124-126; cfr. anche Inf. VI, 25).
Nell’attraversamento del fuoco interposto fra il settimo girone della montagna e la scala che porta alla cima (Purg. XXVII, 10-57) si rinvengono parole-chiave che rinviano alla dottrina relativa a Smirne: “cantar … cantava … tormento … non morte … pon giù ogne temenza … per confortarmi … – canticum … gloriamur in tribulationibus … non ledetur a morte secunda … nichil horum timeas … confortatio”. La voce di Virgilio conforta il discepolo parlandogli di Beatrice; nessun conforto di speranza, invece, vi è per la chiera dei lussuriosi la cui schiera canta i “lai” come le gru (Inf. V, 44).
Quando giungon davanti a la ruina (Inf. V, 34; tab. 2.4).
La tentazione diabolica verso i martiri è finalizzata al loro danno e rovina (Ap 2, 10). Le anime dei lussuriosi “giungon davanti a la ruina” ove gridano, piangono, si lamentano e bestemmiano la virtù divina (Inf. V, 34-36). La “rovina” è lo scoscendimento provocato dal terremoto avvenuto al momento della morte di Cristo, per cui le anime bestemmiano la virtù di Cristo (cfr. Ap 17, 3) che con la sua morte ha sconvolto la vecchia roccia infernale (anche se allude pure alla tentazione che non hanno saputo combattere e sopportare, causa della loro rovina). Il tema si ripresenta in apertura di Inf. XII (la seconda zona, dopo Inf. V, dove prevalgono i motivi del secondo stato), reso con l’immagine di “… quella ruina che nel fianco / di qua da Trento l’Adice percosse, / o per tremoto o per sostegno manco” (vv. 4-9). Il canto, come si è visto, è segnato da una ricca tematica che rinvia semanticamente all’esegesi della seconda chiesa, Smirne, proprio come Inf. V: da essa provengono appunto la “ruina” (vv. 4, 32: Ap 2, 10), il “cantico”, secondo l’interpretazione del nome “Smirne” (“Tal si partì da cantare alleluia”, v. 88: Ap 2, 11); il non diffidare (“la scorta fida”, v. 100: Ap 2, 8.10), la “rapina” (“dier … ne l’aver di piglio”, v. 105: Ap 2, 9), il danno (“li spietati danni”, v. 106: Ap 2, 10), le saette (vv. 56, 77: Ap 2, 11; tema comune con il primo sigillo, Ap 6, 2) [9].
Nella Lectura la “rovina” è altrove connessa con la caduta di Babylon, la Chiesa carnale del sesto stato. Il grande terremoto che si verificherà all’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12) è accostato all’angelo che prende una pietra grande come una mola e la getta nel mare (Ap 18, 21), con il quale è designato il fluttuare delle nazioni infedeli ed anche l’amaro che proviene da tanta sommersione e rovina. Ad Ap 18, 9-19 re e mercanti piangono e lamentano la rovina di Babilonia, come avviene nel compianto e nel lamento dei peccatori carnali “davanti a la ruina” (cfr. infra).
Rotta dal terremoto verificatosi in morte di Cristo, la “ruina” che consente la scesa verso il Flegetonte vede le pietre muoversi sotto i piedi del poeta, “per lo novo carco” (Inf. XII, 28-30), cioè sotto il peso di un corpo vivo, ma il ‘nuovo’ è anche indice del sesto stato, del secolo che si rinnova, del nuovo avvento di Cristo nei suoi discepoli spirituali, che ripercorre il primo avvento del Salvatore, causa per cui, come afferma Virgilio, “questa vecchia roccia, / qui e altrove, tal fece riverso” (vv. 44-45). Come proposto da Charles Singleton, “ruina” è un tema in triplice sviluppo nella prima cantica, da Inf. V, 34 a XII, 4 a XXIII, 137 [10].
***
[1] Cfr. PICONE, Canto V, p. 78.
[2] BALDELLI, Inferno, canto V, pp. 300-301.
[3] PICONE, Canto V, p. 79.
[4] Il tema del desiderio di morte è offerto anche dall’esegesi della quinta tromba (Ap 9, 6: “in quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno; desidereranno morire, ma la morte li fuggirà”) e si presta a numerose variazioni.
[5] BALDELLI, Inferno, canto V, p. 308: “La identificazione di Dante con l’amore di Francesca si fa assoluta”.
[6] LSA, cap. III, Ap 3, 15: «Increpans ergo eum, subdit (Ap 3, 15): “Scio opera tua”, id est scientia iudiciali et improbativa, “quia neque calidus es”, scilicet per caritatem, “neque frigidus”, per infidelitatem vel per omnimodam vite secularitatem, quasi dicat: solam fidem et quandam exterioris religionis speciem absque igne caritatis habes. Quidam vero sumunt frigidum pro contristato de suis peccatis, calidum vero pro exultatione in Deo, quasi dicat: nec scis de Deo per fervidam devotionem gaudere, nec de tuis peccatis et de tua miseria penitentialiter contristari». All’esegesi dell’istruzione data a Laodicea rinvia, in più punti, la descrizione degli ignavi.
[7] F. DE SANCTIS, L’Ugolino di Dante (1869), in Saggi critici, a cura di L. RUSSO, III, 1965, p. 37.
[8] Nella selva dei suicidi (secondo girone del VII cerchio) il gruppo tematico prevalente appartiene al terzo stato; permangono tuttavia numerosi elementi propri del secondo, dei martiri.
[9] Cristo consola la chiesa di Smirne predicendole che la sua tribolazione durerà solo dieci giorni (Ap 2, 10). Il numero dieci, che corrisponde a quello delle persecuzioni generali, si ritrova nel numero dei dannati incontrati da Dante nel girone. Essi sono effettivamente dieci: Alessandro, Dionisio fero, Azzolino (Ezzelino da Romano), Opizzo da Esti, Guido di Montfort, Attila, Pirro, Sesto, Rinier da Corneto e Rinier Pazzo.
[10] C. S. SINGLETON, La poesia della Divina Commedia, Bologna 1978, pp. 475-484.
Tab. 2.1
Purg. XV, 1-6, 106-114Quanto tra l’ultimar de l’ora terza
|
Purg. II, 49-51, 58-63Poi fece il segno lor di santa croce;
|
|
[LSA, prologus, Notabile V (II status)] Quia etiam tota ecclesia in Christi passione fundatur et sibi debet concrucifigi, nichilque ita profuit ad radicationem prime plantationis eius sicut imitatio crucis Christi, idcirco congrue in secundo statu refulsit ordo martirum. |
||
[LSA, prologus, Notabile III (II status)] Item (zelus) est septiformis prout fertur contra quorundam ecclesie primitive fatuam infantiam (I), ac deinde contra pueritiam inexpertam (II), et tertio contra adolescentiam levem et in omnem ventum erroris agitatam (III), et quarto contra pertinaciam quasi in loco virilis et stabilis etatis se firmantem (IV), quinto contra senectutem remissam (V), sexto contra senium decrepitum ac frigidum <et> defluxum (VI), septimo contra mortis exitum despe-ratum et sui oblitum (VII).[LSA, cap. II, Ap 2, 11; (Ia visio, IIa victoria)] Secunda est victoriosus congressus cum mundo et eius temptamentis, qui correspondet congressui martirum cum paganis et eorum idolis, quibus competit premium de quo secunde ecclesie dicitur: “Qui vicerit non ledetur a morte secunda” (Ap 2, 11). […] Victores autem isti sunt sic securi de regno vite eterne quod non timent incidere in mortem secundam.
|
[LSA, prologus, Notabile XIII (II status)] Status vero militie martirum conformatur confirmationi, per quam christiani proprie ponuntur in statu pugilum et roborantur ad pugnam, unde et signo crucis insigniuntur in fronte. […]In secundo vero statu factum est in celo, id est in celesti ecclesia, firmamentum patientie et con-stantie martiriorum, per quod desideria vite superne divisa sunt a desideriis vite terrene quasi aque superiores ab aquis inferioribus (cfr. Gn 1, 6-8). […] Sicut etiam in secunda etate Noe per archam iussu Dei fabricatam salvatur a diluvio, levaturque archa per diluvium super montes altissimos, sic in secundo statu per robur catholice fidei salvatur populus christianus a diluvio paganorum, et tam per hoc diluvium quam per diluvium sanguinis martirum tunc effusi elevatur fides et ecclesia super verticem regum et romani imperii, converso Constantino ad fidem et diluvio idolatrie exsiccato.Aen. V, 213-219Qualis spelunca subito commota columba
|
|
Inf. XVI, 31-33; XXI, 64-66, 81la fama nostra il tuo animo pieghi
|
Purg. XIII, 85-87, 100-102; XIV, 9; XV, 52-54, 64-66Volsimi a loro e: “O gente sicura”,
|
|
Tab. 2.2
[LSA, cap. I, Ap 1, 17 (Ia visio)] Duodecima (perfectio summo pastori condecens) est humi-liatorum et tremefactorum familiaris confortatio et sublevatio, et ad ipsos plenius confortandos perfectionum persone apparentis confortativa expli-catio. Quia vero tremefacti solent confortari tam familiari et amicabili et sublevativo tactu quam familiari et suavi affatu, ideo pro primo dicit: “et posuit dexteram suam super me”, pro secundo autem subdit: “dicens: noli timere”.
|
Inf. III, 19-21; IV, 13-18; XIII, 130-132; XXXI, 28-29E poi che la sua mano a la mia puose
|
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 8.10 (Ia visio, IIa ecclesia)] Hiis autem premittitur primo iussio de scribendo hec episcopo huius ecclesie. Et secundo Christi loquentis introductio, et hoc sub forma sequentibus congruente, ibi (Ap 2, 8): “Hec dicit primus et novissimus”, id est cuius eternitas antecedit et principiat omnia, et est ultra omnia etiam futura, et finit ac consumat omnia, quasi dicat: non diffidas te a tuis passionibus per me salvandum, quia ego sum omnium principium et consumator.
|
||
Inf. II, 10-12, 28-30, 34-35, 49-51Io cominciai: “Poeta che mi guidi, 1, 10
|
||
Inf. V, 19-20, 44-45, 127-129guarda com’ entri e di cui tu ti fide;
|
Inf. VIII, 97-108
“O caro duca mio, che più di sette
volte m’hai sicurtà renduta e tratto
d’alto periglio che ’ncontra mi stette,
non mi lasciar”, diss’ io, “così disfatto;
e se ’l passar più oltre ci è negato,
ritroviam l’orme nostre insieme ratto”.
E quel segnor che lì m’avea menato,
mi disse: “Non temer; ché ’l nostro passo
non ci può tòrre alcun: da tal n’è dato.
Ma qui m’attendi, e lo spirito lasso
conforta e ciba di speranza buona,
ch’i’ non ti lascerò nel mondo basso”.
Par. XXV, 34-48
“Leva la testa e fa che t’assicuri:
ché ciò che vien qua sù del mortal mondo,
convien ch’ai nostri raggi si maturi”.
Questo conforto del foco secondo
mi venne; ond’ io leväi li occhi a’ monti
che li ’ncurvaron pria col troppo pondo.
“Poi che per grazia vuol che tu t’affronti
lo nostro Imperadore, anzi la morte,
ne l’aula più secreta co’ suoi conti,
sì che, veduto il ver di questa corte,
la spene, che là giù bene innamora,
in te e in altrui di ciò conforte,
dì quel ch’ell’ è, dì come se ne ’nfiora
la mente tua, e dì onde a te venne”.
Così seguì ’l secondo lume ancora.
Inf. XII, 55-56, 93-96, 100-106
e tra ’l piè de la ripa ed essa, in traccia
corrien centauri, armati di saette
danne un de’ tuoi, a cui noi siamo a provo, 12, 7
e che ne mostri là dove si guada,
e che porti costui in su la groppa, 8, 9
ché non è spirto che per l’aere vada.
Or ci movemmo con la scorta fida
lungo la proda del bollor vermiglio,
dove i bolliti facieno alte strida.
Io vidi gente sotto infino al ciglio;
e ’l gran centauro disse: “E’ son tiranni
che dier nel sangue e ne l’aver di piglio. 2, 9
Quivi si piangon li spietati danni ……”
[LSA, cap. II, Ap 2, 11 (Ia visio, IIa victoria)] Secunda est victoriosus congressus cum mundo et eius temptamentis, qui correspondet congressui martirum cum paganis et eorum idolis, quibus competit premium de quo secunde ecclesie dicitur: “Qui vicerit non ledetur a morte secunda” (Ap 2, 11). Dignum est enim ut qui mortifera iacula mortis et temptationum et mortificationum victoriose susti-nuerit non ledatur a morte eterna, que respectu predicte et respectu mortis culpe vocatur secunda. Leditur autem ab ea non solum qui ipsam experitur, sed etiam qui terretur ex illa, et maxime si est terror desperativus vel consternativus. Victores autem isti sunt sic securi de regno vite eterne quod non timent incidere in mortem secundam.
[LSA, cap. XX, Ap 20, 5-6 (VIIa visio)] Consimiliter etiam prima mors est mors culpe et etiam temporalis mors, per quam corpus ab anima separatur. Secunda autem (Ap 20, 6) est mors pene eterne, que dicitur mors non quod ibi naturalis vita extinguatur, sed quia omnis delectatio et requies est ibi extincta et quia ibi est dolor perpetuus peior morte et faciens continue appetere mortem.
Inf. XXVII, 43-45, 100-105
La terra che fé già la lunga prova
e di Franceschi sanguinoso mucchio,
sotto le branche verdi si ritrova.
E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti;
finor t’assolvo, e tu m’insegna fare
sì come Penestrino in terra getti. 12, 9
Lo ciel poss’ io serrare e diserrare,
come tu sai; però son due le chiavi
che ’l mio antecessor non ebbe care”.
Inf. XXXIII, 16-18
Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri,
fidandomi di lui, io fossi preso
e poscia morto, dir non è mestieri
Inf. XXI, 61-66, 79-84, 88-90, 133-135
“e per nulla offension che mi sia fatta,
non temer tu, ch’i’ ho le cose conte,
perch’ altra volta fui a tal baratta”.
Poscia passò di là dal co del ponte;
e com’ el giunse in su la ripa sesta,
mestier li fu d’aver sicura fronte.
“Credi tu, Malacoda, qui vedermi
esser venuto”, disse ’l mio maestro,
“sicuro già da tutti vostri schermi,
sanza voler divino e fato destro?
Lascian’ andar, ché nel cielo è voluto
ch’i’ mostri altrui questo cammin silvestro”.
E ’l duca mio a me: “O tu che siedi
tra li scheggion del ponte quatto quatto,
sicuramente omai a me ti riedi”.
Ed elli a me: “Non vo’ che tu paventi;
lasciali digrignar pur a lor senno,
ch’e’ fanno ciò per li lessi dolenti”. lesi
Purg. III, 19-24; IX, 43-48
Io mi volsi dallato con paura 1, 10
d’essere abbandonato, quand’ io vidi
solo dinanzi a me la terra oscura;
e ’l mio conforto: “Perché pur diffidi?”,
a dir mi cominciò tutto rivolto;
“non credi tu me teco e ch’io ti guidi?” 1, 10
Dallato m’era solo il mio conforto,
e ’l sole er’ alto già più che due ore,
e ’l viso m’era a la marina torto. 8, 8
“Non aver tema”, disse il mio segnore;
“fatti sicur, ché noi semo a buon punto;
non stringer, ma rallarga ogne vigore”. Not. XI
Par. XVII, 25-27, 55-57; XVIII, 7-12, 19-21, 25-27
“per che la voglia mia saria contenta
d’intender qual fortuna mi s’appressa:
ché saetta previsa vien più lenta”. ……
“Tu lascerai ogne cosa diletta
più caramente; e questo è quello strale
che l’arco de lo essilio pria saetta”.
Io mi rivolsi a l’amoroso suono 1, 10
del mio conforto; e qual io allor vidi
ne li occhi santi amor, qui l’abbandono:
non perch’ io pur del mio parlar diffidi,
ma per la mente che non può redire
sovra sé tanto, s’altri non la guidi. …… 1, 10
Vincendo me col lume d’un sorriso,
ella mi disse: “Volgiti e ascolta;
ché non pur ne’ miei occhi è paradiso”. ……
così nel fiammeggiar del folgór santo,
a ch’io mi volsi, conobbi la voglia
in lui di ragionarmi ancora alquanto.
Purg. XXXII, 97-99; XXXIII, 40-42, 49-51
In cerchio le facevan di sé claustro
le sette ninfe, con quei lumi in mano
che son sicuri d’Aquilone e d’Austro.
ch’io veggio certamente, e però il narro,
a darne tempo già stelle propinque,
secure d’ogn’ intoppo e d’ogne sbarro ……
ma tosto fier li fatti le Naiade,
che solveranno questo enigma forte
sanza danno di pecore o di biade.
[LSA, cap. I, Ap 1, 10-12 (VIa circumstantia visionum)] Sexta circumstantia est sollempnis iussio sibi facta ut visiones has sollempniter scribat et septem ecclesiis Asie mittat, quasi dicat: non meo motu, sed Dei speciali iussu hec scripsi et mitto. Unde subdit: “et audivi post me vocem” (Ap 1, 10). Secundum Ricardum, ideo post se audivit vocem in signum quod a subditis elongatus et quieti deditus omnem pastoralem sollicitudinem post se longe reliquerat, et ideo dum nunc ad subditorum eruditionem a supernis reducitur, quasi de anterioribus ad posteriora revocatur*.
Vel pro quanto ea que sunt post nos sunt nobis invisibilia, et conversis secundum faciem ad inferiora sunt ea que post tergum nobis superiora, pro tanto vocem post se audit quia ad invisibilia et superiora ipsum sublevat et reducit. Unde et in huius signum, Iohannis XX°, Maria conversa retrorsum dicitur vidisse Ihesum (Jo 20, 14).
Item per hoc significatur quod loquens erat dux eius, quasi post tergum eius existens more custodis et ductoris sui equi vel iumenti, unde Ezechielis III° dicitur: “Assumpsit me spiritus et audivi post me vocem” et cetera. (Ez 3, 12). Dicit autem “magnam”, tum quia magna significabat, tum quia a magna persona et virtute exibat et Iohannem magnifice ex<c>itabat. Dicit etiam “tamquam tube”, tum quia ad bellum contra vitia et contra exercitus reproborum exhortabatur, tum quia ad epulas glorie invitabat et ad audiendum Dei et angelorum consilium convocabat, tum quia forma tube gerit typum predicatorum ecclesie. In quibus a principio usque ad tempora prophetarum fuit predicatio quasi occulta, a diebus vero Isaie manifestior esse cepit usque ad Iohannem Baptistam, ibique consumata est in apostolico choro: “in omnem” enim “terram exivit sonus eorum” (Ps 18, 5; Rm 10, 18). Consimiliter autem intellige de sexto statu ecclesie.
* In Ap I, iv (PL 196, coll. 704 D-705 A).
Tab. 2.3
[LSA, cap. II, Ap 2, 1] Secundum (exercitium) est bellantium contra temptamenta subsequentia virilis concertatio. Nam post fervorem et lactent<is> dulcorem, qui solet inesse noviciis, sequuntur communiter multa et fortia temptamenta.[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (IIa ecclesia)] Secunda autem commendatur de passionibus et predicitur multa passura. Sic etiam fuit de secundo statu, scilicet martirum. Et quia martiria purgant, nec sinunt mentem tepescere vel torpescere, ideo ibi de nullo increpatur. Que et merito vocatur Smirna, id est amaritudo consumpta; interpretatur etiam mirra, que est amara et preservans a corruptione.[LSA, cap. II, Ap 2, 9-10 (Ia visio, IIa ecclesia)] “Scio” (Ap 2, 9), scilicet scientia pastorali seu compassiva et ad regendum et remunerandum intenta, “tribulationem tuam”, qua scilicet a tuis persecutoribus tribularis; “et paupertatem tuam”, scilicet maximam penuriam rerum temporalium tuo victui necessariarum, quam forte non solum ex propria voluntate assumpserat sed etiam per suos persecutores eius temporalia rapientes sibi inflicta erat, iuxta quod ad Hebreos X° (Heb 10, 34) dicitur: “Nam et vinctis compassi estis et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis cognoscentes vos habere meliorem et manentem substantiam”. Unde et hic subditur: “sed dives es”, scilicet gratiis et meritis et virtuosis operibus.
|
||
Inf. XII, 61-63, 67, 103-105; XXVII, 31-33e l’un gridò da lungi: “A qual martiro
|
Purg. III, 31-33A sofferir tormenti, caldi e geli
|
|
Tab. 2.4
[LSA, cap. II, Ap 2, 10-11 (Ia visio, IIa ecclesia)] Secundo eius ad futuras passiones impavide expectandas et tolerandas confortatio, ibi: “Nichil horum timeas” (Ap 2, 10). […] “Nichil horum timeas que passurus es” (Ap 2, 10), quasi dicat: passurus quidem es multa, sed non oportet te timere illa, tum quia ego tecum semper ero et protegam, tum quia non sunt ad tuum dampnum, sed potius ad probationem et ad amplius meritum et ad maioris corone triumphum et premium, quia vero iacula que previdentur minus feriunt, et previa preparatio et animatio sui ad illa constanter toleranda multum confert. […]
|
||
Inf. I, 115-117; III, 46-48ove udirai le disperate strida,
|
||
Inf. V, 25-27, 33-36, 44-46, 115-117; VI, 1-3, 55-57Or incomincian le dolenti note
|
[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 14 (VIa visio)] Unde subdit (Ap 18, 14): “Et poma tua desiderii anime”, id est valde desiderabilia appetitui animali vel, secundum Ricardum, id est minora bona tua que desi-derabiliter dilexisti, “discesserunt a te”, scilicet o Babilon. Secundum enim Ricardum, sicut reges super eius ruina plangentes converterunt querimoniam ad illam, sic et negotiatores convertunt hic suum lamentativum sermonem ad illam*.
* In Ap VI, i (PL 196, col. 842 C-D).
Purg. XIV, 67-72
Com’ a l’annunzio di dogliosi danni
si turba il viso di colui ch’ascolta,
da qual che parte il periglio l’assanni,
così vid’ io l’altr’ anima, che volta
stava a udir, turbarsi e farsi trista,
poi ch’ebbe la parola a sé raccolta.
Purg. XXVII, 10-12, 19-21, 31-32, 52-56
Poscia: “Più non si va, se pria non morde,
anime sante, il foco: intrate in esso,
e al cantar di là non siate sorde ……”.
Volsersi verso me le buone scorte;
e Virgilio mi disse: “Figliuol mio,
qui può esser tormento, ma non morte.
Pon giù omai, pon giù ogne temenza;
volgiti in qua e vieni: entra sicuro!”. 1, 10-12
Lo dolce padre mio, per confortarmi,
pur di Beatrice ragionando andava,
dicendo: “Li occhi suoi già veder parmi”.
Guidavaci una voce che cantava
di là; e noi, attenti pur a lei ……….
[LSA, cap. XX, Ap 20, 5-6 (VIIa visio)] Consimiliter etiam prima mors est mors culpe et etiam temporalis mors, per quam corpus ab anima separatur. Secunda autem (Ap 20, 6) est mors pene eterne, que dicitur mors non quod ibi naturalis vita extinguatur, sed quia omnis delectatio et requies est ibi extincta et quia ibi est dolor perpetuus peior mor-te et faciens continue appetere mortem.
Inf. X, 58-60
piangendo disse: “Se per questo cieco
carcere vai per altezza d’ingegno,
mio figlio ov’ è? e perché non è teco?”.
Inf. XII, 4-6, 88-90
Qual è quella ruina che nel fianco
di qua da Trento l’Adice percosse,
o per tremoto o per sostegno manco
Tal si partì da cantare alleluia
che mi commise quest’ officio novo:
non è ladron, né io anima fuia.
Inf. XIII, 10-12, 46-49, 76-78, 87-88
Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,
che cacciar de le Strofade i Troiani
con tristo annunzio di futuro danno.
“S’elli avesse potuto creder prima”,
rispuose ’l savio mio, “anima lesa,
ciò c’ha veduto pur con la mia rima,
non averebbe in te la man distesa”
E se di voi alcun nel mondo riede,
conforti la memoria mia, che giace
ancor del colpo che ’nvidia le diede.
spirito incarcerato, ancor ti piaccia
di dirne …………………….
Inf. XXIV, 142-144
apri li orecchi al mio annunzio, e odi.
Pistoia in pria d’i Neri si dimagra;
poi Fiorenza rinova gente e modi.
Inf. XXVIII, 118-120
Io vidi certo, e ancor par ch’io ’l veggia,
un busto sanza capo andar sì come
andavan li altri de la trista greggia
Inf. XXXII, 37-39
Ognuna in giù tenea volta la faccia;
da bocca il freddo, e da li occhi il cor tristo
tra lor testimonianza si procaccia.
Inf. XXXIII, 26-27, 40-41, 55-56, 64, 109-110
……….. quand’ io feci ’l mal sonno
che del futuro mi squarciò ’l velame.
Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli
pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava
Come un poco di raggio si fu messo
nel doloroso carcere ………….……..
Queta’mi allor per non farli più tristi ……
E un de’ tristi de la fredda crosta
gridò a noi: …………………………………
3. La pace tolta dalla terra
“fu imperadrice di molte favelle” (Inf. V, 54; tab. 3.1).
Semiramìs veste il panno della prostituta di Ap 17, 3, la donna che siede sopra la bestia scarlatta perché tinta del rosso sangue dei martiri (seconda parte della sesta visione), la quale regnò su molte genti carnali e bestiali (tema su cui si può confrontare Ap 17, 3 con quanto si afferma ad Ap 13, 2 del drago che fece regnare per molti secoli la bestia su molte terre e genti), motivo che si trasforma sia nella lupa, che “molte genti fé già viver grame” (Inf. I, 51), sia nella lussuriosa “imperadrice di molte favelle” (Inf. V, 52-55).
La prostituta è “piena di nomi blasfemi”, sia a motivo dei suoi fedeli passati, presenti e futuri neganti Cristo e la sua fede, sia a motivo dei malvagi cristiani che con le loro colpe bestemmiano la virtù e i precetti di Cristo ai quali si oppongono. Per i loro crimini bestemmia disprezzando Cristo, di cui trasgredisce i precetti e gli esempi; in particolare allorché pecca contro lo Spirito Santo odiando e impugnando la grazia e la vita spirituale dei santi, come farà al tempo dell’Anticristo mistico. Il tema della blasfemia è pure appropriato ai lussuriosi, i quali “quando giungon davanti a la ruina … bestemmian quivi la virtù divina” (Inf. V, 34-36; la “ruina” è tema della seconda chiesa, i cui avversari saranno bestemmiatori contro di essa: Ap 2, 9-10).
È una donna che ha operato il male “in suo priori et antiquo tempore”, cioè tra i pagani, e che continua ad operarlo nel sesto tempo della Chiesa (Ap 17, 6; cfr. infra). Così Dante ode Virgilio “nomar le donne antiche e ’ cavalieri” e poi ode e parla con Francesca sua vittima moderna. La prostituta è sanguine tincta, Dante va visitando “noi che tignemmo il mondo di sanguigno” (Inf. V, 90; cfr. Inf. IX, 37-42, ove le “ceraste”, serpenti cornuti delle “tre furïe infernal di sangue tinte”, rinviano alle dieci corna della donna).
È addobbata di ornamenti carnali (come Giasone, a Inf. XVIII, 91-92, il quale con “parole ornate” ingannò Isifile; ed Erifile, a Purg. XII, 49-51, che pagò caro lo “sventurato addornamento”); crudele, fa strage di anime (come Tamiri di Ciro, a Purg. XII, 55-57, dove è presente anche il motivo della “ruina”).
“tenne la terra che ’l Soldan corregge” (Inf. V, 60).
All’esegesi di Ap 11, 4, passo relativo ai due testimoni, Elia ed Enoch, e al loro stare “in cospetto del Signore della terra” (che può essere il Figlio di Dio oppure l’Anticristo), rinvia lo stare di Francesco, assetato di martirio, “ne la presenza del Soldan superba” quando “predicò Cristo e li altri che ’l seguiro” (Par. XI, 100-102). Che il Sultano sia inteso come “Dominus terre” si ricava dalle parole di Virgilio relative a Semiramìs (“tenne la terra che ’l Soldan corregge”, Inf. V, 60). Il passo, dove si registra un’importante citazione di Gioacchino da Fiore, che Dante appropria a san Domenico (Par. XII, 76-78), è stato esaminato altrove.
“Siede la terra dove nata fui / su la marina dove ’l Po discende / per aver pace co’ seguaci sui” (Inf. V, 97-99; tab. 3.2).
L’esegesi dell’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 4) mostra come un medesimo passo della Lectura possa costituire il nucleo tematico di più momenti della Commedia a prima vista del tutto indipendenti. A Giovanni appare un cavallo rosso (l’esercito dei pagani rosso per il sangue sparso dai martiri). A chi vi sta seduto sopra (l’imperatore romano o il diavolo) è concesso di togliere la pace dalla terra, perseguitando non solo gente estranea e lontana ma anche i propri parenti e vicini.
■ Le parole “terra”, “pace” e il verbo ‘togliere’ (“che mi fu tolta / come suole esser tolto”) sono fili che formano parte del tessuto sia nel discorso di Francesca (Inf. V, 97-102) come in quello di Catalano, uno dei due frati ‘godenti’ bolognesi nella bolgia degli ipocriti (Inf. XXIII, 103-108). Se identiche sono le parole, la loro collocazione è del tutto diversa nei due distinti episodi. Il significato originario – “togliere la pace dalla terra” – si mantiene in entrambi. A Francesca fu tolta la bella persona che fece innamorare Paolo, e quindi fu tolta la pace alla terra, Ravenna, che sembrava ristabilita con il matrimonio che aveva unito una da Polenta con un Malatesta, pace il cui tema viene espresso con il discendere verso il mare del Po. L’esegesi si riferisce ai Gentili, mai senza guerra, dai cuori fluttuanti come il mare (cfr. infra). I due frati bolognesi Catalano dei Malavolti e Loderingo degli Andalò furono tolti (nel senso di presi, eletti) come podestà dalla terra fiorentina nel 1266 per conservare la sua pace, ma si comportarono in modo che gli effetti del loro operato sono ancor visibili presso il Gardingo, dove erano le case degli Uberti distrutte a seguito della rivolta popolare scoppiata dopo il loro governo e da essi preparata. Si può notare che i due passi presentano altre simmetrie (prese costui e insieme presi, ’l modo ancor m’offende e ch’ancor si pare). L’episodio di Francesca, inoltre, a differenza di quello di Catalano e Loderingo, si inquadra principalmente nel secondo stato, quello dei martiri. Dall’apertura del secondo sigillo proviene il tema dell’uccisione dei propri parenti e “vicini” da parte dei persecutori (la Caina che “attende chi a vita ci spense”, Inf. V, 107).
Le parole di Francesca sono il primo esempio nel poema di “poesia geografica, che è uno dei poli di maggior rilievo del realismo del poema” [1]. Si può osservare che la descrizione del particolare luogo non comporta l’indicazione di toponimi e nomi, tranne che per il Po; simile rarefazione avviene anche per la Firenze della Vita Nova. Inoltre, la “terra” nell’esegesi riguarda l’universo, nei versi la città natale di Francesca. È questo un esempio della proprietà dello spirito profetico di passare dal particolare all’universale e viceversa, secondo quanto sostenuto da Olivi ad Ap 13, 1.
■ La tematica dell’esegesi di Ap 6, 4 si ritrova appropriata a Obizzo II d’Este il quale, ucciso dal figliastro, sta immerso nel Flegetonte sanguigno fra i violenti contro il prossimo (Inf. XII, 110-112; di conseguenza, “Alessandro” sarà Alessandro Magno, del quale Dante poteva leggere in Orosio III, xvi, 3: “omnes cognatos ac proximos suos interfecit”). Nello stesso canto, ad essa può essere accostato anche l’accenno ad Arianna, la sorella del Minotauro che ammaestrò Teseo su come portargli la morte (vv. 19-20).
È interessante notare la variante vicino che il codice riccardiano 1005 (Rb nell’edizione del Petrocchi) recava a Inf. XXVII, 88, riferito a Bonifacio VIII, “lo principe d’i novi Farisei”, il quale nella lotta contro i Colonna muove guerra non contro Saraceni o Giudei, “ché ciascun suo nimico era cristiano”: variante che il Petrocchi ritiene originata dall’espressione “presso a Laterano”, ma che, essendo il contesto pregno di temi del secondo stato, potrebbe fare riferimento alla persecuzione operata non verso estranei, ma nei confronti di parenti e di vicini, come per il papa sono i propri correligionari. La variante è stata poi corretta a margine in “nimico”.
Il conte Ugolino è “vicino” all’arcivescovo Ruggieri, del quale si era fidato (Inf. XXXIII, 15; cfr. supra). Al termine del canto, frate Alberigo racconta del genovese Branca Doria, che lasciò un diavolo in sua vece nel proprio corpo, ancora vivo su in terra, insieme ad “un suo prossimano”, cioè ad un suo parente che l’aiutò nel tradimento verso il suocero Michele Zanche (vv. 142-147).
Omberto Aldobrandesco, che nella prima cornice della montagna purga la superbia, da questa ha avuto danno (Ap 2, 10) per sé e i suoi consorti, tutti “tratti seco nel malanno” (dal diavolo, che trae a sé: Ap 12, 9; Purg. XI, 67-69); nel medesimo girone, Oderisi da Gubbio profetizza a Dante l’esilio per opera dei suoi “vicini”, cioè dei concittadini (vv. 139-141).
Al motivo, in apertura del secondo sigillo, di colui che siede sul cavallo rosso allude Iaopo del Cassero: “li profondi fóri / ond’ uscì ’l sangue in sul quale io sedea” (Purg. V, 73-74; incide l’esegesi di Ap 14, 20). Il colore rosso si rinviene in zone nelle quali prevalente è il riferimento al secondo stato: ad esempio in Purg. II, 13-15, nel rosseggiare di Marte nel mattino, che corrisponde (in quello che san Paolo chiama tempo della ‘pienezza delle genti’, cfr. Rm 11, 25) al periodo della lotta dei martiri contro l’idolatria fino a Costantino (prologo, Notabile VII); o negli splendori “tanto robbi” che nel cielo di Marte formano la croce (Par. XIV, 94-95; si tratta, appunto, degli spiriti che combatterono per la fede).
[1] BALDELLI, Inferno, canto V, pp. 290, 302.
Tab 3.1
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 3-4 (VIa visio)] “Et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam”, id est sanguine et colore coccineo tinctam et rubricatam. Nota quod sicut quodlibet caput bestie aliquando dicitur bestia, aliquando vero distinguitur ab ea sicut caput a corpore vel sicut rex a sua gente, sic mulier ista in quantum est carnalis et bestialis dicitur bestia, in quantum vero quondam prefuit et regnavit super bestiales gentes mundi et adhuc super plures bestiales sibi subditas dominatur, dicitur sedere super bestiam. Que quidem bestia tempore paganorum et hereticorum fuit sanguine martirum cruentata, nunc autem sanguine seu strage animarum et impia persecutione spiritus et spiritualium et etiam quorumcumque quos impie affligit est cruentata, et etiam abhominando sanguin<e> luxuriarum suarum.
|
||
|
Inf. IX, 37-42dove in un punto furon dritte ratto
|
|
Tab. 3.2
[LSA, cap. VI, Ap 6, 4 (IIa visio, apertio IIi sigilli)] Subdit ergo: “Et ecce alius”, id est ab equo albo valde diversus, “equus rufus”, id est exercitus paganorum effusione sanguinis sanctorum rubicundus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet romanus imperator vel diabolus, “datum est ei ut sumeret”, id est ut auferret, “pacem de terra”, id est a Deo permissum est ut persequeretur fideles; “et ut invicem se interficiant”, id est ut pagani interficerent corpora fidelium et etiam quorundam fidem, sancti vero interficerent infidelitatem et pravam vitam plurium paganorum, convertendo scilicet eos ad Christum. Vel, secundum Ricardum, “ut invicem se interficiant”, id est ut ipsi persecutores non solum interficiant alienos et remotos, sed etiam suos parentes et notos et domesticos et vicinos *.* In Ap II, v (PL 196, coll. 763 D –764 A). |
||
Inf. XII, 19-21, 103-105, 110-112
|
Inf. XXIII, 103-108Frati godenti fummo, e bolognesi;
|
|
[LSA, prologus, Notabile VII] Rursus sicut omnis dies habet mane, meridiem et vesperam, sic et omnis status populi Dei in hac vita. Nam in eterna erit semper meridies absque nocte. Ergo tempus plenitudinis gentium sub Christo debuit ante conversionem alterius populi, scilicet iudaici, habere mane et meridiem et vesperam. Et sic quasi iam vidimus esse completum et a Iohanne in hoc libro descriptum. Nam eius mane commixtum tenebris idolatrie fuit ab initio conversionis gentium usque ad Constantinum. |
[LSA, cap. II, Ap 2, 10 (Ia visio, IIa ecclesia)] “Nichil horum timeas que passurus es” (Ap 2, 10), quasi dicat: passurus quidem es multa, sed non oportet te timere illa, tum quia ego tecum semper ero et protegam, tum quia non sunt ad tuum dampnum, sed potius ad probationem et ad amplius meritum et ad maioris corone triumphum et premium, quia vero iacula que previdentur minus feriunt, et previa preparatio et animatio sui ad illa constanter toleranda multum confert. |
|
4. Il cuore tempestoso dei Gentili
“Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, / prese costui de la bella persona / che mi fu tolta …” (Inf. V, 100-102; tab. 4.1, 4.2, 4.4).
■ “Eternità d’amore, eternità di martirio”. In queste parole, che De Sanctis trae dalla tragedia Francesca da Rimini di Silvio Pellico, è racchiuso tutto il significato che il Romanticismo trovò nell’episodio di Francesca. Ed è proprio dallo stato dei martiri che il poeta ritaglia il panno per fare la gonna della “prima donna viva e vera apparsa sull’orizzonte poetico de’ tempi moderni” [1].
In primo luogo, il peccato. Questo, scrive De Sanctis, “è un infinito al pari dell’amore, perché amendue coesistono nell’anima e non si possono distrugger l’un l’altro: distruggetemi la coscienza del peccato e mi avete annientata Francesca da Rimini”. I fili con cui, nelle parole di Francesca, sono tessute le reminiscenze del Guinizzelli (Al cor gentil rempaira sempre amore, vv. 11-12: Foco d’amore in gentil cor s’aprende / come vertute in pietra prezïosa), sul cuore gentile al quale Amore sempre ritorna, sul fuoco d’amore che in esso s’accende di virtù, sono tratti da un’esegesi scritturale che dell’amore condanna l’irrazionalità. È il “sensualis et corporalis vite nimius amor”, dalla “nimia brutalitas et impetuositas”, proprio della brutale vita dei Gentili (cioè dei pagani) che chiude il secondo sigillo (ad Ap 5, 1). All’apertura del sigillo, il fervore della fede dei martiri estingue la brutale vita e siffatto amore.
I cuori dei Gentili fluttuano a guisa del mare: in essi, come spiegato nell’esegesi della seconda tromba (Ap 8, 8), fu messo il diavolo, definito “gran monte” per la grandezza della sua potenza naturale, per il tumore della superbia, per l’ardore del fuoco d’ira. La seconda tromba suona contro gli ansiosi flutti dell’amore di sé, che generano affanni e sollecitudini, il cui eccesso è quasi un mare tempestoso (cap. XI). Il vento – “la bufera infernal, che mai non resta” (Inf. V, 31-33) – designa pertanto il fluttuare tempestoso delle passioni nel cuore. Il luogo della bufera infernale “mugghia come fa mar per tempesta, / se da contrari venti è combattuto” (vv. 28-30), dove il combattere fra venti avversi è riferimento alle battaglie della tentazione sostenute dai martiri (prologo, Notabile I; per il mugghiare cfr. l’esegesi della “vox aquarum multarum” ad Ap 1, 15). “Quello amor che i mena”, per un attimo attratto nella sfera dello Spirito dal liberale invito di Dante (cfr. infra), è pena data in eterno al disordinato amor sui e ai suoi eccessi. Il “cor gentil” ha il significato dell’appetito, contrapposto all’anima razionale nella Vita Nova [27.5 (XXXVIII.5)], manifestato nella storia umana dai Gentili, antichi e moderni.
“Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende” (Inf. V, 100). Venire in modo repentino e inopinato – “ratto” – è proprio del ladro che di nascosto toglie e uccide, nella cui veste Cristo si presenterà al momento del giudizio, come minacciato al negligente vescovo della chiesa di Sardi, bella nel principio, non però nel suo avanzamento (Ap 3, 1.3; un passo simmetrico è ad Ap 16, 15): «hec ecclesia dicta est “Sardis”, id est principium pulchritudinis, quia scilicet sola initia boni non autem consumationem habuit … “Si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur”, qui scilicet venit latenter et ex improviso ut bona auferat et possessorem occidat … tunc superveniet eis repentinus interitus … ut vos dies illa tamquam fur comprehendat – Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, / prese costui de la bella persona / che mi fu tolta … mi prese del costui piacer sì forte … Amor condusse noi ad una morte … quel giorno più non vi leggemmo avante» (cfr. le parole di Caino a Purg. XIII, 133: “Anciderammi qualunque m’apprende”).
All’esegesi del ladro, esposta ad Ap 3, 3 e 16, 15, fanno riferimento altri versi del poema, fra i quali quelli relativi a quanti, tardivi nel pentimento e morti, come Francesca e Paolo, di morte violenta, attendono fuori della porta del purgatorio (Purg. V, 52-54, 73-76) [2]. Non sarà casuale la loro applicazione a Guido da Montefeltro, l’uomo d’arme che in vecchiaia si fece francescano ma che, col dare a Bonifacio VIII il “consiglio frodolente” su come prendere Palestrina, si dannò (Inf. XXVII, 112-129). Il “diavolo loïco” ne ‘rubò’ l’anima a Francesco, come Amore fece con Francesca (l’espressione “mi prese” è comune ad entrambi; “come vedi” / “dove vedi” rinviano ad Ap 16, 15). Come forse non è casuale che il nome della donna – Francesca -, reale nella sua storicità ma significante, sia cantato con versi che danno “e piedi e mano” all’esposizione teologica del martirio proprio dei tempi moderni, che affligge l’animo con il dubbio ingannatore più che il corpo con i tormenti, e che dovrà essere sostenuto dagli eletti degli ultimi tempi, i segnati dell’esercito di Cristo, i quali per Olivi altri non sono che i Francescani.
Dolce e leggiadra è la rima d’amore che riecheggia i detti di Guinizzelli, portando i dolci pensieri, il desiderio e i dolci sospiri del tempo felice che rendono pensoso il poeta, facendolo tristo e pio fino alle lacrime. E certo ai martiri non si addice rimprovero, ma dolcezza e conforto [3]. Ma quelle parole non si convengono tutte alla dolcezza del “fino amor” del poeta bolognese. Non gli sono propri l’aggettivo “ratto” della prima terzina, Amore insofferente che chi è amato non riami nella seconda, che conduce “ad una morte” nella terza, senza contare la violenza insita nei verbi “prese costui de la bella persona / che mi fu tolta … mi prese del costui piacer sì forte”. Francesca, inoltre, parla solo perché tace il vento della bufera infernale che non ha mai posa e affanna le anime, in un luogo che, con l’eccezione di quel momento di quiete, mugghia come un mare in tempesta combattuto da venti contrari. Non si può pertanto ritenere col De Sanctis che tutto, nella Francesca ‘tanto gentile’, sia puro e delicato. Dietro la trina dell’amore che è una cosa col cuore gentile, tessuta da Guinizzelli, sta una concezione dell’amore sensibile e irrazionale che si avvicina a quella cantata dall’altro Guido in Donna me prega. L’amore, secondo Cavalcanti, è qualcosa che sforza contro la quale non vale forza né misura, che distrugge la vita e la mente, che fa morire per forza, che prova piacere della vita fera dell’amante, il quale mai non deve sperare altro che la morte. È “accidente” fero ed altero, di un’oscurità che proviene da Marte, che non si adorna mai di riposo, dalla sua potenza consegue spesso morte, muove il riso in pianto, induce paura, dura poco, desta il fuoco d’ira, toglie la ragione. La cortesia e la gentilezza delle donne e dei cavalieri, antichi e moderni, di cui era pregna la letteratura contemporanea, si mescolano in Dante al gran mare dei Gentili, alle loro passioni irrazionali, al non essere mai senza guerra, allo spegnersi a vicenda fra parenti e vicini.
Di fronte a Francesca, come già di fronte alla Donna Gentile, Dante sostiene un “certamen dubitationis”, un vero e proprio martirio psicologico che lo turba, lo scuote ma non lo travolge; l’averlo vinto, continuando “al tornar de la mente” il viaggio, segna la sua ‘linea d’ombra’ rispetto alla cultura letteraria del tempo e l’irrompere di nuovi significati nella parola ‘gentile’.
■ L’esegesi del difetto che chiude il secondo sigillo (ad Ap 5, 1) conduce ad altre utilizzazioni del tema dell’amore brutale e impetuoso proprio della vita dei Gentili. Virgilio, domando il Minotauro, ne ‘spegne’ l’ira bestiale (Inf. XII, 33), variante dell’“a vita ci spense” di Inf. V, 107: l’ira vendicativa del diavolo prostrato a terra (come “l’infamïa di Creti era distesa”) è motivo della seconda tromba (Ap 8, 8) e in particolare della seconda guerra (Ap 12, 12). Il “viver come bruti” è contrapposto da Ulisse, nella sua “orazion picciola”, al “seguir virtute e canoscenza” (Inf. XXVI, 119-120). I lussuriosi secondo natura, che si purgano nel fuoco e fra i quali è Guido Guinizzelli, gridano il nome di Pasifae, che si fece bestia entrando nella “falsa vacca” per concepirvi il Minotauro: essi infatti seguirono l’appetito come bestie, non servando in amore “umana legge”, cioè quella della ragione (Purg. XXVI, 82-87; il gridare è reso con “si legge”: il tema del leggere è tra i principali proposti dall’esegesi della seconda tromba ad Ap 8, 9).
■ Il tema degli affanni d’amore (seconda tromba esposta moralmente, cap. XI) ritorna nell’episodio di Casella in Purg. II, zona che registra numerose vestigia dello stato dei martiri. Dante prega Casella di consolargli, con “l’amoroso canto / che mi solea quetar tutte mie doglie”, l’anima che “è affannata tanto” (vv. 106-111), perché arrivata col corpo alla spiaggia del purgatorio per la via infernale “che fu sì aspra e forte” (vv. 64-66). La seconda chiesa, Smirne, è interpretata come “cantico” nelle tribolazioni (Ap 2, 11); Casella intona dolcemente “Amor che ne la mente mi ragiona”, la canzone commentata nel III trattato del Convivio, e tutti stanno con la mente alle sue note (vv. 112-117). Arriva però Catone a disperdere l’adunata, rimproverando la negligenza delle anime, lente nel correre al monte per spogliarsi “lo scoglio / ch’esser non lascia a voi Dio manifesto” (Purg. II, 118-133; III, 1-3). L’episodio presenta alcune somiglianze con quello di Francesca: l’affanno dell’anima, la dolcezza, soprattutto il richiamo ad Amore. Si tratta di un amore assai diverso da quello tempestoso e brutale dei peccatori carnali, “che la ragion sommettono al talento” (Inf. V, 38-39). Amore che opera nella mente, cioè nella nobile parte dell’anima che partecipa con la ragione, ultima sua potenza, della divina natura, altri non è che la Filosofia, la “sposa dello Imperadore del cielo … e non solamente sposa, ma suora e figlia dilettissima”, la cosa più gentile che Dio, “il sol, che tutto ’l mondo gira”, possa intendere (Convivio III, xii). Ma anche questo amore per la donna gentile è momento da superare nel viaggio verso Beatrice, donna che mostrerà quanto di questo Amore il debole intelletto non comprende e il nostro parlare non ha valore di ritrarre. Alla beatitudine data dalle cose superne fa riferimento Catone nello spronare le anime a purgarsi per togliersi lo “scoglio”, cioè la scorza delle cure e dei desideri mondani che impedisce di vedere Dio. E nel canto successivo un Virgilio turbato ammonisce la gente umana a stare “al quia”, ad essere cioè contenta di credere senza cercare il perché, a non desiderare di vedere tutto con la ragione come fecero Aristotele e Platone ai quali questo desiderio senza frutto è dato per pena eterna nel Limbo (Purg. III, 34-45). Non che nel prosieguo del viaggio taccia la fonte aristotelica, essa rimane sempre “conoscenza viva”; è tuttavia guidata da un’Orsa diversa da quella terrestre, che con il mondo umano armonizza. “Altre corde” tirano verso Dio, quelle di cui gli chiederà conto l’evangelista Giovanni (Par. XXVI, 49-51).
Fra le cause di chiusura dei sigilli al senso umano incapace di comprendere la sapienza riposta nell’apparente stoltezza della croce, la settima è la “sevitia”, cioè la crudeltà con cui Dio ha voluto che il suo Figlio unigenito patisse tanto come unico modo per riconciliarsi con l’uomo da lui creato. Contro l’apparente crudeltà sta il “suavitatis dulcor quietativus” mostrato nella settima apertura (ad Ap 5, 1). Casella dice “soavemente” a Dante di posarsi (che significa ‘fermarsi’, ma il valore è quello del ‘riposare’ proprio del settimo stato e della ‘pausa’ propria della settima visione ad Ap 21, 16: Purg. II, 85), il suo dolce canto quieta il dolore. L’applicazione dei temi dell’apertura del settimo sigillo al canto di Casella, pregustazione sia pure imperfetta della beatitudine finale, dà al viaggio per l’inferno il valore di un patire in apparenza crudele che ripete quello sofferto da Cristo per redimere l’uomo. Dopo aver percorso la via “che fu sì aspra e forte”, dopo che la “morta poesì” ha lasciato “dietro a sé mar sì crudele”, la “sevitia” si è aperta nella quiete dolce e soave, per quanto ancora transitoria, peregrinante e non compiuta.
“Amor, ch’a nullo amato amar perdona … Amor condusse noi ad una morte” (Inf. V, 103, 106; tab. 4.3).
■ Nella seconda visione apocalittica, l’esegesi dell’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 3) si estende in generale ai primi quattro sigilli. All’apertura del primo, infatti, appare Cristo vittorioso che esce in campo sul cavallo bianco (Ap 6, 1-2), mentre nelle aperture dei successivi tre sigilli vengono specificati gli eserciti contrari a Cristo e alle sue tre perfezioni (potenza, sapienza, santità), designati rispettivamente con il cavallo rosso (secondo sigillo: i pagani), nero (terzo sigillo: gli eretici) e pallido (quarto sigillo: i Saraceni). Secondo Gioacchino da Fiore [4], i quattro cavalli corrispondono alle quattro bestie di Daniele 7, 3-7, considerate rispetto al futuro regno dell’Anticristo: la leonessa dalle ali di aquila (i Giudei), l’orso (i pagani), la pantera (le eresie), la quarta bestia ‘diversa’ (i Saraceni). La leonessa, sempre secondo Gioacchino da Fiore, designa la Sinagoga crudele, che negli Scribi e nei Farisei ha due ali come quelle di un’aquila: ad essa, nell’uscire vittorioso di Cristo in campo all’apertura del primo sigillo, si contrappone il leone, come lo spirito alla carne e come il sesso maschile a quello femminile.
Mentre Giudei, pagani ed eretici non ebbero una legge di per sé contraria a quella di Cristo, i Saraceni seguono invece una legge carnale e falsa del tutto dissimile, che non accetta le Scritture cristiane e contro la quale non è possibile qualsiasi confutazione sulla base di queste, come con i Giudei e con gli eretici. Né è possibile argomentare contro sulla base della ragione naturale, come avverso i pagani, in quanto i Saraceni non credono in più dèi, ma in un solo Dio. Inoltre i loro sapienti, afferma Olivi, da lungo tempo si dedicano agli studi filosofici e in particolare di Aristotele, tanto che i cristiani latini hanno ricevuto da essi i commenti ad Aristotele e altre opere, soprattutto di medicina e di astronomia, con cui hanno farcito e insozzato i propri scritti teologici. Ancora, la bestia saracena, a differenza delle prime tre, non tollera che la fede di Cristo venga predicata fra i seguaci della sua setta o che venga detto qualcosa contro la sua legge, pena la morte immediata.
Altrove si è mostrato sino a qual punto delle prerogative della quarta bestia, o dell’equivalente cavallo pallido – l’ipocrita magrezza, la fame, la paura che incute, il dominio su molte genti, la morte come effetto irremissibile – sia carica la lupa, che “non lascia altrui passar per la sua via, / ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide” (Inf. I, 95-96). Con un metodo che non si perita di applicare ai Cristiani quanto i Cristiani dicevano dei Giudei o dei Saraceni (e che è certamente memore di uno dei princìpi fondamentali dell’esegesi apocalittica, cioè l’appropriazione delle figure scritturali ad altri tempi, luoghi e persone), Dante ha vestito la cupidigia con i colori della bestia saracena.
Dopo ciò, non ci si stupirà di vedere in filigrana, nelle parole di Francesca – “Amor, ch’a nullo amato amar perdona … Amor condusse noi ad una morte” (Inf. V, 103, 106) -, parodiato il motivo della legge carnale di Maometto che non tollera confutazione razionale, che non perdona ma uccide, armatura teologica che fascia la regola, esposta nel De amore di Andrea Cappellano (II, 8, xxvi: “Amor nil posset amori denegare”), per cui amore non tollera che chi è amato non riami.
L’espressione “a nullo amato amar perdona” può essere ancora accostata ad Ap 13, 3-4 dove, nell’esegesi della grande guerra del sesto stato, si parla di quanti amano le cose terrene seguendo la bestia che sale dal mare (che viene interpretata come la bestia saracena) e adorando il drago (anch’esso interpretato in tal senso; ad Ap 12, 3 è detto astuto e di grande potenza). Costoro si sottomettono alla bestia chiedendosi chi sia simile ad essa in potenza o chi possa combatterla o farle resistenza, e rispondono “nullus”. “Secuti sunt bestiam” entra anche nel parlare del lussurioso Guinizzelli: “Nostro peccato fu ermafrodito; / ma perché non servammo umana legge, / seguendo come bestie l’appetito …” (Purg. XXVI, 82-84).
■ Perdonare è accostato nell’esegesi a sostenere, nel senso di risparmiare, assumere su di sé la pena. Lo si constata confrontando Ap 6, 3 – “Preterea bestia hec non sustinet fidem Christi inter eos predicari aut aliquid contra eorum legem dici, immo statim morte punitur” – con Ap 15, 1, parte proemiale della quinta visione – “… cur alii pepercerunt viris impiis et sustinuerunt eos usque ad mortem, alii punierunt eos et occiderunt”. I motivi contenuti in quest’ultimo passo, prevalentemente fondato su una citazione dall’Expositio di Gioacchino da Fiore e con oggetto le due vie divine delle quali gli uomini a volte cominciano ad accorgersi, la pietà che redime e risparmia e la giustizia per zelo ardente e punitivo, possono essere verificati in altri luoghi del poema. Perdonare benignamente “in spiritu levitatis”, come Cristo redentore, è nel Padre nostro dei superbi, ai quali Virgilio augura “che possiate muover l’ala, / che secondo il disio vostro vi lievi” (Purg. XI, 16-18, 37-39).
“La morte ch’el sostenne per ch’io viva”, cioè la redenzione operata da Cristo, è fra le corde che tirano verso Dio, fra i morsi dell’amore divino che, come dice Dante a san Giovanni, “tratto m’hanno del mar de l’amor torto, / e del diritto m’han posto a la riva”, mare che, ancora una volta, designa il tempestoso flutto delle passioni (Par. XXVI, 49-63; lo stesso verbo sostenere è appropriato a Beatrice, la quale in vita guidava Dante “in dritta parte” mostrandogli “li occhi giovanetti”: Purg. XXX, 121-123). Ricavata nell’esegesi di Ap 15, 1 è ancora la dura critica di Beatrice contro le false indulgenze dei moderni predicatori dal cappuccio gonfio di vanità e nascondiglio del diavolo: “Ma tale uccel nel becchetto s’annida, / che se ’l vulgo il vedesse, vederebbe / la perdonanza di ch’el si confida” (Par. XXIX, 118-120; cfr. con l’inciso “quia mirantur homines cum incipiunt videre que aliquando non viderunt”).
■ Una curiosa e grottesca utilizzazione del tema della legge di Maometto “diversa”, che non accetta le “nostre scritture”, è in apertura di Inf. XXII: Barbariccia, per dare un cenno di partenza alla schiera dei Malebranche che sorvegliano i barattieri immersi nella pece bollente, “avea del cul fatto trombetta” (Inf. XXI, 139), e il poeta assicura di non aver mai visto fanti o cavalieri muoversi al suono di “sì diversa cennamella”, pur avendo già udito segnali di trombe, di campane, di tamburi, dati “e con cose nostrali e con istrane”.
■ L’esegesi dell’Olivi fa riferimento in senso negativo ai commenti arabi ad Aristotele, come a qualcosa di estraneo alla Sacra Scrittura. Non è la posizione di Dante, che su questo punto non segue il francescano per quanto riguarda Avicenna e “Averoìs, che ’l gran comento feo” (Inf. IV, 144). Si deve anche dire che, collocato con onore il filosofo di Cordova tra gli “spiriti magni” del Limbo, nel corso del viaggio ben due volte la sua “errante” filosofia verrà smentita, prima da Stazio (sull’intelletto possibile unico per tutti gli uomini, Purg. XXV, 62-66) e poi da Beatrice (sulla teoria delle macchie lunari, Par. II, 46-148). Ma gli “spiriti magni”, per quanto formalmente dannati nel Limbo, sono fasciati dai temi della sede divina prima che i sigilli del libro vengano aperti da Cristo, e sono dunque fatti consorti dell’opera voluta dalla Provvidenza, in un processo della Redenzione ancora aperto. Proprio parodiando l’ultimo scritto di Pietro di Giovanni Olivi, fiero oppositore dello Stagirita, Dante ha tentato la più ardua delle conciliazioni, quella di Aristotele con il pensiero cristiano.
[1] DE SANCTIS, Francesca da Rimini, pp. 279, 288-289.
[2] L’esegesi di Ap 3, 3 e 16, 15 è considerata nei dettagli in Il sesto sigillo, 1d. Cfr. anche altrove.
[3] LSA, cap. III, Ap 3, 11 (Ia visio, VIa ecclesia): “Nota quod sicut solum angelum sextum et secundum de nullo increpat, sic solis ambobus coronam dicit esse paratam si perseverent. Cuius una ratio est quia amborum est sustinere summum certamen martiriorum, quibus non est superaddendum honus divine increpationis, sed potius dulcor promissionis et confortationis”.
[4] Cfr. Expositio, pars II, ff. 114va-b, 116ra; pars IV, distinctio IV, f. 163ra-vb: (f. 163va-b) “Si hystorias ecclesiasticas diligenter notamus, cum iam moderata esset persequutio Arrianorum, et etiam in quibusdam deleta inchoante Cosdroe rege Persarum, qui in persequutione orientali precessit Mahometh et successores eius, persequutio ipsius secte sequuta est tam immanis, ut re vera non hominum, sed bestie cuiusdam terribilis esse putaretur, presertim cum ipsius error non aliqua ratione humana videatur esse munitus, sed solo detestandi furore mendacii et tyrannica armorum potestate defensus […] Iudei quidem pugnaverunt contra fidem Christi, sed tamen eis renittentibus et invitis edificate sunt ecclesie Hierosolymis, et non post multos dies absorti sunt a Romanis, ita ut ex tunc quo ad eos finem acciperet et persequutio ecclesiarum et regnum. Pagani pugnaverunt contra Christum, sed quottidie vincebantur a militibus eius, ita ut in diebus Silvestri pape pene redderent arma et eidem Christi vicario sceptrum imperii assignarent. Gothi et Vandali et Longobardi et alii Arriani heretici partim deleti sunt ab exercitu Romanorum, partim ad catholicam fidem conversi. Hec vero quarta bestia indomabilis fuit, ut licet apparuerit ad tempus humiliata et quasi mortua, quam iterum magnificata sit et ad devorandum parata, plus timere est quam exprimere. Hec igitur est illa bestia quam sanctus Daniel nominat terribilem nimis, Ioannes vero tam ipsam quam tres alias comprehendit sub una habente septem capita et in uno eorum cornua decem”.
Tab. 4.1
[LSA, prologus, Notabile I] Secundus (status) fuit probationis et confirmationis eiusdem (primitive ecclesie) per martiria, que potissime inflicta sunt a paganis in toto orbe. […] In secundo vero honus passionis et pugna militaris seu triumphalis. […] Propter quod in primo preeminent pastores ecclesie catholice. In secundo pugiles christiane militie […].
|
||
|
Inf. XXVI, 119-120fatti non foste a viver come bruti,
|
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 12 (IVa visio, IIum prelium)] Deinde explicat augmentum mali quod ex prefata diaboli deiectione subsequuntur terrestres et tempestuosi, unde subdit: “Ve terre”, id est terrenis et terrena amantibus, “et mari”, id est infidelibus vel quibuscumque tempestuosis per varia vitia fluctuantibus et per sevitiam amaris, “quia descendit diabolus ad vos”, scilicet per ampliorem potestatem vos temptandi sibi iuste permissam, quia scilicet tempore tante salutis et victorie per Christum et eius martires obtente, et manifesto exemplo et documento orbi toti ostense, aut nullatenus aut non sufficienter estis eos secuti. “Descendit” etiam “ad vos diabolus” plusquam ante, propter maiorem voluntatem et conatum vos gravius temptandi. Unde subditur: “habens iram magnam”, scilicet se ulciscendi de sua tanta deiectione facta a Christo et a sanctis, et quia non potest se ulcisci in eis vult saltem se ulcisci in nos. Habet etiam “iram magnam” ad hoc ut omne malum implendum, tamquam “sciens quod modicum tempus habet”, scilicet ad temptandum, id est quia scit tempus extremi iudicii cito venturum, et etiam quia scit magnam potestatem temptandi sibi interim super electos esse ablatam usque prope seculi finem, quo est iterum solvendus. |
||
Inf. XXVII, 124-126A Minòs mi portò; e quelli attorse
|
Purg. XV, 94-101Indi m’apparve un’altra con quell’ acque
|
|
Tab. 4.2
[LSA, cap. III, Ap 3, 1. 3 (Ia visio, Va ecclesia)] Unde et Ricardus dat aliam rationem quare hec ecclesia dicta est “Sardis”, id est principium pulchritudinis, quia scilicet sola initia boni non autem consumationem habuit, et solum nomen sanctitatis potius quam rem*. Supra vero fuit alia ratio data. Respectu etiam prave multitudinis tam huius quinte ecclesie quam quinti status, prefert se habere “septem spiritus Dei et septem stellas”, id est fontalem plenitudinem donorum et gratiarum Spiritus Sancti et continentiam omnium sanctorum episcoporum quasi stellarum, tum ut istos de predictorum carentia et de sua opposita immunditia plus confundat, tum ut ad eam rehabendam fortius attrahat. […]
|
||
Purg. XIV, 132-133voce che giunse di contra dicendo:
|
Inf. XXVII, 112-114, 121-132“Francesco venne poi, com’ io fu’ morto,
|
|
Tab. 4.3
Inf. IV, 144Averoìs, che ’l gran comento feo. |
Inf. XXII, 7-12quando con trombe, e quando con campane,
|
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 3 (IIa visio, apertio II.IV sigilli] * Sicut etiam per equum pallidum, cuius sessor est mors, designatur Sarracenorum populus et eius propheta mortiferus, scilicet Mahomet, sic et per quartam bestiam dissimilem ceteris. Hec enim est dissimilis ceteris in tribus. Primo scilicet quia Iudeorum regnum et paganorum et hereticorum confluxerunt ad tempus cum fidelibus Christi et tandem disperierunt, sed bestia sarracenica surgens in quarto tempore confligit et perdurat in toto quinto et pertinget usque ad sectam Antichristi, propter quod hic dicitur quod “infernus”, id est infernalis secta Antichristi, “sequebatur eum”, scilicet equum pallidum et sessorem eius (Ap 6, 8).
|
||
Purg. XI, 16-18, 37-39E come noi lo mal ch’avem sofferto
|
Purg. XXX, 121-123; Par. XXVI, 59Alcun tempo il sostenni col mio volto:
|
|
[LSA, cap. XV, Ap 15, 1 (radix Ve visionis)] Pro primo dicit: “Et vidi aliud signum”, scilicet ab omnibus predictis, vel specialiter ab illo de quo supra ait quod “signum magnum apparuit in celo, mulier amicta sole” et cetera (Ap 12, 1). Illud enim fuit “magnum” in significando magnam gratiam et gloriam sancte matris ecclesie et sue prolis, hoc verum est “magnum et mirabile” in significando magnas et stupendas penas reproborum et magna et terribilia iudicia Dei et magnum et severum zelum sanctorum eius, per quos exercet iudicia sua. Et secundum Ioachim, dicitur “mirabile” quia mirantur homines cum incipiunt videre que aliquando non viderunt, scilicet cur alii pepercerunt viris impiis et sustinuerunt eos usque ad mortem, alii punierunt eos et occiderunt, et cur aliqui loquuntur eis humiliter et benigne quasi fratribus ad mortem egrotantibus, alii autem in zelo quasi hostibus Dei, sicut Christus primo venit in spiritu levitatis ut redimeret, secundo veniet ut iudex in spiritu iudicii et ardoris*.* Expositio, pars V, f. 182ra-b. |
[LSA, cap. XIII, Ap 13, 3-4 (IVa visio, VIum prelium] Sequitur: “Et admirata est universa terra post bestiam” (Ap 13, 3), id est cum multe admirationis timore et stupore de resurrectione capitis bestie seu de reassumptione tante potestatis. Omnes terreni, terrena amantes, secuti sunt bestiam. “Et adoraverunt drachonem, qui dedit potestatem bestie” (Ap 13, 4). Adorare enim errorem et erroneam sectam illius bestie est adorare drachonem actorem illius erroris et secte. Vel, secundum Ioachim, adorare drachonem est quasi adorare regem illum in quo diabolus et eius malitia et potestas singulariter habitabit*. “Et adoraverunt bestiam”, scilicet se subiciendo et humiliando illi bestiali genti et secte eius, “dicentes”, scilicet admirative: “Quis similis bestie?”, scilicet in potestate, quasi dicat: nullus; “et quis poterit pugnare cum ea?”, id est resistere ei, quasi dicat: nullus.* Expositio, pars IV, distinctio IV, f. 165rb. |
|
Tab. 4.4
[LSA, cap. II, Ap 2, 11 ( Ia visio, IIa ecclesia)] Quod tamen dicit quod vincens “non ledetur a morte secunda” (Ap 2, 11), potest martiribus adhuc appropriari secundum aliam interpretationem nominis huius ecclesie. Smirna enim alio modo, secundum Ricardum, interpretatur canticum. Sancti enim exultant et gloriantur in passionibus, secundum illud Apostoli ad Romanos V° (Rm 5, 3): “Gloriamur in tribulationibus”. Et secundum hoc, quasi prima mors est percussio corporum, secunda vero tristitia cordis et terror ex persecutione corporis vel ex eius imminentia causatus. Hanc autem secundam non sentiunt triumphatores martires, saltem sic quod ledantur ab ea.[LSA, cap. XI (IIa tuba moraliter exposita)] Quia vero amor sui parit anxios fluctus curarum et sollicitudinum, ideo contra earum excessum, quasi contra mare tempestuosum, fit secundum tubicinium, et <tertia> pars ei rebellis maiori pondere sollicitudinum aggravatur et maiori ardore ignescit. |
||
|
Purg. II, 106-114E io: “Se nuova legge non ti toglie
|
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (clausura VIIi sigilli)] Secunda causa seu ratio septem sigillorum libri est quia in Christo crucifixo fuerunt septem secundum humanum sensum et estimationem abiecta, que claudunt hominibus sapientiam libri eius. In eius enim cruce et morte apparet humano sensui summa impotentia et angustia et stultitia et inopia et ignominia et inimicitia et sevitia. […] Quod etiam Deus velit suum unigenitum tanta pati, nec aliter velit reconciliari homini quem creavit, pretendit summam inimicitiam et etiam sevitiam. […] Contra autem apparentiam sevitie Dei Patris in proprium Filium morti traditum est sue suavitatis dulcor quietativus in septima apertione monstrandus. |
||
5. Andar per mare
Nell’esegesi della seconda tromba (Ap 8, 8-9), il primo versetto è particolarmente dedicato ai Gentili, perché fra loro suonò il secondo angelo (Ap 8, 8). Il male che seguì, e come il diavolo infiammasse e incitasse i Gentili contro i dottori e la loro dottrina, è così spiegato: “E fu messo nel mare come un gran monte ardente di fuoco”. Questo monte è il diavolo, adorato come Dio dai pagani negli idoli, che viene definito “gran monte” sia per il gran tumore della sua superbia, sia per la sua grande potenza naturale. Costui riarse del fuoco d’ira e d’invidia verso i santi dottori che predicavano contro l’idolatria per espellerla dal mondo quanto possibile, e per l’effetto del suo empio suggerire e insinuarsi “fu messo nel mare”, cioè nel flutto dei cuori dei Gentili, i quali erano come un grande mare inabitabile sia per i semplici fedeli, che si possono considerare quasi pecore e giumenti, sia per i perfetti e discreti, che sono come uomini. Il “mare” spesso nell’Apocalisse designa i Gentili, fluttuosi per gli errori, procellosi per guerre e rivolte, salsi e amari per costumi carnali e per turpe idolatria, profondi come una voragine per malizia e quasi senza fine per la moltitudine dei popoli. Gli effetti della seconda tromba sono specificati col dire: “E la terza parte del mare si fece sangue”, cioè quella parte dei Gentili che non volle credere in Cristo si fece persecutrice uccidendo i fedeli ed effondendo il loro sangue.
Esegesi quasi simmetrica a quella della seconda tromba si presenta quella della seconda coppa (Ap 16, 3; quinta visione), che l’angelo versò nel mare, cioè sui pagani che non volevano credere ai predicatori e anzi li perseguitavano. Anche in questo caso i pagani sono designati dal mare fluttuoso di errori, nel quale non cresceva erba o albero della fede e non era luogo abitabile. La coppa, che sul piano temporale fu versata allorché prima con i martiri e poi con Costantino l’idolatria venne espulsa dal mondo e i pagani che non vollero convertirsi furono segregati come morti dalla vita civile e spirituale, spiritualmente designa il redarguire da parte dei santi martiri l’idolatria e l’ostinazione pagana. “E si fece sangue come quello di un morto”, cioè il mare del paganesimo si convertì in crudeltà mortifera ed effondente il sangue dei martiri. “E ogni anima vivente”, che cioè aveva prima una qualche disposizione alla vita della fede o qualche seme di essa, oppure ogni essere che scelse di vivere per questo mondo, “morì nel mare”, ossia fu morto nel primo seme del bene a causa della miscredenza e della crudele persecuzione dei pagani e destinato alla morte eterna.
■ I temi della seconda tromba risuonano nell’episodio di Guido da Montefeltro. Già nella domanda fatta a Dante – “dimmi se Romagnuoli han pace o guerra” – il motivo della guerra si congiunge con quello del monte allorché Guido precisa la sua origine, i monti tra Urbino e il giogo appenninico da cui nasce il Tevere (Inf. XXVII, 28-30). La risposta di Dante sviluppa il tema del cuore dei Gentili fluttuoso per le guerre: “Romagna tua non è, e non fu mai, / sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni” (vv. 37-38), dove persino il nome della terra allude nel suono al “mons magnus” messo nei cuori tempestosi. Nel seguito dell’episodio il tema del monte grande per superbia viene applicato a Bonifacio VIII, “il gran prete” che chiese a Guido di guarirlo “de la sua superba febbre” dandogli il consiglio fraudolento su come distruggere Palestrina (vv. 70-71, 96-98). Il papa rimise così Guido, pentitosi in vecchiaia del suo operato volpino e fattosi francescano, nelle prime colpe: un motivo, quello del ritorno all’antica idolatria, presente nell’esegesi della seconda guerra (Ap 12, 8).
■ Nel secondo girone del purgatorio, Dante incontra altri due spiriti di Romagna, Guido del Duca e Rinieri da Calboli. Il primo dei due descrive a fosche tinte la valle dell’Arno, il cui nome è ben degno di perire, tanto essa è priva di qualsiasi virtù dal suo principio, dove il fiume nasce in Appennino – “ov’ è sì pregno / l’alpestro monte ond’ è tronco Peloro” – fino alla foce nel mare (Purg. XIV, 28-36; cfr. supra). Il tema del “mons magnus … propter magnum superbie sue tumorem” è reso con il “pregno” dell’alpestro monte, che già Benvenuto, insieme ad altri commentatori, aveva spiegato come “tumorosus vel altus” per l’abbondanza di acque, senza però attribuirgli alcun significato spirituale. Si possono ricordare anche le parole del poeta a Oderisi da Gubbio, che purga la superbia nel girone precedente: “Tuo vero dir m’incora / bona umiltà, e gran tumor m’appiani” (Purg. XI, 118-119). Come nel mare dei Gentili, “inter quos non erat habitatio fidelium simplicium, quasi pecora et iumenta, et multo minus perfectorum et discretorum, qui sunt quasi homines”, così si son fatti a viver come bruti i conriparii del fiero fiume: “ond’ hanno sì mutata lor natura / li abitator de la misera valle, / che par che Circe li avesse in pastura” (Purg. XIV, 40-42).
Guido del Duca parla più avanti di sé stesso: “Fu il sangue mio d’invidia sì rïarso” (Purg. XIV, 82), che rinvia all’ “exarsit igne … invidie” del diavolo-gran monte di Ap 8, 8. “Di mia semente cotal paglia mieto”, continua il romagnolo con il motivo del seminato che è proprio della seconda coppa (Ap 16, 3), “o gente umana, perché poni ’l core / là ’v’ è mestier di consorte divieto?”, dove è presente un riferimento ai turbolenti cuori dei Gentili (vv. 85-87). Nel canto successivo, Virgilio, spiegando questa frase di Guido del Duca sul possesso dei beni terreni che generano invidia se posseduti in compagnia, utilizza il tema della separazione dei desideri superni da quelli terreni proposto nel Notabile XIII del prologo, dove il secondo stato viene assimilato al secondo giorno della creazione, in cui il firmamento separò le acque superiori da quelle inferiori (Purg. XV, 52-54).
Guido passa poi a parlare della sua Romagna, il territorio compreso “tra ’l Po e ’l monte e la marina e ’l Reno” (il “monte” è sempre l’Appennino, il “giogo” da cui nascono Arno e Tevere). Afferma sconsolato che non solo il sangue, già pregiato e onorato, del casato di Rinieri da Calboli, suo compagno di pena, “è fatto brullo” (tema della seconda coppa, ad Ap 16, 3: “et factus est sanguis tamquam mortui”), privo “del ben richesto al vero e al trastullo”, ma che tutta la regione è piena di velenosi e incoltivabili sterpi (Purg. XIV, 88-96). Il compianto sulle genti di Romagna, una volta buone e ora prive del valore di un tempo da nessuno ereditato, si avvicina a quanto ad Ap 16, 3 si dice di coloro che erano inizialmente ‘anime viventi’, che cioè avevano una qualche disposizione alla vita della fede o qualche seme di essa, oppure che scelsero di vivere per questo mondo, e che poi ‘morirono nel mare’, una volta morto in esse il primo seme del bene. La stessa distinzione fatta da Guido tra il bene richiesto “al vero” e quello “al trastullo”, che secondo gli antichi commentatori si richiama alla distinzione aristotelica tra il bene onesto (“bonum animi”) e quello utile e dilettevole (“bonum corporis”), sembra concordare con la distinzione nel testo di esegesi scritturale tra le anime viventi perché disposte alla fede e quelle che scelsero di vivere per il mondo, che nella trasformazione poetica sono l’amore e cortesia che invogliavano i cuori ora fatti tanto malvagi.
Si può notare, nel lamento di Guido del Duca sui casi di Romagna, accanto al nuovo valore assegnato ai ‘gentili’ (gente dal cuore tumultuoso, sediziosa e sempre in guerra: “o gente umana, perché poni ’l core / là ’v’ è mestier di consorte divieto?”, Purg. XIV, 86-87), così come proposto ad Ap 8, 8 e in altri luoghi della Lectura, la presenza del significato tradizionale, caro al primo Dante, della parola ‘gentile’, cioè nobile di spirito, liberale: “quando in Faenza un Bernardin di Fosco, / verga gentil di picciola gramigna?” (vv. 101-102). Una ‘gentilezza’ di vita («Ugolin d’Azzo che vivette nosco – “Et omnis anima vivens” … mortificata est a primo seminario boni et fortius destinata ad mortem eternam», v. 105; cfr. Ap 16, 3) che non solo si è perduta, ma che anzi è tornata allo stato brutale prima che fosse seminata la pianta: il verso “Oh Romagnuoli tornati in bastardi!” (v. 99) non ha unicamente il senso di ‘esser vòlti’, perché essi sono ‘ritornati’ al silvestre stato precedente il tempo della vera ‘gentilezza’, di cui Guido ricorda “le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi / che ne ’nvogliava amore e cortesia” (vv. 109-110; cfr. infra). Sotto questo rispetto, Purg. XIV, 99 – “Oh Romagnuoli tornati in bastardi!” – è parodica variazione, come lo sono state le parole del Montefeltrano sul “gran prete” a Inf. XXVII, 71 – “che mi rimise ne le prime colpe” -, del tema del ritorno all’antico paganesimo proprio della seconda guerra sostenuta dalla Chiesa (Ap 12, 8).
■ Temi propri dei Gentili – l’andar per mare (da Ap 8, 9), il cuore – accompagnano Dante e Virgilio sul “lito diserto” del purgatorio: “Noi eravam lunghesso mare ancora, / come gente che pensa a suo cammino, / che va col cuore e col corpo dimora” (Purg. II, 10-12). Sono motivi, nella loro razionale serenità affermata dalla canzone “Amor che ne la mente mi ragiona” intonata da Casella (v. 112), speculari a quelli tempestosi e passionati di Inf. V: «Io venni in loco d’ogne luce muto, / che mugghia come fa mar per tempesta … I’ cominciai: “Poeta, volontieri / parlerei a quei due che ’nsieme vanno” … Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende» (vv. 28-29, 73-74, 100).
I tempestosi cuori dei ‘gentili’ si registrano ancora nel principio del lamento sulla condizione d’Italia (Purg. VI, 76-87): «Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere in gran tempesta … e ora in te non stanno sanza guerra / li vivi tuoi … Cerca, misera, intorno da le prode / le tue marine – “missus est in mare”, id est in fluctuosis cordibus gentilium … Per “mare” enim sepe in hoc libro designatur gentilitas, quia fuit erroribus fluctuans et bellis ac seditionibus procellosa … “Et omnis anima vivens” …» (“nave” rinvia all’esegesi del versetto successivo, Ap 8, 9). E Sordello, “quell’anima gentil” pronta a far festa al suo concittadino Virgilio “sol per lo dolce suon de la sua terra”, rappresenta, nella sua nobiltà di spirito, l’altro significato dell’essere ‘gentile’.
Patrick Boyde ha seguito le trasformazioni assunte dalla parola “gentilezza”, che non si trova né in Aristotele né nella Bibbia ma che è centrale per la comprensione dei primi tentativi di Dante nel campo dell’etica (A courtly value in Dante’s hands, in Human Vices and Human Worth in Dante’s Comedy, Cambridge 2000, pp. 126-146). Qui si intende mostrare come ‘gentile’ abbia acquistato spessore nella Commedia rispetto alla Vita Nova. Accanto al significato di ‘cortese’ o ‘liberale’ si fa sempre più forte il senso di ‘gente’ tumultuosa per passioni e conflitti intestini, fluttuante come il mare in tempesta, come “la bufera infernal che mai non resta” che porta in eterno Francesca e Paolo, la cui vita spense “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende”. Beatrice, la “gentilissima” del “libello” giovanile, non è fregiata nella Commedia con tale prerogativa. Ora la donna attende il suo amico sulla cima della montagna, al termine del viaggio nella storia umana dove la gentilità è più di un modo di essere, è un periodo della storia umana i cui temi vestono parodicamente i personaggi del poema.
■ L’episodio di Francesca si colloca in una zona del poema dove prevalgono numerosi i temi del secondo stato, proprio dei martiri, che si intrecciano però con temi di tutti gli altri stati, e in particolare con il martirio psicologico proprio del sesto, cioè dell’età moderna (cfr. infra). Di questi temi si mostra qui l’esegesi della seconda tromba, nel suo secondo versetto, che suona contro i Gentili: “E morì la terza parte delle creature che avevano l’anima nel mare” (Ap 8, 9), cioè quei semplici Gentili i quali col credere in Cristo avevano un’anima, ossia la vita della grazia, sia pure con una certa animalità, ma non furono capaci di portare e vincere una tentazione tanto grande e morirono apostatando dalla fede. “E andò perduta la terza parte delle navi”, cioè quei fedeli dottori che con le parole, con l’esempio, con i suffragi e con pia dedizione portavano e conducevano gli altri come navi per il mare dei Gentili, e che però non furono capaci o non vollero patire tanta persecuzione, perirono apostatando dalla fede. Oppure, secondo Riccardo di San Vittore, con ‘coloro che avevano un’anima’ sono designati quanti fra i Gentili apparivano più dotati di ragione, mentre con le ‘navi’ lo sono quelli che portavano e sostenevano gli altri, i quali rifiutando la fede rimasero nell’infedeltà e furono così destinati a sparire nella morte eterna.
Secondo Gioacchino da Fiore, il “gran monte” di cui si parla al versetto precedente (Ap 8, 8) deve identificarsi con Nicola, uno dei primi sette diaconi, il quale, acceso da maligno zelo, fu istitutore dell’eresia che da lui prende nome (cfr. Ap 2, 6). Come dalla Chiesa apostolica uscirono i falsi apostoli a contrastarne la libertà, contro i quali resistette san Paolo con i suoi compagni, così dai sette diaconi uscirono i Nicolaiti, che contaminarono con la loro eresia quella parte del mare dei Gentili e dei fedeli ‘animali’ che aderì alla loro crudeltà, lussuria e commercio con gli idoli, e anche parecchie chiese le quali, aggiunge Olivi, erano come navi per i credenti. Dei diaconi – si tratta di un inciso incastonato nella libera citazione oliviana di Gioacchino, ma che non appartiene all’abate calabrese – è proprio il compito di leggere e di portare sulle spalle il peso della passione di Cristo.
I temi del leggere, del portare, dell’essere vinti da una tentazione troppo grande, dell’apostatare dalla fede, dell’animalità percorrono Inf. V, il canto dei peccatori carnali. Il tema del leggere, che corrisponde a un compito proprio dei diaconi, vi compare ben cinque volte, una riferito a Semiramìs – “di cui si legge / che succedette a Nino e fu sua sposa” (vv. 58-59; prima ocorrenza del verbo nel poema) -, quattro ai “due cognati” amanti, nel giro di dodici versi (vv. 127-138), una volta per ciascuna delle quattro terzine in cui Francesca ricorda la radice del loro amore: “Noi leggiavamo un giorno per diletto / di Lancialotto come amor lo strinse … Per più fïate li occhi ci sospinse / quella lettura, e scolorocci il viso … Quando leggemmo il disïato riso / esser basciato da cotanto amante … quel giorno più non vi leggemmo avante”. Non sarà casuale che siano sette, come i sette diaconi, “le donne antiche e ’ cavalieri” nominati da Virgilio tra le “più di mille ombre” (vv. 52-72). Francesca e Paolo “uscir de la schiera ov’è Dido” (v. 85), quasi momentaneamente assunti a una milizia più alta (si ricordi Dante, “ch’uscì per te de la volgare schiera”, Inf. II, 105; cfr. infra).
Altrettanto forte è, in Inf. V, la presenza del “portare” e del “condurre”, tema anch’esso appropriato ai diaconi, “quorum est legere et super humeros honus passionis Christi portare”, secondo l’aggiunta di Olivi alla libera citazione di Gioacchino da Fiore: gli stornelli “ne portan l’ali” (v. 40), le “ombre portate da la detta briga” (v. 49), le due “anime affannate” che “quali colombe dal disio chiamate … vegnon per l’aere, dal voler portate” (vv. 82-84), le parole “porte” (v. 108) dall’“anime offense” (“verbo … portabant et deducebant”, come è proprio della terza parte delle navi andata perduta). Il portare per nave, congiunto col leggere, è nell’espressione “Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse” (v. 137), dove il nome di Galehoz, intermediario d’amore tra Lancillotto e Ginevra, che in questo caso designa il libro che sospinse gli amanti al punto che li vinse, concorda pure con “galeotto” nel senso di nocchiero, di cui è esempio Flegiàs in Inf. VIII, 17 e in Purg. II, 27 l’angelo che porta le anime dalla foce del Tevere alla riva del purgatorio.
Il tema dell’animalità, che denota una minor presenza dell’elemento razionale nell’“anima vivens”, cioè nell’essere vivente, è nel rivolgersi di Francesca a Dante chiamandolo “animal grazïoso e benigno” (Inf. V, 88); quello dell’apostatare dalla fede è appropriato, nel medesimo canto, a Didone, “colei che s’ancise amorosa, / e ruppe fede al cener di Sicheo” (vv. 61-62).
■ Come sempre, più luoghi del poema, alcuni dei quali posti in ‘zone’ dove prevale la tematica dello stato o periodo trattato, sollecitano la memoria verso un medesimo punto dell’esegesi scritturale. Il tema del leggere si ritrova con i lussuriosi purganti che peccarono secondo natura (i quali però non sono collocati, come i lussuriosi del secondo cerchio infernale, in una zona nella quale prevalgano i temi dei martiri; il loro stato è il settimo). Come dice Guido Guinizzelli, “in obbrobrio di noi, per noi si legge”, cioè si grida, il nome di Pasifae, che si fece bestia entrando nella “falsa vacca” per concepirvi il Minotauro: essi infatti seguirono l’appetito come bestie, non servando in amore “umana legge”, cioè quella della ragione (Purg. XXVI, 82-87).
In tutt’altro contesto, “amore” e “leggere” sono uniti nelle parole dette dal poeta a san Giovanni che lo esamina sulla carità (Par. XXVI, 16-18), dove la terzina contiene anche il riferimento ad Ap 1, 8; 21, 6 e 22, 13, cioè a Dio, che “Alfa e O è di quanta scrittura / mi legge Amore o lievemente o forte”. Sta qui la consumazione della “scrittura” d’Amore, sulla quale “s’appunta” l’anima di Dante, iniziata con l’inganno di Francesca e Paolo, vinti da “un punto”. Ben oltre, nel viaggio della conoscenza intrapreso per terra e cielo, è andato il poeta. Quelli avevano letto da soli, a lui viene letto per dettato interiore (“Noi leggiavamo … quel giorno più non vi leggemmo avante /… mi legge Amore”). Dante ha avuto due guide nel viaggio, entrambe testimoni di Cristo, del suo lato umano o esteriore (Virgilio) e del suo lato spirituale o interiore (Beatrice). L’essere “soli” dei due amanti anticipa la risposta data a Cavalcante: «E io a lui: “Da me stesso non vegno: / colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”» (Inf. X, 61-63). Disdegno verso l’essere guidati in un viaggio tanto arduo. Francesca e Paolo, che “paion sì al vento esser leggeri”, sono dannati fra “i peccator carnali, / che la ragion sommettono al talento” (Inf. V, 37-39, 75). Esempio di “amor sui” che, pur essendo fondamento di tutti gli affetti, preso per sé partorisce affanni come in un mare tempestoso. La loro levità è propria dell’adolescenza della Chiesa, leggera e agitata dal vento dell’errore, contro cui si appunta lo zelo dei dottori del terzo stato, i quali con la spada della ragione rompono le eresie. Dante, di fronte a san Giovanni, ‘ragiona’ di Amore (Par. XXVI, 19-66). Riaffiora la canzone Amor che nella mente mi ragiona (“mi legge Amore o lievemente o forte”), che aveva sentito nelle dolci note di Casella appena arrivato sulla spiaggia del purgatorio, per poco però, dato l’intervento di Catone a disperdere l’adunata verso il monte della purgazione. Amore che legge, che cioè detta dentro, incorpora la Filosofia, il vero oggetto della canzone. Ma, oltre all’“intelletto umano” e alle “autoritadi a lui concorde”, oltre cioè alla ragione e alla Scrittura – i due primi motori del Convivio -, Dante sente “altre corde” che tirano verso Dio. Si tratta di “tutti quei morsi” che concorrono alla carità: l’esistenza del mondo e delle creature, la Redenzione, la speranza della beatitudine eterna. Morsi non sentiti dall’autore del Convivio di cui però, al termine del viaggio, è ormai esperto. Amore, come la “pietade” descritta nel Convivio (II, x, 5-6), non è solo passione, “anzi è una nobile disposizione d’animo” atta a ricevere speciali effetti passionati.
■ Molti altri luoghi del poema rinviano semanticamente alla dottrina esegetica di Ap 8, 8-9. In una ‘zona’ dedicata al secondo stato, il centauro Nesso porta Dante sulla groppa e fa da guida nell’attraversare il Flegetonte, la riviera del sangue in cui sono bolliti i violenti contro il prossimo (Inf. XII, 93-96). Alla stessa rosa tematica, variante del “portabant et deducebant alios per mare gentilium”, appartiene l’apostrofe di Virgilio al Minotauro: “Forse / tu credi che qui sia ’l duca d’Atene, / che sù nel mondo la morte ti porse?” (vv. 16-18), dove però si intrecciano fili dall’esegesi della seconda guerra (Ap 12, 7).
Unito al mantenimento della fede, il “portare” è rivendicato da Pier della Vigna: “fede portai al glorïoso offizio … vi giuro che già mai non ruppi fede / al mio segnor, che fu d’onor sì degno” (Inf. XIII, 62, 74-75; siamo nella ‘zona’ successiva, nella quale prevalgono i temi del terzo stato).
Gerione, in cui prevale invece una trama tessuta coi fili del sesto stato, concede “i suoi omeri forti”: sulle sue “spallacce” il poeta si assetta, nonostante che le “parole porte” da Virgilio, le quali attestano che per scendere non ci sono altre scale, gli abbiano quasi messo addosso la febbre della quartana. Ma Virgilio, come in altre occasioni, ‘sostiene’ (che è variante del “portare” da parte delle “navi”, le quali designano i Gentili più razionali) il discepolo tenendolo abbracciato (Inf. XVII, 41-42, 79-96).
Fra i seduttori puniti nella prima bolgia, Giasone, “che per cuore e per senno / li Colchi del monton privati féne” – che fu quindi tra i Gentili razionali –, ingannò Isifile “con parole ornate” (“verbo … portabant et deducebant alios”), lasciandola “gravida, soletta” (variante del “fidem respuere”): tale colpa lo condanna “a tal martiro”, per cui è vendicata anche la seduzione di Medea (Inf. XVIII, 86-96). Giasone è preceduto, nell’altra fila, dal ruffiano Venedico Caccianemico, che condusse, cioè portò, la Ghisolabella “a far la voglia del marchese” (vv. 55-57). Il passaggio alla seconda bolgia avviene lì dove lo stretto calle “s’incrocicchia” con il secondo argine (il segno della croce è proprio del sacramento della cresima, che conferma i martiri nella fede: prologo, Notabile XIII), che in quel punto fa da “spalle” nel reggere l’arco di un altro ponte (vv. 100-102). Il tema del sostenere, proprio della seconda tromba, si intreccia talora con quanto esposto nella settima visione sugli angoli delle dodici porte della città celeste (della quale l’inferno è opposta immagine), che designano la forza e l’ornato, perché nelle case le pareti si congiungono agli angoli (Ap 21, 12). In tal senso si dice di Cristo che è pietra angolare, e in Zaccaria si afferma la futura forza del vittorioso regno di Giuda definendolo angolo, palo e “arco”, con riferimento ai robusti duci che sostengono gli altri (Zc 10, 4). Il tema del portare, congiunto con quello dell’arco, si presenta ancora nella risalita dalla terza bolgia dei simoniaci, allorché Virgilio ‘porta’ Dante stretto a sé “sovra ’l colmo de l’arco”, che a sua volta porta (“è tragetto”) dal quarto al quinto argine (Inf. XIX, 127-129).
Gli invidiosi del secondo girone del purgatorio, fra i tanti temi del secondo stato con cui è tessuta la loro trama, stanno seduti con gli occhi cuciti con un filo di ferro, sostenendosi l’un l’altro con la spalla, mentre tutti sono sostenuti dalla parete rocciosa: il tema del sostenere usa in questo caso la variante “sofferia … sofferti”, che allude alla sofferenza dei martiri (Purg. XIII, 59-60). Guido del Duca, che nel nome concorda col “deducere”, variante del portare di Ap 8, 9, usa questo verbo nel rivelarsi a Dante (Purg. XIV, 77-81).
Unito al motivo della pietà (le navi dei dottori “qui verbo et exemplo et elemosinarum suffragio vel aliis piis obsequiis portabant et deducebant alios per mare gentilium quasi naves eorum”), ‘portare’ è appropriato a Beatrice, che pietosa soccorse l’amico e porse vere parole al cortese Virgilio (Inf. II, 133-135). Parole che sono “preghi … piangendo … porti” a colui che l’avrebbe condotto fino al Paradiso terrestre (Purg. XXX, 139-141).
Il motivo del portare con la parola si può accostare al ‘portare novella’ nel mondo (Inf. XXVIII, 92, 133; XXXII, 111; Purg. V, 50; Par. XXV, 129). In Purg. V il tema del gran monte tumoroso si ritrova nel racconto che Buonconte da Montefeltro fa dello strazio del proprio corpo morto e insepolto, operato dal diavolo dopo che l’angelo di Dio gli ha sottratto l’anima per una lagrimetta di estremo pentimento: “per la virtù che sua natura diede”, cioè per la sua potenza naturale, il diavolo mosse il fumo e il vento e coperse di nebbia la piana di Campaldino, dove Buonconte era caduto combattendo, “da Pratomagno al gran giogo” rendendo l’aria pregna di acqua (vv. 112-118). Anche in questo caso, come nella Romagna di Guido da Montefeltro, l’aggettivo “magnus” è appropriato a entità geografiche diverse dal monte, elemento comunque presente.
■ Nella spiegazione dell’ordine dell’universo data da Beatrice in Par. I vengono utilizzati i motivi del mare e del portare propri della seconda tromba, ma la variazione, che avviene in un contesto lontanissimo dall’ordito originario, è appena percettibile in una sublimazione della Gentilità, bruta o razionale, nel macrocosmo: le specie naturali “si muovono a diversi porti / per lo gran mar de l’essere”, ciascuna portata dall’istinto datole, che porta il fuoco a salire verso la luna, che muove i “cor mortali”, cioè le creature irrazionali (animali e piante), che “in sé stringe e aduna” la terra con la legge di gravità. Ad essere indirizzate al proprio fine non sono solo le creature prive di ragione, ma anche quelle dotate di intelligenza e amore (Par. I, 109-120). Rimane, dell’esegesi di partenza, l’immagine del mare per designare il luogo che tutte le creature devono attraversare. La terza parte delle creature che avevano un’anima perì nel mare, si legge ad Ap 8, 9. Il mare è anche l’amore tempestoso che genera affanni e un viver come bruti (così nell’interpretazione tropologica della seconda tromba in fine del cap. XI). Si tratta dei Gentili dall’amore brutale e dai cuori sempre tempestosi per guerre. È il caso di Francesca e dei Romagnoli dei quali vuol sapere il francescano Guido da Montefeltro. Anche le creature più razionali, “c’hanno intelletto e amore”, fanno parte della terza parte morta nel mare. Il viaggio di Dante è esempio del superamento del mare tempestoso, dell’“Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende”; una volta lasciati alle spalle i “luoghi tristi” al di là delle “lontane acque” e delle “larghe onde”, sulle “altre corde” della carità che “tratto m’hanno del mar de l’amor torto, / e del diritto m’han posto a la riva”, come dichiara il poeta stesso di fronte a san Giovanni (Par. XXVI, 61-63).
È da notare come, in Par. I, 114.117, ai motivi del mare e del portare si aggiunga quello dell’“istinto”, anch’esso presente ad Ap 8, 8 nell’empio suggerire del diavolo-gran monte messo nel mare: ad Ap 2, 9 (seconda chiesa) la “suggestio”, sempre diabolica, equivale a “instinctus” e si accompagna all’“adunare”, verbo che pure è presente nelle parole di Beatrice (l’istinto che “la terra in sé stringe e aduna”), la quale appropria all’ordine dato da Dio motivi che nel testo teologico sono connessi con l’operare diabolico.
Il tema del mare e quello del portare sono presenti disgiunti nell’invito alla prudenza nel giudicare con cui, nel cielo del Sole, Tommaso d’Aquino conclude il suo discorso: egli ha infatti visto il pruno, “rigido e feroce” durante l’inverno, “poscia portar la rosa in su la cima” e la nave che ha corso il mare dritta e veloce perire all’entrare in porto (Par. XIII, 133-138).
L’andar per mare, congiunto con il motivo della fede (la “vita fidei” di Ap 8, 9) e con il ‘tentare’ (altro motivo proprio del secondo stato), sono contenuti nelle parole con le quali Beatrice si rivolge a san Pietro – “a cui Nostro Segnor lasciò le chiavi, / ch’ei portò giù, di questo gaudio miro” – pregandolo di ‘tentare’, cioè di esaminare, Dante nella fede che gli consentiva di camminare sul mare, per cui non perì come la terza parte delle ‘navi’ contro le quali suona la seconda tromba (Par. XXIV, 34-39).
■ Se si collaziona Ap 8, 9 con Ap 18, 17, passo della sesta visione relativo al pianto sulla caduta di Babilonia da parte dei comandanti di navi che commerciano per mare, che l’esegesi spiega essere coloro che commerciano “per vias graviores” e navigano verso città o porti lontani, il confronto è con le parole dette da Caronte a Dante, “anima viva” (Ap 8, 9: “qui credendo in Christum habebant animam, id est vitam gratie”) che deve dipartirsi dai morti e venire a piaggia “per altra via, per altri porti”, portato da “più lieve legno” (Inf. III, 88-93; cfr. l’esegesi di Ap 11, 18).
Tab. 5.1
[LSA, cap. V, Ap 5, 1] Prima (causa) est quia septem sunt defectus in nobis claudentes nobis intelligentiam huius libri. Secundus est sensualis et corporalis vite nimius amor, eiusque nimia brutalitas et impetuositas. […] In secunda vero fervor fidei, usque ad martiriorum perpessionem, brutalem vitam gentilium et amorem ipsius extinxit.[LSA, cap. XI (IIa tuba moraliter exposita)] Quia vero amor sui parit anxios fluctus curarum et sollicitudinum, ideo contra earum excessum, quasi contra mare tempestuosum, fit secundum tubicinium, et <tertia> pars ei rebellis maiori pondere sollicitudinum aggravatur et maiori ardore ignescit.[LSA, cap. VIII, Ap 8, 8-9 (IIIa visio, IIa tuba)] […] “et tamquam mons magnus igne ardens missus est in mare” (Ap 8, 8). Mons iste est diabolus, qui a gentilibus in idolis colebatur ut Deus, qui dicitur “mons magnus” tum propter magnum superbie sue tumorem, tum propter magnitudinem sue naturalis potentie, qui contra sanctos doctores, contra eius cultum et idolatriam predicantes et ipsam pro posse a toto orbe expellentes, exarsit igne ire et invidie contra ipsos, et per effectum impie suggestionis et successionis “missus est in mare”, id est in fluctuosis cordibus gentilium, quorum multitudo erat quasi mare magnum et inter quos non erat habitatio fidelium simplicium, quasi pecora et iumenta, et multo minus perfectorum et discretorum, qui sunt quasi homines. Per “mare” enim sepe in hoc libro designatur gentilitas, quia fuit erroribus fluctuans et bellis ac seditionibus procellosa et moribus carnalibus et idolatriis turpibus salsa et amara et malitiis profunda et voraginosa et multitudine plebium quasi infinita. Quid autem mali fecerit ostenditur cum subditur: “Et facta est tertia pars maris sanguis”, id est illa pars gentilium, que noluit in Christum credere, facta est persecutrix et interfectrix fidelium et effundens sanguinem eorum.
|
||
Inf. XXVII, 22-24, 28-30, 36-39, 70-71, 96-97
|
Purg. II, 10-12, 106-114Noi eravam lunghesso mare ancora,
|
|
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 9 (IIIa visio, IIa tuba)] “Et mortua est tertia pars creature eorum, que habebant animas in mari” (Ap 8, 9), id est illa pars simplicium gentilium, qui credendo in Christum habebant animam, id est vitam gratie cum quadam tamen animalitate, et que non valuit tantam temptationem portare et vincere, “et mortua est” a vita fidei apostatando ab ea.
|
||
Inf. XII, 16-18, 93-96Lo savio mio inver’ lui gridò: “Forse
|
Inf. XIII, 62, 73-75, 129fede portai al glorïoso offizioPer le nove radici d’esto legno
|
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] In scripturis tamen sepe angulus sumitur pro fortitudine et ornatu, quia in angulis domorum, in quibus parietes coniunguntur, est fortitudo domus. Unde Christus dicitur esse factus in caput anguli et lapis angularis; et Iob I° dicitur “ventus” <concussisse> “quattuor angulos domus” ut dirueret ipsam domum (Jb 1, 19), et Zacharie X°, ubi agitur de futura fortitudine et victoria regni Iude, dicitur quod “ex ipso” erit “angulus et paxillus et archus prelii” (Zc 10, 4), id est robusti duces qui erunt aliorum sustentatores sicut angulus et paxillus; et Sophonie I° dicitur quod “dies ire” erit “super civitates munitas et super angulos excelsos” (Sph 1, 15-16), et capitulo III° dicitur: “Disperdidi gentes et dissipati sunt anguli earum” (Sph 3, 6), id est robusti duces earum; et Io Regum XIIII° dixit Saul: “Applicate huc universos angulos populi” et cetera (1 Rg 14, 38). |
||
Tab. 5.2
Gli elementi semantici presenti nell’esegesi di Ap 8, 8-9 (terza visione, seconda tromba) e dei passi simmetrici del capitolo XI, nella sua conclusione (seconda tromba, senso morale), e di Ap 16, 3 (quinta visione, seconda coppa) – tutti relativi al secondo stato -, nella tabella precedente esposti sinotticamente con la Commedia, vengono qui singolarmente riscontrati con l’indicazione del canto e del numero del verso. |
|
(Inf. II) pietosa (133), parole, ti porse (135)(Inf. III) anima viva (88), legno (93), ti porti (93)
|
|
[Ap 8, 8; IIIa visio, IIa tuba] mons magnus … propter magnum superbie sue tumorem … propter magnitudinem sue naturalis potentie … exarsit igne … invidie
|
|
(Purg. II) mare (10), gente (11), cuore (12), galeotto (27), amoroso (107), affannata (111), Amor (112)(Purg. V) di là … porti (50), sua natura (114), Pratomagno (116), gran giogo (116), pregno (118)
|
6. Liberalità e cortesia
Accanto alla Gentilità tumultuosa nelle sue marine, la cui vita non sta senza guerra, la “gentilezza” veramente nobile, liberale e cortese trova anch’essa nella Lectura i suoi punti di riferimento.
Ad Ap 22, 16 (ultimo capitolo del libro, nella sua conclusione) Cristo si definisce “stella splendida”, illuminatrice dei santi, e “matutina”, che promette, predica e mostra la luce futura dell’eterno giorno. È stella in quanto fu uomo mortale e sole in quanto Dio. Egli invita tutti alla gloria (Ap 22, 17). Lo “sposo”, che secondo Riccardo di San Vittore è Cristo (Olivi nota che alcuni correttori del testo hanno tuttavia ad Ap 22, 17 “spirito” al posto di “sposo”, intendendo che Cristo invita tanto per sé quanto per il suo Spirito e per ispirazione interiore), e la “sposa”, cioè la Chiesa generale, sia quella dei beati sia quella peregrinante come quella contemplativa, dicono “Vieni”, cioè alla gloriosa cena delle nozze dell’Agnello. “E chi ascolta”, ossia chi è a conoscenza dell’invito, oppure chi crede e opera in modo retto e con obbedienza, “dica: vieni” a quelli che sono da chiamare alla cena e alla città beata. Poi è Cristo stesso ad invitare con liberalità dicendo: “Chi ha sete venga, e chi vuole riceva gratuitamente l’acqua della vita”. Dice “chi ha sete e chi vuole” perché nessuno può venire senza che ci sia desiderio e volontario consenso. “Venire” equivale a ricevere l’acqua della vita, cioè la grazia che ristora, vivifica e conduce alla vita eterna. Essa è “gratuita” perché viene data dalla carità e dalla liberalità di Cristo e ricevuta senza l’intervento di alcun prezzo venale ed esteriore, ma anche perché la prima grazia viene data senza alcun merito precedente essendo principio e causa del merito stesso e del suo aumento.
■ L’angelo dell’umiltà, che conduce i poeti al passaggio dal primo al secondo girone del purgatorio e cancella il primo “P” dalla fronte di Dante (Purg. XII, 88-99), ha il volto scintillante come la stella mattutina. Invita dicendo “Venite”, e promette “sicura” la salita, come la stella mattutina promette il sole. Nel canto successivo, gli esempi di carità nel girone degli invidiosi sono voci di “spiriti” che invitano cortesemente alla mensa d’amore. Gli “spiritus vocales”, come li chiama Benvenuto, sono solo ascoltati e non anche veduti (corrisponde a «“et qui audit”, scilicet hanc nostram invitationem”»). La prima voce ricorda l’intervento di Maria alle nozze di Cana perché il Figlio provvedesse con un miracolo alla mancanza di vino (Purg. XIII, 25-30; cfr. supra). I temi riaffiorano nel passaggio dal terzo al quarto girone (Purg. XVII, 46-63): l’invito dell’angelo (“Or accordiamo a tanto invito il piede”), che è quello liberale e gratuito dello Spirito (“Questo è divino spirito, che ne la / via da ir sù ne drizza sanza prego”), e la volontà che acconsente (“e fece la mia voglia tanto pronta”).
■ Tracce del tema della “stella matutina” si trovano in Virgilio, il cui parlare, prospettando a Dante il viaggio nell’oltretomba, è promessa di tanto bene (Inf. II, 126). Lo stesso presentarsi del poeta pagano – “Non omo, omo già fui” (Inf. I, 67) – sembra alludere al “fui homo mortalis ipsam precurrendo” detto da Cristo ad Ap 22, 16, stella che predica, promette e mostra la luce dell’eterno giorno. In questo il poeta pagano, anche se nell’Eden esce dal campo per anima più degna, che designa il gusto e il sentimento dell’amore appropriato allo Spirito Santo, non è solo prefigurazione ma figura conforme del Cristo uomo, con tutte le insegne e prerogative che gli vengono attribuite nel testo apocalittico [1].
■ Il tema del venire per desiderio e volontario consenso di “chi ha sete e chi vuole” si ritrova, nel terzultimo verso del poema (Par. XXXIII, 143), nel volgere da parte di Dio “il mio disio e ’l velle”, ribadito dall’“in che sua voglia venne” che precede di due versi, allorché la folgore della grazia percuote la mente del poeta rendendola in grado di comprendere il mistero del rapporto tra l’umano e il divino nel Verbo [2].
Si può anche citare il “vegnati in voglia di trarreti avanti” detto da Dante e Matelda (Purg. XXVIII, 46), in cui, come osservò il Torraca, “l’accento végnati dà l’inflessione della voce, che invita con desiderio”.
Il medesimo gruppo di temi viene variato, in tutt’altra situazione, nel basso litigio tra maestro Adamo e Sinone, allorché il primo contrappone la propria sete di idropico all’arsura del greco il quale, “per leccar lo specchio di Narcisso”, cioè per avere un po’ d’acqua, non si farebbe molto pregare (l’espressione “non vorresti a ’nvitar molte parole”, contiene in sé l’invito e la volontà di aderirvi). Virgilio, nel rimproverare Dante, riprende i temi affermando che “voler ciò udire è bassa voglia” (Inf. XXX, 124-129, 148).
■ Per quanto riguarda il tema della gratuità della grazia, la quale nel passo di Olivi è “prima gratia” che esclude ogni merito precedente essendo “tamquam principium et caus<a> meriti”, si può osservare che in Par. XXV, 67-70 la speranza è prodotta “da grazia divina e precedente merto”, e questa è verità che deriva a Dante da molte stelle, cioè da molte scritture (il tema della “stella matutina” che predica e mostra). In questo caso la definizione della speranza ricalca quella data da Pietro Lombardo, “veniens ex Dei gratia et ex meritis praecedentibus” (Sent. III, xxvi, 1). Il merito è “precedente” rispetto alla cosa aspettata, ma l’habitus spei è dato gratuitamente da Dio senza precedente merito (cfr. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, IIa IIe, qu. 17, a. 1, resp. ad secundum).
Nel caso degli angeli, Beatrice, in Par. XXVIII, 112-113, afferma che la misura del vedere è proporzionata al merito, prodotto dalla grazia e dalla volontà buona da questa suscitata. Principio identico a quanto contenuto nell’esegesi di Ap 22, 17 (la prima grazia è data gratuitamente ma, come l’acqua di chi ha sete, ad essa si deve venire “per desiderium et voluntarium consensum”, deve cioè essere accettata) e ribadito nel canto successivo (Par. XXIX, 61-66), dove la donna dà per certo che gli angeli buoni, che con umiltà riconobbero il proprio essere dalla bontà di Dio, ebbero la loro capacità di vederlo esaltata per effetto della grazia illuminante e del loro merito, in modo che essi ora posseggono una piena e ferma volontà. La grazia, come intese Benvenuto, “fuit praedestinata meritis”, fu cioè causa del merito, non il merito (nel caso la fedeltà degli angeli) causa della grazia.
Anche Salomone, in Par. XIV, 37-51, sostiene che la visione dei beati è tanta quanta è la grazia che si aggiunge “sovra suo valore”, cioè al merito di ciascuno. Dopo la resurrezione dei corpi, quando la persona sarà più grata per il fatto di essere tutta quanta, anima e corpo (è la grazia che ci rende grati a Dio, di cui ad Ap 1, 4), ci sarà un aumento della prima grazia data gratuitamente e quindi una crescita della visione, e in conseguenza una crescita dell’ardore di carità che da quella si accende e della luce che dalla carità proviene.
Questioni ampiamente discusse nelle scuole, come quella della grazia infusa negli angeli o della visione dei beati dopo la resurrezione, sono affrontate da Dante concordando la soluzione, talora sfumandola, con un testo di teologia della storia. Ciò mostra come la Lectura non sia una nuova fonte di Dante che si presenta come principale rispetto a quelle già conosciute. Essa è il ‘libro’ della storia delle illuminazioni sapienziali con cui tutto deve concordare. Virgilio, Ovidio o Lucano, Boezio, Aristotele, Pietro Lombardo, Alberto Magno o Tommaso d’Aquino, la stessa Scrittura in quanto tale, le più svariate esperienze poetiche o le conoscenze di astronomia, sono, nel poema, tutte fonti ordinate alla Lectura.
■ Altro esempio dell’invito d’amore è Tommaso d’Aquino prima di iniziare il suo discorso in Par. XIII (vv. 34-36). Della sua “infiammata cortesia” dice Bonaventura, il maestro di Olivi, accostando ad essa il verbo ‘venire’ (“di cui Tomma / dinanzi al mio venir fu sì cortese”): la liberalità di Tommaso, nel lodare Francesco “poverel di Dio”, ha fatto ‘venire’ con desiderio, ha cioè aperto l’affetto e la volontà di Bonaventura nel dire di Domenico (Par. XII, 109-111, 142-145; cfr. il rivolgersi di Dante ad Adamo a Par. XXVI, 95-96). È il “libero amore” che il poeta riscontra in Pier Damiani, sola anima predestinata dalla grazia divina all’ufficio di scendere i gradini della “scala santa” per far festa a Dante col suo parlare e risplendere (Par. XXI, 73-78).
■ Cortesia, in quanto volontà che s’apre e viene, non è estranea al duro e lapideo mondo infernale. Dice Virgilio dei tre sodomiti fiorentini sotto la pioggia di fuoco: “a costor si vuole esser cortese”, e nel successivo colloquio essa riaffiora nel ricordo di una vita cittadina ormai estinta: “cortesia e valor dì se dimora / ne la nostra città sì come suole, / o se del tutto se n’è gita fora” (Inf. XVI, 15, 67-69: il liberale invito dello Spirito di Cristo è alla cena della città beata). È un segno di come, nell’amarezza dell’esilio, il poeta sempre ami un’idea della sua Firenze, patria di degni cittadini “ch’a ben far puoser li ’ngegni” (Inf. VI, 81). Come sarebbe stato un giorno per Savonarola, che ne fustigò i vizi, Firenze è l’eletta e diletta città, nuova Gerusalemme santa e pacifica.
La cortese apertura della volontà è negata a frate Alberigo che l’aveva sollecitata: «“E perché tu più volontier mi rade / le ’nvetrïate lagrime dal volto … Ma distendi oggimai in qua la mano; / aprimi li occhi”. E io non gliel’ apersi; / e cortesia fu lui esser villano» (Inf. XXXIII, 127-129, 148-150).
■ Nel purgatorio, che è il regno della ‘gentilità’, venire e cortesia sono propri dell’angelo portiere (Purg. IX, 91-93; cfr. V, 66, 70). Desiderio, volere e liberalità percorrono l’incontro con Arnaut Daniel: «e dissi ch’al suo nome il mio disire / apparecchiava grazïoso loco. / El cominciò liberamente a dire: / “Tan m’abellis vostre cortes deman, / qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire”» (Purg. XXVI, 137-141). Liberalità, carità, adesione volontaria sono temi riassunti nelle celebri parole di Guido del Duca: “le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi / che ne ’nvogliava amore e cortesia / là dove i cuor son fatti sì malvagi” (Purg. XIV, 109-111).
■ All’inizio e al termine del viaggio sta la “donna … gentil nel ciel” – unica donna, con Matelda (Purg. XXXIII, 130), fregiata di tale appellativo -, cioè la Vergine madre nella quale si assomma ogni liberalità: “La tua benignità non pur soccorre / a chi domanda, ma molte fïate / liberamente al dimandar precorre” (Inf. II, 94-96; Par. XXXIII, 16-18; cfr. infra).
Nel suo lungo sperimentare i significati della “gentilezza”, Dante l’ha infine affrontata con la liberalità dello Spirito di Cristo, di cui tratta un passo della teologia della storia che egli ha deciso di parodiare trasformandola nel suo “poema sacro”. Quanto acquisito nel corso delle prime prove, dalla Vita Nova alla canzone Le dolci rime e al suo commento nel IV trattato del Convivio non si è perduto, si è arricchito di un valore non solo teologico ma anche storico. L’Etica aristotelica non è più giustapposta alla teologia come nel Convivio, è inserita in un processo storico, dell’individuo e dell’umanità, che la rende presente ad ogni momento del viaggio. La parola “cortesia”, che ricorre nel poema, è certamente carica del significato aristotelico di “vertute”, quella “che fa l’uom felice / in sua operazione” (Le dolci rime, 83-84). La metamorfosi semantica della Lectura dell’Olivi rende sacro quel significato, diffonde sul mondo umano le prerogative divine assegnate alla Chiesa nella sua storia e mostra quanto alto sia stato in Dante lo sforzo di concordare Aristotele con i testi sacri [3].
■ L’episodio di Francesca registra i temi del secondo stato come prevalenti, ma il contrappunto con i temi del sesto stato è tanto intenso da imprimere il suggello nei momenti salienti del dramma.
Alla chiesa di Filadelfia, la sesta, Cristo promette di far venire quelli che si dicono Giudei senza esserlo, mutati nel cuore e disposti a farsi battezzare e governare (Ap 3, 9). Il venire dei due “cognati” al richiamo del poeta è un momento di mutazione, sebbene limitata al momento del colloquio (Inf. V, 76-87). È un venire suggerito da Virgilio: «Ed elli a me: “Vedrai quando saranno / più presso a noi; e tu allor li priega / per quello amor che i mena, ed ei verranno”».
È un venire con desiderio, quello che nasce dall’invito dello Spirito. L’appello di Dante – “O anime affannate, / venite a noi parlar, s’altri nol niega!” – è tessuto sui temi, sopra considerati, offerti da Ap 22, 17, dove lo “sposo” (Cristo e il suo Spirito) e la “sposa” (la Chiesa, nelle sue varie forme) invitano, dicendo “Vieni”, alla gloriosa cena delle nozze dell’Agnello e alla città beata. Poi è Cristo stesso a invitare con liberalità dicendo: “Chi ha sete venga, e chi vuole riceva gratuitamente l’acqua della vita”, cioè la grazia che ristora, vivifica e conduce alla vita eterna. Dice “chi ha sete e chi vuole” perché nessuno può venire senza che ci sia desiderio e volontario consenso. Così le due anime, “quali colombe dal disio chiamate … vegnon per l’aere, dal voler portate”.
Il venire umile e devoto dei Giudei, nella loro conversione, al vescovo di Filadelfia è quello di Dante all’angelo portinaio del purgatorio (Ap 3, 9).
Far venire a sé da parte di Cristo è tema proprio di altri passi dell’Apocalisse. Nel capitolo XV, ‘radice’ proemiale della quinta visione delle coppe, i santi che hanno vinto la bestia e che stanno dritti sul mare di cristallo misto a fuoco cantano sia il cantico di Mosè, proprio di servi che temono i giudizi divini, sia il cantico dell’Agnello, del quale lodano le opere di misericordia, fra le quali è il far venire, chiamandole, tutte le genti (Ap 15, 3-4; cfr. anche altrove). Così quei due, “quali colombe dal disio chiamate”.
Ogni stato, sostiene Olivi, ha qualcosa degli altri, dunque anche del sesto, che è lo stato cristiforme per eccellenza, coincidente con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Il richiamo di Dante ai due dannati perché parlino equivale ad un invito a convivare. Venire “quali colombe … dal voler portate” può essere riferito sia all’“apertio voluntatis” propria della sesta chiesa (Ap 3, 8), sia al rispondere all’invito di Ap 22, 17 con desiderio e volontario consenso. Al sesto stato è data la porta aperta al parlare. Così Francesca vuole venire e parla: “Di quel che udire e che parlar vi piace, / noi udiremo e parleremo a voi” (Inf. V, 94-95).
Ancora, come ogni stato, e quindi ogni momento della storia umana, ha una sua “quietatio”, una pausa di pace, di quiete, di silenzio propria del settimo e ultimo degli stati, così Francesca parla e ascolta “mentre che ’l vento, come fa, ci tace” (cfr. infra, tab. 6.3 e nota). Il vento – “la bufera infernal, che mai non resta” – designa il fluttuare tempestoso delle passioni nel cuore. La seconda tromba, quella del periodo dei martiri, suona contro gli eccessi dell’amore dei Gentili che produce gli ansiosi flutti delle cure e delle sollecitudini, come contro un mare in tempesta (cap. XI). “Quello amor che i mena”, per un attimo attratto nella sfera dello Spirito dalla “summa caritas Christi et summe gratuita et liberalis” impersonata da Dante (e anche da Virgilio, la cui voce esteriore suggerisce al discepolo ciò che deve fare), è pena data in eterno al disordinato amor sui e ai suoi eccessi.
Ma nel momento in cui il vento “piega” i due dannati verso i poeti, in modo che Dante possa pregarli e farli venire, quella bufera è anche il vento dello Spirito, di cui dice Ezechiele citato nell’esegesi dell’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 1): “vieni dai quattro venti, Spirito, e soffia su questi morti, perché rivivano” (Ez 37, 9). Dei quattro venti, è il quarto, quello della meridiana carità, che liberalmente invita a venire. È lo Spirito ad eccitare l’attenzione dei vescovi delle sette chiese d’Asia, che Cristo visita per mezzo delle istruzioni scritte loro da Giovanni, dicendo: “Chi ha orecchio ascolti”, cioè comprenda affettuosamente e operosamente, “ciò che lo Spirito dice alle chiese” (Ap 2, 7). Allo stesso modo il poeta va “visitando … per l’aere perso”, e fa venire con “affettüoso grido” (Inf. V, 87, 89-90).
[1] Su Virgilio come “voce esteriore”, appropriata al Cristo uomo, che lascia nell’Eden per Beatrice, la “voce interiore” assimilata allo Spirito di Cristo cfr. l’esegesi di Ap 2, 7.
[2] Fu la “femminetta samaritana” a domandare, e dunque a desiderare e a volere, la grazia dell’acqua che sazia eternamente (Purg. XXI, 1-3). Il riferimento dell’espressione “il mio disio e ’l velle” ad Ap 22, 17 (venire su invito, con desiderio e con volontario consenso) sembra prestare argomento a quanti (cfr. A. M. CHIAVACCI LEONARDI, Paradiso, Milano 2007 p. 929) ritengono che i due termini siano da rapportare non all’intelletto (il desiderio di conoscere) e alla volontà (l’amore per il bene), come nel caso di Par. XV, 73-84 (“L’affetto e ’l senno … Ma voglia e argomento”), bensì all’uguaglianza del volere istintivo con il volere razionale. Ciò sembra confermato dal caso di Francesca e Paolo: “Quali colombe dal disio chiamate … vegnon per l’aere, dal voler portate” (Inf. V, 82-84).
[3] Sulla nobiltà di cui tanta gente erroneamente parla, che è grazia che discende da Dio, “appo cui non è scelta di persone, sì come le divine Scritture manifestano” (Convivio, IV, xx, 3-6) cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, 3. Sulla presenza dell’etica cortese nella teologia dell’Olivi cfr. A. CICERI in Petri Iohannis Olivi Quaestiones circa matrimonium, Ad Claras Aquas, Grottaferrata, 2001 (Collectio Oliviana, III), pp. 396-401.
Tab. 6.1
Purg. XII, 88-94, 99A noi venìa la creatura bella,
|
Par. XXXII, 106-108Così ricorsi ancora a la dottrina
|
|
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 16-17 (finalis conclusio totius libri)] “Sum” etiam “stella splendida” (Ap 22, 16), omnium scilicet sanctorum illuminatrix, “et matutina”, future scilicet et eterne diei immensam claritatem predicando et promittendo et tandem prebendo, et etiam prout fui homo mortalis ipsam precurrendo, ut ipse secundum quod homo sit stella et secundum quod Deus sit sol.
|
||
|
|
||
Inf. V, 73-87I’ cominciai: “Poeta, volontieri
|
Inf. XIII, 85-87
Perciò ricominciò: “Se l’om ti faccia
liberamente ciò che ’l tuo dir priega,
spirito incarcerato, ancor ti piaccia …”
Inf. XVI, 13-15, 64-69
A le lor grida il mio dottor s’attese;
volse ’l viso ver’ me, e “Or aspetta”,
disse, “a costor si vuole esser cortese”.
“Se lungamente l’anima conduca
le membra tue”, rispuose quelli ancora,
“e se la fama tua dopo te luca,
cortesia e valor dì se dimora
ne la nostra città sì come suole,
o se del tutto se n’è gita fora …”
Inf. XXXIII, 127-129, 148-150
“E perché tu più volontier mi rade
le ’nvetrïate lagrime dal volto,
sappie che, tosto che l’anima trade …”
“Ma distendi oggimai in qua la mano;
aprimi li occhi”. E io non gliel’ apersi;
e cortesia fu lui esser villano.
Par. XII, 109-111, 142-145; XIII, 34-36
ben ti dovrebbe assai esser palese
l’eccellenza de l’altra, di cui Tomma
dinanzi al mio venir fu sì cortese.
Ad inveggiar cotanto paladino
mi mosse l’infiammata cortesia
di fra Tommaso e ’l discreto latino;
e mosse meco questa compagnia.
e disse: “Quando l’una paglia è trita,
quando la sua semenza è già riposta,
a batter l’altra dolce amor m’invita”.
Purg. V, 64-72
E uno incominciò: “Ciasun si fida
del beneficio tuo sanza giurarlo,
pur che ’l voler nonpossa non ricida.
Ond’ io, che solo innanzi a li altri parlo,
ti priego, se mai vedi quel paese
che siede tra Romagna e quel di Carlo,
che tu mi sie di tuoi prieghi cortese
in Fano, sì che ben per me s’adori
pur ch’i’ possa purgar le gravi offese”.
Purg. IX, 91-93
“Ed ella i passi vostri in bene avanzi”,
ricominciò il cortese portinaio:
“Venite dunque a’ nostri gradi innanzi”.
Purg. XXVI, 136-147
Io mi fei al mostrato innanzi un poco,
e dissi ch’al suo nome il mio disire
apparecchiava grazïoso loco.
El cominciò liberamente a dire:
“Tan m’abellis vostre cortes deman,
qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.
Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
consiros vei la passada folor,
e vei jausen lo joi qu’esper, denan.
Ara vos prec, per aquella valor
que vos guida al som de l’escalina,
sovenha vos a temps de ma dolor!”.
Par. XXI, 73-78
“Io veggio ben”, diss’ io, “sacra lucerna,
come libero amore in questa corte
basta a seguir la provedenza etterna;
ma questo è quel ch’a cerner mi par forte,
perché predestinata fosti sola
a questo officio tra le tue consorte”.
Purg. XIV, 109-111
le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi
che ne ’nvogliava amore e cortesia
là dove i cuor son fatti sì malvagi.
Par. XXVI, 91-96
E cominciai: “O pomo che maturo
solo prodotto fosti, o padre antico
a cui ciascuna sposa è figlia e nuro,
divoto quanto posso a te supplìco
perché mi parli: tu vedi mia voglia,
e per udirti tosto non la dico”.
Tab. 6.2
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (VIa ecclesia)] Sexta (ecclesia) autem dicitur habere hostium scripturarum <ac> predicationis et cordium convertendorumapertum (cfr. Ap 3, 8), et quod Iudei debent ad eam cum summa humilitate adduci, et quod est servanda ne cadat in temptationem toti orbi venturam, quia Dei consilia et mandata longanimiter et patienter servavit, que utique competunt statui sexto. Unde et congrue vocatur Philadelphia, id est salvans hereditatem, quia in regula evangelica, quasi in archa Noe, salvabitur semen fidei et electorum a diluvio Antichristi tam mistici quam aperti.[LSA, cap. III, Ap 3, 12 (VIa victoria)] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et transformationem mentis in ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. […] |
||
[LSA, cap. XV, Ap 15, 2-4 (Va visio, radix)] Unde subditur: “(Ap 15, 2) Habentes citharas Dei (Ap 15, 3) et cantantes canticum Moysi servi Dei et canticum Agni”. Canticum utriusque in hoc convenit, quod uterque cantavit de pia liberatione electorum et de terribili submersione seu perditione hostium. Differunt autem in hoc, quod canticum Moysi fuit sicut servi, cuius est timere Dominum terribilem in iudiciis; canticum vero Agni fuit vere filii mitissimi, cuius est filialiter amare patrem et consequi eius hereditatem. Ergo isti cantant simul canticum timoris ut servi et amoris ut filii, et hoc ipsum patet ex materia cantici eorum, unde subditur: “dicentes: Magna”, scilicet in se, “et mirabilia”, scilicet contemplantibus, “sunt opera tua, Domine Deus omnipotens”. Pro operibus autem seu iudiciis iustitie, subdunt: “Iuste et vere vie tue”, id est opera tua, “rex seculorum. (Ap 15, 4) Quis non timebit te, Domine, et magnificabit nomen tuum?”. Pro operibus vero misericordie, subdunt: “Quia solus pius es”, scilicet per se et substantialiter et summe; “quoniam omnes gentes venient”, scilicet ad te tamquam a te misericorditer vocate et tracte, “et adorabunt in conspectu tuo, quoniam iudicia tua manifesta sunt”, scilicet per evidentes effectus perditionis Antichristi et suorum et salvationis electorum.
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 7.9 (Ia visio, VIa ecclesia)] Hiis autem, sicut et in ceteris, premittitur preceptum scribendi hec huic ecclesie et introductio Christi sibi hec dicentis, cum subditur: “Hec dicit sanctus” (Ap 3, 7). Quia hunc episcopum commendat tamquam singulariter sanctum et sibi dilectum, ideo proponit se ei ut sanctum, supple, supersubstantialiter et fontaliter tamquam primam et summam causam omnis sanctitatis omnium sanctorum. […]
|
|
Purg. IX, 61-63, 91-94, 106-111, 127-131Qui ti posò, ma pria mi dimostraro
|
Purg. XXXII, 106-108Così Beatrice; e io, che tutto ai piedi
|
|
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 17 (finalis conclusio totius libri)] Septimo loquitur ut invitator omnium ad prefatam gloriam, et hoc tam per se quam per ecclesiam et eius doctores, unde subdit: “Et sponsus”, id est, secundum Ricardum, Christus (quidam tamen habent “Spiritus”, et quidam correctores dicunt quod sic habent antiqui et Greci, ut sic Christus tam per se quam per Spiritum suum et eius internam inspirationem ostendat se invitare), “et sponsa”, id est generalis ecclesia tam beata quam peregrinans vel contemplativa ecclesia, “dicunt: veni”, scilicet ad nuptias. Ideo enim dixit “sponsa”, ut innueret nos invitari ad gloriosam cenam nuptiarum Agni. “Et qui audit”, scilicet hanc nostram invitationem, id est qui est de hiis sufficienter doctus; vel “qui audit”, id est recte et obedienter credit et opere perficit, “dicat”, scilicet unicuique vocandorum: “veni”, scilicet ad cenam et civitatem beatam. Deinde ipse Christus per se liberaliter invitat et offert, dicens: “Et qui sitit veniat, et qui vult accipiat aquam vite gratis”. Quia nullus cogitur nec potest venire nisi per desiderium et voluntarium consensum, ideo dicit “qui sitit et qui vult”. Idem autem est venire quod accipere “aquam vite”, id est gratiam vite refectivam et vivificam et perducentem in vitam eternam. Dicit autem “gratis”, tum quia absque omni pretio venali et exteriori datur et accipitur, tum quia prima gratia datur absque omni previo merito et tamquam principium et caus<a> meriti, ac per consequens totum premium et augmentum gratie quod per primam gratiam acquiritur gratia reputatur. Dicit etiam “gratis”, quia tota a summa caritate Christi et summe gratuita et liberali predestinatur et offertur et datur. |
||
Tab. 6.3
Par. I, 94-99S’io fui del primo dubbio disvestito
|
Par. XXVIII, 31-33, 64-66Sopra seguiva il settimo sì sparto
|
|
[LSA, prologus, Notabile I] Septimus vero (status), prout spectat ad vitam istam, est quedam quieta et mira participatio future glorie ac si celestis Iherusalem videatur descendisse in terra<m>; prout tamen spectat ad aliam vitam, est status generalis resurrectionis et glorificationis sanctorum et finalis consumationis omnium.[LSA, prologus, Notabile III] De septimo (dono) etiam patet, quia in quolibet septem statuum predictorum est aliqua quietatio spiritus in Deo et aliquis gustus Dei. […] Item quilibet statuum predictorum habuit aliquam pacem post sue adversitatis noctem, ut ex “vespere et mane” fieret “dies unus” (cfr. Gn 1, 5). […]
|
||
Inf. I, 58-60tal mi fece la bestia sanza pace,
|
||
Inf. V, 91-96se fosse amico il re de l’universo,
|
Inf. III, 45; XIII, 55-57, 79-81, 93
Rispuose: “Dicerolti molto breve”.
E ’l tronco: “Sì col dolce dir m’adeschi,
ch’i’ non posso tacere; e voi non gravi
perch’ ïo un poco a ragionar m’inveschi”.
Un poco attese, e poi “Da ch’el si tace”,
disse ’l poeta a me, “non perder l’ora;
ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace”.
Brievemente sarà risposto a voi.
Inf. XV, 103-105; XVII, 40-45
Ed elli a me: “Saper d’alcuno è buono;
de li altri fia laudabile tacerci,
ché ’l tempo saria corto a tanto suono”.
“Li tuoi ragionamenti sian là corti;
mentre che torni, parlerò con questa,
che ne conceda i suoi omeri forti”.
Così ancor su per la strema testa
di quel settimo cerchio tutto solo
andai, dove sedea la gente mesta.
Inf. XXXII, 109-114
“Omai”, diss’ io, “non vo’ che più favelle,
malvagio traditor; ch’a la tua onta
io porterò di te vere novelle”.
“Va via”, rispuose, “e ciò che tu vuoi conta;
ma non tacer, se tu di qua entro eschi,
di quel ch’ebbe or così la lingua pronta”.
Inf. XXXIV, 103-105
ov’ è la ghiaccia? e questi com’ è fitto
sì sottosopra? e come, in sì poc’ ora,
da sera a mane ha fatto il sol tragitto?
Purg. X, 34-39
L’angel che venne in terra col decreto
de la molt’ anni lagrimata pace,
ch’aperse il ciel del suo lungo divieto,
dinanzi a noi pareva sì verace
quivi intagliato in un atto soave,
che non sembiava imagine che tace.
Purg. XXVI, 31-33, 52-54, 88-90
Lì veggio d’ogne parte farsi presta
ciascun’ ombra e basciarsi una con una
sanza restar, contente a brieve festa
Io, che due volte avea visto lor grato,
incominciai: “O anime sicure
d’aver, quando che sia, di pace stato”
Or sai nostri atti e di che fummo rei:
se forse a nome vuo’ saper chi semo,
tempo non è di dire, e non saprei.
Purg. XXVII, 25-27, 76-84
Credi per certo che se dentro a l’alvo
di questa fiamma stessi ben mille anni,
non ti potrebbe far d’un capel calvo.
Quali si stanno ruminando manse
le capre, state rapide e proterve
sovra le cime avante che sien pranse,
tacite a l’ombra, mentre che ’l sol ferve,
guardate dal pastor, che ’n su la verga
poggiato s’è e lor di posa serve;
e quale il mandrïan che fori alberga,
lungo il pecuglio suo queto pernotta,
guardando perché fiera non lo sperga
Inf. XXIII, 85-87; XXIV, 34-36; XXV, 4-6, 16-18, 94-99
Quando fuor giunti, assai con l’occhio bieco
mi rimiraron sanza far parola;
poi si volsero in sé, e dicean seco
E se non fosse che da quel precinto
più che da l’altro era la costa corta,
non so di lui, ma io sarei ben vinto.
Da indi in qua mi fuor le serpi amiche,
perch’ una li s’avvolse allora al collo,
come dicesse ‘Non vo’ che più diche’
El si fuggì che non parlò più verbo;
e io vidi un centauro pien di rabbia
venir chiamando: “Ov’ è, ov’ è l’acerbo?”.
Taccia Lucano omai là dov’ e’ tocca
del misero Sabello e di Nasidio,
e attenda a udir quel ch’or si scocca.
Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio,
ché se quello in serpente e quella in fonte
converte poetando, io non lo ’nvidio
Inf. XXVII, 1-3
Già era dritta in sù la fiamma e queta
per non dir più, e già da noi sen gia
con la licenza del dolce poeta
Nota alla Tab. 6.3
“mentre che ’l vento, come fa, ci tace” (Inf. V, 96).
■ I temi principali del settimo stato sono la brevità, la quiete, la pace, il silenzio.
Il settimo stato ha principalmente ad oggetto la settima visione apocalittica, che descrive la Gerusalemme celeste (capp. XX-XXII). Si distingue però da essa: le precedenti sei visioni sono infatti divisibili in sette stati (dove il settimo stato della Chiesa ha una sua autonomia), mentre la settima non lo è. Ciò sia perché la settima visione riguarda soprattutto la gloria finale dei beati, nella quale non ci sarà una successione di stati (cioè di periodi storici) come in questa vita; sia perché tale gloria, comprendendo in sé, in somma unità e ridondanza, le perfezioni di tutti gli stati, non si distingue secondo gli stretti e imperfetti limiti di questa vita. Da un punto di vista temporale, il settimo stato è caratterizzato dalla brevità e dalla uniformità. Infatti, all’apertura del settimo sigillo è fatto silenzio per mezz’ora (Ap 8, 1; nel Notabile XI del prologo il silenzio è connesso con il glorioso ritorno in Asia di san Giovanni dopo l’esilio in Patmos); al suono della settima tromba è detto brevemente “factum est regnum huius mundi Domini nostri” (Ap 11, 15) e nel versare la settima coppa si dice solo “factum est” (Ap 16, 17). Però la settima visione coincide in parte con il settimo stato in quanto questo designa la quiete delle anime sante dopo la morte, dopo le tante pressure intervenute nei primi sei stati: se infatti si fa iniziare la settima visione con il XX capitolo, essa comincia con l’incarcerazione di Satana per mille anni, i quali non vengono distinti secondo i vari stati per designare l’uniformità della grazia spirituale e della pace data alla Chiesa dal suo inizio fino a Gog che verrà per ultimo (prologo, Notabile III).
La soavità e la pace del settimo stato corrispondono al sacramento dell’estrema unzione. Come il settimo giorno della creazione, il settimo stato, dedito al riposo, è libero da ogni fatica servile e fruisce della pace che trascende ogni sentimento (prologo, Notabile XIII).
Pertanto il settimo stato dell’Olivi si realizza parte in questa vita (come pregustazione in terra della gloria eterna, cioè fin sulla cima della montagna) e in parte nella futura (nel senso della quiete delle anime beate in attesa della resurrezione, che è la materia del Paradiso; cfr. Topografia spirituale della Commedia [PDF; introduzione in html]).
■ Il tema degli stretti (“arcti”) e imperfetti limiti di questa vita è riferito parzialmente, in Par. XXVIII, 64-66, ai cieli materiali – “Li cerchi corporai sono ampi e arti” – e, con diversa appropriazione, anche al settimo dei cerchi che girano intorno al punto luminosissimo designanti le intelligenze angeliche (vv. 31-33). A differenza delle sfere materiali dei cieli, che sono tanto più veloci e di maggior diametro quanto più si allontanano dal loro centro geometrico costituito dalla terra, i cerchi che rappresentano le gerarchie angeliche sono tanto più veloci e di diametro più stretto (cioè più brevi) quanto più sono vicine al punto, cioè a Dio. Il cerchio che designa la settima gerarchia angelica (i Principati: corrispondono al cielo di Venere) è dunque “sì sparto / già di larghezza, che ’l messo di Iuno / intero a contenerlo sarebbe arto”, cioè l’arcobaleno o iride (che designa i limiti di questa vita) sarebbe stretto contenitore (l’iride ha sette colori, come sono sette gli stati: cfr. Purg. XXIX, 76-78).
Il tema della brevità, congiunto con quello del silenzio, si trasforma nel breve parlare (esempi in Inf. III, 45 e XIII, 79-80, 93, dove l’espressione di Virgilio richiama il silenzio e il breve tempo in apertura del settimo sigillo: «Dicerolti molto breve … Da ch’el si tace … non perder l’ora … Brievemente sarà risposto a voi – brevis respectu priorum temporum … in apertione septimi signaculi dicitur “factum” esse “silentium quasi media hora”»). Si aggiungono i motivi della “quieta et mira participatio future glorie” in Par. I, 94-99, allorché il poeta si acqueta – “requïevi” – “per le sorrise parolette brevi” di Beatrice e non cessa tuttavia di ammirare, irretito da un nuovo dubbio (cfr. Par. XXX, 52-57).
Il parlare deve essere breve con gli usurai, “su per la strema testa / di quel settimo cerchio” (Inf. XVII, 40-45). Tacere per corto tempo è stato anche, in precedenza, nel parlare di Brunetto Latini (Inf. XV, 104-105; la zona dei sodomiti afferisce al quinto stato). La “strema testa” contiene in sé anche un riferimento all’“unctio extrema”, appropriato a un luogo dove non può esserci soavità e pace. La tematica del settimo sacramento è ancora utilizzata più avanti, in modo beffardo, nella terza bolgia.
Nel settimo e ultimo girone del purgatorio le anime delle due schiere dei lussuriosi si fanno festa brevemente, senza fermarsi (Purg. XXVI, 31-33, da rilevare il motivo della pace al v. 54 e, al v. 90, quello del silenzio nelle parole di Guinizzelli: “tempo non è di dire, e non saprei”). Più avanti, allorché Dante è renitente a mettersi nel muro di fuoco, Virgilio usa il tema dei mille anni nei quali Satana sta incarcerato e i santi hanno pace nella mente con Cristo per spiegare al discepolo che, anche se stesse nella fiamma per mille anni, non ne avrebbe danno alcuno (Purg. XXVII, 25-27). Ancor più avanti, il silenzio (le “capre … tacite a l’ombra”) e la quiete (del pastore) segnano l’ultima notte trascorsa in terra (vv. 76-87).
■ La rima “pace / tace”, si registra in opposte variazioni a Inf. I, 58/60 (la lupa, “bestia sanza pace”, respinge Dante nella selva, “là dove ’l sol tace”, dove cioè tace Cristo, “sol mundi”) e a Purg. X, 35/39 (l’angelo dell’annunciazione). Come ogni stato, e quindi ogni momento della storia umana, ha una sua “quietatio”, una pausa di pace, di quiete, di silenzio propria del settimo e ultimo degli stati, così Francesca parla e ascolta “mentre che ’l vento, come fa, ci tace”, per quanto dalla sua terra, Ravenna, la pace sia stata tolta (Inf. V, 92/96; cfr. supra).
7. L’impossibile schiera degli amici di Dio
“cotali uscir de la schiera ov’ è Dido” (Inf. V, 85; tab. 7.1).
L’angelo del sesto sigillo (Ap 7, 2) rimuove un impedimento (i quattro angeli nocivi che tengono i quattro venti: Ap 7, 1), dopo di che il segno è posto sulla fronte, non vergognosa e gravata di viltà ma liberamente magnanima, degli eletti amici di Dio, difensori della fede fino al martirio da lui conosciuti per nome e ascritti alla più alta milizia dei baroni, dei decurioni, dei cavalieri che si distingue da quella volgare dei fanti. Costoro, configurati in Cristo crocifisso, designati dai 144.000 segnati eletti dalle dodici tribù d’Israele (Ap 7, 3-6), guidano la “turba magna, quam dinumerare nemo poterat” dei fedeli al trono dell’Agnello attraverso le grandi tribolazioni (Ap 7, 13-17).
Fra gli scritti di “direzione spirituale” di Olivi, il Miles armatus è un manuale per sfuggire i lacci e i pericoli degli ultimi tempi, nel quale i generosi cavalieri devono prepararsi al combattimento prima che, all’imminente apertura del sesto sigillo, il sole e la luna si oscurino, le stelle cadano dal cielo, un violento terremoto faccia muovere monti e isole, secondo quanto scritto dal frate provenzale nel 1295 ai figli di Carlo II d’Angiò prigionieri degli Aragonesi [1]. Espressione significativa dell’assunzione da parte della spiritualità francescana dell’allegoria militare, forse anche per un’influenza degli scritti di materia tattico-strategica del tempo [2], il Miles armatus sarà ripreso, in tutt’altro contesto storico e spirituale, da Bernardino da Siena nel De pugna et saccomanno Paradisi sive caelestis Jerusalem [3].
Questa esegesi, nella quale il sesto stato corrisponde agli ultimi sei anni della costruzione del Tempio dopo la cattività in Babilonia, è una sacra sinfonia militare i cui temi trascorrono in più luoghi: dalla “signatio” poetica di Dante, amico di Beatrice e “sesto tra cotanto senno” nella schiera dei sommi poeti del Limbo, alla “signatio” apostolica nell’esame sulle virtù teologali di fronte a Pietro, Giacomo e Giovanni; dall’impossibile amicizia con Dio di Francesca e Paolo (anch’essi in una schiera) alle famiglie fiorentine, menzionate da Cacciaguida, le quali portano la “bella insegna” del marchese Ugo di Toscana, assunte a una milizia più alta rispetto a Giano della Bella, l’autore dei famosi Ordinamenti di giustizia (1293) anch’egli di essa insignito (la quale “fascia col fregio”) ma che oggi si raduna col popolo, corrispondente alla volgare e pedestre milizia che viene dopo i segnati. Questi eletti ‘sesti’ amati da Dio sono lo sviluppo sacro di coloro (De vulgari eloquentia, II, iv, 10-11) che Virgilio, nel sesto dell’Eneide, definisce “Dei dilectos”, i poeti tragici innalzati al cielo per ardente virtù (Aen., VI, 129-131: “Pauci, quos aequus amavit / Iuppiter”), designati dall’“astripeta aquila”. La lettura dell’esegesi dell’angelo del sesto sigillo (che si estende ben oltre la parte relativa alla “signatio”) forse segnò la decisione di fare il viaggio, ascrivendo la poesia, in tutti i suoi stili, a un’alta milizia.
Qui di seguito sono riportati solo alcuni esempi, tratti dalle tabelle che sono state descritte altrove nei singoli significati.
■ Il tema dell’amicizia divina contrapposto alla volgare milizia è presente nelle accorate parole con cui Lucia invita Beatrice a soccorrere Dante, “ch’uscì per te de la volgare schiera” dei poeti (Inf. II, 103-105), che la stessa Beatrice, rivolgendosi a Virgilio, definisce “l’amico mio, e non de la ventura” [v. 61; da notare, nello stesso canto (vv. 44-45), il contrasto tra il “magnanimo” Virgilio e la “viltade” da cui è offesa l’anima di Dante; a Inf. III, 52 l’insegna designa la viltà degli ignavi]. Virgilio che, mosso da Beatrice, rimuove l’“impedimento” frapposto dalla lupa a Dante nel salire il “dilettoso monte”, svolge in qualche modo la funzione dell’angelo del sesto sigillo. Il tema dell’amicizia è presente ancora nelle parole di Sapia senese, “spirito eletto”, cioè già salvo, che dice al poeta: «“Oh, questa è a udir sì cosa nuova”, / rispuose, “che gran segno è che Dio t’ami”» (Purg. XIII, 145-146). Non sarà casuale, poi, che Sapia, nel parlare secondo la Lectura super Apocalipsim, ricordi Pier Pettinaio, lo spirituale francescano che fu uditore a Santa Croce dell’Olivi con Ubertino da Casale (1287-1289), grazie alle cui preghiere la sua penitenza è stata abbreviata (vv. 127-129).
■ Il motivo della schiera, accompagnato dal numero corrispondente allo stato della Chiesa – il sesto, il “novum saeculum” che tanto s’aspetta – compare nel Limbo, allorché i cinque poeti (Omero, Orazio, Ovidio, Lucano e Virgilio) ammettono Dante nella loro “schiera” (Inf. IV, 100-102). È il momento della “signatio” poetica di Dante, che si ritrova ad essere “sesto tra cotanto senno”, con tutto quello che comporta il significato, sia pur recondito, dell’essere sesto, secondo l’esegesi della Lectura: divenire depositario della sapienza passata, avere la porta aperta al parlare, rinnovare la fede e la vita evangelica (mettendo fuori le “nove rime”), sentire l’ordine interiore che spinge a dire, essere conformi a Cristo e fedeli al Verbo (le “penne” vanno strette ad Amore, interno “dittator” che “spira”, elemento di distinzione del “dolce stil novo” dalla vecchia poetica, come riconosciuto da Bonagiunta nel ‘sesto’ girone del purgatorio).
■ L’amicizia di Dio e la schiera sono invece disgiunte nell’episodio di Francesca e Paolo. Le due anime affannate escono dalla “schiera” ov’è Didone, chiamate dall’affettuoso grido di Dante in luogo dove tace il vento (e pertanto a uno stato migliore, sia pur momentaneo, della precedente “bufera infernal, che mai non resta”), ma l’amicizia di Dio è solo ipotetica (“se fosse amico il re de l’universo”) nel desiderio di un’impossibile preghiera per la pace del poeta pietoso del loro male perverso (Inf. V, 85, 91-93).
■ Il tema della “signatio” sulla fronte degli eletti amici di Dio, difensori pubblici della fede, si mostra fin dal primo canto del poema, d’altronde percorso da molti motivi dell’apertura del sesto sigillo, nella “vergognosa fronte” con cui Dante risponde a Virgilio (Inf. I, 81; cfr. III, 79. Anche l’espressione di Virgilio al v. 129 – “oh felice colui cu’ ivi elegge!” – fa parte del gruppo tematico).
Farinata, il magnanimo difensore “a viso aperto” di Firenze contro quanti l’avrebbero voluta distruggere dopo Montaperti, “s’ergea col petto e con la fronte”. A suo modo, lo sdegnoso ghibellino ha vissuto un momento del sesto stato, predicando (senza esserne consapevole) la fede di Cristo. Firenze, anche se “nido di malizia tanta”, è infatti pur sempre il luogo dove sarebbe nato Dante, pianta in cui rivive la “sementa santa” dei Romani, come dice Brunetto Latini. Salvando Firenze, Farinata ha salvato il seme della fede (Inf. X, 35, 73, 93).
Il sole riluce “’n fronte” a Dante nel momento in cui, sulla soglia dell’Eden, Virgilio gli dice che il suo arbitrio è “libero, dritto e sano”, tale da poter essere assecondato senza guida (Purg. XXVII, 133, 139-140).
Nel girone dove si purgano i superbi, di Provenzan Salvani dice Oderisi da Gubbio che “quando vivea più glorïoso”, messa da parte ogni vergogna, liberamente si piantò a mendicare nel Campo di Siena per raccogliere il denaro necessario al riscatto dell’amico prigioniero di Carlo d’Angiò (Purg. XI, 133-138). Se deporre la viltà per la magnanimità appartiene al Cristo vittorioso che esce “in campo” all’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2), l’affiggersi “liberamente” è proprio dei segnati che all’apertura del sesto sigillo ricevono il sigillo di Dio sulla fronte, lì dove si mostra il segno dell’audacia e della strenuità o della pusillanimità e dell’inerzia, della gloria o della vergogna (Ap 7, 3: la fronte in questo caso non è citata, ma lo sono i motivi connessi). Lo stesso ‘stare fisso’ è una prerogativa della sesta vittoria (Ap 3, 12). Così il Campo di Siena fu per il Salvani, come per Cristo, luogo di vittoria: l’atto di umiltà, per il quale “si condusse a tremar per ogne vena”, tolse a colui che “fu presuntüoso / a recar Siena tutta a le sue mani” lo stare fuori dei gironi della montagna a purgare anche la negligenza della tardiva conversione.
“se fosse amico il re de l’universo, / noi pregheremmo lui de la tua pace” (Inf. V, 91-92; tab. 7.2).
■ La tribù di Simeone, la settima fra le dodici d’Israele da cui provengono i segnati all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 7), designa la devota preghiera che, sospirando e gemendo, impetra le grazie superne ed è degna di essere esaudita, oppure la pia condiscendenza della benigna commiserazione. Il nome viene pertanto interpretato come “ascolto” o “esaudibile” o “colui che ascolta il dolore”. Appartiene allo stato dei perfetti; è lo zelo che si manifesta nella “benigne miserationis pia condescensio”, che corrisponde a uno dei temi più importanti del quinto stato, la “pietas” che condiscende verso gli infermi, il “sensum vivum et tenerum pietatis” (prologo, Notabile XIII; con questi motivi viene presentato san Bernardo a Par. XXXI, 61-63).
Fra i vari luoghi del poema che ad essi si riferiscono, i temi della tribù Simeone sono in primo luogo propri di Beatrice: a lei Lucia si rivolge perché ascolti “la pieta” del pianto del suo amico, che poi soccorre “pietosa” (Inf. II, 106, 133); è lei ad ascoltare “sospirosa e pia” il salmo Deus, venerunt gentes cantato lacrimando dalle sette virtù dopo le visioni delle tribolazioni del carro della Chiesa militante (Purg. XXXIII, 4-6; i motivi sono appropriati a Dante a Purg. XX, 16-18), a trarre un “pio sospiro” alla domanda di Dante che non comprende come possa trascendere i corpi lievi (Par. I, 100-102). I temi si mescolano con quelli del quinto stato, momento in cui eccelle il senso vivo della pietà, ad esempio con il tema della pietà con cui la madre indulge al figlio (Ap 5, 1), che corrisponde a “quel sembiante / che madre fa sovra figlio deliro” con il quale Beatrice drizza gli occhi a Dante dopo il “pio sospiro”.
I motivi del discendere, della pietà, dell’ascoltare e del sospirare sono compresenti nel discendere “nel cieco mondo”, allorché il colore smorto del viso di Virgilio suscita preoccupazione in Dante che vede la sua guida impallidire, ma Virgilio lo rassicura che quello è il colore non della paura, ma della pietà per “l’angoscia de le genti / che son qua giù”. Subito all’ingresso del primo cerchio si ode un pianto fatto di sospiri, “che l’aura etterna facevan tremare” (Inf. IV, 13-27).
■ Per la pace del poeta, “animal grazïoso e benigno” pietoso del loro “mal perverso”, Francesca e Paolo pregherebbero Dio, se fosse loro amico (Inf. V, 88-93; l’aggettivo “grazioso”, che in Convivio IV, xxv, 1 è connesso con la cortesia, concorda con i motivi propri dello smeraldo, una delle dodici pietre a fondamento della città celeste, che ad Ap 21, 19 designa il grazioso contemperare della pietà e della misericordia). È Dante ad ascoltare il triste lamento: “Di quel che udire e che parlar vi piace, / noi udiremo e parleremo a voi” (vv. 94-95); “tristo e pio”, chiede a Francesca del “tempo d’i dolci sospiri” (vv. 116-118).
Quella che De Sanctis definiva “preghiera condizionata” – “non c’è la preghiera, ma c’è l’intenzione; ci è terra e inferno mescolati nell’anima di Francesca; una intenzione pia con linguaggio ed abitudine di persona ancora viva” [4] – è in studiata tensione con il verso 36: “bestemmian quivi la virtù divina” [5]. La durezza dell’inferno è rotta dall’invito di Dante ai dannati perché parlino. Far parlare liberamente, per dettato interiore, è la principale prerogativa del sesto stato – la nuova età che tanto s’aspetta, quella che ode del “dolce stil novo” e delle “nove rime” -, ed è tema che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo, anche nella vecchia roccia infernale. Appartiene alla sesta chiesa il parlare liberamente di Cristo – ad essa è dato l’“ostium apertum”, che è “ostium sermonis” –, la porta aperta al parlare, il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà. Appartiene alla sesta chiesa anche il far venire quelli che si dicono Giudei senza esserlo, mutati nel cuore e disposti a farsi battezzare e governare (Ap 3, 9). Questo far venire a parlare equivale all’invito dello Spirito di Cristo a convivare, a venire con desiderio e volontario consenso, con “disio” e con “velle”, in una pausa di pace nell’eterna dannazione (Ap 22, 17). All’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono “dal voler portate” verso un momento di mutazione, sebbene limitata al successivo colloquio. Tutto l’Inferno è un contrappunto fra la durezza del giudizio, le bestemmie dei peccatori e l’apertura al ricordo della vita per la parola dirompente, finché essa dura, la pena.
■ La tribù successiva, Levi, designa la speranza nei confronti della pietà e liberalità di Dio che elargisce al di là dei voti e meriti, al di là di quanto aspettiamo; Levi significa “aggiunto”. Se si congiungono le caratteristiche delle due tribù di Simeone e di Levi – benignità, misericordia, pietà da una parte e liberalità dall’altra -, si ottengono alcune delle prerogative della Vergine lodate nella preghiera di san Bernardo (Par. XXXIII, 16-19), la quale rientra nella tematica propria della tribù di Simeone in quanto orazione che impetra grazia e, poiché devota, grata ed esaudita (Par. XXXII, 147-148; XXXIII, 40-42). I motivi della benignità e della liberalità sono congiunti nella “cortesia del gran Lombardo / che ’n su la scala porta il santo uccello” a Par. XVII, 73-75.
Un esempio dell’andare oltre le speranze sta nella risposta del frate Catalano – “Più che tu non speri” – a Virgilio che gli chiede come uscire dalla sesta bolgia: il muoversi del gran sasso, rotto nel sesto ponte ma che consente la salita all’argine della settima bolgia, è tema che accompagna il terremoto in apertura del sesto sigillo (Inf. XXIII, 133-138).
[1] Cfr. PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Scritti scelti, a cura di P. VIAN, Roma 1989 (Fonti cristiane per il terzo millennio, 3), pp. 145-169: 166-169 (traduzione italiana de Il Cavaliere armato).
[2] Cfr. F. CARDINI, Nel nome di Gesù. Bernardino da Siena e la battaglia mistica, Città di Castello 2012, p. 41.
[3] S. BERNARDINI SENENSIS Ordinis Fratrum Minorum Opera omnia, vol. II, Ad Claras Aquas, Quaracchi, Florentiae, 1950, Quadragesimale de christiana religione, sermo LXVI, pp. 452-471.
[4] DE SANCTIS, Francesca da Rimini, p. 284.
[5] Il contrasto fra i due luoghi è sottolineato da G. INGLESE, in Dante Alighieri, Inferno. Revisione del testo e commento, Roma 2007, p. 88, nt. a v. 91.
Tab. 7.1
[LSA, cap. VII, Ap 7, 3-4 (apertio VIi sigilli)] Clamat ergo (Ap 7, 3): “Nolite”, id est non audeatis; vel si ad bonos angelos loquitur, dicit “nolite” quia, ex quo ipse prohibuit, non debuerunt velle; “nocere”, scilicet per effrenatam temptationem vel per predicationis et gratie impeditionem, “terre et mari neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum”.
|
||
Inf. X, 35, 73-74, 93ed el s’ergea col petto e con la fronteMa quell’ altro magnanimo, a cui posta
|
||
Inf. V, 85-87, 91-93cotali uscir de la schiera ov’ è Dido,
|
Purg. XXVII, 133, 139-140
Vedi lo sol che ’n fronte ti riluce ……
Non aspettar mio dir più né mio cenno;
libero, dritto e sano è tuo arbitrio
Purg. XI, 133-135
“Quando vivea più glorïoso”, disse,
“liberamente nel Campo di Siena,
ogne vergogna diposta, s’affisse”
Purg. XIII, 103-105, 142-147
“Spirto”, diss’ io, “che per salir ti dome,
se tu se’ quelli che mi rispondesti,
fammiti conto o per luogo o per nome”.
“E vivo sono; e però mi richiedi,
spirito eletto, se tu vuo’ ch’i’ mova
di là per te ancor li mortai piedi”.
“Oh, questa è a udir sì cosa nuova”,
rispuose, “che gran segno è che Dio t’ami;
però col priego tuo talor mi giova”.
Inf. III, 52-60, 79
E io, che riguardai, vidi una ’nsegna
che girando correva tanto ratta,
che d’ogne posa mi parea indegna;
e dietro le venìa sì lunga tratta 7, 9
di gente, ch’i’ non averei creduto
che morte tanta n’avesse disfatta.
Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l’ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto.
Allor con li occhi vergognosi e bassi
Inf. XXI, 64-66; XXII, 73-75
Poscia passò di là dal co del ponte;
e com’ el giunse in su la ripa sesta,
mestier li fu d’aver sicura fronte.
Draghignazzo anco i volle dar di piglio
giuso a le gambe; onde ’l decurio loro
si volse intorno intorno con mal piglio.
Tab. 7.2
[LSA, cap. VII, Ap 7, 7 (IIa visio, apertio VIi sigilli)]VII. SimeonSeptimo exigitur devota oratio supernarum gratiarum impetrativa et exauditione digna, quam designat Simeon, qui interpretatur auditio vel exaudibilis.Ad tertium etiam statum, scilicet perfectorum, spectant tria.
|
||
Inf. II, 106, 133Non odi tu la pieta del suo pianto ……Oh pietosa colei che mi soccorse!
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 19 (VIIa visio)] “Smaragdus”, qui est summe viriditatis, habens colorem purissimi olei, significat dulcorem et gratiosam contem-perantiam pietatis seu misericordie.Purg. IV, 130-135Prima convien che tanto il ciel m’aggiri
|
Inf. IV, 13-27“Or discendiam qua giù nel cieco mondo”,
|
|
VIII. LeviOctavo exigitur spes de superfluentia pietatis et liberalitatis Dei supererogantis ultra omnia vota et merita et ultra quam presumamus, et hanc designat Levi, qui interpretatur superadditus.Secundum consiliorum Christi supererogatio, et hoc est Levi, id est additus.Secundo severe dist<ri>ctionis emulatoria rectitudo, et hoc est Levi, id est additus, qui propter zelum contra idolatras accepit sacerdotium, unde et Finees, eiusdem tribus, accepit a Deo pactum sacerdotii eterni, quia zelatus est contra fornicationem cum Madianit<is> (cfr. Nm 25, 10-13). |
||
Par. XVII, 70-75Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello
|
Par. XXXII, 147-148; XXXIII, 40-42orando grazia conven che s’impetri (Simeon)
|
|
8. La via al “doloroso passo”
“e ’l modo ancor m’offende … che, come vedi, ancor non m’abbandona” (Inf. V, 102, 105; tab. 8.1, 8.2).
■ (tab. 8.1) In un poema che parla, come la Scrittura, tutte le lingue, si piange in ogni lingua. L’esegesi di Ap 1, 7 (“E lo vedrà ogni occhio”) riguarda tutti gli uomini, ma in particolare i malvagi – coloro che “punsero” sulla croce, offesero e disprezzarono Cristo – dei quali sarà proprio piangere, gemere, perdere la gloria, ed anche essere “punti”, offesi, dispetti. Ciò che in Olivi è teologicamente inteso in senso assoluto, è ricostruito e separato da Dante in più affluenti, facendo risuonare ora l’uno ora l’altro tema: vi sono interessati i lussuriosi con Francesca e Paolo (Inf. V), i tiranni immersi nel Flegetonte sanguigno (Inf. XII), il fiorentino suicida (Inf. XIII), i tre sodomiti fiorentini (Inf. XVI), il ruffiano Venedico Caccianemico (condotto “a sì pungenti salse”, Inf. XVIII), Dante medesimo di fronte alla pena degli indovini (Inf. XX), Ulisse e Diomede (Inf. XXVI), e anche la “trista Cleopatra” di cui dice Giustiniano (Par. VI) nonché il pianto di Feltre sul suo vescovo traditore profetizzato da Cunizza (Par. IX). Qui “sta – direbbe Contini – la mondanità discretiva del Dante della Commedia, unicuique suum” [1].
■ (tab. 8.1) Scrive Giovanni allo stesso versetto: “Piangeranno tutte le tribù della terra”. Affinché gli si creda con maggiore certezza conferma ciò in duplice lingua, quella gentile e quella ebraica, dicendo: “Etiam. Amen”, cioè piangeranno veramente sé stessi. Entrambe le parole, la latina e l’ebraica (l’etiam latino traduce l’avverbio greco, lingua in cui il libro fu scritto) sono poste a ribadire che il pianto sarà vero pianto, confermato in ogni lingua, “gentile” (greco e latino) o ebraica, sia dai fedeli come dagli stessi reprobi, stimolati dall’esperienza della pena (un passo simmetrico è, alla fine del libro, ad Ap 22, 20). Francesca ripete due volte l’avverbio ancor: “e ’l modo ancor m’offende … che, come vedi, ancor non m’abbandona” (Inf. V, 102, 105). In entrambi i casi ancor è asseverativo, sta a testimoniare universalmente, quasi con un sì, la verità [2]. Quale? L’intensità dell’amore terreno che continua nell’al di là, dove chi punse offendendo Cristo in vita sta ora, anima offesa (v. 109), nel “dolor, che punge a guaio” (v. 3). Vi è dunque, come intesero il Pagliaro e il Sapegno [3], un “parallelismo logico e formale” fra le due terzine (vv. 100-105) nelle quali, a sottolineare la subitanea violenza d’amore, si insinua il tema del ladro, il cui avvento è improvviso e letale: “s’apprende … prese costui … mi prese” (cfr. supra). L’inciso “e ’l modo ancor m’offende” non può pertanto essere riferito a quel che precede immediatamente – “che mi fu tolta”, con allusione al modo efferato in cui Gianciotto avrebbe ucciso i due amanti togliendo loro la possibilità di pentirsi. Amore subitaneo, furtivo, mortifero contiene di per sé, nella sua intensità (“’l modo”), l’uccisione di chi si sente sicuro (“sanza alcun sospetto”, v. 129) e tarda nel pentimento.
A favore della variante n’offende, nel senso che Amore nocque a entrambi i dannati, non solo a Francesca, sta, al di là del riscontro al v. 109 (anime offense; cfr. Inglese, ad loc.), la forma plurale dell’esegesi di Ap 1, 7: «“Et plangent se super eum”, id est super offensis quas sibi intulerunt».
■ Piange Venedico Caccianemico (Inf. XVIII, 58-63), ma non da solo, perché anzi (etiam) “tante lingue” piangono con lui, di bolognesi abituati a dire sipa (sia, che rende amen, equivalente a sic fiat, cfr. Ap 1, 6).
Sottolineato dall’“ancor” (appropriato a Deidamía) è il pianto di Ulisse e Diomede (Inf. XXVI, 61-63), come quello di Cleopatra (Par. VI, 76).
Nell’Eden Dante piange la scomparsa di Virgilio, ma alcune tra le prime parole di Beatrice lo invitano a non farlo: “non pianger anco, non piangere ancora”: “verso grondante di nonsenso grammaticale … È un singhiozzo fissato fonosimbolicamente, per solidarietà col rimproverato persistendo, e insistendo, la necessità del rimprovero” (Contini) [4]. La ripetizione dell’avverbio – come già avvenuto con Francesca, per quanto in due differenti versi – ricalca quella di «“etiam. amen” … id est vere plangent se», quasi per dire che il vero pianto deve ancora venire: “ché pianger ti conven per altra spada” (Purg. XXX, 55-57). Dopo le accuse, la donna (che parla “per punta”, Purg. XXXI, 2) si aspetta una confessione, perché le memorie tristi della colpa non sono ancora “offense” dall’acqua del Lete (pungere e offendere sono variazioni su temi presenti nell’esegesi di Ap 1, 7). Confusione e paura spingono fuori dalla bocca del poeta un fioco sì (amen) (Purg. XXXI, 10-15).
■ (tab. 8.2) Nel rivolgersi al conte Ugolino (Inf. XXXII, 135-139), Dante varia i temi presenti ad Ap 1, 7: il piangere (“che se tu a ragion di lui ti piangi”, cioè dell’arcivescovo Ruggieri), il linguaggio che rende certo (“nel mondo suso ancora io te ne cangi, / se quella con ch’io parlo non si secca”). Nel sottile tessuto di temi che si fanno versi, interviene anche l’esegesi di Ap 7, 9.13-14. All’apertura del sesto sigillo, un vegliardo domanda (“risponde”) a Giovanni: “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono”, cioè di quali e quante dignità sono insigniti, “e donde vengono?”, cioè per quali meriti e quale via di santità sono pervenuti a tanta gloria; e Giovanni, quasi discepolo a maestro: “Signore mio, tu lo sai”, come per dire: io non lo so ma insegnamelo tu che lo sai; e il vegliardo: “Essi sono coloro che sono venuti”, a tanta gloria, “attraverso la grande tribolazione”, cioè attraverso le grandi tribolazioni patite per Cristo. Questi versetti, con i motivi che recano, sono ancillari di numerose agnizioni del poema. Si tratta di temi banali, per cui qualcuno chiede chi sia un altro, e da dove venga, tanto ovvi che li si ritrova nelle parole di Nestore a Telemaco (Odissea, III, 71): “ὦ ξει̃νοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλει̃θ’ ὐγρὰ κέλευθα”. Qui però si registra una rosa semantico-tematica, che rende unica quella forma comune di dire e la applica a qualsivoglia situazione. Si osservi il “ditemi chi voi siete e di che genti” di Inf. XXIX, 106, variante dell’inciso “et unde venerunt” di Ap 7, 13; il tema del rispondere di uno dei seniori è appropriato a uno dei due falsari (v. 110), mentre al verso 93 i motivi servono ai due ‘Latini’ per rivolgersi a Virgilio. Il non sapere, proprio di Giovanni nei confronti del vegliardo, si insinua nelle parole di Ugolino: “Io non so chi tu se’ né per che modo / venuto se’ qua giù – hii … qui sunt … et unde venerunt … ego nescio, sed tu me doce quia tu hoc scis” (Inf. XXXIII, 10-11). Né Ap 7, 9.13-14 discorda da quanto si afferma ad Ap 1, 7 sul piangere in ogni lingua, perché i vestiti di bianco dei quali interroga il vegliardo appartengono alla “turba magna” proveniente “ex omnibus gentibus … et linguis” (Ap 7, 9). Le fiere parole del conte rivolte in seguito al poeta – “e se non piangi, di che pianger suoli?” (v. 42) – significano allora ‘in che lingua sei solito piangere?’, al modo in cui Venedico Caccianemico afferma il suo piangere bolognese insieme agli altri (Inf. XVIII, 58-63). Così, ad Inf. XXIX, 106, il poeta chiede al falsari: “ditemi chi voi siete e di che genti”.
Il tema del parlare – precipuo del sesto stato, al quale è data la “porta aperta”, al quale cioè si apre la volontà di dire per dettato interiore di Cristo – è cuneo che penetra nella durezza infernale; nell’“aura sanza tempo tinta” la poesia apre per un attimo la porta del dire dei dannati e fa assurgere la perduta gente allo stato per eccellenza cristiforme, il sesto. Vero è che i temi del sesto stato nell’Inferno sono come chiusi, incompiuti, tronchi, tanto quanto saranno aperti nelle due successive cantiche dove subiranno nuove variazioni. Eppure questa chiusura non è totale, perché la parola è adito all’intelligenza spirituale, invito a convivare, a ricordare il dolce mondo.
«per ch’i’ dissi: “Maestro, chi son quelle / genti che l’aura nera sì gastiga?”» (Inf. V, 50-51).
La domanda di Dante al suo maestro Virgilio è una delle numerose variazioni sul tema della domanda e risposta fra il vegliardo e san Giovanni ad Ap 7, 13. È opportuno qui esaminare l’intera esegesi di Ap 7, 9-17, con i passi simmetrici suscettibili di collazione, per rendersi conto della vasta utilizzazione di queste variazioni diffuse per tutto il poema, a partire da Inf. III, 32-33 (già in embrione ad Inf. II, 18) e fino a Par. XXXII, 103. Essa rende l’immagine del “panno” servito per il lungo cucire la “gonna” (cfr. Par. XXXII, 139-141).
Scorrendo le tabelle qui di seguito spiegate nei dettagli, non si mancherà di notare i tanti luoghi della Commedia che rinviano la memoria del lettore spirituale alla medesima esegesi di un passo dell’Apocalisse, utilizzata dunque in momenti diversi della stesura del poema. Si tratta di una costante che si ripete per molti altri passi della Lectura oliviana.
L’arte della memoria per parole-chiave non doveva servire soltanto agli Spirituali. Il fatto che gruppi di terzine numericamente corrispondenti, a diversi stadi della Commedia, contengano parole-chiave che conducono alla medesima pagina esegetica sembra indicare che queste parole, se dovevano essere per il lettore spirituale signacula mnemonici di un altro testo, erano per il poeta anche segni del numero dei versi, “luogo” dove collocare i medesimi signacula in forma e contesto diversi. Ap 7, 9.13-14 (tab. 8.9, 1-3) è solo un esempio, perché innumerevoli altri luoghi della Lectura si propongono a riaffermare la medesima norma (cfr., ancora, Ap 7, 3-4).
■ (tab. 8.3) L’esegesi di Ap 7, 9, relativa alla moltitudine immensa non di una sola gente o lingua, ma “di ogni gente, tribù, popolo e lingua”, che sta dinanzi al trono, trova un passo simmetrico ad Ap 5, 9, nel “canto nuovo” che i quattro animali (o esseri viventi) e i ventiquattro seniori cantano prostrati dinanzi all’Agnello. Il canto loda Cristo (l’Agnello) perché ha riscattato con il suo sangue uomini non di una sola gente, ma “di ogni tribù, lingua, popolo e nazione”. Secondo Riccardo di San Vittore, il termine “tribù” proviene dai tre ordini corrispondenti alle genti discendenti dai tre figli di Noè, nei quali sono comprese settanta lingue. Nelle singole lingue sono più popoli e in ciascun popolo più nazioni. L’evangelista inizia pertanto da ciò che è più generale (le tribù) per discendere a ciò che è speciale. Secondo Isidoro di Siviglia, tuttavia, l’etimologia di “tribù” deriva dai tre ordini – senatori, militi e plebe – in cui Romolo divise (“fuerunt … dispertiti”) i Romani. Pertanto, seguendo questa interpretazione, l’evangelista procede dallo speciale al generale: “natio” è il termine più generale, perché contiene più popoli; “populus” più lingue, “lingua” più tribù (la lingua d’Israele comprendeva dodici tribù). Si può anche dire, sostiene Olivi, che non intese seguire alcun ordine, insinuando solo che gli eletti proverranno da ogni gente o città: con “popolo” è infatti designata la moltitudine di una città. Si può altresì intendere che gli eletti saranno principalmente tra i Giudei (designati dalle tribù e dai popoli) e i Gentili (designati dalle lingue e dalle nazioni). L’essere stati redenti da “ogni tribù”, significa anche che noi siamo stati, per singolare grazia, separati dalla comune e perduta massa dell’umana gente.
‘Dipartirsi’ dagli altri ed essere separati per grazia dalla massa è proprio dei grandi poeti antichi del Limbo, “c’hanno cotanta onranza, / che dal modo de li altri li diparte”, perché l’onorevole fama, che risuona ancora nella vita degli uomini, “grazïa acquista in ciel che sì li avanza” (Inf. IV, 74-78). La massa da cui sono separati sono “le turbe, ch’eran molte e grandi, / d’infanti e di femmine e di viri” (vv. 29-30), che corrispondono alla “turba magna” di Ap 7, 9. E in effetti agli “spiriti magni” sono appropriati temi dei segnati dalle dodici tribù d’Israele, di coloro cioè che precedono la “turba magna” (Ap 7, 3-4). La domanda di Dante a Virgilio – “questi chi son c’hanno cotanta onranza” – ripete l’“hii qui sunt” di Ap 7, 13, allorché il vegliardo dice: “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono”, cioè di quali e quante dignità sono insigniti, “e donde vengono?”, cioè per quali meriti e quale via di santità sono pervenuti a tanta gloria. Una variazione del “dipartire” è appropriata a Virgilio: “l’ombra sua torna, ch’era dipartita”, che cioè si era a sua volta separata dal gruppo dei poeti, segregati dalla massa, per compiere la missione di salvare Dante affidatagli da Beatrice (v. 81). ‘Dipartirsi’ da Circe fu proprio di Ulisse (Inf. XXVI, 90-93), separato “a communi et perdita massa generis humani” (cfr. “la perduta gente” di Inf. III, 3).
Nella valletta dei principi, Nino Visconti – il “giudice Nin gentil” – grida a Corrado Malaspina di venire a veder quel “che Dio per grazia volse” (anch’egli “dal modo de li altri dipartito”), e si rivolge poi al poeta, pregandolo, per la singolare gratitudine che egli deve a Dio, di dire a sua figlia Giovanna che preghi per lui “là dove a li ’nnocenti si risponde” (è il “rispondere” di uno dei seniori di Ap 7, 13; Purg. VIII, 52-72; “Giovanna” è nome consonante con Giovanni, protagonista nel testo sacro).
Il tema della tribù è appropriato alle tre virtù teologali che nell’Eden chiedono a Beatrice la grazia di svelare al suo fedele la bocca, mostrandosi “di più alto tribo”, cioè dotate di maggiore elevatezza negli atti rispetto al gruppo delle quattro virtù cardinali (Purg. XXXI, 130-132).
■ Nel finale dell’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 13), uno dei seniori ‘risponde’, cioè si rivolge a Giovanni parlando. Questo vegliardo, nell’interpretazione di Riccardo di San Vittore, designa la totalità dei profeti, degli apostoli, dei dottori, ed insegna la giustizia e la gloria degli eletti; in tal modo è come se parlasse a nome di tutti. Secondo Gioacchino da Fiore, il vegliardo è lo stesso beato Giovanni, autore del libro, il quale ci interroga ed incita a cercare, a capire, a imitare quei santi. Egli è uno, e il maggiore, dei ventiquattro seniori. Noi siamo qui da lui designati in quanto viene edotto dall’angelo che assume la forma di un seniore. Il vegliardo dice: “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono”, cioè di quali e quante dignità sono insigniti, “e donde vengono?”, cioè per quali meriti e quale via di santità sono pervenuti a tanta gloria. Come noi con le domande del maestro siamo stimolati alla ricerca della verità di ciò su cui ci stiamo interrogando, ad avvertirne qualche difficoltà e a cercare un maestro che ce la insegni, così avviene spesso in queste visioni: è così indicato ogni incoraggiamento degli angeli inferiori o degli uomini mortali da parte degli angeli superiori perché gli inferiori si innalzino più attentamente e altamente ad accogliere l’illuminazione dei superiori.
E Giovanni: “Signore mio, tu lo sai” (Ap 7, 14), come per dire: io non lo so ma insegnamelo tu che lo sai. Il vegliardo: “Essi sono coloro che sono venuti”, a tanta gloria, “attraverso la grande tribolazione”, cioè attraverso le grandi tribolazioni patite per Cristo a causa degli empi e a causa di sé stessi in lotta contro le concupiscenze.
In un passo simmetrico, ad Ap 5, 2 (nella “radice” della seconda visione), il tema dell’interrogare da parte del maestro viene introdotto all’atto della domanda fatta dall’angelo forte che chiede a gran voce chi sia degno di aprire il libro segnato da sette sigilli. Questo modo di domandare da una parte designa il maestro che stimola il discepolo ad apprendere chiedendo, dall’altra indica l’alta ammirazione di colui che domanda e la rarità, la difficoltà e l’arditezza della cosa richiesta.
Il primo esempio di variazione su Ap 7, 13 – «“hii, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis» – è l’espressione di Inf. II, 18 riferita ad Enea: “pensando l’alto effetto / ch’uscir dovea di lui, e ’l chi e ’l quale” (cfr. “l’alto effetto … di sua vittoria” con il “victoriosus effectus” degli alti anacoreti, per antonomasia operosi nelle res gestae: Ap 2, 26-28).
Il tema della moltitudine innumerevole – la “turba magna” – che segue i segnati passa negli ignavi, “sì lunga tratta / di gente, ch’i’ non averei creduto / che morte tanta n’avesse disfatta”, che va dietro a un’insegna “che girando correva tanto ratta, / che d’ogne posa mi parea indegna” (Inf. III, 52-57). L’insegna rinvia all’esegesi della “signatio” (Ap 7, 3-4); correre senza posarsi ad Ap 21, 16, dove si tratta della misura della città, che è di 12.000 stadi. Lo stadio è lo spazio al cui termine si sosta o si posa per respirare e lungo il quale si corre per conseguire il premio. Esso designa il percorso del merito che ottiene il premio in modo trionfale, secondo quanto scrive san Paolo ai Corinzi: “Non sapete che tutti corrono nello stadio, ma di costoro uno solo prende il premio?” (1 Cor 9, 24). Ciò concorda con il fatto che lo stadio è l’ottava parte del miglio e in questo senso designa l’ottavo giorno di resurrezione. In tal modo agli ignavi, che corrono senza meta in cui posarsi, è applicato al contrario il motivo paolino. perché della loro vita non è rimasta alcuna fama nel mondo non avendo in essa conseguito alcun premio; al tempo stesso sono la negazione delle genti innumerevoli vestite di bianco che seguono i segnati e che l’Agnello guida alle fonti delle acque (Ap 7, 17), cioè a un termine e a un obiettivo finale.
La collazione di Ap 7, 13 con Ap 5, 2, con le sue variazioni e diverse appropriazioni, è fonte di numerosi procedimenti di agnizione nel poema, come si può notare nelle tabelle, riscontrando i temi offerti dall’esegesi scritturale (non solo dal testo sacro) – “et respondit … unus de senioribus”, “excitat nos ad querendum … excitamur ad inquirendum”, “per magistrales interrogationes”, «“hii qui sunt”, id est quales et quante dignitatis, “et unde venerunt”, id est … ad tantam gloriam”», “ego nescio … tu hoc scis” – con i più svariati versi del poema.
In questo modo Virgilio stimola Dante a domandare (“Tu non dimandi …”) degli spiriti che nel Limbo sospirano (come i santi, ad Ap 5, 4, piangono e sospirano perché il libro venga aperto). Le espressioni “son questi … questi chi son” traducono l’“hii … qui sunt” di Ap 7, 13; Dante domanda chiamando Virgilio “maestro” e “segnore” (è un “senior”, in forma di angelo, che interroga Giovanni, a sua volta il maggiore dei vegliardi), in merito a coloro “c’hanno cotanta onranza”, trasposizione del “quante dignitatis” del commento teologico (Inf. IV, 31-32, 46, 74).
Nell’attesa dell’arrivo del messo celeste che aprirà la porta della città di Dite, un Dante dubbioso domanda a Virgilio se capiti mai che qualche anima che sta nel Limbo discenda al fondo dell’inferno. Il maestro risponde che ciò avviene “di rado”, confermando la difficoltà (la “raritas” ad Ap 5, 2) contenuta nella domanda del discepolo, ma assicurandolo di aver già una volta compiuto il cammino (Inf. IX, 16-21). Di fronte alla visione dei candelabri – “alte cose” -, il discepolo nell’Eden si rivolge pieno di ammirazione al maestro e questi ‘risponde’ con sguardo non meno stupito (Purg. XXIX, 55-58). Altra variazione è nella meravigliata richiesta di Dante nell’ascoltare che due gentili, Traiano e Rifeo Troiano, sono fra le luci che formano il ciglio dell’aquila (Par. XX, 82-87).
Senza intreccio con Ap 5, 2 (e dunque senza il tema della rarità o della meraviglia), ad Ap 7, 13 è comunque riconducibile Inf. VIII, 8-9, nella domanda su cosa ‘risponda’ la fiammella di lungi alle due apposte sull’alta torre e su coloro che l’abbiano accese («et respondit … et dixit mihi: hii … qui sunt – dissi: “Questo che dice? e che risponde / quell’ altro foco? e chi son quei che ’l fenno?”»). La medesima domanda, congiunta con il motivo del maestro, si verifica per la “fiamma cornuta” che fascia Ulisse e Diomede (Inf. XXVI, 49-54).
L’incontro con Brunetto Latini registra il tema della meraviglia accostato al motivo del rispondere (Inf. XV, 22-30). Più avanti, Brunetto chiede al discepolo: “e chi è questi che mostra ’l cammino?” (v. 48), dove affiora il tema, che l’esegesi propone successivamente ad Ap 7, 17, di Cristo che conduce alle fonti delle acque della vita. Si può notare come gli stessi motivi, variati, si ritrovino nell’incontro con Marco Lombardo (Purg. XVI, 25-33). La meraviglia e il rispondere sono temi contesti anche nel ricchissimo tessuto delle mutue trasformazioni di uomini e serpenti proprie dei ladri della settima bolgia, la prima riferita all’incredibile trasformazione di Cianfa e di Agnolo Brunelleschi, il secondo a quella di Francesco Cavalcanti e di Buoso, per la quale i due “insieme si rispuosero a tai norme” (Inf. XXV, 46-48, 103-105).
La presenza frequente del termine “gente” nella rosa tematica (tab. 8.3–8.4) – “e che gent’ è che par nel duol sì vinta?” (Inf. III, 33); “Maestro, chi son quelle / genti che l’aura nera sì gastiga?” (Inf. V, 50-51; cfr. IX, 124-126); “Maestro mio, or mi dimostra / che gente è questa” (Inf. VII, 37-38); “ditemi chi voi siete e di che genti” (Inf. XXIX, 106: variante, già sopra menzionata, di “et unde venerunt”; al verso 93 i motivi servono ai due “Latini” per rivolgersi al poeta); “e chi eran le genti / tra esso degne di più alti scanni” (Par. XVI, 26-27); “e altro mi rispuose … e vidi un sene / vestito con le genti glorïose” (Par. XXXI, 58-60; con ripresa tematica, in relazione all’arcangelo Gabriele, a Par. XXXII, 103) -, come pure la presenza, meno frequente, del termine “turba” – “chi siete voi, e chi è quella turba” (Purg. XXVI, 65) – è da connettere all’essere quelli, di cui ad Ap 7, 13 si domanda, una “turba magna … ex omnibus gentibus … vestita stolis albis” ad Ap 7, 9.
La domanda “et unde venerunt” diventa talora ricerca del luogo di nascita: «domandollo ond’ ei fosse, e quei rispuose: / “I’ fui del regno di Navarra nato”» (Inf. XXII, 47-48); “e quella non rispuose al suo dimando, / ma di nostro paese e de la vita / ci ’nchiese” (Purg. VI, 69-71; la tematica prosegue a Purg. VII, 3, 9, 23; cfr. infra). La domanda non concerne soltanto persone, ma anche cose inanimate, realtà spirituali, come nel caso della speranza su cui san Jacopo esamina come un dottore interroga un discente: “la spene … dì quel ch’ell’ è … e dì onde a te venne” (Par. XXV, 44-47; il rapporto tra dottori e discepoli è ad Ap 5, 2).
Giovanni replica al vegliardo che lo ha interrogato: “Signore mio, tu lo sai” (Ap 7, 14), come per dire: io non lo so ma insegnamelo tu che lo sai. Ed ecco che il motivo del non sapere (“ego nescio” non è nel testo sacro, ma nell’esegesi) si insinua nel gruppo dei temi: “Io non so chi tu se’ né per che modo / venuto se’ qua giù” (Inf. XXXIII, 10-11); “Chi è costui che ’l nostro monte cerchia … Non so chi sia, ma so ch’e’ non è solo; / domandal tu che più li t’avvicini” (Purg. XIV, 1, 4-5). Variazioni in senso positivo sono le forme: «per ch’io dissi: “Maestro, or mi concedi / ch’i’ sappia quali sono”» (Inf. III, 72-73); «E io: “Maestro mio, fa, se tu puoi, / che tu sappi chi è lo sciagurato”» (Inf. XXII, 43-44); le parole di Virgilio a Catone (“Tu ’l sai …”, Purg. I, 73). Particolare il caso di Inf. XIX, dove il poeta prima domanda al maestro – «“Chi è colui, maestro, che si cruccia / guizzando più che li altri suoi consorti”, / diss’ io, “e cui più roggia fiamma succia?”» (vv. 31-33) -, ma poi di fronte alle parole di Niccolò III, che lo crede Bonifacio VIII venuto a prendere il suo posto nel foro dei simoniaci, si fa “quai son color che stanno, / per non intender ciò ch’è lor risposto, / quasi scornati, e risponder non sanno” (vv. 58-60), per ‘rispondere’ infine come imposto da Virgilio (vv. 61-63).
Questi temi sono presenti nei canti di Cacciaguida. A Par. XV, 58-59, l’espressione “e però ch’io mi sia e perch’ io paia / più gaudïoso a te, non mi domandi” varia quella di Virgilio nel Limbo: “Tu non dimandi / che spiriti son questi che tu vedi?” (Inf. IV, 31-32). Così lo stimolare da parte del maestro affinché il discepolo domandi è nell’invito successivo: “la voce tua sicura, balda e lieta / suoni la volontà, suoni ’l disio, / a che la mia risposta è già decreta!” (Par. XV, 67-69), motivo ripetuto più avanti da Beatrice: “perché t’ausi / a dir la sete, sì che l’uom ti mesca” (Par. XVII, 11-12; cfr. la congiunzione dei motivi del rispondere e della sete a Purg. XXVI, 19-21). Il tema della sete, centrale nei versetti successivi, viene esaminato in seguito.
Nella domanda che Dante pone all’avo – “ditemi de l’ovil di San Giovanni / quanto era allora, e chi eran le genti / tra esso degne di più alti scanni” (il terzo e il quarto quesito in Par. XVI, 22-27) – si nota la corrispondenza con «“Et dixit mihi: hii, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis (inciso frammentato in due distinte appropriazioni), “et unde venerunt ”» ad Ap 7, 13. Conseguentemente, Cacciaguida conclude la risposta al primo quesito – “quai fuor li vostri antichi” – riprendendo il tema: “chi ei si fosser e onde venner quivi, / più è tacer che ragionare onesto” (vv. 44-45). Dopo le domande di Dante, la luce di Cacciaguida si avviva come carbone in fiamma allo spirare del vento: “così vid’ io quella / luce risplendere a’ miei blandimenti” (vv. 28-30). Da rilevare la variante “rispondere”, accettata dal Boccaccio e considerata dal Petrocchi “senza dubbio lezione equivalente e interessante”; sembra rientrare nel gruppo tematico che qui si esamina, essa sarà compiutamente discussa infra.
Fra i motivi della chiusura dei sigilli connessi alla passione di Cristo, la quale per sette motivi appare abietta all’umana prudenza, il sesto è l’apparente inimicizia per la quale Dio ha voluto che il suo unico figlio patisse tanto, e che non ci fosse altro modo per riconciliarsi con l’uomo. Contro l’apparente inimicizia sta, nella sesta apertura, lo smisurato e singolare ardore di carità nella riconciliazione con cui le dodici tribù di Israele vengono segnate all’alta e gloriosa milizia di Cristo, in modo che sia manifesto che esse appartengono alla singolare famiglia e al domestico gregge delle pecore di Cristo, e nell’essere tutte le nazioni condotte al trono e al tempio di Dio che abita in esse, e nella familiarità dell’Agnello, per cui si dice che “l’Agnello che sta in mezzo al trono li guiderà e li condurrà alle fonti della vita” (Ap 7, 17; cfr. l’esegesi proposta ad Ap 5, 1). Ad Ap 7, 13 è riportata l’opinione di Gioacchino da Fiore, per cui Giovanni, l’autore del libro, è in realtà il seniore che ‘risponde’. Questa esegesi teologica arma la definizione di Firenze “ovil di San Giovanni” (Par. XVI, 25) [5]. All’inciso “unus de senioribus” rinviano, in contesti che registrano altri temi della medesima rosa, anche Carlo Martello (Par. VIII, 31, 85-86: “Indi si fece l’un più presso a noi … Però ch’i’ credo che l’alta letizia / che ’l tuo parlar m’infonde, segnor mio”) e san Bernardo (Par. XXXI, 59: “e vidi un sene …”).
■ (tab. 8.5) All’esegesi di Ap 7, 13 – il rispondere, la domanda “et unde venerunt” – rinvia l’incontro tra Virgilio e Sordello: “e quella non rispuose al suo dimando, / ma di nostro paese e de la vita / ci ’nchiese” (Purg. VI, 67-75). Ma altro tema risuona più alto. Ad Ap 5, 5 uno dei vegliardi dice a Giovanni di non piangere più, perché ha vinto il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide. È Cristo, nato dalla tribù di Giuda, che aprirà il libro segnato da sette sigilli risorgendo possente e invincibile come un leone verso la preda. Egli nascerà dalla radice di Davide in quanto radice di tutta la vita spirituale a lui precedente e successiva. Come tutti i rami di un albero procedono dalla radice e in essa trovano solidità, così tutto l’albero dei santi padri dell’Antico e del Nuovo Testamento procede da Cristo e da lui prende vigore. L’anima del trovatore, altera e disdegnosa, se ne sta sola soletta “solo sguardando / a guisa di leon quando si posa” (vv. 64-66). Il ‘posarsi’ deriva da Ap 21, 16 (la misura della città celeste, nella settima visione; cfr. altre variazioni sul tema) e indica in senso paolino [6] lo stare trionfale (elemento che collega questo passo ad Ap 5, 5) di chi, dopo aver corso nello stadio, ha ottenuto il premio corrispondente al merito: Sordello è ormai già spirito eletto, sicuro di arrivare a vedere l’alto Sole. Al suo opposto, al termine dell’invettiva contro la “serva Italia”, sta la dolorosa Firenze, “quella inferma / che non può trovar posa in su le piume” (vv. 148-151). A Virgilio che lo interroga sulla migliore via per salire la montagna, Sordello non risponde ma a sua volta interroga “di nostro paese e de la vita”. Al nome “Mantüa …” pronunciato da Virgilio, Sordello “surse ver’ lui del loco ove pria stava”: il leone, prima posato, risorge all’udire che di una sola radice nacque lui e il suo concittadino. Una è la vita spirituale che unisce l’antico poeta e il nuovo, per cui “e l’un l’altro abbracciava”. [Ulteriori sviluppi dell’esegesi della “radice di David” sono esposti altrove].
«Quando rispuosi, cominciai: “Oh lasso, / quanti dolci pensier, quanto disio / menò costoro al doloroso passo! … E quella a me: “Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore”» (Inf. V, 112-114, 121-123; tab. 8.6–8.7).
Viene qui di seguito considerata nel suo complesso l’esegesi conclusiva dell’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 13-17) [7].
Uno dei seniori ‘risponde’, cioè si rivolge a Giovanni parlando. Questo vegliardo, nell’interpretazione di Riccardo di San Vittore, designa la totalità dei profeti, degli apostoli, dei dottori, che insegna la giustizia e la gloria degli eletti, e in tal modo è come se parlasse a nome di tutti. Secondo Gioacchino da Fiore, il vegliardo è il beato Giovanni, autore del libro, il quale ci interroga ed incita a cercare, a capire, a imitare quei santi. Egli è uno, e il maggiore, dei ventiquattro seniori. Noi siamo qui da lui designati in quanto viene edotto dall’angelo che assume la forma di un seniore. Il vegliardo dice (Ap 7, 13): “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono”, cioè di quali e quante dignità sono insigniti, “e donde vengono?”, cioè per quali meriti e quale via di santità sono pervenuti a tanta gloria. Come noi con le domande del maestro siamo stimolati alla ricerca della verità di ciò su cui ci stiamo interrogando, ad avvertirne qualche difficoltà e a cercare un maestro che ce la insegni, così avviene spesso in queste visioni: è così indicato ogni incoraggiamento degli angeli inferiori o degli uomini mortali da parte degli angeli superiori perché gli inferiori si innalzino più attentamente e altamente ad accogliere l’illuminazione dei superiori.
E Giovanni: “Signore mio, tu lo sai” (Ap 7, 14), come per dire: io non lo so ma insegnamelo tu che lo sai. Il vegliardo: “Essi sono coloro che sono venuti”, a tanta gloria, “attraverso la grande tribolazione”, cioè attraverso le grandi tribolazioni patite per Cristo a causa degli empi e a causa di sé stessi in lotta contro le concupiscenze. Costoro “hanno lavato le loro vesti”, cioè i corpi e le anime, “e le hanno imbiancate”, con il candore della perfetta grazia, “col sangue dell’Agnello”, cioè col merito della passione di Cristo attraverso la fede, il battesimo, le mortificazioni penitenziali e infine il martirio. Per questo stanno davanti al trono di Dio, servendo giorno e notte nel suo santuario Colui che abita sopra di loro (Ap 7, 15).
“Non avranno più fame né avranno più sete” (Ap 7, 16), cioè di cibo e bevanda corporali e di qualunque desiderio che reca pena o di qualunque desiderio che non ha subito e pienamente quello che vuole. “Né li colpirà il sole”, affliggendoli per troppo ardore, “né arsura di sorta”, cioè non saranno afflitti da nessun difetto interiore, come la fame e la sete, o esteriore, grande o piccolo.
“Perché l’Agnello che sta in mezzo al trono” (Ap 7, 17), cioè come persona mediana nella Trinità e come mediatore tra noi e Dio (o è “in mezzo al trono”, cioè nell’intimo seno del Padre o nell’intimo della Chiesa come il suo centro), “li governerà” non permettendo che siano afflitti in alcun modo, “e li guiderà alle fonti delle acque”, cioè ad attingere e a bere le immense fonti delle acque della vita beatissima di Dio, che è lo stesso Dio. Esse designano in particolare l’immensa multiformità delle dolcezze e dei beni desiderabili dell’unico semplicissimo Dio. Viene usato il futuro – “governerà”, “guiderà” – per mostrare l’eterna continuazione e durata di questi atti. Guidare qui non significa un atto distante dal termine e obiettivo finale, ma piuttosto con esso immediatamente unito. “E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi”, cioè rimuoverà perfettamente e totalmente ogni dolore passato, ogni segno penale, ogni sua penale memoria.
Quanto detto sopra, dello stare davanti al trono di Dio e del non aver più fame, può essere riferito allo stato di questa vita, nel quale dopo molte tribolazioni adoreranno Dio pacificamente, giocondamente e saranno condotti alla gloria divina. Così intende Riccardo di San Vittore, e in questo senso il trono è la Chiesa e la sua sede principale alla quale sono condotti dallo stato di infedeltà attraverso molte tribolazioni e contro le resistenze dei loro. Nell’altro senso il non aver più fame è inteso nell’altro secolo, e cioè che l’Agnello li guiderà dallo stato di questa vita alle fonti della beata vita eterna. Il primo senso sembra più letterale.
■ Questa pagina apocalittica, che Olivi aveva già proposto ai figli di Carlo II d’Angiò prigionieri degli Aragonesi, perché nelle avversità di questo mondo il loro animo regale non fosse oppresso ma si gloriasse [8], ha la sua metamorfosi poetica nell’episodio di Francesca. Il tema del maestro che interroga è introdotto da Virgilio, il quale richiama Dante dal suo riflettere sulle prime parole porte da Francesca con un “che pense?” (Inf. V, 111), eco dell’invito di Gregorio Magno a considerare la singolare intensità psicologica del martirio proprio degli ultimi tempi segnato dal dubbio ingannatore, trattato nel Notabile X del prologo della Lectura (cfr. infra). Lo sviluppo interviene con “quando rispuosi” (v. 112) e con “parla’ io” di Dante (v. 115), prima (“et respondit”) nei confronti di Virgilio, poi (“prolocultus est”) verso i due dannati, per apprendere a che e come Amore concedette loro di conoscere i “dubbiosi disiri”. In questo secondo caso è Dante ad assumere la funzione di Giovanni, che interroga per sapere la verità di ciò di cui lui stesso si sta interrogando, e che si esprime nella risposta a Virgilio: “O lasso, / quanti dolci pensier, quanto disio / menò costoro al doloroso passo!” (vv. 112-114). In queste parole compare il tema di Cristo che conduce alle fonti delle acque dolci e desiderabili e della cancellazione di ogni dolore passato e di ogni penale memoria. Il “passo”, cioè il patire dei due cognati nella tentazione, è stato “doloroso” non solo perché a causa di esso la loro vita corporale è stata spenta, ma perché ora, nella miseria, essi ricordano con dolore il tempo felice. Le parole di Francesca che tanto piacquero ai romantici – “Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / ne la miseria” (vv. 121-123) – sono la consapevole negazione della gloria cui Cristo mena, in dolcezza e desiderio, coloro che hanno patito nelle tentazioni vincendole. I due amanti, vinti da “un punto” della lettura del libro galeotto, ora hanno come pena, al di là della “bufera infernal, che mai non resta”, la memoria dolorosa, che Cristo terge invece a coloro che nel sangue lavarono le loro vesti, cioè, come si afferma nell’esegesi oliviana, hanno combattuto e vinto le concupiscenze. Quelle parole, memori di un passo del De consolatione philosophiae di Boezio (II, pr. IV, 2) – “in omni adversitate fortunae, infelicissimum est genus infortunii fuisse felicem” -, mostrano, nei fili dell’ordito, un’armatura tutta spirituale e apocalittica. Felicità e miseria sono pure contrapposte nella Lectura ad Ap 9, 17, la prima appropriata proprio alla lussuria, la seconda ad una vita casta derisa come misera. Il che conferma che Francesca, definendo “felice” il tempo dell’amore carnale, non si è distaccata da quel “piacer sì forte, / che, come vedi, ancor non m’abbandona” (vv. 104-105). Le sue parole riprendono quindi il tema del maestro: dicendo “e ciò sa ’l tuo dottore” (v. 123), l’anima affannata recita, quasi umilmente, il “tu me doce, quia tu hoc scis” detto da Giovanni al vegliardo il quale, come Virgilio, è “maestro” e “seniore”. E proprio il motivo della memoria dolorosa non cancellata sembra ricondurre il ‘sapere’ di Virgilio, di cui dice Francesca, all’“infandum, regina, iubes renovare dolorem” con cui Enea inizia a narrare a Didone la caduta di Troia e la miseria da lui vista e partecipata (Aen. II, 3-13), piuttosto che ad un generico riferimento al ricordo della vita mondana.
Il motivo del guidare – “deducere” – come atto non distante dal termine e obiettivo finale, ma piuttosto con esso immediatamente unito, che mostra la sua eterna continuazione e durata, è applicato dal poeta alla propria poesia incapace di esprimere il riso di Beatrice, lasciato “a maggior bando / che quel de la mia tuba, che deduce / l’ardüa sua matera terminando” (Par. XXX, 34-36).
■ Francesca e Paolo non sono gli unici personaggi per i quali dei motivi collocati nel testo di origine in un ambito glorioso e trionfale passano nella poesia dell’infernale miseria. Nell’ultima bolgia, maestro Adamo, il falsario di Romena, si rivolge anch’egli a Dante e a Virgilio variando i temi apocalittici (Inf. XXX, 58-63). Il non essere afflitti da alcun desiderio penale (Ap 7, 16) è appropriato ai due poeti (“O voi che sanz’ alcuna pena siete”), mentre il falsario, che in vita ebbe esauditi in abbondanza i suoi desideri (“io ebbi, vivo, assai di quel ch’i’ volli”; cfr. l’inciso “respectu … cuiuscumque desiderii non habentis plene et indistanter quod optat”), ora, nella miseria, brama un goccio d’acqua, asciugato com’è dall’immagine de “li ruscelletti che d’i verdi colli / del Casentin discendon giuso in Arno” (cfr. la brama data in pena ad Adamo “in pena e in disio” a Purg. XXXIII, 61-63). Il tema del maestro è invertito, rispetto alle parole di Francesca: lì Virgilio sapeva, qui Adamo, che pure è “maestro”, non comprende – “e non so io perché” – il motivo della presenza “nel mondo gramo” dei due visitatori. Anche l’accenno alla “Fonte Branda” nel Campo di Siena, per la quale l’idropico non commuterebbe il vedere puniti i tre conti Guidi che lo istigarono a coniare fiorini di metallo vile (vv. 76-78; intervengono motivi da Ap 16, 12-14), rientra nella tematica di Cristo che conduce alle fonti delle acque della vita (Ap 7, 17).
■ Il tema della sete appagata dalle acque della vita è presente anche ad Ap 22, 17 (cfr. supra), dove nella settima e ultima visione lo sposo e la sposa dicono “Vieni”, cioè invitano alla gloriosa cena delle nozze dell’Agnello. “E chi ascolta”, ossia chi è a conoscenza dell’invito, oppure chi crede e opera in modo retto e con obbedienza, “dica: vieni” a quelli che sono da chiamare alla cena e alla città beata. Poi è Cristo stesso ad invitare con liberalità dicendo: “Chi ha sete venga, e chi vuole riceva gratuitamente le acque della vita”. Dice “chi ha sete e chi vuole” perché nessuno può venire senza che ci sia desiderio e volontario consenso. “Venire” equivale a ricevere l’acqua della vita, cioè la grazia che ristora, vivifica e conduce alla vita eterna.
La “femminetta / samaritana domandò la grazia” di avere l’acqua che sazia eternamente “la sete natural”; “domandò”, quindi con desiderio e volontario consenso (Purg. XXI, 1-3; i motivi vengono ripresi ai vv. 37-39; a Par. I, 28-33 le “umane voglie” sono contrapposte alla “fronda peneia” che “di sé asseta”).
Alla collazione di Ap 7, 17 con Ap 22, 17 rinviano terzine come quelle di Par. III, 70-75, in cui Piccarda introduce il tema della volontà, che nei beati è concorde con quella di Dio, accanto al motivo del non aver sete per desiderio di trovarsi in luogo più alto di quello assegnato. Una variazione è nelle parole di Cacciaguida che invita Dante a far sentire la sua volontà e il suo desiderio, affinché meglio s’adempia “’l sacro amore in che io veglio / con perpetüa vista e che m’asseta / di dolce disïar” (Par. XV, 64-69). Il tema del maestro che stimola il discepolo a domandare, combinato con quello dell’avere sete, si ritrova in Par. XVII, 7-12, nel punto in cui Beatrice spinge Dante a chiedere ciò che desidera, mandando fuori la vampa del desiderio, non perché la conoscenza dei beati – nel caso di Cacciaguida – si accresca per il suo parlare, ma perché egli si abitui “a dir la sete”, in modo che altri la possa appagare.
A questi passi fanno riferimento altri versi del poema, ad esempio nel girone dei golosi (Purg. XXIII, 67-75, 85-87) e in quello dei lussuriosi (Purg. XXV, 106; XXVI, 16-21), oppure nell’andare verso il dolce bere dell’Eunoè, al quale Dante viene condotto da Matelda (Purg. XXXIII, 127-129, 136-138). Il verbo menare, qui presente (“menalo ad esso”) come in Inf. V, 32, 43, 78, 114 – “mena li spirti con la sua rapina … di qua, di là, di giù, di sù li mena … per quello amor che i mena … menò costoro al doloroso passo” – traduce mener, che nel Roman de Tristan è proprio della Fortuna , alla quale amore soggiace, “qui l’ome moine a sa volenté, ore desus, ores dejus, or en joie, or en corroz” [9]. Quella reminiscenza oitanica ora s’affronta con il deducere da parte di Cristo al termine finale di tutto ciò che è dolce e desiderabile.
Le parole “… Amor che ’l ciel governi … Quando la rota che tu sempiterni / desiderato” (Par. I, 74, 76-77) sono elaborate sull’esegesi di Ap 7, 17: «Unde pluraliter dicit “fontes aquarum”, ad designandum immensam multiformitatem dulcorum et desiderabilium bonitatum unius simplicissimi Dei. Dicit autem de futuro “reget et deducet”, ut monstret eternam continuationem et perdurationem istorum actuum» (cfr. l’avverbio sempiternaliter ad Ap 19, 3, passo analogicamente connesso al precedente: perdurationem / perdurat: l’esegesi si riferisce al fumo dei tormenti, ma le parole nei versi sono appropriate liberamente alla porta dell’inferno, Inf. III, 7-8, e ai durevoli beni eterni, Par. XV, 11-12).
■ (tab. 8.8) Con l’invito alla cena nuziale dell’Agnello si apre Par. XXIV. I versi rinviano ad Ap 22, 17: la cena dell’Agnello; la volontà degli eletti, che vengono aderendo all’invito; la grazia, fatta a Dante di prelibare quanto cade dalla mensa. Simmetrica è l’esegesi di Ap 19, 1.9, dove si esprime il gaudio della Chiesa dopo la dannazione della nuova Babilonia (alla fine del canto precedente si parla del godere del tesoro di meriti acquistato piangendo nell’esilio di Babilonia). Come Assuero, ripudiata Vasti ed “eletta” quale sposa l’umile e santa Ester, fece un grande (“magnificum”) convivio (il sodalizio è “eletto” e la cena è “grande”), così avvenne con l’abbandono della Sinagoga e con l’elezione della Chiesa della pienezza delle genti, e così sarà nel sesto stato con il ripudio dell’adultera Babylon e l’esaltazione della Chiesa spirituale.
Altri motivi derivano da Ap 3, 20: cibare da parte dell’Agnello il sodalizio (“vi ciba”); l’“affezione” di Dante, che corrisponde all’aprire il viscerale consenso del proprio cuore al cenare con Cristo con cibi amabili e soavi (cfr. altri aspetti di questa esegesi).
Altri ancora da Ap 7, 15-17, dove l’Agnello conduce a bere le immense acque della beatissima vita di Dio (l’aggettivo “immenso”, che non è del testo scritturale ma dell’esegeta, è appropriato all’“affezione” di Dante). Il tema dell’aver sete di Dio e dell’acqua della vita consente una collazione tra Ap 22, 17 e Ap, 7, 16-17.
“dirò come colui che piange e dice” (Inf. V, 126; tab. 8.10).
Piangono i re della terra la caduta improvvisa e irreparabile della maledetta Babilonia, «“dicentes”, scilicet plangendo: “Ve, ve, ve”» (Ap 18, 10). Triplicano la dolorosa interiezione, parlano di Babilonia in terza persona e poi in seconda, al modo di coloro che prima piangono con sé stessi, poi si rivolgono alla persona compianta. È il modo di Francesca: “dirò come colui che piange e dice” (Inf. V, 126), ove si passa dalla prima alla terza persona: «si allontana dalla rappresentazione immediata (“piangerò e dirò”, scilicet insieme) per ricondurre l’azione al suo paradigma» (Contini) [10]. E Ugolino: “parlare e lagrimar vedrai insieme” (Inf. XXXIII, 9). Ai tre sodomiti che gli hanno chiesto (per bocca di Iacopo Rusticucci) se cortesia e valore dimorino “ne la nostra città sì come suole”, riferendosi ad essa in terza persona, Dante risponde direttamente in seconda persona, triplicando in modo anaforico: “La gente nuova e i sùbiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni” (Inf. XVI, 64-75). La dolorosa scritta sulla porta dell’inferno ripete per tre volte “Per me si va”; l’anafora distingue ancora il dire di Francesca, che ripete per tre volte “Amor”.
Anche i mercanti piangono la perdita del lucro acquistato nei commerci con Babilonia, ora che è caduta (Ap 18, 11-14, 17.19). Il linguaggio mercantile – l’acquistare e il tristo perdere, il perdere ogni speranza di guadagni, l’equivoco tra merce (il lucro) e mercede (il premio), il navigare per vie più o meno gravi verso porti più o meno lontani, la fine delle delizie di Babilonia, desideri per anime sensuali – segna molti luoghi dei primi canti del poema: Dante che prima acquista e poi perde piangendo, a causa della lupa, la salita del “dilettoso monte”, “ch’io perdei la speranza de l’altezza” (Inf. I, 52-60); al quale Caronte dice che dovrà passare “per altra via, per altri porti”, portato da “più lieve legno” (Inf. III, 88-93); le ultime parole scritte sulla porta, “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate” (v. 9); le anime del Limbo, delle quali dice Virgilio che non peccarono, ma se hanno meriti (“mercedi”) non basta, perché non furono battezzate, cui è pertanto applicato il tema della speranza perduta – “Per tai difetti, non per altro rio, / semo perduti, e sol di tanto offesi / che sanza speme vivemo in disio” (Inf. IV, 31-42; quest’ultimo, più che al carnale appetito delle delizie perdute è da ricondurre al desiderio dei santi padri dell’Antico Testamento, i quali nel Limbo piangono e sospirano con desiderio affinché il libro della vita venga loro aperto, secondo quanto si dice ad Ap 5, 4). La variazione più distante dal tema originale è per l’ottavo cielo, dove discendono trionfalmente le schiere di Cristo e la Vergine: “Quivi si vive e gode del tesoro / che s’acquistò piangendo ne lo essilio / di Babillòn, ove si lasciò l’oro” (Par. XXIII, 133-135; cfr. le parole di san Pietro a Par. XXVII, 40-42).
Da notare che le parole di Virgilio su quello che è il proprio stato oltremondano sono introdotte con il motivo del maestro che interroga, per stimolare i discepoli a chiedere, sulla dignità dei vestiti di bianche stole all’apertura del sesto sigillo, che sono “turba magna”: «per magistrales interrogationes excitamur ad inquirendum veritatem eius de quo interrogamur et <ad> advertendum aliquam difficultatem ipsius et ad requirendum magistrum ut doceat nos ipsam (Ap 7, 13) … “Et dixit michi: Hii, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis – Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi / che spiriti son questi che tu vedi?”», cioè “le turbe, ch’eran molte e grandi”, che sospirano nel Limbo (Inf. IV, 29, 31-32).
Al contrario di quella che grava su Babylon, la maledizione dei pastori non ha fatto perdere a Manfredi la speranza: “Per lor maladizion sì non si perde, / che non possa tornar, l’etterno amore, / mentre che la speranza ha fior del verde” (Purg. III, 133-135). Perderanno, invece, i Senesi la speranza di mantenere il controllo di Talamone e ancor più “vi perderanno li ammiragli” (i “gubernatores” dell’esegesi), secondo Sapìa (Purg. XIII, 151-154).
[1] G. CONTINI, Filologia ed esegesi dantesca (1965) in Un’idea di Dante. Saggi danteschi, Torino 1970 e 1976, p. 135.
[2] Cfr. le terzine di Inf. XXVI, 61-63 e Par. IX, 52-54, dove parole-chiave che rinviano all’esegesi di Ap 1, 7 (Piangevisi … ancor si duole, piangerà … ancora … sì che …) sono accompagnate, nel contesto, dal pronome atono riflessivo si, o dalla congiunzione sì che; il significato è diverso dalla locuzione affermativa sì, ma la funzione asseverativa, che accerta trattarsi di vero pianto o dolore, permane.
[3] Cfr. DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di N. SAPEGNO, Milano-Napoli 1957, pp. 64-65, nt. a vv. 100-107.
[4] CONTINI, Filologia ed esegesi dantesca (cfr. nt. 1), p. 141.
[5] “Rispondere” equivale a parlare – «“Et respondit” (Ap 7, 13), id est prolocutus est, “unus de senioribus”» -, nel senso di De vulgari eloquentia I, iv, 5, dove si afferma che Adamo fu il primo a rivolgersi a Dio anche se questi non gli aveva rivolto di per sé alcuna domanda: “cum dicimus superius per viam responsionis hominem primum fuisse locutum”. Secondo Gioacchino da Fiore, il vegliardo è lo stesso Giovanni edotto dall’angelo (cfr. Purg. XXIX, 143-144: “e di retro da tutti un vecchio solo / venir, dormendo, con la faccia arguta”).
[6] Il passo paolino (1 Cor 9, 24) è citato in Convivio IV, xxii, 6.
[7] Cfr. la traduzione italiana in VIAN, Pietro di Giovanni Olivi. Scritti scelti, pp. 130-132, che qui si segue in parte parafrasando con alcune abbreviazioni e varianti.
[8] Cfr. la traduzione italiana e la relativa bibliografia ibid., pp. 195-199, 210-217.
[9] PICONE, Canto V, p. 80.
[10] CONTINI, Filologia ed esegesi dantesca (cfr. nt. 1), pp. 140-141.
Tab. 8.1
[LSA, cap. I, Ap 1, 7 (Salutatio)] “Et videbit eum omnis oculus”, scilicet bonorum et malorum. Non quod eius deitatem videant, sed corpus assumptum in quo omnibus visibiliter et manifeste apparebit. Unde Matthei XXIV° dicitur: “Sicut fulgur exit ab oriente et apparet in occidente, ita erit adventus Filii hominis” (Mt 24, 27). Per hoc autem monstrat eum iudicaturum omnes tam bonos quam malos.
|
||
[segue Ap 1, 7] “Plangent”, inquam, “omnes tribus terre”. Secundum Ricardum, “tribus terre” vocat omnes terrena diligentes et terrena Christo preferentes*. Et ut certius sibi credatur confirmat hoc in duplici lingua, scilicet gentili et hebrea, dicendo: “Etiam. Amen”, id est vere plangent se. “Amen” enim est hebreum, sed “etiam” est latinum, pro quo est ibi adverbium grecum, quia hic liber fuit scriptus in greco. Utraque autem lingua, scilicet greca et latina, est gentilis. Per hec autem innuit quod in omni lingua fidelium hoc confirmabitur, et omnis lingua reproborum hoc clamabit experimento penarum compulsa.* In Ap I, ii (PL 196, col. 699 D). |
[LSA, cap. I, Ap 1, 6 (Salutatio)] “Amen”, id est sic fiat; vel “amen”, id est vere et fideliter sit ei.[LSA, cap. XXII, Ap 22, 20 (finalis conclusio totius libri)] Deinde ad magis confirmandum subdit: “Dicit”, scilicet predicta, “qui testimonium perhibet ipsorum”, scilicet Christus, secundum Ricardum: «Christus enim cuncta que in hoc libro sunt attestatur»*. Posset tamen dici quod Iohannes dicit hoc de se ipso. Nam et in fine evangelii sui consimiliter dicit: “Hic est discipulus ille qui testimonium perhibet de hiis” (Jo 21, 24), et sicut hic confirmative subdit: “Etiam. Amen”, sic et ibi subdit: “Et scimus quia verum est testimonium eius”. Posuit autem hebreum “amen”, et ultra hoc adver-bium grecum pro quo nos habemus latine “etiam”, ut innuat hoc omnimode et in omni lingua esse indubitabiliter asserendum.* In Ap VII, ix (PL 196, col. 884 C). |
|
|
|
||
Inf. V, 3, 100-105, 109, 126, 139-140e tanto più dolor, che punge a guaio.Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
|
Inf. XII, 131-136; XIII, 131-132, 137-138
……… infin ch’el si raggiunge
ove la tirannia convien che gema.
La divina giustizia di qua punge
quell’ Attila che fu flagello in terra,
e Pirro e Sesto; e in etterno munge
le lagrime, che col bollor diserra
e menommi al cespuglio che piangea
per le rotture sanguinenti in vano. ……
disse: “Chi fosti, che per tante punte
soffi con sangue doloroso sermo?”.
Inf. XVI, 22-24, 28-30, 52-53, 76-90
Qual sogliono i campion far nudi e unti,
avvisando lor presa e lor vantaggio,
prima che sien tra lor battuti e punti
E “Se miseria d’esto loco sollo
rende in dispetto noi e nostri prieghi”,
cominciò l’uno, “e ’l tinto aspetto e brollo”
Poi cominciai: “Non dispetto, ma doglia
la vostra condizion dentro mi fisse”
Così gridai con la faccia levata;
e i tre, che ciò inteser per risposta,
guardar l’un l’altro com’ al ver si guata.
“Se l’altre volte sì poco ti costa”,
rispuoser tutti, “il satisfare altrui,
felice te se sì parli a tua posta!
Però, se campi d’esti luoghi bui
e torni a riveder le belle stelle,
quando ti gioverà dicere ‘I’ fui’,
fa che di noi a la gente favelle”.
Indi rupper la rota, e a fuggirsi
ali sembiar le gambe loro isnelle.
Un amen non saria possuto dirsi
tosto così com’ e’ fuoro spariti;
per ch’al maestro parve di partirsi.
Inf. XVIII, 51-54, 58-63; XX, 25-27
“Ma che ti mena a sì pungenti salse?”.
Ed elli a me: “Mal volontier lo dico;
ma sforzami la tua chiara favella,
che mi fa sovvenir del mondo antico. ……
E non pur io qui piango bolognese;
anzi n’è questo loco tanto pieno,
che tante lingue non son ora apprese
a dicer ‘sipa’ tra Sàvena e Reno;
e se di ciò vuoi fede o testimonio, e
rècati a mente il nostro avaro seno”.
Certo io piangea, poggiato a un de’ rocchi
del duro scoglio, sì che la mia scorta
mi disse: “Ancor se’ tu de li altri sciocchi?”
Purg. XXX, 52-57; XXXI, 1-3, 10-15
né quantunque perdeo l’antica matre,
valse a le guance nette di rugiada
che, lagrimando, non tornasser atre.
“Dante, perché Virgilio se ne vada,
non pianger anco, non piangere ancora;
ché pianger ti conven per altra spada”.
“O tu che se’ di là dal fiume sacro”,
volgendo suo parlare a me per punta,
che pur per taglio m’era paruto acro ……
Poco sofferse; poi disse: “Che pense?
Rispondi a me; ché le memorie triste
in te non sono ancor da l’acqua offense”.
Confusione e paura insieme miste
mi pinsero un tal “sì” fuor de la bocca,
al quale intender fuor mestier le viste.
Inf. XXVI, 58-63
e dentro da la lor fiamma si geme
l’agguato del caval che fé la porta
onde uscì de’ Romani il gentil seme.
Piangevisi entro l’arte per che, morta,
Deïdamìa ancor si duol d’Achille,
e del Palladio pena vi si porta.
Par. IX, 52-54
Piangerà Feltro ancora la difalta
de l’empio suo pastor, che sarà sconcia
sì, che per simil non s’entrò in malta.
Par. VI, 76-78
Piangene ancor la trista Cleopatra,
che, fuggendoli innanzi, dal colubro
la morte prese subitana e atra.
Inf. XXXIII, 19-21, 42
però quel che non puoi avere inteso,
cioè come la morte mia fu cruda,
udirai, e saprai s’e’ m’ha offeso.
e se non piangi, di che pianger suoli?
Tab. 8.2
[LSA, cap. I, Ap 1, 7 (Salutatio)] “Plangent”, inquam, “omnes tribus terre”. Secundum Ricardum, “tribus terre” vocat omnes terrena diligentes et terrena Christo preferentes. Et ut certius sibi credatur confirmat hoc in duplici lingua, scilicet gentili et hebrea, dicendo: “Etiam. Amen”, id est vere plangent se. “Amen” enim est hebreum, sed “etiam” est latinum, pro quo est ibi adverbium grecum, quia hic liber fuit scriptus in greco. Utraque autem lingua, scilicet greca et latina, est gentilis. Per hec autem innuit quod in omni lingua fidelium hoc confirmabitur, et omnis lingua reproborum hoc clamabit experimento penarum compulsa. |
|
Inf. XVIII, 58-61E non pur io qui piango bolognese;
|
Inf. XXXII, 135-139; XXXIII, 10-12, 42“dimmi ’l perché”, diss’ io, “per tal convegno,
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 9.13-14 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Sequitur (Ap 7, 9): “Post h<e>c vidi turbam magnam”. Non dicit “post hec” ex hoc quod tota hec turba convertatur post predictos signatos, sed quia ista per imitationem sequetur illos tamquam perfectiores et exemplares, iuxta quod pedites in exercitu sequuntur equites et duces. “Quam dinumerare nemo poterat”, non quod sit simpliciter et secundum se numeri infiniti vel confusi, immo erit secundum legem Dei et secundum mensuram et proportionem ecclesiastice fabrice et eterne glorie mensuratus et prefixus. “Turbam”, inquam, non solum ex una gente vel lingua existente<m>, sed “ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis stantes ante tronum”, id est ante regiam dignitatem divine maiestatis designatam per tronum. Vel “ante tronum”, id est ante generalem ecclesiam Dei, vel ante supercelestem, vel ante priorem ecclesiam sanctorum. […]
|
|
Tab. 8.3
[LSA, cap. V, Ap 5, 9 (radix IIe visionis)] “Redemisti” (Ap 5, 9), inquam, “nos” non solum ex una gente, puta solos Iudeos, sed “ex omni tribu et lingua et populo et natione”. Tribus, secundum Ricardum, dicitur a tribus ordinibus gentium filiorum Noe, in quibus sunt septuaginta lingue. In singulis autem linguis sunt plures populi, et in unoquoque populo plurime nationes. Incipit ergo a generalibus, descendens per ordinem ad specialia*. Isidorus tamen, libro IX° Ethimologiarum, dicit tribus esse dictas ex hoc quod Romani in principio fuerunt a Romulo tripharie dispertiti, scilicet in senatores et milites et plebes*. Unde potest dici quod hic ascenditur a specialibus ad generaliora, ut natio contineat plures populos, et populus plures linguas, et lingua plures tribus. Unde una lingua Israel habebat duodecim tribus. Vel potius dicendum quod de tali ordine non curavit, sed solum significare electos communiter eligi de omni gente et urbe. Nam populus est proprie multitudo unius civitatis. Videtur tamen specialiter insinuare electos eligi communiter ex Iudeis et gentibus, ut per tribum et populum designentur Iudei, per linguas vero varias et nationes significet gentiles, quia lingue eorum ab hebrea lingua, que fuit lingua Adam, sunt divise. Ipsi etiam vivunt ut nati sunt unde, secundum Isidorum** et Papiam*, nationes sunt que, propriis nationibus terminate, gentes vocantur. Sciendum etiam quod per redemptos nos esse “ex omni tribu” non solum significatur nos electos esse de omni gente, sed etiam quod per singularem gratiam redemptoris sumus discreti et segregati a communi et perdita massa generis humani.* In Ap II, iii (PL 196, col. 758 B). * Etymologiarum IX, iv, 7 (ed. W. M. Lindsay, Oxonii 1911, vol. I) ** Ibid., IX, ii, 1; iv, 4 * Papias vocabulista (ed. Venetiis 1496), p. 216b. |
||
Inf. IV, 28-32, 46-47, 73-81ciò avvenia di duol sanza martìri,
|
Purg. VIII, 52-72Ver’ me si fece, e io ver’ lui mi fei:
|
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 9.13-14 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Sequitur (Ap 7, 9): “Post h<e>c vidi turbam magnam”. Non dicit “post hec” ex hoc quod tota hec turba convertatur post predictos signatos, sed quia ista per imitationem sequetur illos tamquam perfectiores et exemplares, iuxta quod pedites in exercitu sequuntur equites et duces. “Quam dinumerare nemo poterat”, non quod sit simpliciter et secundum se numeri infiniti vel confusi, immo erit secundum legem Dei et secundum mensuram et proportionem ecclesiastice fabrice et eterne glorie mensuratus et prefixus. “Turbam”, inquam, non solum ex una gente vel lingua existente<m>, sed “ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis stantes ante tronum”, id est ante regiam dignitatem divine maiestatis designatam per tronum. Vel “ante tronum”, id est ante generalem ecclesiam Dei, vel ante supercelestem, vel ante priorem ecclesiam sanctorum. […]
|
||
Inf. II, 16-21Però, se l’avversario d’ogne male
|
Inf. VII, 36-39; VIII, 7-9, 31-36; IX, 16-21, 124-126E io, ch’avea lo cor quasi compunto,
|
|
Tab. 8.4
[LSA, cap. VII, Ap 7, 9.13-14 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Sequitur (Ap 7, 9): “Post h<e>c vidi turbam magnam”. Non dicit “post hec” ex hoc quod tota hec turba convertatur post predictos signatos, sed quia ista per imitationem sequetur illos tamquam perfectiores et exemplares, iuxta quod pedites in exercitu sequuntur equites et duces. “Quam dinumerare nemo poterat”, non quod sit simpliciter et secundum se numeri infiniti vel confusi, immo erit secundum legem Dei et secundum mensuram et proportionem ecclesiastice fabrice et eterne glorie mensuratus et prefixus. “Turbam”, inquam, non solum ex una gente vel lingua existente<m>, sed “ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis stantes ante tronum”, id est ante regiam dignitatem divine maiestatis designatam per tronum. Vel “ante tronum”, id est ante generalem ecclesiam Dei, vel ante supercelestem, vel ante priorem ecclesiam sanctorum. […]
|
|
Purg. VII, 1-3, 7-9, 20-24Poscia che l’accoglienze oneste e liete
|
Par. XV, 58-60, 67-69e però ch’io mi sia e perch’ io paia
|
Tab. 8.5
[LSA, cap. VII, Ap 7, 13-14 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] “Et respondit” (Ap 7, 13), id est prolocutus est, “unus de senioribus”, per quem secundum Ricardum designatur universitas prophetarum et apostolorum et doctorum docens iustitiam et gloriam electorum. Et secundum hoc sumitur hic “unus” quasi loquens in persona omnium. Secundum vero Ioachim, iste “unus” est beatus Iohannes, cuius est liber iste. Ipse enim s<cis>citatur et excitat nos ad querendum et intelligendum et ad imitandum istos sanctos. Ipse est enim unus et magnus de hiis viginti quattuor senioribus. Nos sumus hic designati per ipsum in quantum edocebatur ab angelo tenente formam senioris. “Et dixit michi: Hii, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis, “et unde venerunt”, id est ex quibus meritis et per quam viam sanctitatis ad tantam gloriam pervenerunt?
|
|
Purg. VI, 64-75, 148-151Ella non ci dicëa alcuna cosa,
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 16 (VIIa visio)] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia”. Stadium est spatium in cuius termino statur vel pro respirando pausatur, et per quod curritur ut bravium acquiratur, secundum illud Apostoli prima ad Corinthios, capitulo IX°: “Nescitis quod hii, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium?” (1 Cor 9, 24), et ideo significat iter meriti triumphaliter obtinentis premium. Cui et congruit quod stadium est octava pars miliarii, unde designat octavam resurrectionis.
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 5 (radix IIe visionis)] Deinde subditur consolatoria promissio: “Et unus de senioribus dixit michi: Ne fleveris: ecce vicit”, id est victoriose promeruit et etiam per triumphalem potentiam prevaluit, “leo de tribu Iuda”, id est Christus de tribu Iuda natus ac invincibilis et prepotens et ad predam potenter resurgens sicut leo.
|
|
Tab. 8.6
[LSA, cap. VII, Ap 7, 9.13-14.16-17 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Sequitur (Ap 7, 9): “Post h<e>c vidi turbam magnam”. Non dicit “post hec” ex hoc quod tota hec turba convertatur post predictos signatos, sed quia ista per imitationem sequetur illos tamquam perfectiores et exemplares, iuxta quod pedites in exercitu sequuntur equites et duces. “Quam dinumerare nemo poterat”, non quod sit simpliciter et secundum se numeri infiniti vel confusi, immo erit secundum legem Dei et secundum mensuram et proportionem ecclesiastice fabrice et eterne glorie mensuratus et prefixus. “Turbam”, inquam, non solum ex una gente vel lingua existente<m>, sed “ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis stantes ante tronum”, id est ante regiam dignitatem divine maiestatis designatam per tronum. Vel “ante tronum”, id est ante generalem ecclesiam Dei, vel ante supercelestem, vel ante priorem ecclesiam sanctorum. […]
|
||
|
Par. XXX, 34-38Cotal qual io la lascio a maggior bando
|
|
[LSA, cap. IX. Ap 9, 17 (IIIa visio, VIa tuba)] Luxuria vero sic facit eos estimare vitam carnalem et opulentam esse felicem quod contrariam, quantum-cumque castam et sanctam, derident ut miseram et stolidam. |
Boezio, De consolatione philosophiae, II, pr. iv, 2: Sed hoc est quod recolentem vehementius coquit. Nam in omni adversitate fortunae infelicis-simum est genus infortunii fuisse felicem. |
|
Tab. 8.7
[LSA, cap. VII, Ap 7, 13-14.16-17 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] “Et respondit” (Ap 7, 13), id est prolocutus est, “unus de senioribus”, per quem secundum Ricardum designatur universitas prophetarum et apostolorum et doctorum docens iustitiam et gloriam electorum. Et secundum hoc sumitur hic “unus” quasi loquens in persona omnium. Secundum vero Ioachim, iste “unus” est beatus Iohannes, cuius est liber iste. Ipse enim s<cis>citatur et excitat nos ad querendum et intelligendum et ad imitandum istos sanctos. Ipse est enim unus et magnus de hiis viginti quattuor senioribus. Nos sumus hic designati per ipsum in quantum edocebatur ab angelo tenente formam senioris. “Et dixit michi: Hii, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis, “et unde venerunt”, id est ex quibus meritis et per quam viam sanctitatis ad tantam gloriam pervenerunt?
|
|
Inf. XXX, 58-63, 76-78, 91, 94-95“O voi che sanz’ alcuna pena siete,
|
Purg. XXXIII, 61-63, 127-129, 136-138Per morder quella, in pena e in disio
|
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 17 (finalis conclusio totius libri)] Septimo loquitur ut invitator omnium ad prefatam gloriam, et hoc tam per se quam per ecclesiam et eius doctores, unde subdit (Ap 22, 17): “Et sponsus”, id est, secundum Ricardum, Christus (quidam tamen habent “Spiritus”, et quidam correctores dicunt quod sic habent antiqui et Greci, ut sic Christus tam per se quam per Spiritum suum et eius internam inspirationem ostendat se invitare), “et sponsa”, id est generalis ecclesia tam beata quam peregrinans vel contemplativa ecclesia, “dicunt: veni”, scilicet ad nuptias. Ideo enim dixit “sponsa”, ut innueret nos invitari ad gloriosam cenam nuptiarum Agni. “Et qui audit”, scilicet hanc nostram invitationem, id est qui est de hiis sufficienter doctus; vel “qui audit”, id est recte et obedienter credit et opere perficit, “dicat”, scilicet unicuique vocandorum: “veni”, scilicet ad cenam et civitatem beatam.
|
|
[Ap 7, 17] Dicit autem de futuro “reget et deducet”, ut monstret eternam continuationem et perdura-tionem istorum actuum.[LSA], cap. XIX, Ap 19, 3 (VIa visio)] Deinde redit ad explicandum effectum et signum prefati iudicii et vindicte dicens: “Et fumus eius”, id est tenebrosa amaritudo tormentorum eius, “ascendit in secula seculorum”, id est sempiternaliter in sua altitudine et vivacitate perdurat. |
Par. I, 76-78Quando la rota che tu sempiterni
|
Tab. 8.8
[LSA, cap. XIX, Ap 19, 1.9 (VIa visio)] “Post hoc audivi”. Descripta Babilonis dampnatione, subditur hic festivale gaudium sancte ecclesie quod erit post dampnationem Babilonis. Sicut enim Vasti regina a regno et coniugio regis Assueri abiecta, electa est Hester humilis et sancta ad eiusdem regis conubium et regnum, fecitque ex hoc rex magnificum convivium cunctis principibus et servis suis (cfr. Est 2, 18), sic reiecta sinagoga electa est ecclesia plenitudinis gentium, sicque in sexto statu ecclesie reiecta Babilone adultera oportet spiritalem ecclesiam exaltari et celebre ac spiritale convivium pro eius nuptiis celebrari. In hac igitur parte primo narratur gaudium ex iusta dampnatione Babilonis et ex liberatione sanctorum a servitute ipsius proveniens. Secundo subditur gaudium de exaltatione et clarificatione regni Christi et ex nuptiis Christi et spiritalis ecclesie procedens, ibi: “Et audivi quasi vocem tube magne” (Ap 19, 6). […] Quam gloriosum autem sit esse in hiis nuptiis vult nobis confirmari non solum verbo, sed etiam autentico et indel<e>bili scripto, unde subdit (Ap 19, 9): “Et dixit michi:”, scilicet angelus qui vocem laudis predicte formaverat similem tube, “scribe: Beati qui ad cenam nuptiarum Agni vocati sunt”. Non dicit ‘ad prandium’ sed “ad cenam”, quia hoc convivium in fine secundi status generalis erit, ut sit trina cena Christi: prima scilicet in fine legis veteris seu primi status generalis, secunda in fine secundi, tertia vero in fine seculi seu in eterna patria. Ut autem sibi firmius credatur, subdit: “Et dixit michi: Hec verba Dei”, que scilicet premisi, “vera sunt”, quasi dicat: tanto maiori fide hec que dixi credere debetis quanto ea et Dei esse et vera esse manifestius auditis. Hec autem signanter sic confirmat, quia difficile est credere quod tales nuptie et iubilationes sint tunc fiende, immo carnales et animales hoc derident et est eis quasi fabulosum. |
|
Par. XXIII, 133-135; XXIV, 1-9Quivi si vive e gode del tesoro
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 20 (VIIa victoria)] “Si quis audierit”, id est cordaliter seu obedienter receperit, “vocem meam”, scilicet monitionum mearum predictarum, “et aperuerit michi ianuam”, id est viscerales consensus et affectus cordis sui, “intrabo ad illum”, scilicet per influxus et illapsus gratie, “et cenabo cum illo”, scilicet acceptando et amative michi incorporando ipsum et omnia bona eius tamquam cibos michi amabiles et suaves, “et ipse mecum”, scilicet me et meam dulcedinem et boni-tatem iocunde gustando et comedendo ac bibendo et incorporando.
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 16-17 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] “Non esurient neque sitient amplius” (Ap 7, 16), scilicet respectu corporalis cibi et potus et respectu cuiuscumque penalis desiderii aut cuiuscumque desiderii non habentis plene et indistanter quod optat. Alias enim semper esuriunt et sitiunt Deum suum et gloriam eius. “Neque cadet super illos sol”, scilicet per nimium ardorem affligens, “neque ullus estus”, id est a nullo interiori defectu, qualis est esuries vel sitis, nec ab aliquo exteriori magno vel parvo affligentur.
|
|
Tab. 8.9.1
[LSA, cap. VII, Ap 7, 9.13-14 (apertio VIi sigilli)] Sequitur (Ap 7, 9): “Post h<e>c vidi turbam magnam”. Non dicit “post hec” ex hoc quod tota hec turba convertatur post predictos signatos, sed quia ista per imitationem sequetur illos tamquam perfectiores et exemplares, iuxta quod pedites in exercitu sequuntur equites et duces. “Quam dinumerare nemo poterat”, non quod sit simpliciter et secundum se numeri infiniti vel confusi, immo erit secundum legem Dei et secundum mensuram et proportionem ecclesiastice fabrice et eterne glorie mensuratus et prefixus. “Turbam”, inquam, non solum ex una gente vel lingua existente<m>, sed “ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis stantes ante tronum”, id est ante regiam dignitatem divine maiestatis designatam per tronum. Vel “ante tronum”, id est ante generalem ecclesiam Dei, vel ante supercelestem, vel ante priorem ecclesiam sanctorum. […]
|
||
| Purg. VII, 1-3 (1)
Poscia che l’accoglienze oneste e liete
|
Purg. XIV, 1-6 (1-2)
“Chi è costui che ’l nostro monte cerchia |
|
| Inf. VIII, 7-9 (3)
E io mi volsi al mar di tutto ’l senno; |
Purg. VII, 7-9
“Io son Virgilio; e per null’ altro rio |
|
| Inf. II, 16-18 (6)
Però, se l’avversario d’ogne male
|
Inf. IX, 19-21 (7)
Questa question fec’ io; e quei: “Di rado |
Purg. XXVI, 16-21 (6-7)
“O tu che vai, non per esser più tardo, |
| Purg. XXVI, 25-27 (9)
Sì mi parlava un d’essi; e io mi fora |
Par. XVI, 25-27
ditemi de l’ovil di San Giovanni |
|
| Inf. XV, 29-30 (10)
e chinando la mano a la sua faccia, |
Purg. XVI, 25-30 (9-10)
“Or tu chi se’ che ’l nostro fummo fendi,
|
Par. XVI, 25-30 (9-10)
“ditemi de l’ovil di San Giovanni |
Tab. 8.9.2
[Ap 7, 9.13-14] Sequitur (Ap 7, 9): “Post h<e>c vidi turbam magnam”. Non dicit “post hec” ex hoc quod tota hec turba convertatur post predictos signatos, sed quia ista per imitationem sequetur illos tamquam perfectiores et exemplares, iuxta quod pedites in exercitu sequuntur equites et duces. “Quam dinumerare nemo poterat”, non quod sit simpliciter et secundum se numeri infiniti vel confusi, immo erit secundum legem Dei et secundum mensuram et proportionem ecclesiastice fabrice et eterne glorie mensuratus et prefixus. “Turbam”, inquam, non solum ex una gente vel lingua existente<m>, sed “ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis stantes ante tronum”, id est ante regiam dignitatem divine maiestatis designatam per tronum. Vel “ante tronum”, id est ante generalem ecclesiam Dei, vel ante supercelestem, vel ante priorem ecclesiam sanctorum. […]
|
||
| Inf. III, 31-33 (11)
E io ch’avea d’error la testa cinta, |
Inf. IV, 31-33
Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi |
Inf. XIX, 31-33
“Chi è colui, maestro, che si cruccia |
| Inf. IV, 46-48 (16)
“Dimmi, maestro mio, dimmi segnore”, |
Inf. XV, 46-48 (16)
El cominciò: “Qual fortuna o destino |
Inf. XXII, 43-48 (15-16)
E io: “Maestro mio, fa, se tu puoi, |
| Par. VIII, 43-48 (15-16)
rivolsersi a la luce che promessa |
Par. XVI, 43-45 (15)
Basti d’i miei maggiori udirne questo: |
Par. XXV, 43-48 (15-16)
“sì che, veduto il ver di questa corte, |
| Inf. V, 50-51 (17)
per ch’i’ dissi: “Maestro, chi son quelle
|
Inf. XXVI, 49-54 (17-18)
“Maestro mio”, rispuos’ io, “per udirti |
|
| Inf. XIX, 58-60 (20)
Tal mi fec’ io, quai son color che stanno, |
Par. XV, 58-60
e però ch’io mi sia e perch’ io paia |
Par. XXXI, 58-60
Uno intendëa, e altro mi rispuose: |
Tab. 8.9.3
[Ap 7, 9.13-14] Sequitur (Ap 7, 9): “Post h<e>c vidi turbam magnam”. Non dicit “post hec” ex hoc quod tota hec turba convertatur post predictos signatos, sed quia ista per imitationem sequetur illos tamquam perfectiores et exemplares, iuxta quod pedites in exercitu sequuntur equites et duces. “Quam dinumerare nemo poterat”, non quod sit simpliciter et secundum se numeri infiniti vel confusi, immo erit secundum legem Dei et secundum mensuram et proportionem ecclesiastice fabrice et eterne glorie mensuratus et prefixus. “Turbam”, inquam, non solum ex una gente vel lingua existente<m>, sed “ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis stantes ante tronum”, id est ante regiam dignitatem divine maiestatis designatam per tronum. Vel “ante tronum”, id est ante generalem ecclesiam Dei, vel ante supercelestem, vel ante priorem ecclesiam sanctorum. […]
|
||
| Purg. VI, 67-69 (23)
Pur Virgilio si trasse a lei, pregando |
Par. XV, 67-69
la voce tua sicura, balda e lieta |
|
| Inf. III, 72-73 (24-25) per ch’io dissi: “Maestro, or mi concedi ch’i’ sappia quali sono ……………….” |
Inf. IV, 73-75 (25)
O tu ch’onori scïenzïa e arte, |
Purg. I, 73-75 (25)
Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara |
| Inf. XIV, 103-105 (35)
Dentro dal monte sta dritto un gran veglio, |
Inf. XXV, 103-105
Insieme si rispuosero a tai norme, |
Par. XXXII, 103-105
qual è quell’ angel che con tanto gioco |
| Inf. XIV, 133-135 (45)
“In tutte tue question certo mi piaci”, |
Inf. XXIX, 133-135
Ma perché sappi chi sì ti seconda |
|
Tab. 8.10
[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 10-12.14.17.19 (VIa visio)] Et ideo convertentur ad luctum “dicentes”, scilicet plangendo: “Ve, ve, ve” (Ap 18, 10), id est summa et summe stupenda et lugenda maledictio et dampnatio est ista, scilicet “civitas illa magna Babilon, civitas illa fortis, quoniam una hora venit iudicium tuum”, id est tota dampnatio tua! Loquuntur autem primo de ea in tertia persona et postea in secunda secundum modum plangentium et stupentium, qui primo stupent secum et mox vertunt considerationem suam quasi ad personam quam plangunt. Triplicatio autem dolorose interiectionis, scilicet ipsius “ve”, significat vehementiam stuporis et planctus et casus quem plangunt et etiam consuetum modum graviter plangentium. Et potest legi: Ve, ve, ve, civitas illa magna, quomodo sic cecidit vel cecidisti! […]
|
|
Inf. I, 52-60questa mi porse tanto di gravezza
|
Inf. IV, 31-42Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi 7, 13
|
9. Il dubbio ingannatore
“Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, / a che e come concedette amore / che conosceste i dubbiosi disiri?” (Inf. V, 118-120; tab. 9.1).
Secondo il principio della concorrenza tra gli stati [1], affermato nel Notabile X del prologo della Lectura super Apocalipsim, il sesto stato – cioè il periodo in cui vivono Olivi e Dante e che è iniziato con Francesco d’Assisi [2] – concorre con il secondo, per antonomasia lo stato dei martiri, non per connessione temporale (questo inizia infatti con la persecuzione di Nerone o con la lapidazione di santo Stefano o con la passione di Cristo e dura fino alla pax costantiniana), ma a motivo della quantità dei testimoni della fede. Il tipo di martirio è tuttavia diverso. I martiri del sesto stato soffrono nel dubbio, il loro è un “certamen dubitationis” che i primi testimoni della fede non provarono per l’evidenza dell’errore in cui incorrevano gli idolatri pagani. Nel sesto stato il martire non prova soltanto il tormento del corpo, viene anche spinto (“propulsabuntur martires”) dalla sottigliezza degli argomenti filosofici, dalle distorte testimonianze scritturali, dall’ipocrita simulazione di santità, dalla falsa immagine dell’autorità divina o papale, in quanto falsi pontefici insorgono, come Anna e Caifa insorsero contro Cristo. Per rendere più intenso il martirio, i carnefici stessi operano miracoli. Tutto ciò appartiene alla tribolazione del tempo dell’Anticristo, alla tentazione che induce in errore persino gli eletti, come testimoniato da Cristo nella grande pagina escatologica di Matteo 24, 24: “dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi”. Scrive Gregorio Magno nei Moralia, commentando Giobbe 40, 12 – “stringe (nel senso di tendere) la sua coda come un cedro” -: “ora i nostri fedeli fanno miracoli nel patire perversioni, allora i seguaci di Behemot faranno miracoli anche nell’infliggerle. Pensiamo perciò quale sarà la tentazione della mente umana allorché il pio martire sottoporrà il corpo ai tormenti mentre davanti ai suoi occhi il carnefice opererà miracoli”.
■ Del tema del martirio inferto dal dubbio è pregno, in Inf. V, l’episodio di Francesca e Paolo, d’altronde principalmente ordito su temi del secondo stato. I “dubbiosi disiri” [3] vengono conosciuti mentre i due amanti leggono “di Lancialotto come amor lo strinse”, quella lettura “per più fïate li occhi ci sospinse”. Vinti dalla passione, essi non arrivano a sostenere fino in fondo il loro “certamen dubitationis”. Se è vero che al secondo e al sesto stato spetta il martirio e al tempo stesso la dolcezza del conforto e della promessa (ad Ap 3, 11), i “dolci sospiri” dei due amanti sono stati da loro male interpretati, nel senso dell’amore carnale e non dell’“amore acceso di virtù” di cui Virgilio avrebbe parlato a Dante nel purgatorio (cfr. Purg. XVIII, 13-75; XXII, 10-12). Al momento della prova, i due vengono sospinti dalla lettura di un libro (“Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse”) verso un punto che li vince, non diversamente da come i nuovi martiri vengono sospinti dagli “intorta testimonia scripturarum”.
“Per più fïate li occhi ci sospinse / quella lettura, e scolorocci il viso” (Inf. V, 131-132). Il pallore degli amanti, cantato da Ovidio (Ars amatoria I, 729: “palleat omnis amans: hic est color aptus amanti”), definito da Andrea Cappellano (De amore II, 8, reg. xv: omnis consuevit amans in coamantis aspectu pallescere”), è qui segnato dal pallore della morte, figurata nel cavallo pallido e magro all’apertura del quarto sigillo (Ap 6, 8). Dietro alle parole di Francesca appare, in filigrana, l’immagine della lupa omicida.
Ma il martirio non è stato inferto solo ai “due cognati” in vita, perché anche Dante sta dinanzi a loro come un pio martire del sesto stato: prova pietà del loro “male perverso” (cioè dei tormenti inusitati loro comminati in pena) [4], è “tristo e pio” fino alle lacrime dinanzi ai “martìri”, per la pietà viene meno (“sì che di pietade / io venni men così com’ io morisse. / E caddi come corpo morto cade”; cfr. infra) prova un’angoscia che chiude la mente. Perfino la domanda di Virgilio dopo le prime parole di Francesca – “Che pense?” – sembra parodiare l’invito di Gregorio Magno a riflettere sulla singolarità della tentazione: “… tunc autem Behemot huius satellites, etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit humane mentis illa temptatio, quando pius martir corpus tormentis subicit, et tamen ante eius oculos miracula tortor facit”.
Grande motivo del canto, la pietà ha già toccato Dante ascoltando Virgilio che nomina “le donne antiche e’ cavalieri”: “pietà mi giunse e fui quasi smarrito” (Inf. V, 72). Anticipo del venir meno nel finale del canto, il termine smarrito, già occorso due volte nel poema (Inf. I, 3; II, 64), rinvia all’esegesi dell’istruzione data al torpido vescovo di Sardi, la quinta delle sette chiese d’Asia (Ap 3, 2-3).
Motivi che non sono stati estranei a Virgilio, conforto “al mio dubbiare” nel momento di discendere “nel cieco mondo”, allorché Dante si accorge di un colore smorto nel viso che è in realtà pietà per “l’angoscia de le genti / che son qua giù” (Inf. IV, 16-22: cfr. il “ne sospigne” della via, che è “cammino … de la pietate”, cioè di tentazioni subdole, con il “ci sospinse” nella lettura del libro ‘galeotto’).
■Il tema del “certamen dubitationis” subisce molte variazioni nella Commedia. È accompagnato in vario modo dai motivi compresenti nel Notabile X: il tormento, gli occhi, il pensare, lo stringere, l’essere spinti, la sottigliezza, gli argomenti scritturali, l’immagine torta, la meraviglia.
Stringere e dubitare sono insieme nella schiera degli scomunicati, stretti all’alta e dura parete della montagna (Purg. III, 70-72). Il tormento dei superbi, rannicchiati a terra sotto il peso dei macigni, provoca una “tencione” negli occhi di Virgilio, incerti se paiano o meno persone (Purg. X, 115-117).
Il vecchio dubbio di Dante sulla giustificazione per la fede (con la conseguente questione della salvezza degli infedeli giusti) viene sciolto dall’aquila, che s’assottiglia su quel mistero, con riferimento all’autorità della Scrittura, senza la quale “da dubitar sarebbe a maraviglia” (Par. XIX, 32-33, 82-84). Si meraviglia il poeta nel sentire che Traiano e Rifeo Troiano sono fra i beati: il “dubbiar … con la forza del suo peso” gli “pinse” le parole, “tempo aspettar tacendo non patio” (Par. XX, 79-84). Ma non è un perverso patire. L’aquila, immagine e segno, non è depositaria degli “intorta testimonia scripturarum sanctarum” che hanno ‘spinto’ gli occhi dei due amanti, né si nasconde “per falsam imaginem divine et pontificalis auctoritatis” dalla quale Guido da Montefeltro è stato ingannato.
San Bernardo scioglie il dubbio, che annoda ‘stringendo’ “li pensier sottili” del poeta, sulla differente distribuzione dei bambini nei vari gradi della rosa celeste (Par. XXXII, 49-51).
■ La figura di Gerione, che viene in su nuotando per l’“aere grosso e scuro”, è “maravigliosa ad ogne cor sicuro” (Inf. XVI, 132), cioè tale da sgomentare anche un animo saldo, e corrisponde all’operare meraviglie da parte del carnefice di fronte al tormentato degli ultimi tempi. L’essere sicuri è un tema precipuo dei martiri, proposto alla seconda chiesa ad Ap 2, 11, contrapposto alla tristezza del cuore atterrito dalla “seconda morte”.
Nel periodo dell’Anticristo, o in quello che precede di poco l’apertura del sesto sigillo, gli eletti patiranno un tale aggrovigliarsi delle coscienze da essere indotti nell’errore. Così Gregorio Magno, commentando il passo di Giobbe 40, 12 (lo stesso passo citato nel Notabile X del prologo) – “Nervi testiculorum eius perplexi sunt” -, spiega che gli argomenti dei predicatori dell’Anticristo, allo scopo di attirare i buoni, sono annodati, quasi come nervi intrecciati, con asserzioni dolose che non è possibile sciogliere e che guastano i cuori con le parole mostrando innocenza nell’operare (ad Ap 5, 5). Questo aggrovigliarsi si trasforma nei nodi e nelle rotelle di cui Gerione ha dipinto il dorso, il petto e i fianchi: la fiera, “sozza imagine di froda”, ha la faccia di uomo giusto con pelle di fuori benigna (Inf. XVII, 10-15). Ma lo stesso motivo può essere ‘torto’ in bonam partem e ritrovarsi in Dante irretito in dubbi sciolti da Virgilio (sull’ordinamento dell’inferno, Inf. XI, 91-96) e da Beatrice (nell’ascesa al cielo, Par. I, 94-99).
■ Tace il tema del dubbio, ma contiene molti altri motivi tratti dal Notabile X (l’appello al lettore affinché rifletta, la pietà del martire che patisce tormentato da una falsa e mirabile immagine, da qualcosa di distorto), la descrizione del pianto di Dante, nuovo martire, di fronte agli indovini che col capo stravolto camminano all’indietro nella quarta bolgia, pianto che Virgilio riprende come sciocco, perché “qui vive la pietà quand’ è ben morta” (Inf. XX, 19-30 25-28; è da notare l’accostamento di “io piangea” ad “ancor”, proprio di altri luoghi del poema, da Ap 1, 7). I versi 29-30 – “chi è più scellerato che colui / che al giudicio divin passion comporta?” sono stati esaminati insieme all’intero canto.
La meraviglia di Virgilio al vedere Caifa crocifisso nella sesta bolgia (degli ipocriti) – “Allor vid’ io maravigliar Virgilio / sovra colui ch’era disteso in croce / tanto vilmente ne l’etterno essilio” (Inf. XXIII, 124-126) – è dovuta letteralmente al fatto che, quando Virgilio era sceso per la prima volta nel basso inferno (Inf. IX, 22-30; XII, 34-36), Cristo non era stato ancora crocifisso e dunque il poeta pagano non aveva potuto vedere Caifa punito. Il senso spirituale è altro. Virgilio prova la meraviglia che si insinua nel martirio del sesto stato. Nel vedere Caifa, il sommo pontefice crocifisso che allo scorgere Dante, anch’egli ammirato, “tutto si distorse”, Virgilio prova il martirio di chi, nel sesto stato, vede cose mirabili che in realtà sono “intorta testimonia scripturarum sanctarum”, allorché falsi pontefici insorgono, come Anna e Caifa insorsero contro Cristo. La meraviglia si accompagna, in Virgilio, all’irato turbamento (e quindi all’incertezza, al dubbio) per essere stato ingannato dai diavoli bugiardi circa il ponte rotto sopra la sesta bolgia (Inf. XXIII, 139-146), turbamento che fa sbigottire anche Dante, ma che subito si muta in sicurezza nella salita all’argine della settima bolgia (Inf. XXIV, 1-30).
■Il “punto”, nel quale Lancillotto (secondo Dante, che inverte il rapporto) bacia Ginevra, corrisponde falsamente all’ardua visione dello splendore del volto di Cristo, che riluce come il sole in tutta la sua virtù e che nel sesto stato deve raggiare in tutta la sua chiarezza, imprimendo in chi guarda un senso di tremore (cfr. infra). Anche l’autore dell’Imitazione di Cristo – opera nella quale la dimensione escatologica è del tutto assente – mette in guardia dalle tentazioni (I, xiii). Ma si tratta di quelle tribolazioni da cui nessuno è esente, per cui è scritto nel libro di Giobbe: “La vita dell’uomo sulla terra è tentazione” (Jb 7, 1). Nulla di simile al dubbio ingannatore di cui parla Olivi, dietro al quale può celarsi l’eterna perdizione tramite una falsa Scrittura (Francesca e Paolo), una falsa immagine di autorità pontificale o sacra (Guido da Montefeltro, che non diffidò di Bonifacio VIII; e il conte Ugolino, che si fidò dell’arcivescovo Ruggieri), un sentimento di pietà che deve vivere solo quand’è morta (Dante, e lo stesso Virgilio), o di inadeguatezza nel momento in cui non si deve negare il nome di Cristo (“colui / che fece per viltade il gran rifiuto”).
Nel corso del viaggio, anche il dubbio perde progressivamente questo valore voraginoso; i nodi e gli attorcigliamenti delle coscienze (cfr. Ap 5, 5) restano sottili ma sono meno drammatici. Esiste anche il dubbio che “nasce … a piè del vero … ed è natura / ch’al sommo pinge noi di collo in collo” (Par. IV, 130-132). Lo stesso panno esegetico qui è torto in senso positivo, di appagamento (con la guida, in questo caso Beatrice) dell’intelletto illuminato dal “ver … di fuor dal qual nessun vero si spazia” (vv. 125-126), e concordato con quanto scrive Aristotele sulla necessità del dubbio (Metafisica, B 1, 995a, 24-34).
■ Lo stesso passo dei Moralia di Gregorio Magno su Giobbe 40, 12, citato nel Notabile X del prologo della Lectura super Apocalipsim, era già stato utilizzato dall’Olivi nell’Expositio in Canticum Canticorum (sicuramente precedente, poiché la Lectura venne completata nel 1298, anno della morte) [5]. Come vari luoghi della Commedia, primi fra essi Inf. V, rinviano alla citazione di Gregorio Magno incastonata nell’esegesi della Lectura super Apocalipsim, così sull’Expositio in Canticum Canticorum è tessuta in parte la Donna Gentile o Pietosa della Vita Nova, l’antagonista di Beatrice, che può essere così messa a confronto con Francesca.
“a che e come concedette amore …” (Inf. V, 119; tab. 9.2).
La causa efficiente del libro dell’Apocalisse è quadruplice. La principale è Dio, la secondaria Cristo in quanto uomo, l’intermedia l’angelo, la prossima Giovanni. Così si dice della “rivelazione di Gesù Cristo”, cioè fatta da Cristo, “che Dio gli diede”, che gli fu data dal Padre e da tutta la Trinità non solo per sua conoscenza ma “per render noto”, ossia per manifestare, “ai suoi servi le cose che è necessario avvengano presto”.
Parlando di “necessità” si tocca anche la causa materiale, costituita dagli eventi futuri, necessari non in senso assoluto, bensì rispetto all’infallibilità della prescienza divina, all’utilità e alla necessità della Chiesa, alla giustizia distributiva, alla malizia dei reprobi. Questi eventi futuri è necessario avvengano “presto” sia perché cominciano e continuano e si compiono senza interruzione; sia perché il tempo, comparato all’eternità, è quasi un momento; sia perché il tempo della nuova legge, rispetto ai tempi precedenti, viene computato come “l’ultima ora”, secondo quanto detto nella prima lettera di Giovanni (1 Jo 2, 18 “novissima hora est”).
Si soggiunge la causa intermedia e poi quella prossima, dicendo: “e che egli”, cioè Cristo, “manifestò”, cioè rivelò o mostrò per mezzo di segni figurali, “inviando il suo angelo”, per annunziare tali cose, “al servo suo Giovanni”.
■ A Dante è appropriato il tema della singolare grazia concessa da Dio a Cristo perché riveli quel che è arcano e incomprensibile: a lui viene infatti ‘concesso’ per grazia di vedere i troni del trionfo eterno prima di abbandonare il militare terreno (Par. V, 115-117) e di venire d’Egitto in Gerusalemme (Par. XXV, 55-57).
A Par. V l’espressione “ben nato”, oltre che alla “beatitudo”, causa finale del libro, rinvia anche all’interpretazione del nome “Beniamin”, il figlio di Rachele chiamato dapprima dalla madre “Bennoni”, cioè figlio del dolore, perché nel darlo alla luce morì. Alla tribù di Beniamino è appropriata la pace, nella quale la mente muore a sé stessa e passa alla destra di Dio. Ben, con o senza nati, è accostato a pace a Purg. III, 73-74 e V, 60-61.
Il tema del concedere da parte di Dio (Ap 1, 1) e della dignità di Giovanni, testimone del Verbo divino e insieme dell’umanità di Cristo (Ap 1, 2), è appropriato a sé stesso da Dante, dubbioso nel fare il viaggio proposto da Virgilio e accettato con troppa fretta: “Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede? / Io non Enëa, io non Paulo sono; / me degno a ciò né io né altri ’l crede” (Inf. II, 31-33; cfr. la richiesta a Virgilio circa le genti in riva all’Acheronte: «per ch’io dissi: “Maestro, or mi concedi / ch’i’ sappia quali sono …”», Inf. III, 72-73). “Lo tempo è poco omai che n’è concesso, / e altro è da veder che tu non vedi”, afferma Virgilio nel lasciare la nona bolgia (Inf. XXIX, 11-12).
‘Concedere’ è proprio di Dio e del suo provvedere. Cacciaguida, che pure in quanto beato va da tempo “leggendo del magno volume / du’ non si muta mai bianco né bruno” (Par. XV, 50-51), avrebbe voluto che almeno vi fosse stato mutato il destino di Buondelmonte, cosicché costui fosse morto, affogato nella sua Val di Greve, prima di entrare nella pacifica Firenze: “Molti sarebber lieti, che son tristi, / se Dio t’avesse conceduto ad Ema / la prima volta ch’a città venisti. / Ma conveniesi, a quella pietra scema / che guarda ’l ponte, che Fiorenza fesse / vittima ne la sua pace postrema” (Par. XVI, 142-147). “Ma conveniesi … oportet fieri”, cioè era utile e necessario, che Firenze piangesse.
■ A Francesca e a Paolo Amore “concedette” di conoscere i “dubbiosi disiri” (Inf. V, 118-120), ma fu un concedere male interpretato dai due amanti, nel senso dell’amore carnale.
“Ma s’a conoscer la prima radice / del nostro amor tu hai cotanto affetto, / dirò come colui che piange e dice” (Inf. V, 124-126; tab. 9.3).
Il terzo stato dei dottori concorre con il quarto degli anacoreti, è anzi il più evidente esempio del fenomeno per cui un periodo storico continua nel successivo, come questo ha radici nel precedente (prologo, Notabile X). La trattazione della terza e della quarta guerra (Ap 12, 13-16) avviene infatti congiuntamente, e in essa alla donna, figura della Chiesa, vengono date due ali di una grande aquila, per combattere da una parte le eresie con il lume dei dottori, dall’altra l’affluenza dei beni temporali con la santità di vita degli anacoreti. Le cronache dimostrano la loro concorrenza. Ad esempio, l’anacoreta Antonio e il dottore Atanasio fiorirono entrambi al tempo di Costantino. Ilario e Ambrogio furono contemporanei di Macario e di altri anacoreti. San Basilio, grande dottore, visse nello stesso periodo di Gregorio Nazianzeno, anch’egli grande dottore e autore di una regola monastica assai rigida. Così al tempo di Gregorio Magno molti furono gli austeri anacoreti.
Come l’affetto presuppone la “notitia intellectus”, cioè la conoscenza, poiché non si può amare se non ciò che è già conosciuto, ma questa conoscenza non è santa senza un santo affetto, così il chiaro lume dei dottori precede l’esercizio degli affetti e la contemplazione degli anacoreti, ma non può essere chiaro senza l’eccellenza della vita propria di questi. Pertanto i due stati, entrambi di solare sapienza, concorrono, con mutuo ossequio, ad illuminare e ad infiammare l’orbe convertito nel mezzogiorno.
■ Nella domanda di Dante a Francesca – “a che e come concedette amore / che conosceste i dubbiosi disiri?” (Inf. V, 119-120) – viene premesso il conoscere al desiderio, l’intelletto all’affetto. I peccatori carnali sono quelli “che la ragion sommettono al talento”, cioè pospongono l’intelletto all’affetto o al desiderio (v. 39): nella sua domanda il poeta sembra voler ripristinare il corretto ordine. La risposta di Francesca – “Ma s’a conoscer la prima radice / del nostro amor tu hai cotanto affetto, / dirò come colui che piange e dice” (vv. 124-126) – fa riferimento sia alla conoscenza come al desiderio, ma sembra accentuare quest’ultimo (“cotanto affetto”).
■ In Inf. VII, 52-54, a Dante che vorrebbe riconoscere qualcuno fra gli avari e i prodighi, Virgilio risponde che “la sconoscente vita che i fé sozzi, / ad ogne conoscenza or li fa bruni”: l’espressione “sconoscente vita”, cioè la vita priva dell’intelletto che discerne, contiene in sé i motivi dell’intelletto e dell’affetto (la santa vita) propri rispettivamente dei dottori e degli anacoreti. Alle schiere degli avari e dei prodighi è inoltre assegnata una pena per cui percorrono, facendo rotolare pesi col petto, la metà del quarto cerchio fino al punto in cui cozzano insieme scambiandosi ingiurie, per poi tornare indietro a ripercuotersi nel punto diametralmente opposto. I due punti del cerchio, che distinguono la loro pena, segnano anche la concorrenza delle due schiere, quasi entrambe abbiano un solo orizzonte e diversi emisferi, non molto diversamente da quanto avviene nella posizione astronomica di Gerusalemme e della montagna del purgatorio, poste agli antipodi e nel mezzo di due emisferi opposti, come descritta da Virgilio in Purg. IV, 61-75 (cfr. Inf. XX, 124-126).
L’intelletto e l’affetto sono complementari nell’episodio dell’incontro con Casella (che, come quello di Francesca, registra la prevalenza dei temi del secondo stato dei martiri): “Io vidi una di lor trarresi avante / per abbracciarmi, con sì grande affetto … Soavemente disse ch’io posasse; / allor conobbi chi era …”. L’affetto di Casella precede l’agnizione da parte di Dante, che è seguita da nuova manifestazione di affetto: «Rispuosemi: “Così com’ io t’amai / nel mortal corpo, così t’amo sciolta”» (Purg. II, 76-90).
Il precedere della “notitia intellectus”, cioè della conoscenza, rispetto all’affetto, poiché non si può amare se non quanto si è preventivamente conosciuto, trova un’applicazione nelle parole con cui Beatrice, spiegando nel Primo Mobile le gerarchie angeliche, afferma che la beatitudine si fonda “ne l’atto che vede, / non in quel ch’ama, che poscia seconda” (Par. XXVIII, 109-111; cfr. XXIX, 139-141), asserzione che solo apparentemente accetta la dottrina tomista in contrasto col volontarismo francescano (ad Ap 21, 22 Olivi afferma la concorrenza, nella visione di Dio, del “lumen” con il “beatificus actus caritatis”).
Ancora, “lo ’ntelletto / de le prime notizie … e de’ primi appetibili l’affetto”, cioè la disposizione a conoscere e ad amare, sono innate nell’uomo (nell’uomo razionale: prologo, Notabile I), come detto da Virgilio nella spiegazione razionale data del rapporto tra amore e libero arbitrio (Purg. XVIII, 55-60).
La concorrenza tra il lume dei dottori e la santa ed eccellente vita degli anacoreti è impersonata in Carlo Martello, “la vita di quel lume santo” (Par. IX, 7). I temi sono poi ripresi e variati da Cunizza: “vedi se far si dee l’omo eccellente, / sì ch’altra vita la prima relinqua” (vv. 41-42), nel senso che l’uomo razionale, che designa i dottori, deve avere vita santa, propria degli anacoreti. Ciò è detto di Folchetto, trovatore e vescovo di Tolosa, di cui rimase “grande fama” per l’uno e per l’altro operare, concorrendo in questo il chiaro lume dell’intelletto e la santa vita affettiva.
Si tratta di motivi che vengono variamente appropriati nel cielo del Sole: Tommaso d’Aquino è “luce” che narra la “mirabil vita” di Francesco, “anima preclara” (Par. XI, 115), “poverel di Dio” (Par. XIII, 32-33), verso la cui “eccellenza” l’Aquinate “fu sì cortese” (Par. XII, 109-111). Tale “infiammata cortesia” muove “la vita” di Bonaventura ad elogiare (“inveggiar”, da invidiare nel senso di emulari in bono, come nell’esegesi di Ap 3, 19) san Domenico (vv. 142-145). Nel reciproco elogio dei fondatori del proprio ordine, Tommaso e Bonaventura concorrono anch’essi “ad mutuum obsequium (la “cortesia”) et ad meridiem universi orbis tunc ad fidem conversi simul clarificandam et inflammandam”. Nel Paradiso terrestre, allorché il sole tiene il cerchio di mezzogiorno “più corusco e con più lenti passi”, Dante ha visto i due fiumi “Ëufratès e Tigri” uscire da una sorgente e dipartirsi pigri come due amici che si lasciano (Purg. XXXIII, 103-114).
[1] Il principio della concorrenza tra gli stati – una delle leggi fondamentali della teologia della storia dell’Olivi, esposta nel Notabile X del prologo della Lectura super Apocalipsim – fa sì che, per maggiore connessione, nella storia della Chiesa il periodo successivo inizi sempre prima che il precedente si esaurisca del tutto, come il bambino viene formato e nutrito nell’utero della madre prima di uscire e di distinguersi da lei, oppure come il fanciullo riceve il nutrimento e gli insegnamenti paterni prima di diventare erede e governare la casa: così il periodo che segue inizia sotto il regime del precedente per poter partecipare della perfezione di questo. Se lo stato che precede venisse meno prima dell’inizio del seguente, il mondo sarebbe privato del lume di entrambi. Lo stato che segue incomincia prima anche per poter essere provato dall’impugnazione fatta dagli zelanti del tempo che precede, e per questo Cristo iniziò il suo stato, il primo della Chiesa, sotto la vecchia legge e il sesto stato è iniziato con Francesco (con la sua conversione, nel 1206) fra le impurità del quinto. La concorrenza tra gli stati comporta che ad essi possano essere attribuiti vari termini iniziali e finali. Il primo stato (degli Apostoli) concorre con l’inizio del secondo (dei martiri) sia perché gli Apostoli fondarono la Chiesa fra i pagani e quindi da questi furono perseguitati, sia perché dovettero con il martirio confermare la fede che avevano predicato. Il secondo stato concorre con il terzo, proprio dei dottori che fiorirono a partire da Costantino, che ha le sue radici nel precedente: dottori come Clemente di Alessandria e Origene fiorirono ben prima di Costantino, con la cui conversione si fa iniziare il terzo stato. Il quinto stato (dei “condescensivi”) concorre con il quarto (degli anacoreti) perché in quest’ultimo periodo, che a sua volta concorre con il terzo dei dottori, vissero Benedetto e Agostino, le cui regole fiorirono poi nei monaci e canonici del quinto (che inizia molto più tardi, con Carlo Magno o con la venuta in Italia, a sostegno della Chiesa contro i Longobardi, di suo padre Pipino). In ciascuno stato alcuni doni (dello Spirito increato, uno e settiforme), uffici, temi sono prevalenti rispetto agli altri; ciò non toglie che in ciascuno si ritrovino tutte le prerogative altrui. Pietro, ad esempio (come affermato ancora nel Notabile X), fu pastore (I stato), martire (II), dottore (III), solitario ed austero (IV), condescensivo (V) e professore di vita evangelica (VI e, si può aggiungere, provò il pieno gusto dell’“excessus mentis” proprio del settimo stato). Le proprietà dei singoli stati corrono a confluire nel sesto, che per Olivi e Dante corrisponde ai tempi moderni, all’illuminazione del quale stanno concorrendo tutte le precedenti, come vi sta ricadendo tutta la malizia precedente. Questo intreccio fra le maglie della storia si mostra più stretto tra il terzo e il quarto stato (cfr. infra). Bisogna ricordare che gli stati sono periodi storici e insieme modi di essere dell’individuo, assimilabili alle età dell’uomo.
[2] Il sesto stato, che segna un “novum seculum”, ha in realtà quattro diversi inizi temporali: il primo, profetico, con Gioacchino da Fiore, che lo vide in spirito nel concepire la sua terza età del mondo; il secondo allorché fu generata la pianta in san Francesco, che rinnovò la regola evangelica; il terzo (dopo circa due o tre generazioni dal secondo) a partire dalla nuova fioritura dovuta alla predicazione degli Spirituali contro la nuova Babilonia, la chiesa carnale; il quarto, per cui si distingue effettivamente dal quinto stato, a partire dalla distruzione della stessa Babilonia. Olivi e Dante vivono sulla soglia del terzo inizio, quando il sesto stato concorre ancora con il quinto.
[3] Nessuno dei commentatori di Dante ha mai interpretato i “dubbiosi disiri” nel senso di un “certamen dubitationis” in cui Francesca e Paolo furono sconfitti dal dubbio ingannatore. Si ricordi, per tutte, la chiosa del Boccaccio: «Chiámagli “dubbiosi” i disidèri degli amanti, percioché, quantunque per molti atti appaia che l’uno ami l’altro e l’altro l’uno, tuttavia suspicano non sia così come a lor pare, insino a tanto che del tutto discoperti e conosciuti sono» [cfr. G. BOCCACCIO, Il «Comento alla Divina Commedia» e gli altri scritti intorno a Dante, a cura di D. Guerri, II, Bari 1918 (Scrittori d’Italia, G. Boccaccio, Opere volgari, XIII), pp. 143-144].
[4] Tale è il senso di “mal perverso”; cfr. INGLESE, Inferno, p. 89, nt. al v. 93.
[5] PETRI IOHANNIS OLIVI Expositio in Canticum Canticorum, ed. J. SCHLAGETER, Ad Claras Aquas Grottaferrata 1999 (Collectio Oliviana, II), p. 302.
Tab. 9.1
Inf. IV, 16-22E io, che del color mi fui accorto,
|
Par. IV, 130-132Nasce per quello, a guisa di rampollo,
|
|
[LSA, prologus, Notabile X] Sextus (status) vero concurrit cum secundo non in eodem tempore sed in celebri multitudine martiriorum, prout in apertione quinti signaculi aperte docetur (cfr. Ap 6, 9), quamvis in modo martirii quoad aliqua differant. Nam martiria a paganis et idolatris facta nullum certamen dubitationis inferebant martiribus, aut probabilis rationis, propter nimiam evidentiam paganici erroris. Non sic autem fuit de martiriis per hereticos, unum Deum et unum Christum confitentes, inflictis. In sexto autem tempore non solum propulsabuntur martires per tormenta corporum, aut per subtilitatem rationum philosophicarum, aut per intorta testimonia scripturarum sanctarum, aut per simulationem sanctitatis ypocritarum, immo etiam per miracula a tortoribus facta. Nam, teste Christo, “dabunt signa et prodigia magna” (Mt 24, 24). Unde Gregorius, XXXII° Moralium super illud Iob: “stringit caudam suam quasi cedrum” (Jb 40, 12), dicit: «Nunc fideles nostri mira faciunt, cum perversa patiuntur; tunc autem Behemot huius satellites, etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit humane mentis illa temptatio, quando pius martir corpus tormentis subicit, et tamen ante eius oculos miracula tortor facit»*. Propulsabit etiam eos per falsam imaginem divine et pontificalis auctoritatis. Sic enim tunc surgent pseudochristi et pseudochristus contra electos, sicut Annas et Caiphas pontifices insurrexerunt in Christum. Erunt ergo tunc tormenta intensive maiora, tempore autem paganorum fuerunt extensive pluriora: nam plusquam per ducentos annos duraverunt.* S. Gregorii Magni Moralia in Iob, libri XXIII-XXXV, cura et studio M. Adriaen, Turnholti 1975 (Corpus Christianorum. Series Latina, CXLIII B), lib. XXXII, cap. XV, 67-72 (n. 24), p. 1648 (= PL 76, col. 650 C). |
||
|
Inf. XX, 7-30e vidi gente per lo vallon tondo
|
|
[LSA, prologus, Notabile X] Sextus (status) vero concurrit cum secundo non in eodem tempore sed in celebri multitudine martiriorum, prout in apertione quinti signaculi aperte docetur (cfr. Ap 6, 9), quamvis in modo martirii quoad aliqua differant. Nam martiria a paganis et idolatris facta nullum certamen dubitationis inferebant martiribus, aut probabilis rationis, propter nimiam evidentiam paganici erroris. Non sic autem fuit de martiriis per hereticos, unum Deum et unum Christum confitentes, inflictis. In sexto autem tempore non solum propulsabuntur martires per tormenta corporum, aut per subtilitatem rationum philosophicarum, aut per intorta testimonia scripturarum sanctarum, aut per simulationem sanctitatis ypocritarum, immo etiam per miracula a tortoribus facta. Nam, teste Christo, “dabunt signa et prodigia magna” (Mt 24, 24). Unde Gregorius, XXXII° Moralium super illud Iob: “stringit caudam suam quasi cedrum” (Jb 40, 12), dicit: «Nunc fideles nostri mira faciunt, cum perversa patiuntur; tunc autem Behemot huius satellites, etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit humane mentis illa temptatio, quando pius martir corpus tormentis subicit, et tamen ante eius oculos miracula tortor facit». Propulsabit etiam eos per falsam imaginem divine et pontificalis auctoritatis. Sic enim tunc surgent pseudochristi et pseudochristus contra electos, sicut Annas et Caiphas pontifices insurrexerunt in Christum. Erunt ergo tunc tormenta intensive maiora, tempore autem paganorum fuerunt extensive pluriora: nam plusquam per ducentos annos duraverunt. |
||
Inf. XVI, 124-132; XVII, 13-15Sempre a quel ver c’ha faccia di menzogna
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 5 (radix IIe visionis)] Hoc (hec revelatio et fletus Iohannis) autem potissime spectat ad triplex tempus. […] Tertio ad tempus Antichristi seu ad tempus aliquantulum precedens plenam apertionem sexti signaculi. Tunc enim erunt mire perplexitates conscientie in electis ita ut, teste Christo, fere in errorem ducantur (cfr. Mt 24, 24). Unde Gregorius, Moralium XXXII° super illud Iob: “Nervi testiculorum eius perplexi sunt” (Jb 40, 12) dicit hoc ideo dici, «quia argumenta predicatorum Antichristi dolosis assertionibus innodantur ut alligationum implicatio, quasi nervorum perple-xitas, etsi videri possit, solvi non possit. Plerumque autem cum corda verbis inficiunt, in opere inno-centiam ostendunt, neque enim aliter ad se traherent bonos».
|
|
Tab.9.2
[LSA, cap. I, Ap 1, 1-2 (prohemium, titulus)] Nota etiam quod ex hoc quod dicit eam sibi esse datam “palam facere”, docet duo. Primum est quod multa dantur et revelantur non ad ali<is> revelandum nec cum auctoritate propalandi ea, immo cum precepto vel debito ea secrete servandi.
|
||
Inf. II, 31-33; III, 72-75Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede?
|
||
Inf. V, 118-120Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri,
|
Inf. XXIX, 11-12
lo tempo è poco omai che n’è concesso,
e altro è da veder che tu non vedi.
Par. XVI, 142-147
Molti sarebber lieti, che son tristi,
se Dio t’avesse conceduto ad Ema
la prima volta ch’a città venisti.
Ma conveniesi, a quella pietra scema
che guarda ’l ponte, che Fiorenza fesse
vittima ne la sua pace postrema.
[Ap 1, 1] In quo tangit causam materialem, quia est de futuris que non ex absoluta necessitate, sed respectu infallibilitatis divine prescientie et respectu utilitatis ac necessitatis ecclesie et respectu iustitie Dei retributive et respectu malitie reproborum, “oportet fieri”.
Par. XXI, 52-54
E io incominciai: “La mia mercede
non mi fa degno de la tua risposta;
ma per colei che ’l chieder mi concede …”.
Par. V, 109-120
Pensa, lettor, se quel che qui s’inizia
non procedesse, come tu avresti
di più savere angosciosa carizia;
e per te vederai come da questi
m’era in disio d’udir lor condizioni,
sì come a li occhi mi fur manifesti.
“O bene nato a cui veder li troni
del trïunfo etternal concede grazia
prima che la milizia s’abbandoni,
del lume che per tutto il ciel si spazia
noi semo accesi; e però, se disii
di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia”.
[LSA, cap. VII, Ap 7, 8 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Post hoc autem duodecimo ascenditur ad extaticam contemplationem et pacem que exsuperat omnem sensum, per quam quidem tota mens moritur sibi ipsi et huic vite ut transeat ad dexteram Dei, et hec designatur per Beniamin, qui in Psalmo dicitur “adol<es>centulus in mentis excessu” (Ps 67, 28), et qui interpretatur filius dextere dictusque est primo a matre Bennoni, id est filius doloris, quia in partu eius obiit pro dolore (cfr. Gn 35, 18).
Purg. III, 73-75; V, 58-63
“O ben finiti, o già spiriti eletti”,
Virgilio incomiciò, “per quella pace
ch’i’ credo che per voi tutti s’aspetti …”.
E io: “Perché ne’ vostri visi guati,
non riconosco alcun; ma s’a voi piace
cosa ch’io possa, spiriti ben nati,
voi dite, e io farò per quella pace
che, dietro a’ piedi di sì fatta guida,
di mondo in mondo cercar mi si face”.
Par. XXV, 55-57
però li è conceduto che d’Egitto
vegna in Ierusalemme per vedere,
anzi che ’l militar li sia prescritto.
Tab.9.3
[LSA, prologus, Notabile X] Prout vero status ab invicem per certam propriorum donorum et officiorum preeminentiam ac multitudinis personarum in ipsis concurrentium distinguuntur, sic concurrit tertius cum quarto non quidem in eodem statu sed in eodem tempore. […] Ideo autem quartus status concurrit eodem tempore cum tertio, quia sicut affectus exigit notitiam intellectus, nec ista notitia est sancta absque sancto affectu, sic affectualis exercitatio et contemplatio anachoritarum et sanctorum illitteratorum eguit preclaro lumine doctorum, nec illud preclarum esse potuit absque precellentia vite. Unde ad mutuum obsequium et ad meridiem universi orbis tunc ad fidem conversi simul clarificandam et inflammandam debuerunt illi duo status concurrere simul. Sicut autem notitia preit amorem, quia non potest amari nisi cognitum, sic status doctorum in hoc libro premittitur ante statum anachoritarum; in quarta tamen visione ostenduntur simul concurrere, ubi dicitur quod “date sunt mulieri due ale aquile magne ut volaret in desertum” (Ap 12, 14). Quod autem de facto insimul concurrant, patet ex cronicis. […][LSA, prologus, Notabile VII] Rursus sicut omnis dies habet mane, meridiem et vesperam, sic et omnis status populi Dei in hac vita. Nam in eterna erit semper meridies absque nocte. Ergo tempus plenitudinis gentium sub Christo debuit ante conversionem alterius populi, scilicet iudaici, habere mane et meridiem et vesperam. Et sic quasi iam vidimus esse completum et a Iohanne in hoc libro descriptum. Nam eius mane commixtum tenebris idolatrie fuit ab initio conversionis gentium usque ad Constantinum (I-II). Eius vero meridies fuit in preclara doctrina et contemplatione et vita doctorum et anachoritarum (III–IV). Eius vero vespera circa finem quinti temporis nimis apparet (V). Et cum Babilon meretrix et bestia portans eam erit in suo summo, tunc erit nox eius tenebrosissima, de qua in Psalmo dictum est: “Posuisti tenebras et facta est nox, in ipsa pertransibunt omnes bestie silve” (Ps 103, 20). Ipse sunt et bestie sexto die formate, post quas et formatus est homo ad imaginem Dei, quia post has convertetur Israel cum reliquiis gentium et apparebit christiformis vita et imago Christi (VI). |
||
Inf. VII, 31-35, 43-45, 53-54Così tornavan per lo cerchio tetro
|
Purg. II, 76-78, 85-90Io vidi una di lor trarresi avante
|
|
10. Il “disïato riso” di Ginevra
“ma solo un punto fu quel che ci vinse” (Inf. V, 132; tab. 10.1).
■Il sesto stato – iniziato con Francesco e non ancora terminato (si tratta dell’età contemporanea a Olivi e Dante) – è, insieme al successivo e breve settimo stato, il “punto” da cui dipendono gli altri stati, perché appare nel testo dell’Apocalisse in modo più evidente degli altri, che da esso assumono chiarezza quanto alla loro manifestazione nella storia, come l’intelligenza delle cose ordinate ad un fine dipende dal fine (prologo, Notabile VIII). A conclusione del processo, la luce della luna sarà come quella del sole, e il sole della sapienza cristiana luminoso della luce dei sette giorni, secondo l’espressione di Isaia 30, 26 con cui si apre il prologo della Lectura. Come il solenne inizio del Nuovo Testamento ebbe luogo con la sesta età del mondo, illuminando le cinque età precedenti e l’intelligenza profetica relativa al primo avvento di Cristo, così il solenne inizio del sesto stato della Chiesa, preceduto dai primi cinque, chiarisce l’intelligenza del libro dell’Apocalisse e delle altre scritture profetiche quanto al triplice avvento di Cristo – nella carne (primo stato), nello Spirito (sesto stato) e nel giudizio (la parusia) – e ai tempi che precedono sia il primo come il secondo avvento.
Nel Primo Mobile Dante vede “un punto … che raggiava lume / acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca / chiuder conviensi per lo forte acume” (Par. XXVIII, 16-18). Intorno al punto, che designa la semplicità e indivisibilità di Dio, girano nove cerchi concentrici di fuoco via via meno veloci quanto più se ne allontanano, che rappresentano le gerarchie angeliche. Come afferma Beatrice, “da quel punto / depende il cielo e tutta la natura” (vv. 41-42). A Dio è dunque appropriato il tema del sesto stato come “punto”, fine da cui dipendono gli stati ad esso ordinati (è da notare la presenza del verbo ‘dipendere’ nel Notabile VIII e nei versi; cfr. le variazioni sull’esegesi di Ap 14, 4, che interviene nei versi successivi). È “punto che mi vinse” (Par. XXX, 11). Un punto luminoso non solo matematico o metafisico, ma anche storico-provvidenziale e spirituale, che riassume cioè tutti e sette i doni che lo Spirito increato, uno semplicissimo e molteplice, distribuisce e tutte le illuminazioni del libro progressivamente aperto agli uomini. La Metafisica di Aristotele e il relativo commento di Tommaso d’Aquino [1], fonti della frase detta da Beatrice, concordano con la Lectura dell’Olivi, il ragionamento umano con la manifestazione dei segni provvidenziali nella storia.
Il tema del “punto” è presente anche, in forma diversa, ad Ap 11, 6 (terza visione, sesta tromba), dove si dice che i due testimoni, Enoch ed Elia, chiuderanno il cielo affinché non piova, ossia nasconderanno agli indegni la sapienza cristiana e la grazia al modo con cui un’aquila volando in alto si sottrae alla nostra vista o con cui una mole grossa si attenua riducendosi a un punto invisibile.
■ I due significati del “punto” – come passaggio al sesto stato (prologo, Notabile VIII) e come il ridursi della sapienza cristiana da una mole grossa a un punto invisibile (Ap 11, 6) -, si ritrovano in Inf. XXXIV, 70-93, nel volgersi di Virgilio sull’anca di Lucifero. Con Dante avvinghiato al collo, il poeta pagano, quando le sei ali di Lucifero sono bene aperte (variazione di un tema del terzo e quarto stato, allorché alla donna sono date due grandi ali d’aquila per vincere la guerra; in questo caso le ali di Lucifero sono di aiuto), si appiglia alle costole e scende giù di vello in vello (sono temi del condescensivo quinto stato sia il discendere sia l’avere una ‘costa’ cui aggrapparsi). Arrivato là ove la coscia di Lucifero “si volge, a punto in sul grosso de l’anche” (i due opposti motivi, del punto e della grossezza, sono congiunti poiché la testa del femore costituisce il punto medio del corpo di Dite), Virgilio volge la testa e si aggrappa al pelo per risalire lungo le gambe di Lucifero. Il punto in cui Virgilio si volge coincide con il centro della terra, punto che la “gente grossa” non vede nella sua ignoranza: sono qui presenti i motivi, da Ap 11, 6, della sapienza che si sottrae alla vista e della “moles grossa” che si riduce, quest’ultimo tema già anticipato all’inizio del canto con la similitudine della “grossa nebbia” e dell’apparire “di lungi un molin che ’l vento gira”, che è in realtà Lucifero (vv. 4-7). Il contrasto tra l’umile semplicità degli uomini spirituali e la grossezza degli inferiori è anche uno dei temi della sesta vittoria (Ap 3, 12). Il volgersi di Virgilio nel “punto / al qual si traggon d’ogne parte i pesi” (vv. 110-111) segna il passaggio dall’“emisperio nostro”, delle terre emerse, a quello dov’è la montagna del purgatorio. Come gli dice Virgilio, Dante è rimasto nel primo emisfero finché è durata la discesa (tema del quinto stato). Il “punto” segna il passaggio, con l’uscita dall’inferno, ad uno stato migliore, verso il secondo regno. È terminato il viaggio nelle prime cinque età del mondo (l’Antico Testamento); ora la seconda cantica narrerà il viaggio dei due poeti nella sesta età, quella della Chiesa di Cristo.
■ La luce divina, che tanto si leva dai concetti mortali, per cui la sua espressione sembra essere chiusa alla lingua del poeta, è “punto” nell’ultima visione: “Un punto solo m’è maggior letargo / che venticinque secoli a la ’mpresa / che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo” (Par. XXXIII, 94-96). Il “letargo” è l’oblio che induce la visione suprema esposta ad Ap 1, 16-17, quando il sublime “splendor faciei” di Cristo imprime negli inferiori un sentimento di annullamento e di umiliazione, di tremore e di adorazione. Il “punto” che è causa di oblio si contrappone, sul piano temporale, ai “venticinque secoli” che sono trascorsi, non ponendola in dimenticanza, dall’impresa degli Argonauti. Si contrappone ancora, sul piano spaziale, a qualcosa di ‘grosso’, cioè all’ombra della grande nave che Nettuno meravigliato guarda dal basso solcare il mare: un accostamento, quello del “punto” e dell’“ombra”, che è proprio anche del cono d’ombra proiettato dalla terra (la ‘mole grossa’ del “vostro mondo”) che “s’appunta”, cioè termina, sul terzo cielo di Venere (Par. IX, 118-119).
È da notare che tra i dodici esercizi di ascesi alle virtù, proposti nell’esegesi di Ap 7, 5-8 come interpretazione dei nomi delle dodici tribù d’Israele da cui proverranno i 144.000 segnati all’apertura del sesto sigillo, la quinta tribù, Nèftali, rappresenta la virtù che sa trasferirsi dal sensibile allo spirituale e all’eterno, di modo che il sensibile e il temporale appaiano segno e specchio dell’intellettuale e dall’innumerevole multiformità del sensibile ci si dilati nella contemplazione dell’intellettuale. Per questo Nèftali (Ap 7, 6) viene interpretato come “comparatio” o “conversio translativa” o “latitudo”. Poi si esige la dimenticanza dello stesso sensibile; per passare infatti dal segno relativo e dallo specchio all’intellettuale bisogna spogliarsi del sensibile come di veli tenebrosi. Questo il significato della sesta tribù, Manasse, nome interpretato come “oblivio”. Nell’ordine degli esercizi viene dunque prima la dilatazione o la larghezza, poi l’oblio. Così la terzina che concerne il “letargo” (Par. XXXIII, 94-96) segue quella (vv. 91-93) in cui il poeta dichiara di aver visto “la forma universal di questo nodo” – cioè l’amoroso legame “in un volume” di “ciò che per l’universo si squaderna: / sustanze e accidenti e lor costume / quasi conflati insieme …” (vv. 85-90) -, e crede che sia così “perché più di largo, / dicendo questo, mi sento ch’i’ godo”. Conseguita la dilatazione contemplando in Dio la forma universale dell’innumerevole multiformità del sensibile, al poeta tocca l’oblio che si libera dai veli tenebrosi, figurati dall’ombra della nave degli Argonauti, antico precorrimento, con reminiscenze ovidiane (Am., II, 11, 1-2) e virgiliane (Aen., I, 124-128; VIII, 91), del viaggio “in pelago” del suo “legno che cantando varca” (cfr. Par. II, 1-18). Nella Lectura “ombra” e “velo” sono termini di significato equivalenti; l’“umbra velaminis” viene compiutamente tolta dalla gloria di Cristo per la quale, nel sesto e nel settimo stato, la luce della luna (il Vecchio Testamento) sarà come quella del sole (il Nuovo Testamento) e risplenderà della luce di sette giorni, cioè di tutte le illuminazioni verificatesi nella storia, secondo quanto scritto in Isaia 30, 26, il già ricordato passo assunto dall’Olivi come incipit del commento all’Apocalisse. I veli, o l’ombra, designano la poesia stessa, che spira da Dio e ombreggia con segni e con figure, cioè con immagini, verità superiori, come i sacramenti ombreggiano la verità divina (ad Ap 22, 2). Il “letargo” determinato dal “punto” divino è annullamento dell’ombra: l’intelletto tanto si profonda nella visione di Dio, che nessuna immagine si ritrova per esprimerla.
■ Ancora nella visione finale, il tema dell’intimo mutarsi di colui che contempla un’ardua visione, da Ap 1, 17 (lo “splendor faciei” di Cristo nel sesto stato), si ritrova nella contemplazione della luce divina, semplice e immutabile sembiante che tuttavia si trasforma – “a me si travagliava” – nel mutarsi del soggetto vedente, “per la vista che s’avvalorava / in me guardando” (Par. XXXIII, 109-114): sul piano teologico è così offerta la giustificazione al succedersi di figure diverse con cui la poesia descrive la visione, che è una, dei misteri della Trinità e dell’Incarnazione. Una delle spiegazioni dell’esistenza dei sette sigilli e delle loro chiusure sul libro sta nella passione di Cristo, che per sette motivi appare abietta al senso umano, il quale trova nella morte in croce impotenza, angustia, stoltezza, inopia, ignominia, inimicizia e sevizia (ad Ap 5, 1). Il terzo motivo è l’apparente stoltezza, per cui Dio si è fatto uomo ed è morto per dare soddisfazione alle ingiurie a Lui stesso arrecate e ha redento con tale prezzo coloro che avrebbe potuto salvare col solo suo potere. Contro l’apparente stoltezza sta il “valore”, di incomparabile lucro, che deriva dal commercio della dottrina di Cristo. In cambio di un solo denaro – la fede unica e semplice – si ottengono infatti beni senza prezzo, cioè il grano, l’orzo, il vino e l’olio di cui si dice nella terza apertura e che corrispondono ai quattro sensi della Scrittura (Ap 6, 6). Il commercio della sapienza tramite lo studio delle Scritture si contrappone alla bilancia dolosa ed erronea degli eretici, che vacilla dal retto equilibrio della verità. Il tema del valore incomparabile ottenuto in cambio di un solo denaro e di una fede unica e semplice viene utilizzato dal poeta per esprimere l’avvalorarsi della propria vista che, nella visione finale della Trinità e dell’Incarnazione, subiva crescenti mutazioni di aspetti pur rimanendo la luce divina, oggetto della contemplazione, “un semplice sembiante” e “una sola parvenza”. Da notare che il valore senza prezzo, nell’esegesi oliviana, si contrappone all’apparente stoltezza per cui Cristo si è fatto uomo.
L’intimo mutarsi, che per Olivi è segno della vera visione, è già stato proprio di Beatrice nell’Eden, nei cui occhi il grifone-Cristo, che pur sta fermo (nella sua unità e semplicità), raggia la sua immagine (il suo “idolo”) “come in lo specchio il sol (et facies eius sicut sol … debet preclarius radiare) … or con altri, or con altri reggimenti”, cioè come duplice natura, umana-leone e divina-aquila (Purg. XXXI, 121-126). Di tale accertamento interiore attesta il Caffarini, allorché Caterina da Siena disse al suo confessore di prepararsi, perché gli avrebbe mandato Cristo: “Et ita factum est, non quidem corporaliter, sed per novam ipsius confessoris immutationem prout ipse testatus fuit” [2].
Dopo aver considerato il significato di “punto” nel rispondersi in più luoghi fra Commedia e Lectura, si esaminerà la filigrana spirituale delle parole di Francesca: “ma solo un punto fu quel che ci vinse …” (Inf. V, 132).
“Quando leggemmo il disïato riso / esser basciato da cotanto amante, / questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto tremante. … E caddi come corpo morto cade” (Inf. V, 133-136, 142; tab. 10.2-12).
Fra le tante appropriazioni agli individui, registrabili nella Commedia, delle prerogative di Cristo descritte nella Lectura super Apocalipsim, eccellono quelle proposte ad Ap 1, 16-17. Si tratta della decima e undecima perfezione di Cristo sommo pastore, premesse alla prima visione. Queste perfezioni, afferma l’Olivi, possono adattarsi ai prelati, ma anche agli eletti, membra del corpo mistico di Cristo:
Notandum autem quod perfectiones predicte possunt anologice coaptari perfectis prelatis sub Christo, ita quod eorum perfectiones ascribantur Christo sicut cause efficienti et exemplari. Possunt sibi etiam ascribi tamquam capiti corporis mistici, et tunc per membra Christi hic posita possunt significari diversi electi, qui sunt mistica membra Christi, puta per oculos contemplativi, per pedes activi, per os autem seu per vocem doctores et iudices seu correctores.
La decima perfezione consiste nell’incomprensibile gloria che deriva a Cristo dalla chiarezza e dalla virtù, per cui si dice: “e la sua faccia riluce come il sole in tutta la sua virtù” (Ap 1, 16). Il sole riluce in tutta la sua virtù nel mezzogiorno, quando l’aere è sereno, fugata ogni nebbia o vapore grosso. Allora il viso corporeo di Cristo ha incomparabilmente più luce e vigore, e ciò designa l’ineffabile chiarezza e virtù della sua divinità e della sua mente. Lo splendore del volto indica l’aperta e fulgida conoscenza della Sacra Scrittura, che deve raggiare in modo più chiaro nel sesto stato, prefigurata dalla trasfigurazione sul monte avvenuta dopo sei giorni e designata dall’angelo che, al suono della sesta tromba, ha la faccia come il sole (cfr. Ap 10, 1).
L’undecima perfezione sta nell’imprimere negli inferiori, di fronte a tante sublimità, un sentimento di umiliazione, di tremore e di adorazione, per cui si dice: “e vedendolo”, cioè tanto e tale, “caddi ai suoi piedi come morto” (Ap 1, 17). Il cadere (è da intendere che Giovanni cadde col viso a terra in atto di adorazione, perché il cadere supino è segno di disperazione) è causato sia dall’intollerabile eccesso dell’oggetto visto, sia dall’influsso dell’angelo o dell’assistente divino che incute terrore e provoca un sentimento di mutazione, sia dalla materiale fragilità del soggetto o dell’organo visivo. Proprio il senso di intimo mutare rende colui che vede esperto del fatto che si tratta di una visione ardua, divina e derivata da cause supreme. Sentirsi annullato predispone a ricevere le visioni divine in modo più umile e timorato, e significa che la virtù e la perfezione dei santi provoca tremore e umiliazione negli inferiori. Significa anche che l’ascesa alla contemplazione divina avviene unicamente tramite l’oblio, la negazione, la mortificazione di sé stessi e la privazione di ogni cosa.
■ I signacula di questa esegesi del volto di Cristo che irradia, nel sesto stato, più luce e più rivelazione della Scrittura, percorrono tutta la terza cantica a partire dal principio, con la gloria della divina virtù che risplende, con l’essere il poeta disceso dal “ciel che più de la sua luce prende” (Par. I, 1-2, 4, 22).
“In una parte più e meno altrove” (v. 3). Nella settima visione, trattando delle porte della Gerusalemme celeste (Ap 21, 12-13), Olivi afferma che la divina sapienza e provvidenza, che risplende nelle sue parti in modo diverso – “arbor seu fabrica ecclesie et divine providentie ac sapientie in eius partibus diversimode refulgentis et participate” -, si esplica tutta, dopo successive e crescenti illuminazioni del popolo di Dio, nel terzo stato del mondo (l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore), che corrisponde al sesto e settimo stato dell’Olivi, come un albero si mostra compiutamente solo nelle foglie e nei frutti.
“E vidi cose che ridire / né sa né può chi di là sù discende … sarà ora materia del mio canto” (vv. 5-6, 12). “Et nemo poterat dicere canticum … nec possunt cantare canticum superiorum” (Ap 14, 3): nessuno può esprimere compiutamente il canto dei compagni dell’Agnello, che stanno sul monte Sion. Cantare la lode di Dio è possibile, senza però raggiungere quel livello.
“perché appressando sé al suo disire, / nostro intelletto si profonda tanto, / che dietro la memoria non può ire” (vv. 7-9). Nella contemplazione delle cose divine non si ascende se non “per sui oblivionem” (Ap 1, 17).
■ (tab. 10.3) Quello che nell’esegesi di Ap 1, 16-17 è concentrato unicamente su Cristo e sullo splendore del suo volto (“splendor faciei”) viene frantumato, secondo l’avvertenza dell’Olivi, su più soggetti. Beatrice, in primo luogo, con il suo sorriso (esempi a Purg. XXXI, 121-126, 139-145; XXXII, 9-12; XXXIII, 115-117; Par. XXIII, 10-12, 25-72; XXX, 19-21, 25-27; cfr. infra), ma anche Matelda (Purg. XXVIII, 64-69), l’angelo nocchiero (Purg. II, 19-21, 37-39), l’angelo portiere (Purg. IX, 79-81) e altri “officiali” della montagna (Purg. XV, 10-12, 25-27), Tommaso d’Aquino (Par. XI, 16-21; XIII, 73-81), l’“amore angelico” (Par. XXIII, 106-108), il canto di “gloria” nell’ottavo cielo (Par. XXVII, 4-9), la Vergine madre (Par. XXXII, 85-87).
Nell’arrivo al cielo di Mercurio (Par. V, 94-108), il pianeta più lucente se ne fé per il letiziare di Beatrice, si cambiò per intima mutazione, come il poeta si fece trasmutabile. La stella rise: ridere corrisponde allo splendor faciei di Cristo, che equivale alla trasfigurazione.
Il poeta scorge in ciascuno dei beati “l’ombra piena di letizia / nel folgór chiaro che di lei uscia” (Par. V, 106-108). Si inserisce a questo punto il gruppo tematico della folgore, che nell’esegesi ha più occorrenze collazionabili (Ap 1, 7; 4, 5; 8, 5). L’essere chiaro della folgore (Ap 4, 5) la congiunge con la claritas della faccia di Cristo di Ap 1, 16. “Nel folgór … che di lei uscia”: ad Ap 1, 7, nella citazione di Matteo 24, 27, l’avvento di Cristo è folgore che ‘esce’ (“Sicut fulgur exit”) da oriente e appare in occidente. La claritas della folgore “longe lateque coruscat”, si desume da Ap 4, 5, e Dante vede come il lume che raggia dall’anima di Giustiniano sia tratto dagli occhi perché, gli dice, esso corusca, cioè lampeggia, “sì come tu ridi”, cioè ti illumini di letizia (vv. 124-126). Riso che, anche in questo caso, corrisponde allo splendor faciei di Cristo di Ap 1, 16. Nel testo della Lectura Dante trovava corrispondenza con quanto da lui affermato nel Convivio, del ridere come “una corruscazione della dilettazione dell’anima, cioè uno lume apparente di fuori secondo sta dentro” (III, viii, 11). La luce di Giustiniano (vv. 130-139), alla domanda di Dante, si fa lucente più assai (il riferimento è ancora a plus incomparabiliter lucet del volto di Cristo) e si nasconde dentro al suo raggio per più letizia, come il sole il cui calore abbia diradato i fitti vapori che ne temperavano il fulgore (temi da Ap 1, 16; temperate sono le “voci” che seguono i fulmini) e che si celi allo sguardo per eccesso di luminosità (l’“ex intolerabili superexcessu obiecti” di Ap 1, 17).
La contaminazione, sempre variata e diversamente appropriata, fra i due gruppi di signacula – Ap 1, 16-17 (lo splendore del volto di Cristo, ovvero il sorriso, che induce oblio) e 1, 7; 4, 5; 8, 5; 11, 19 (il folgorare che divide; la voce, che segue, più soave e temperata) – si registra in altri luoghi, come nel cielo del Sole e in quello di Marte: Par. X, 58-69 (Beatrice e gli spiriti sapienti); Par. XVI, 28-33 (Cacciaguida) [3]; XVII, 121-123 (ancora Cacciaguida).
Il lettore ‘spirituale’ della Commedia avrebbe soppesato ogni parola nei suoi significati non letterali, pervenendo a una dottrina indotta. Ad esempio, leggendo a Par. XXI, 4-12 la spiegazione data da Beatrice sul mancato suo ridere nel settimo cielo, sarebbe andato con la mente ad Ap 1, 16-17 («S’io ridessi … più s’accende … tanto splende – splendor faciei … plus incomparabiliter lucet … “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” … ex intolerabili superexcessu obiecti»). Questo eccessivo splendore (il ridere della donna) viene paragonato alla folgore (“che ’l tuo mortal podere, al suo fulgore, / sarebbe fronda che trono scoscende”), e qui l’accorto lettore avrebbe ravvisato la sequenza “fulgura-voces-tonitrua” (Ap 4, 5; 8, 5; 11, 19) che lo avrebbe portato a concludere: il ridere di questa donna, che fa cadere chi lo guarda come morto (Ap 1, 17) è come la folgore corruscante e scindente che emana dalla sede divina (Ap 4, 5); deve pertanto essere temperato (“se non si temperasse”), come le voci sono temperate, soavi, umane, razionali rispetto alla folgore. Dalla sede emanano anche i tuoni, cioè le terribili minacce fatte in cielo: ed ecco che “la dolce sinfonia di paradiso”, che suona devota giù nelle altre sfere, in quella di Saturno “si tace” per dare luogo a un canto – la zelante preghiera di vendetta divina contro i moderni pastori, dopo che Pier Damiani li ha vituperati – che è “tuono” che vince e trasmuta (Par. XXI, 139-142; XXII, 10-15). Ancora, il nostro spirituale, leggendo oltre il senso letterale “se non si temperasse” (Par. XXI, 10), si sarebbe ricordato che il temperamento è proprio del condescensivo e pietoso quinto stato, intervenuto dopo l’arduo e solitario quarto stato (prologo, notabile III) e, arrivato al “si tace” (v. 58), avrebbe intuito che il tacere e il silenzio sono temi precipui del settimo e ultimo stato (siamo nel settimo cielo; notabile III; cfr. tab. 6.3). Si sarebbe ricordato degli altri luoghi del poema che presentano, in modo variato, gli stessi motivi.
■ Lo splendore del volto di Cristo (il ridere o corruscare dell’animo), che è anche apertura dell’arcano per più luce, si riverbera nel ridere di Gregorio Magno, una volta giunto nel nono cielo (Cristallino o Primo Mobile), sull’ordine da lui dato nei Moralia circa le gerarchie angeliche (che Dante aveva seguito in Convivio II, v, 6), diverso da quello vero stabilito da Dionigi, l’Areopagita che l’aveva appreso direttamente dal suo maestro san Paolo (Par. XXVIII, 133-139).
Questo gruppo tematico, originario di Ap 1, 16-17, è solo una parte del panno su cui sono cuciti i versi, perché altri gruppi sono sempre presenti per collazione. Ad esempio, il tema dell’aria serena liberata da ogni nebbia e grosso vapore (Ap 1, 16) si intreccia con l’analogo proveniente dalla settima coppa (Ap 16, 17): a quest’ultima esegesi dell’aria purgata, di ciò che è sereno, tranquillo, puro rinvia la similitudine con il chiaro rispondere di Beatrice, a Par. XXVIII, 79-87, sull’apparente discordare nella misura tra le sfere celesti e i cerchi angelici, similitudine che segue la prosa anche nella struttura sintattica (Sicut … sic … post / Come … così … poi che).
■ Lo splendor faciei di Cristo, che si incarna nel sorriso di Beatrice, discorre per tutto il Paradiso, con variazioni della rosa semantica che lo costella: l’essere più lucente, la troppa luce, il mettere in oblio, l’intimo accorgersi di più ardua visione. All’esegesi di queste due perfezioni di Cristo sommo pastore rimandano le parole incastonate nei versi come pietre miliari, a ricordare una dottrina poeticamente rivestita. Le variazioni, come si è visto, non sono solo interne al ristretto passo esegetico (Ap 1, 16-17), ma coinvolgono altri luoghi della Lectura.
Un lettore ‘spirituale’, di fronte al ridere di Beatrice, avrebbe senz’altro rammentato l’esegesi del volto solare di Cristo. Non nel senso di una reale identificazione, ma della conformità che nasce dal seguirlo. Se non esiste paragone per il volto di Cristo – “sì ch’io non so trovare essempro degno” (Par. XIV, 105) -, proprio una delle sue prerogative come sommo pastore è di essere “simile al Figlio dell’uomo” (Ap 1, 13). Dal fatto che non si dica “Figlio dell’uomo” ma “simile al Figlio dell’uomo” – scrive Olivi – Riccardo di San Vittore deduce trattarsi di un angelo apparso a Giovanni, che gli mostrava le cose con persona simile a quella di Cristo e in modo tanto più autorevole per il fatto di somigliare al Salvatore. Tale è Beatrice alter Christus (come san Francesco), che prende il luogo dell’angelo. Così si rende per lei possibile il sorriso, che l’iconografia tradizionalmente aveva evitato nelle raffigurazioni di Cristo.
Questo lettore virtuale avrebbe ritrovato il bianco – colore per eccellenza della luce di Cristo risorto e vittorioso all’apertura del primo sigillo “in equo albo” (Ap 6, 2 [5, 1]) – nel tentativo, di per sé limitato, di rendere il lampeggiante albore di Cristo nella croce formata dai beati nel cielo di Marte (Par. XIV, 94-99, 103-108; “Resurgi” e “Vinci” è quanto si ode della melodia cantata dai beati, vv. 124-126). Ancora una volta lo splendor e il lucore, da Ap 1, 16-17 (anticipati dal ridere di Beatrice e della stella, vv. 79-81, 85-87), sono contaminati con altro passo, in questo caso relativo all’esegesi della sede divina, adornata di vari colori (Ap 4, 3): qui incidono la cornalina (rossa per il sacrificio del Figlio di Dio; da notare la rima “robbi / addobbi”, vv. 94/96) e, fra i colori dell’iride, il fiammeggiare per carità e il bianco per sapienza (e al bianco ancora rinvia il biancheggiare della Galassia, “sì, che fa dubbiar ben saggi”, vv. 98-99). “Ché quella croce lampeggiava Cristo … vedendo in quell’ albor balenar Cristo” (vv. 104, 108): la folgorante luce della fede diffusa dagli apostoli fu “instar fulguris universa subito discurrentis” (prologo, notabile XII). Il folgorare di Cristo si estende ai beati: la luce di Cacciaguida discende ai piedi della croce “quale per li seren tranquilli e puri / discorre ad ora ad or sùbito foco” (Par. XV, 13-14; cfr. il passo simmetrico ad Ap 13, 3, che interessa anche i due versi seguenti); lo stesso verbo designa la subitanea creazione (“lo discorrer di Dio sovra quest’ acque”, Par. XXIX, 21). La vittoriosa luce di Cristo è insita nel ridere di Beatrice: “Vincendo me col lume d’un sorriso” (Par. XVIII, 19).
■ Quanto è riferito alla decima e undecima perfezione di Cristo sommo pastore può congiungersi con altre perfezioni della stessa serie: ad esempio in Par. XV, 71, dove l’espressione “e arrisemi un cenno”, riferita a Beatrice, cuce lo splendore nel sorridere con quello che deriva dallo zelante guardare con occhi di fuoco ogni atto, intenzione, cenno altrui (Ap 1, 14; quinta perfezione). La contaminazione dei due passi si registra ancora nell’incontro fra Stazio e Virgilio (Purg. XXI, 109-114; XXII, 25-27). Nella visione finale dell’Incarnazione, il sorriso appartiene alla “… luce etterna che sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente te ami e arridi”, mentre il vedere con occhi di fuoco (già appropriato a Caronte e a Cesare) è trasferito sul poeta che contempla: “Quella circulazion che sì concetta / pareva in te come lume reflesso, / da li occhi miei alquanto circunspetta” (Par. XXXIII, 124-129).
Così, a Par. XX, 13-15, nel primo verso – “O dolce amor che di riso t’ammanti” -, il sorridere (decima perfezione) e l’ammantarsi (terza, Ap 1, 13: la santità del manto sacerdotale) si riflettono “in que’ flailli, / ch’avieno spirto sol di pensier santi”, cioè nelle luci che formano l’aquila. L’esegesi del manto (“vestitum podere”) è tela su cui il poeta sovrappone numerosi ricami.
■ Ulteriori collazioni dell’esegesi di Ap 1, 16-17 si registrano con Ap 14, 2 (il canto dei compagni dell’Agnello sul monte Sion), toccando in particolare le parole di Tommaso d’Aquino a Par. XIII, 73-78 (l’esame del versetto è stato condotto altrove), e con Ap 21, 16 (l’uguaglianza di lunghezza, larghezza e altezza nei quattro lati della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione), in relazione alle sorrise parole rivolte da Beatrice a san Giacomo (Par. XXV, 25-33).
■ Beatrice, nell’attesa che le schiere del trionfo di Cristo discendano dall’Empireo al Cielo stellato, “stava eretta / e attenta, rivolta inver’ la plaga / sotto la quale il sol mostra men fretta” (Par. XXIII, 10-12), cioè verso mezzoggiorno quando, secondo l’esegesi di Ap 1, 16, il volto di Cristo si mostra, come il sole, di più luminoso splendore in tutta la sua virtù e chiarezza. È un sole che accende “migliaia di lucerne”, “quale ne’ plenilunïi sereni / Trivïa ride tra le ninfe etterne / che dipingon lo ciel per tutti i seni” (vv. 25-30). La luna che ride e accende le stelle appare con lo stesso splendore del sole-Cristo che illumina i beati; la similitudine raffigura il passo di Isaia 30, 26 “Erit lux lune sicut lux solis”, incipit della Lectura super Apocalipsim.
All’arrivo delle schiere, Beatrice dice a Dante di guardarla – “Apri li occhi e riguarda qual son io” -, perché egli ha veduto tali cose – “la lucente sustanza tanto chiara / nel viso mio, che non la sostenea”, cioè Cristo, che “è virtù da cui nulla si ripara” – che hanno reso la sua facoltà visiva disposta a sostenere il proprio sorriso (Par. XXIII, 31-36, 46-48). Il poeta è “come quei che si risente / di visïone oblita e che s’ingegna / indarno di ridurlasi a la mente” (vv. 49-51), deve rinunciare a cantare “il santo riso” (il sacro poema lo ‘salta’ nel descrivere il paradiso) perché il suo è omero mortale che si fa carico del “ponderoso tema”, e chi questo pensasse “nol biasmerebbe se sott’ esso trema” (vv. 55-69). Nei versi si ritrovano motivi da Ap 1, 16-17: la “claritas” e la “virtus” di Cristo, sole che accende migliaia di lucerne, cioè di anime luminose; l’“aperta et superfulgida notitia scripture sacre” raggiante nel sesto stato della Chiesa, che corrisponde all’invito di Beatrice al poeta di aprire gli occhi; lo “splendor faciei”, che è lo stesso sorriso della donna, come nella similitudine di Trivia; la fragilità dell’organo visivo; l’“oblivio sui”, sperimentato da Dante alle parole di Beatrice che lo richiamano dalla visione di Cristo che lo aveva fatto uscir di mente; la “tremefactio intuentium”, per cui il poeta trema nel tentativo, cui dice di rinunciare, di cantare l’aspetto della sua donna; l’arditezza della visione, che si traspone nell’“ardita prora” del poema sacro [4].
La “lucente sustanza”, che “per la viva luce trasparea” (Par. XXIII, 31-32), deriva da Ap 22, 1, dall’esegesi del fiume che scorre nel mezzo della Gerusalemme celeste, il quale indica la sostanza della grazia e della gloria della somma Trinità che viene comunicata a tutti i beati e che procede ed è dispensata dal Cristo uomo e fa trasparire nelle sue acque vive, come in un cristallo solido e perspicuo, la luce della somma sapienza [5].
La stessa materia offerta da Ap 1, 16-17 e da Ap 22, 1, appropriata nell’ottavo cielo a Cristo e al riso di Beatrice, è stata già utilizzata, nell’Eden, per lo svelamento della donna “ne l’aere aperto” e, ancor prima, per descrivere il riflettersi del grifone-Cristo nei suoi occhi (Purg. XXXI, 121-126, 139-145). Nell’Eden, che sta in terra, Beatrice è “luce” e “gloria de la gente umana” (Purg. XXXIII, 115), prerogative del sommo pastore nella sua decima perfezione.
■ I temi da Ap 1, 16-17 fasciano ancora il senso di annullamento e di oblio provato da Dante, sulla soglia dell’Empireo, di fronte alla bellezza di Beatrice, alla quale egli è tornato con gli occhi dopo l’estinguersi alla sua vista del trionfo dei cori angelici attorno al punto luminoso “che mi vinse”. Il solo ricordo “del dolce riso” – il ridere rende lo “spendor faciei” di Ap 1, 16 – annulla le facoltà della sua mente: “ché, come sole in viso che più trema, / così lo rimembrar del dolce riso / la mente mia da me medesmo scema” (Par. XXX, 25-27). L’espressione “come sole in viso che più trema” cuce i temi della decima perfezione di Cristo (“sicut sol”) e dell’undecima (la “tremefactio intuentium”), con il “più” trasferito dalla luce dell’una al render tremanti dell’altra. È da notare il riferimento all’ora sesta, cioè meridana, che “ferve” (vv. 1-2) e al trasmodare della bellezza della donna (vv. 19-21, “si trasmoda” è hapax nel poema), che corrispondono al sesto stato e alla trasfigurazione avvenuta dopo sei giorni. Il poeta si dichiara vinto: “Da questo passo vinto mi concedo / più che già mai da punto di suo tema / soprato fosse comico o tragedo” (vv. 22-24).
■ L’esegesi del solare volto di Cristo, registrabile, come si è visto, con una certa frequenza nel Purgatorio e nel Paradiso, emerge in filigrana solo in un punto dell’Inferno (V, 133-136, 142). I temi della decima perfezione del sommo pastore formano l’armatura del “riso” di Ginevra, il “punto” della lettura del libro ‘galeotto’ che “vinse” Francesca e Paolo. Esso si annida nella “claritas” e nello “splendor faciei” di Cristo. Nel sesto stato, allorché lo splendore del volto di Cristo diviene più lucente come il sole, si verifica quanto scritto nel Cantico dei Cantici (Cn 8, 2), della sposa che desidera l’amato in modo da poterlo baciare e introdurre nella casa materna. L’amato viene considerato come un fratello che succhia il seno della stessa madre, e per questo la sesta chiesa, Filadelfia, viene interpretata come “amore fraterno” (Ap 3, 7, unico luogo della Lectura che contenga un riferimento al baciare: il sesto stato è segnato dal vincolo della “familiarior signatio et notitia et amicitia apud Deum”; cfr. supra). “Questi … la bocca mi basciò tutto tremante”, sperimenta cioè la “tremefactio” propria di colui che contempla un’ardua e sublime visione (Ap 1, 17), ma è il “disiato riso” di Ginevra a proporsi come falsa immagine della “claritas” e dello “splendor faciei” del volto di Cristo (Ap 1, 16). Il cadere come morto (Ap 1, 17) è appropriato a Dante che viene meno per la pietà verso i “due cognati”.
« … ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” – Quando leggemmo il disïato riso / esser basciato da cotanto amante, / questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto tremante. … E caddi come corpo morto cade» (Inf. V, 133-136, 142).
Il cadere di Dante non è però disperato (la “mente”, chiusa per la pietà e confusa di tristezza per il peccato, torna poi alla ragione: Inf. VI, 1-3), non come quello di Cavalcante, che “supin ricadde e più non parve fora” di fronte all’indugiare della risposta di Dante alla domanda se il proprio figlio Guido sia ancora in vita (Inf. X, 72).
■ Lo splendore del volto di Cristo cresce con l’andare nel viaggio, come aumenta nella storia della Chiesa, le cui prerogative sono da Dante sparse sull’intero mondo umano. Così cresce il ridere di Beatrice fino alla piena apertura nell’ottavo cielo, al momento della discesa delle schiere del trionfo di Cristo (Par. XXIII, 46-69) e poi, infine, sulla soglia dell’Empireo (Par. XXX, 19-36).
La centralità di Ap 1, 16-17 in tanti luoghi del poema, da Francesca a Beatrice, è trasposizione di quello che è il tema fondamentale della Lectura super Apocalipsim – che non si ritrova in altra opera contemporanea -, cioè la centralità di Cristo [6], il cui splendore aumenta nella storia con il procedere verso il sesto stato della Chiesa, quando il libro, non Galeotto ma vero, sarà tutto aperto. Da “ma solo un punto fu quel che ci vinse” di Francesca (Inf. V, 132), al “punto che mi vinse” nel Primo Mobile e al vittorioso sorriso di Beatrice sulla soglia dell’Empireo (cfr. Par. XXX, 11, 22-24), al finale “punto solo” (Par. XXXIII, 94): “dall’occasione di tanto peccato – scrive Gianfranco Contini – alla visione divina, quale abisso e quale preterintenzionalità di parentela!” [7]. La parentela non è però preterintenzionale, trattandosi di diversi stadi di un medesimo processo storico di epifania del Cristo dio e uomo: il primo come vano desiderio e malvagia tentazione provata nel subdolo martirio degli ultimi tempi; il secondo nello spazio e nel tempo degli uomini (il tempo ha nel Primo Mobile le sue radici); il terzo, non più per specula, di fronte al divino.
Il compimento della “scrittura” d’Amore, iniziata con l’inganno di Francesca e Paolo vinti da “solo un punto”, avverrà con le parole dette dal poeta a san Giovanni che lo esamina sulla carità (Par. XXVI, 16-18), dove la terzina contiene anche il riferimento ad Ap 1, 8; 21, 6 e 22, 13 (“Ego sum A et Ω, principium et finis”): “Lo ben che fa contenta questa corte, / Alfa e O è di quanta scrittura / mi legge Amore o lievemente o forte”. In tutt’altro contesto, ‘Amore’ e ‘leggere’ sono uniti. I due “cognati” avevano letto da soli, a Dante viene letto per dettato interiore (“Noi leggiavamo … quel giorno più non vi leggemmo avante /… mi legge Amore …”) [8].
***
[1] Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, Λ 7, 1072 b 13-14; THOMAS DE AQUINO, Sententia libri Metaphysicae, lib. 12, lectio 7, n. 16: “Ex hoc igitur principio, quod est primum movens sicut finis, dependet caelum, et quantum ad perpetuitatem substantiae suae, et quantum ad perpetuitatem sui motus; et per consequens dependet a tali principio tota natura, eo quod omnia naturalia dependent a caelo, et a tali motu eius”.
[2] THOMAS ANTONII DE SENIS «CAFFARINI», Libellus de Supplemento legende prolixe virginis beate Catherine de Senis, primum ediderunt I. Cavallini – I. Foralosso, Roma 1974 (Centro Nazionale di Studi Cateriniani. Testi Cateriniani, III), p. 27 (pars I, tract. II, 19).
[3] Cfr. supra.
[4] In Par. XXIII fanno da contrappunto ad Ap 1, 16-17 anche le proprietà di almeno quattro delle dodici tribù d’Israele da cui proverranno i segnati all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 6-8; cfr. anche supra), quasi a voler significare una graduale ascesa alla perfezione “ad perfectum … nexum amoris”: la quarta tribù, Aser (“amor ad superna elavatus”): beatus, pinguis → Bëatrice, più pingue; la quinta, Neptalim (“amor ad fraterna dilatatus”: la virtù per cui ci si dilata all’eterno da ciò che è temporale, cosicché questo sia specchio dell’altro): se … dilatat → per dilatarsi; la sesta, Manasse (“amor inferiorum oblitus”: una volta passati all’intellettuale dal sensibile, sopravviene l’oblio di questo come una liberazione da veli tenebrosi): oblitus → oblita (hapax nella Commedia). Si aggiunge anche Isachar, la nona tribù rappresentante l’assiduo e fervido sospirare verso la ricompensa dell’eterna gloria che per essa si sottopone a ogni servizio di Dio e dei suoi: omni servituti Dei et suorum se subiciens … subposuit humerum suum ad portandum → in che gravi labor li sono aggrati … e l’omero mortal che se ne carca.
[5] Per l’esame compiuto di Ap 22, 1-2 cfr. altrove.
[6] Olivi fa propria la posizione di Bonaventura, secondo la quale Cristo non è la “fine dei tempi”, come indicato dalla teologia dei Padri, ma il centro della storia, “medium Scripturae”. Cfr. J. RATZINGER, San Bonaventura. La teologia della storia, ed. it. a cura di L. Mauro, S. Maria degli Angeli – Assisi 2008 (Viator, 4), pp. 137-166: 157: “È evidente che questa idea originariamente bonaventuriana doveva naturalmente creare una certa apertura nei confronti del duplice schema settenario di Gioacchino; tale schema, dopo l’eliminazione di un tempo autonomo dello Spirito, offriva una rappresentazione piena di vita della posizione mediana nel tempo di Cristo”.
[7] Cfr. G. CONTINI, Un esempio di poesia dantesca (Il canto XXVIII del Paradiso) (1965), in ID., Un’idea di Dante, p. 206.
[8] A ragione M. CARRUTHERS (The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge 1990, pp. 230-233) afferma che la colpa di Paolo e Francesca non consiste nell’aver letto quel libro, ma di essersi fermati al primo stadio, di non averlo letto tutto: «Paolo and Francesca are reading properly here, recreating the exemplary scene, rewritting in their own memories. But having eaten the book with Ezechiel and St. John, they find in the experience a fitting echo of the Apocalypse account, as its sweetness turns bitter. Their fault is not in having read the Lancelot in the first place, nor is it simply in allowing their reading to create desire, it is in reading “no farther”, imperfectly in the medieval sense of “incompletely”» (p. 231).
Tab.10.1
[LSA, prologus, Notabile VIII] Rursus quinque membra sic distincte et interscalariter currunt inter radicem visionum et inter sextum membrum, quod ex hoc ipso aperte insinuatur per ipsa designari quinque sollempnia tempora cum suis sollempnibus statibus et operibus ordinate percurrentibus ab initio ecclesie usque ad sextum tempus ipsius. Que autem essent illa tempora vel opera, aut in quo puncto inchoarentur et finirentur, non potuit a nobis communiter sciri vel investigari nisi per realem et manifestum adventum ipsorum ac per preclaram et sollempnem initiationem status sexti. Et ideo sicut sollempnis initiatio novi testamenti facta in sexta mundi etate cum precursione quinque etatum elucidat intellectum prophetarum quoad primum Christi adventum et quoad tempora ipsum precurrentia, sic sollempnis initiatio sexti status ecclesie cum precursione quinque priorum elucidat intelligentiam huius libri et ceterorum prophetalium quoad trinum Christi adventum et quoad tempora precurrentia tam primum quam secundum adventum, propter quod in ipso sexto tempore erit sol sapientie christiane septempliciter lucens sicut lux septem dierum (cfr. Is 30, 26). (…) Ex predictis autem patet quod principalis intelligentia sexti et septimi membri visionum huius libri fortius probatur et probari potest quam intelligentia membrorum intermediorum inter primum et sextum seu inter radicem et sextum, unde et clara intelligentia ipsorum dependet ab intelligentia sexti, sicut et ratio eorum que sunt ad finem dependet a fine. |
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 4 (IVa visio)] Unde et sextum preconium prerogative ipsorum est indivisibilis et indistans ipsorum ad Christum familiaritas, propter quod subditur: “Et sequuntur Agnum quocumque ierit”. Quantum unusquisque Deum imitatur et participat, in tantum sequitur eum. Qui ergo pluribus et altioribus seu maioribus perfectionibus ipsum imitantur et possident altius et multo fortius ipsum sequuntur. Qui ergo secundum omnes sublimes et supererogativas perfectiones mandatorum et con-siliorum Christi ipsum prout est hominibus huius vite possibile participant, “hii sequuntur Agnum quocumque ierit”, id est ad omnes actus perfec-tionum et meritorum ac premiorum eis corres-pondentium, ad quos Christus tamquam dux et exemplator itineris ipsos deducit.
|
Par. XXVIII, 16-18, 22-27, 40-42, 91-102
|
Par. III, 124-126La vista mia, che tanto lei seguio
|
Par. XXXII, 142-150e drizzeremo li occhi al primo amore,
|
Variazioni sul tema del seguire l’Agnello ovunque vada (Ap 14, 4) sono il proporsi di Virgilio come guida da seguire (Inf. I, 113); la vista di Dante che segue Piccarda, per quanto possibile, finché svanisce (Par. III, 124-125); seguire il corso del cielo da parte dell’aquila dietro a Enea (Par. VI, 1-3); seguire Domenico, di cui dice Tommaso d’Aquino (“per che qual segue lui, com’ el comanda, / discerner puoi che buone merce carca”, Par. XI, 121-123, versi che rinviano anche ad Ap 7, 7); seguire il Figlio da parte di Maria nell’alto preconio dell’amore angelico rotante (Par. XXIII, 106-108); seguire con l’affetto da parte del poeta la preghiera di san Bernardo alla Vergine per poi drizzare, in virtù della grazia di costei, gli occhi al primo amore penetrando “quant’ è possibil per lo suo fulgore” (Par. XXXII, 142-150).
|
|
[LSA, prologus, Notabile VIII] Rursus quinque membra sic distincte et interscalariter currunt inter radicem visionum et inter sextum membrum, quod ex hoc ipso aperte insinuatur per ipsa designari quinque sollempnia tempora cum suis sollempnibus statibus et operibus ordinate percurrentibus ab initio ecclesie usque ad sextum tempus ipsius. Que autem essent illa tempora vel opera, aut in quo puncto inchoarentur et finirentur, non potuit a nobis communiter sciri vel investigari nisi per realem et manifestum adventum ipsorum ac per preclaram et sollempnem initiationem status sexti. Et ideo sicut sollempnis initiatio novi testamenti facta in sexta mundi etate cum precursione quinque etatum elucidat intellectum prophetarum quoad primum Christi adventum et quoad tempora ipsum precurrentia, sic sollempnis initiatio sexti status ecclesie cum precursione quinque priorum elucidat intelligentiam huius libri et ceterorum prophetalium quoad trinum Christi adventum et quoad tempora precurrentia tam primum quam secundum adventum, propter quod in ipso sexto tempore erit sol sapientie christiane septempliciter lucens sicut lux septem dierum (cfr. Is 30, 26). (…) Ex predictis autem patet quod principalis intelligentia sexti et septimi membri visionum huius libri fortius probatur et probari potest quam intelligentia membrorum intermediorum inter primum et sextum seu inter radicem et sextum, unde et clara intelligentia ipsorum dependet ab intelligentia sexti, sicut et ratio eorum que sunt ad finem dependet a fine.[LSA, cap. XI, Ap 11, 6 (IIIa visio, VIa tuba)] Abscondent etiam eis celestem sapientiam et gratiam eo modo quo aquila per summam evolationem in altum abscondit se visui nostro, et eo modo quo molem grossam attenuando et minuendo fere redigit in invisibilem punctum. |
|
Par. IX, 118-120Da questo cielo, in cui l’ombra s’appunta
|
Inf. XXXIV, 4-6, 76-77, 91-93Come quando una grossa nebbia spira,
|
Par. XXXIII, 91-96, 109-114La forma universal di questo nodo
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 6 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Quinto exigitur virtus sciens ex omnibus sensibilibus se comparative transferre ad spiritualia et eterna, ita quod numquam assumit sensibilia et temporalia nisi ut signa et specula intellectualium, et ex innumera multiformitate sensibilium se multiformiter dilatat in contemplatione intellectualium. Hec autem designa-tur per Neptalim, qui interpretatur comparatio vel conversio, scilicet translativa, vel latitudo.
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1; IIIum sigillum] Deum autem humanari ac sperni et mori, ut Deomet satisfiat de iniuriis sibi ab alio factis, et ut illos tali pretio redimeret, qui simpliciter erant sub dominio suo et quos per solam potentiam salvare poterat, pretendit summam stultitiam. […] Contra stultitiam vero, est mercationum doctrine Christi lucrosus et incomparabilis valor. Nam pro denario unius et simplicis fidei habetur impretiabile triticum et ordeum et vinum et oleum, prout in tertia apertione monstratur (cfr. Ap 6, 6).[LSA, cap. I, Ap 1, 17 (radix Ie visionis)] Undecima est ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum quod cecidit in faciem prostratus, quia talis competit actui adorandi; casus vero resupinus est signum desperationis et desperate destitutionis. Huius casus sumitur ratio partim ex intolerabili superexcessu obiecti, partim ex terrifico et immutativo influxu assistentis Dei vel angeli, partim ex materiali fragilitate subiecti seu organi ipsius videntis. Est etiam huius ratio ex causa finali, tum quia huiusmodi immutatio intimius et certius facit ipsum videntem experiri visionem esse arduam et divinam et a causis supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi annichilatus humilius et timoratius visiones suscipit divinas, tum quia valet ad significandum quod sanctorum excessiva virtus et perfectio tremefacit et humiliat et sibi subicit animos subditorum et etiam ceterorum intuentium. Significat etiam quod in divine contemplationis superexcessum non ascenditur nisi per sui oblivionem et abnegationem et mortificationem et per omnium privationem. |
|
Tab.10.2
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. I, 1-12, 22La gloria di colui che tutto move
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (I sigillum)] Nam in prima (apertione) triumphalis lux fidei, procedens a Christo quasi acuta sagitta ex archu, penetravit et illustravit cecos in tenebris sedentes.Par. XXXI, 22-24ché la luce divina è penetrante
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12-13 (VIIa visio)] Sciendum igitur quod, licet per apostolos et per alios sanctos secundi status generalis ecclesie intraverit multitudo populorum ad Christum tamquam per portas civitatis Dei, nichilominus magis appropriate competit hoc principalibus doctoribus tertii generalis status, per quos omnis Israel et iterum totus orbis intrabit ad Christum. Sicut enim apostolis magis competit esse cum Christo fundamenta totius ecclesie et fidei christiane, sic istis plus competet esse portas apertas et apertores seu explicatores sapientie christiane. Nam, sicut arbor dum est in sola radice non potest sic tota omnibus explicari seu explicite monstrari sicut quando est in ramis et foliis ac floribus et fructibus consumata, sic arbor seu fabrica ecclesie et divine providentie ac sapientie in eius partibus diversimode refulgentis et participate non sic potuit nec debuit ab initio explicari sicut in sua consumatione poterit et debebit. Et ideo sicut ab initio mundi usque ad Christum crevit successive illuminatio populi Dei et explicatio ordinis et processus totius veteris testamenti et providentie Dei in fabricatione et gubernatione ipsius, sic est et de illuminationibus et explicationibus christiane sapientie in statu novi testamenti. |
|
Tab.10.3
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. V, 94-105, 130-137Quivi la donna mia vid’ io sì lieta,
|
Par. X, 58-69come a quelle parole mi fec’ io;
|
Tab.10.4
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. V, 94-108, 124-126, 130-137Quivi la donna mia vid’ io sì lieta,
|
Par. X, 58-69come a quelle parole mi fec’ io;
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 7 (Salutatio)] “Et videbit eum omnis oculus”, scilicet bonorum et malorum. Non quod eius deitatem videant, sed corpus assumptum in quo omnibus visibiliter et manifeste apparebit. Unde Matthei XXIIII° dicitur: “Sicut fulgur exit ab oriente et apparet in occidente, ita erit adventus Filii hominis” (Mt 24, 27). Per hoc autem monstrat eum iudicaturum omnes tam bonos quam malos.[LSA, cap. IV, Ap 4, 5 (radix IIe visionis)] “Et de trono procedebant” (Ap 4, 5), vel secundum aliam litteram “procedunt”, “fulgura et voces et tonitrua”, quia tam a Deo quam ab eius ecclesia et quam a sanctis, qui sunt sedes Dei, procedunt “fulgura” miraculorum, quorum claritas longe lateque coruscat sicut fulgura discurrentia; et “voces” rationabilis ac temperate predicationis, “et tonitrua” terribilium comminationum, vel tonitrua altiorum et spiritualium documentorum, que competunt perfectioribus. Voces enim in terra fiunt, tonitrua vero in celo seu ethere, vocesque sunt modice respectu tonitruorum.[LSA, cap. VIII, Ap 8, 5; radix IIIe visionis] “Et facta sunt tonitrua” (Ap 8, 5), scilicet illius altioris doctrine quam Apostolus loquebatur solis perfectis, vel “tonitrua” grandium comminationum; “et voces”, scilicet doctrine rationalis et quasi humane; “et fulgura”, scilicet coruscantium et stupendorum miraculorum, vel superfervidorum eloquiorum sic penetrantium et scindentium et incendentium corda sicut fulgur terrena penetrat et scindit, vel “fulgura” iudiciorum terribilium, ut cum Ananias et Saphira repente occisi sunt ad sententiam Petri, prout scribitur Actuum quinto (Ac 5, 1-11).[LSA, cap. XI, Ap 11, 19 (radix IVe visionis)] […] “et voces”, id est et suaves ac rationabiles persuasiones et predicationes sunt facte. |
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
||
Par. XVI, 28-33 [10-11]
|
Par. XXIII, 25-30 [9-10]Quale ne’ plenilunïi sereni
|
Par. XXV, 25-33 [9-11]Ma poi che ’l gratular si fu assolto,
|
Dopo le domande di Dante, la luce di Cacciaguida si avviva come carbone in fiamma allo spirare del vento: “così vid’ io quella / luce risplendere a’ miei blandimenti” (Par. XVI, 28-30). Da rilevare la variante rispondere, accettata dal Boccaccio e considerata dal Petrocchi “senza dubbio lezione equivalente e interessante”. Essa potrebbe rientrare nel gruppo tematico offerto dall’esegesi di Ap 7, 13 che ha segnato la terzina precedente (vv. 25-27). Tuttavia il principio della prevalenza della zona esegetica, ai significati della quale rinviano le parole-segni in un contesto ristretto, obbliga a privilegiare risplendere, per gli altri riferimenti ad Ap 1, 16 nelle terzine 10a e 11a.
|
||
Tab.10.5
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. XIV, 79-81, 85-87, 94-99, 103-108, 124-126Ma Bëatrice sì bella e ridente
|
Par. XVIII, 19-21Vincendo me col lume d’un sorriso,
|
[LSA, cap. IV, 4, 3 (radix IIe visionis)] “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id est aspectibili seu visibili forme, “lapidis iaspidis et sardini” […] Lapidi vero pretioso dicitur similis, quia quicquid est in Deo est pretiosissimum super omnia. Sicut autem iaspis est viridis, sardius vero rubeus et coloris sanguinei, sic Deus habet in se immarcescibilem decorem et virorem delectabilissimum electis, gratioso virori gemmarum et herbarum assimilatum. Rubet etiam caritate et pietate ad electos et fervida iracundia seu odio ad reprobos. Rubet etiam in eo quod voluit et fecit suum Filium pro nobis sanguine rubificari.
|
|
Tab.10.6
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. XV, 70-72Io mi volsi a Beatrice, e quella udio
|
Purg. XXI, 109-114; XXII, 25-27Io pur sorrisi come l’uom ch’ammicca;
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 13-14 (radix Ie visionis)] Tertia (perfectio summo pastori condecens) est sacerdotalis et pontificalis ordinis et integre castitatis et honestatis sanctitudo, unde subdit: “vestitum podere” (Ap 1, 13). Poderis enim erat vestis sacerdotalis et linea pertingens usque ad pedes, propter quod dicta est poderis, id est pedalis: pos enim grece, id est pes latine. Poderis enim, secundum aliquos, erat tunica iacinctina pertingens usque ad pedes, in cuius fimbriis erant tintinabula aurea, et de hac videtur dici illud Sapientie XVI<II>° (Sap 18, 24): “In veste poderis, quam habebat, totus erat orbis terrarum, et parentum magnalia in quattuor ordinibus lapidum erant sculpta”. […]
|
|
Tab.10.7
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. XIII, 13-24aver fatto di sé due segni in cielo,
|
Par. XIII, 73-78, 115-123Se fosse a punto la cera dedutta
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 2 (IVa visio, VIum prelium)] Quarto erat suavissima et iocundissima et artificiose et proportionaliter modulata, unde subdit: “et vocem, quam audivi, sicut citharedorum citharizantium cum citharis suis”. Secundum Ioachim, vacuitas cithare significat voluntariam paupertatem. Sicut enim vas musicum non bene resonat nisi sit concavum, sic nec laus bene coram Deo resonat nisi a mente humili et a terrenis evacuata procedat.
|
|
Il discorso di Tommaso d’Aquino (Par. XIII, 115-117, 121-123) prima definisce stolti coloro che affermano e negano “sanza distinzione … ne l’un così come ne l’altro passo”, cioè in modo precipitoso e temerario (variazione del tema, esposto nell’esegesi di Ap 14, 2, della necessaria concordia delle opposte corde della cetra, come lo zelo e la misericordia), poi si appunta su colui che, come un pescatore, si mette a cercare la verità senza avere l’arte per farlo, tornando peggiorato nell’ignoranza rispetto a quando era partito (tema dell’arte). L’espressione “non torna tal qual e’ si move”, che esprime un discordare tra un prima e un poi proprio di chi non possiede l’arte per frequente uso, conduce in ben altro contesto ai versi, più antichi e famosi, con cui Dante replica a Farinata che i propri ‘maggiori’, se cacciati due volte (nel 1248 e nel 1260), tornarono a Firenze in entrambi casi (nel 1251 e nel 1266), mentre i ghibellini non appresero bene l’arte di ritornare: «“S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte”, / rispuos’io lui, “l’una e l’altra fïata; / ma i vostri non appreser ben quell’ arte”» (Inf. X, 49-51). La speranza del poeta di tornare a Firenze, vincendo la crudeltà, che lo ha esiliato, per mezzo del suo “poema sacro”, che l’artista citaredo ha bene compulsato imitando il divino citarista, risuona in principio di Par. XXV, il canto dove Dante viene esaminato da san Giacomo sulla speranza: «Se mai continga … con altra voce … ritornerò poeta – si … contingit … “et vocem, quam audivi, sicut citharedorum citharizantium cum citharis suis” … et sub debitis circumstantiis unam virtutem et eius actus aliis virtutibus et earum actibus proportionaliter concordare et concorditer coherere, ita quod rigor iustitie non excludat nec perturbet dulcorem misericordie nec e contrario». Giustizia e misericordia, le due vie di Dio, valgono anche per l’esule. In Tre donne, nel secondo congedo, l’esule fiorentino scriveva: “camera di perdon savio uom non serra, / ché ’l perdonare è bel vincer di guerra”. Dante sperava in una “revocatio gratiosa” in patria; sdegnò il rientro dietro pagamento di una somma di denaro e la sopportazione dell’ignominiosa “oblatio”, come scrisse dopo il 19 maggio 1315 all’amico fiorentino (Epistola XII). |
|
Tab.10.8
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 17 (Va visio, VIIa phiala)] Secundum autem Ioachim, septima phiala effun-ditur super “aerem”, id est super electos, ut si que eis macule adheserunt de communione Babilonis, purgentur et dealbentur super nivem, et in per-cussione septima cessat plaga Domini a populo Dei. Et subdit: «In aere ergo spiritalis ecclesia designatur, que nichil iam sapiet terrenum atque carnale, sed sublimata a terra, munditia et sanctitate angelice vite appropinquabit. Tuncque “de templo”, id est de utroque testamento, et de “trono” Dei, id est de ecclesia, egredietur “vox magna”, id est manifesta intelligentia que docebit omnia esse consumata, nichilque superesse de reliquo nisi quod unusquisque propriam mercedem accipiat secundum suum labo-rem». Hec Ioachim*.
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen desi-gnatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).Par. XXVIII, 79-87Come rimane splendido e sereno
|
Purg. I, 13-18, 22-24Dolce color d’orïental zaffiro,
|
Par. V, 100; XIII, 4-6; XV, 13, 23-24; XXIII, 25-27Come ’n peschiera ch’è tranquilla e puraquindici stelle che ’n diverse plage
|
Tab.10.9
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. XXV, 25-33Ma poi che ’l gratular si fu assolto,
|
Par. XXVI, 25-30E io: “Per filosofici argomenti
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 16 (VIIa visio)] “Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum.
|
|
Tab.10.10
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Par. XXIII, 10-12, 25-72 (cfr. incipit)così la donna mïa stava eretta
|
Par. XXX, 1-2, 10-15, 19-21, 25-27Forse semilia miglia di lontano
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 6 (IIa visio, apertio VIi sigilli)][IV-Aser] Quarto exigitur patientia glorians et gaudens in tribulationibus, quam designat Aser, qui interpretatur beatus et de quo dicitur: “Aser pinguis panis eius, tingat in oleo pedem suum” (Gn 49, 20; Dt 33, 24). Quid enim beatius et pinguius aut magis fortificativum cordis quam sic se habere in adversis ac si suavi oleo inungeretur?[V-Neptalim] Quinto exigitur virtus sciens ex omnibus sensibilibus se comparative transferre ad spiritualia et eterna, ita quod numquam assumit sensibilia et temporalia nisi ut signa et specula intellectualium, et ex innumera multiformitate sensibilium se multiformiter dilatat in contemplatione intellectualium. Hec autem designatur per Neptalim, qui interpretatur comparatio vel conversio, scilicet translativa, vel latitudo.[VI-Manasse] Sexto exigitur oblivio ipsorum sensibilium. Postquam enim ex eis tamquam ex relativis signis et speculis ascendimus ad intellectualia, debemus oblivisci ipsorum ut denudemur ab eis tamquam a velaminibus tenebrosis, et hoc designatur per Manasse, qui interpretatur oblivio. […] Ad perfectum autem nexum amoris exiguntur tria, scilicet amor ad superna elavatus et ad fraterna dilatatus et inferiorum oblitus. |
|
Tab.10.11
Par. XXIII, 103-111“Io sono amore angelico, che giro cfr. 5, 8
|
Par. XXVI, 10-12perché la donna che per questa dia
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
|
Purg. XXXI, 139-145O isplendor di viva luce etterna,
|
Par. XXIII, 25-36Quale ne’ plenilunïi sereni
|
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 1 (VIIa visio)] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit*. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum.* In Ap VII, vii (PL 196, col. 875 C). |
|
Tab.10.12
[LSA, prologus, Notabile VIII] Rursus quinque membra sic distincte et interscalariter currunt inter radicem visionum et inter sextum membrum, quod ex hoc ipso aperte insinuatur per ipsa designari quinque sollempnia tempora cum suis sollempnibus statibus et operibus ordinate percurrentibus ab initio ecclesie usque ad sextum tempus ipsius. Que autem essent illa tempora vel opera, aut in quo puncto inchoarentur et finirentur, non potuit a nobis communiter sciri vel investigari nisi per realem et manifestum adventum ipsorum ac per preclaram et sollempnem initiationem status sexti. Et ideo sicut sollempnis initiatio novi testamenti facta in sexta mundi etate cum precursione quinque etatum elucidat intellectum prophetarum quoad primum Christi adventum et quoad tempora ipsum precurrentia, sic sollempnis initiatio sexti status ecclesie cum precursione quinque priorum elucidat intelligentiam huius libri et ceterorum prophetalium quoad trinum Christi adventum et quoad tempora precurrentia tam primum quam secundum adventum, propter quod in ipso sexto tempore erit sol sapientie christiane septempliciter lucens sicut lux septem dierum (cfr. Is 30, 26). (…) Ex predictis autem patet quod principalis intelligentia sexti et septimi membri visionum huius libri fortius probatur et probari potest quam intelligentia membrorum intermediorum inter primum et sextum seu inter radicem et sextum, unde et clara intelligentia ipsorum dependet ab intelligentia sexti, sicut et ratio eorum que sunt ad finem dependet a fine.[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare*. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
||
Inf. X, 72supin ricadde e più non parve fora.Inf. IX, 37-39dove in un punto furon dritte ratto
|
Par. XXX, 1-2, 10-15, 19-21, 25-27Forse semilia miglia di lontano
|
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 7 (Ia visio, VIa ecclesia)] Unde congrue nomen huius sexte ecclesie, scilicet Philadelphia, non solum interpretatur salvans hereditatem, prout tactum est supra, sed etiam amor fratris, prout dicit Ricardus. Nam in sexto statu, qui est tertius generalis status populi Dei, anthonomasice complebitur illud quod in tertia parte Cantici Canticorum dicit sponsa ad sponsum (Cn 8, 1-2): “Quis michi det te fratrem meum suggentem ubera matris mee, ut inveniam te solum foris et <de>obsculer? Apprehendam te et ducam in domum matris mee”, scilicet sinagoge tunc temporis convertende. |
||
Tab. 10.13
[LSA, incipit] “Erit lux lune sicut lux solis, et lux solis erit septempliciter sicut lux septem dierum, in die qua alligaverit Dominus vulnus populi sui et percussuram plage eius sanaverit”. In hoc verbo, ex XXX° capitulo Isaie (Is 30, 26) assumpto, litteraliter prophetatur precellentia fulgoris celestium luminarium, quam in fine mundi ad pleniorem universi ornatum Dei dono habebunt. Allegorice vero extollitur gloria Christi et Novi Testamenti. Novum enim Testamentum se habet ad Vetus sicut sol ad lunam, unde IIa ad Corinthios III° (2 Cor 3, 7-8) dicit Apostolus: “Quod si ministratio mortis”, id est veteris legis mortem et dampnationem per accidens inducentis, “fuit in gloria, ita ut non possent filii Israel intendere in faciem Moysi propter gloriam vultus eius, que evacuatur”, id est que fuit temporalis et transitoria, “quomodo non magis ministratio spiritus”, id est spiritualis gratie et sapientie Christi, “erit in gloria?”. Tempore autem quo Christus erat nostra ligaturus vulnera sol nove legis debuit septempliciter radiare et lex vetus, que prius erat luna, debuit fieri sicut sol. Nam umbra sui velaminis per lucem Christi et sue legis aufertur secundum Apostolum, capitulo eodem dicentem quod “velamen in lectione Veteris Testamenti manet non revelatum, quoniam in Christo evacuatur”. Unde “usque in hodiernum diem, cum legitur Moyses”, id est lex Moysi, “velamen est positum super cor” Iudeorum; “cum autem conversus fuerit ad Dominum, auferetur velamen. Nos vero revelata facie gloriam Domini speculantes in eandem imaginem transformamur a claritate in claritatem” (2 Cor 3, 14-16, 18). Et subdit (2 Cor 4, 6): “Quoniam Deus, qui dixit de tenebris lucem splendescere”, id est qui suo verbo et iussu de tenebrosa lege et prophetarum doctrina lucem Christi eduxit, “ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientie et claritatis Dei in faciem Christi Ihesu”, scilicet existentis et refulgentis.
|
|
Par. XXII, 139-143, 148-150Vidi la figlia di Latona incensa
|
Par. XXIII, 16-21, 25-33Ma poco fu tra uno e altro quando,
|
Il tema da Isaia 30, 26 costituisce l’incipit della Lectura: “La luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà sette volte di più, quando il Signore curerà le ferite del suo popolo e sanerà le piaghe prodotte dalle sue percosse”. È questa, secondo Olivi, allegoria della gloria di Cristo e del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è, rispetto al Vecchio, come il sole rispetto alla luna, la cui ombra e il cui velo vengono tolti dalla luce di Cristo. Come scrive san Paolo ai Corinzi, se il ministero della morte, cioè la lettera della vecchia legge che uccide, fu glorioso al punto che i figli di Israele non potevano fissare Mosè disceso dal Sinai a causa dello splendore sia pure effimero del suo volto (cfr. Esodo 34, 29-35), quanto più glorioso non sarà il ministero dello Spirito (2 Cor 3, 7-8)? Un velo è steso sul cuore dei figli di Israele, ma quando ci sarà la conversione esso sarà tolto. Allora tutti, riflettendo come in uno specchio la gloria di Dio, verranno trasformati in quella medesima immagine, sempre più chiara (ibid., 3, 15-18). La dottrina di Cristo è contenuta nell’Antico Testamento come il pulcino nell’uovo o il frutto nel seme e nella radice o come la luce di una lucerna che illumina un luogo tenebroso. Il sole sarà luminoso sette volte per designare i sette giorni della solare dottrina di Cristo che nella vecchia legge e nei profeti restarono nascosti sotto il velo. Il numero sette indica anche il corso settiforme della storia della Chiesa, che si svolge, con successive illuminazioni, attraverso sette stati o periodi e viene descritto nel libro dell’Apocalisse, il quale aggrega in sé la multiformità radiosa della luce di sette giorni, illumina la dottrina contenuta nel Vecchio Testamento e si propone come medicina sanatrice delle piaghe del popolo di Dio. Nel Nuovo Testamento, maggiore sarà l’illuminazione del sesto e del settimo stato (a cominciare da Francesco fino alla fine dei tempi), i periodi della storia sui quali ricadono e ricadranno tutti i doni (come tutta la malizia) dei momenti precedenti. Nel passo oliviano non si registrano citazioni di autori, ma non si può fare a meno di notare che i riferimenti all’Esodo e alla lettera paolina ai Corinzi si trovano nell’esegesi di Gioacchino da Fiore relativa allo splendore del volto di Cristo di Ap 1, 16.
|
|
APPENDICE
La “riviera del sangue”, ovvero la grande sineddoche della storia pagana e cristiana
Ad Ap 17, 1 (sesta visione) Olivi afferma che la grande meretrice designa la gente e l’impero dei Romani sia nello stato del paganesimo come in quello cristiano, durante il quale colpevolmente fornicò molto con questo mondo. Tale continuità viene sviluppata ad Ap 17, 6, dove il francescano pone la questione del perché vengano menzionate le colpe commesse da questa donna nel suo primo e antico periodo, al tempo dei pagani: per esse non dovrebbe essere infatti condannata la gente carnale e semicristiana che vive nel sesto tempo della Chiesa. La risposta sta nelle parole di Cristo in Matteo 23, 35: “perché venga su di voi il sangue innocente effuso dal sangue di Abele il giusto”. Come un fiume che dura per molto tempo viene sempre considerato uno, per quanto l’acqua dei suoi primi anni sia diversa dall’acqua di questo anno che corre – al modo con cui diciamo che sono ormai cent’anni che questo fiume ha straripato o si è fatto sangue -, così il continuo succedere del popolo romano viene considerato una gente e un popolo, in modo che si possa dire che questo popolo fu prima pagano e poi cristiano, così da attribuire, quasi per sineddoche, quel che è di una parte all’altra parte o al tutto. Così la colpa della prima parte ridonda nella successiva, in quanto recidiva e fatta ingrata della grazia di Cristo che con misericordia l’ha lavata e santificata. Questa donna, pertanto, che dopo i molti e gravi giudizi fatti nella prima parte del suo popolo non temette di cadere in peccati simili o peggiori, deve essere giudicata per il dispregio di tutti i primi giudizi, anche misericordiosi, dati da Dio sui primi suoi padri, e dunque anche su di essa, su cui sarebbero ricaduti se non avesse demeritato. Imitando i peccati dei padri, li ha abbracciati e proseguiti, e pertanto è rea di tutto, come dice Cristo agli Ebrei del suo tempo: “Guai a voi che edificate i monumenti dei profeti, i vostri padri li hanno uccisi, poiché con la vostra opera date testimonianza che consentite alle opere dei vostri padri” (Luca, 11, 47- 48).
Questo passo contenente l’immagine del fiume “per multa tempora durans”, che giustifica teologicamente il connubio fra tempo pagano e tempo cristiano nel giudizio divino, si presta nel poema a molte variazioni. La storia umana che corre al giudizio come un unico grande fiume, anche se le sue acque non sono le stesse attraverso i secoli, rende partecipe – come in una sineddoche – il paganesimo di tutto il bene e il male che ridondano di secolo in secolo e ricadono infine sul sesto stato, cioè sull’età moderna.
■ Il Flegetonte, “la riviera del sangue” (Inf. XII, 47; XIV, 76-78) dove sono bolliti pagani e cristiani, forma una cascata dal settimo all’ottavo cerchio, paragonata a quella che, rimbombando sopra San Benedetto dell’Alpe, forma il Montone. Questo fiume ha prima il nome di Acquacheta, poi, disceso nella piana di Forlì, cambia nome (o, meglio, è ‘vacante’ di quel nome), ma la caduta dell’acqua è “ad una scesa”, come una è l’acqua del Flegetonte che cade dalla ripa discoscesa (Inf. XVI, 94-105). È da notare che l’acqua del fiume infernale viene chiamata “tinta”, secondo quanto detto ad Ap 17, 3 della donna “sanguine et colore coccineo tinctam et rubricatam”.
I motivi del fiume di sangue che cade sono appropriati all’Arno nell’episodio con Guido del Duca e Rinieri da Calboli nel secondo girone del purgatorio. Il “fiumicel che nasce in Falterona, / e cento miglia di corso nol sazia” (Purg. XIV, 16-18, con riferimento alla “mulier satiata” di Ap 17, 6; cfr. l’inciso: “dicamus quod iste fluvius, iam centum anni sunt, inundavit vel fuit sanguineus”), volge prima il suo corso tra i “brutti porci” abitatori del Casentino; poi, “venendo giuso”, tra i “botoli” aretini; quindi “vassi caggendo” tra i lupi fiorentini e infine tra le volpi pisane (vv. 43-54). Mutano gli abitanti ai lati delle sponde, ma il fiume resta lo stesso, sempre sventura del luogo che bagna, dove tutti fuggono la virtù come nemica biscia (cfr. Ap 12, 9). È fiume di sangue perché Fulcieri, nipote di Rinieri da Calboli e podestà di Firenze nel 1303, vende sulle sue rive la carne dei propri concittadini e poi li uccide, uscendo sanguinoso dalla “trista selva” fiorentina, come il Flegetonte “spiccia fuor de la selva” dei suicidi col suo raccapricciante rossore (Purg. XIV, 55-72: 64-66; Inf. XIV, 76-78). È un fiume il cui nome va taciuto perché aborrito (Purg. XIV, 25-27): variante negativa, questa, del tema della donna che non nasconde il proprio nome famoso per la confusione della colpa (Ap 17, 5, tema presente, con ancor diversa variante, anche nel riferimento del poeta al proprio “nome”, che “ancor molto non suona” in Purg. XIV, 21; sul significato recato dal nome “Arno” cfr. infra).
I motivi, presenti nell’esegesi scritturale, dell’ingratitudine, del discendere o cadere nella colpa antica, senza riferimento al fiume, si trovano nel parlare di Brunetto Latini e di Cacciaguida. Il primo definisce i Fiorentini “quello ingrato popolo maligno / che discese di Fiesole ab antico” (Inf. XV, 61-62), il secondo i fuorusciti Bianchi “la compagnia malvagia e scempia / con la qual tu cadrai in questa valle / … tutta ingrata …” (Par. XVII, 61-65; notare la simetria fra i due luoghi, in terzine numericamente corrispondenti, a partire dalla 21a: ingrato … ti si farà … / tutta ingrata … si farà contr’ a te – de omnibus facta ingrata). Presto, soggiunge l’avo del poeta variando il motivo della strage e della “carnalis et bestialis mulier” presente ad Ap 17, 3, sarà la tua compagnia e non tu ad averne “rossa la tempia” e a fare la prova “di sua bestialitate” (vv. 65-68), con allusione al tentativo di rimpatrio fallito alla Lastra nel 1304; “sì ch’a te fia bello / averti fatta parte per te stesso” (vv. 68-69).
■ Nel corso del colloquio con Ciacco, che gli ha esposto “a che verranno / li cittadin de la città partita”, cioè la divisione della Parte Guelfa a partire dal calendimaggio 1300 (Inf. VI, 60-75), Dante desidera ardentemente vedere Farinata degli Uberti, insieme ad altri cittadini di Firenze che ritiene “sì degni”, e che invece, come gli riferisce Ciacco, “son tra l’anime più nere” (vv. 79-87). Vengono così coinvolte le generazioni precedenti, e di entrambi gli schieramenti, dal ghibellino Farinata, che difese “a viso aperto” Firenze dalla distruzione decretata dopo la battaglia di Montaperti (1260) e che ora è dannato come eresiarca epicureo, ai guelfi Tegghiaio Aldobrandi e Iacopo Rusticucci che stanno sotto la pioggia di fuoco coi sodomiti, fino al Mosca dei Lamberti, che dicendo “Capo ha cosa fatta” decretò l’assassinio di Buondelmonte (1216) e l’inizio della divisione fra Guelfi e Ghibellini, come da lui stesso dichiarato nella bolgia che punisce i seminatori di scandalo e di scisma. Sui dissidi della propria generazione, Dante fa in tal modo ricadere tutto il male precedente, in modo non dissimile da Cristo, che attribuisce tutti i mali provenienti da ogni generazione di reprobi alla particolare malvagia generazione dei reprobi Giudei del suo tempo, sulla quale ricade tutto il sangue versato dal tempo di Abele il giusto (Matteo 23, 35-36: “ut veniat super vos omnis sanguis iustus … Dopo lunga tencione verranno al sangue”: Inf. VI, 64-65). Il ridondare della colpa antica dei padri sulla nuova dei figli è tema che passa in Giustiniano, il quale parla per opera del reverendo segno dell’aquila che gli fa dire, a proposito di Carlo II d’Angiò e dei suoi Guelfi (ma in una contestuale condanna di entrambe le fazioni), che “molte fïate già pianser li figli / per la colpa del padre” (Par. VI, 109-110; cfr., ad Inf. XIX, 115-117, il lamento verso “il primo ricco patre”, cioè Costantino, per la cui donazione tanto male venne al mondo da esserne distrutto, come precisato a Par. XX, 55-60).
Essere reo di colpe altrui è un motivo insito nella dolorosa domanda del fiorentino suicida, il cui cespuglio è stato devastato e rotto dalle nere cagne correnti nella selva dopo che uno scialacquatore in fuga vi si è messo al riparo: «“O Iacopo”, dicea, “da Santo Andrea, / che t’è giovato di me fare schermo? / che colpa ho io de la tua vita rea?”» (Inf. XIII, 133-135).
■ Gli ornamenti della donna, che siede sulla bestia dalle sette teste e dalle dieci corna (Ap 17, 3), possono essere anche intesi come i doni intellettuali che la Chiesa carnale scialacqua con la sua superbia, come rimproverato da Dio in Ezechiele 16, 10-19 alla Sinagoga (e quindi alla Chiesa in essa prefigurata) per avere fatto immagini idolatre delle vesti d’oro e d’argento che le aveva dato e per avere offerto a quelle ogni ornamento e ricchezza precedentemente avuti (Ap 17, 3-6). È quanto Dante rimprovera a Niccolò III, nella bolgia dei simoniaci che attristano il mondo con la loro avarizia idolatra: “Fatto v’avete dio d’oro e d’argento” (Inf. XIX, 112-114). La libera volontà, afferma Beatrice, è il maggior dono di cui Dio dotò tutte e solo le creature intelligenti; di qui l’alto valore del voto, sacrificio di tale dono, nel quale non c’è contraddizione fra il consentire divino e quello umano (Par. V, 22-27; i versi rinviano a una quaestio di Olivi).
■ Altro esempio è l’ammonimento di Beatrice a non prendere i voti alla leggera, ad essere fedeli ma non in modo sconsiderato (Par. V, 64-84). Il “siate fedeli” (v. 65) è filo che proviene dalla chiesa di Smirne, alla quale Cristo dice: “Esto fidelis usque ad mortem” (Ap 2, 10; cfr. altri esempi). Il contrasto tra un ‘prima’ santificato e lavato dalla grazia e dalla misericordia divina e un ‘poi’ caduto in una colpa peggiore della precedente, contrasto che segna il ricadere dell’acqua antica del fiume sulla nuova, è presente nella figura di Jefte che fece voto a Dio di offrirgli la prima cosa gli fosse venuta incontro sulla porta della casa – “la sua prima mancia” -, con il risultato di uccidere l’unica figlia: meglio avrebbe fatto a dire “mal feci” e a ritornare sul voto promesso che, mantenendolo, “far peggio” (vv. 66-68). Si conferma l’interpretazione, proposta dal Daniello, di “mancia” come saluto del buon mattino dato per Natale e nel primo giorno del nuovo anno, che ben corrisponde al senso di ‘primo dono’ della grazia divina poi scialacquato. L’espressione di Beatrice, rivolta ai cristiani – “e non crediate ch’ogne acqua vi lavi” (v. 75) – è anch’essa intrecciata coi motivi del fiume-donna (“Prima culpa prioris partis redundat pro tanto in postremam pro quanto, per Christi gratiam ab ill<a> misericorditer lota et sanctificata, est recidivando de omnibus facta ingrata”).
■ Consentire alle opere dei padri, cioè alle precedenti colpe, ha condotto alla dannazione Guido da Montefeltro. I motivi dell’esegesi del fiume, ad Ap 17, 6, punteggiano tutto l’episodio (senza che il fiume sia mai citato). Già nel primo rivolgersi della fiamma al poeta, che Guido ritiene “caduto … di quella dolce terra / latina ond’ io mia colpa tutta reco” (Inf. XXVII, 25-27), si riconoscono il “cadere in peccata” e l’essere “omnium rea” della donna-fiume antica e nuova. Il Montefeltrano accusa Bonifacio VIII – “se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!, / che mi rimise ne le prime colpe” (vv. 70-71) – in quanto istigatore alla colpa recidiva: domandandogli consiglio su come gettare a terra Palestrina, lo ha fatto ricadere nel vecchio peccato di frode per cui si era acquistato fama con le sue opere volpine (cfr. Ap 12, 8). La risposta data al pontefice dal vecchio uomo d’arme, che ora porta la corda francescana per fare ammenda del passato, è una testimonianza di consenso alle opere dei padri che caddero in peccato, edificando così, nonostante il divieto di Cristo, un monumento ai profeti: «e dissi: “Padre, da che tu mi lavi / di quel peccato ov’ io mo cader deggio”» (vv. 108-109). Guido chiama Bonifacio “padre”, ed è motivo che concorda col cadere nel peccato antico. Erroneamente crede che da esso il pontefice possa lavarlo, cioè assolverlo: le parole di ammonimento di Beatrice sulla leggerezza nel far voti – “e non crediate ch’ogne acqua vi lavi” (Par. V, 75) – risuonano, a molti versi di distanza dall’episodio infernale, come un suggello.
Se Guido ha consentito peccando alle opere dei padri, la “contradizion … nol consente” che ci si possa pentire della colpa e insieme volerla commettere, come argomenta il diavolo “löico” di fronte a san Francesco, venuto invano a prendere l’anima del frate dopo la morte (Inf. XXVII, 112-120). È da notare che il verbo ‘consentire’ compare, nel senso di aderire al vecchio, oltre che nella citazione di Luca 11, 48 ad Ap 17, 6, anche ad Ap 6, 12 (apertura del sesto sigillo), dove si spiega che l’Ordine francescano necessita di due o tre generazioni di tirocinio per essere disposto a sostenere una condanna simile a quella di Cristo pronunciata dai sommi pontefici giudei e da quanti ad essi consentono (Bonifacio VIII è “lo principe d’i novi Farisei”). La stessa contraddizione è caratteristica del Vecchio Testamento, il cui senso è involuto, oscuro e fluttuante quasi un mare procelloso o una nube densa e tetra che assume ora un colore ora un altro, come spiegato nell’esegesi dei motivi che rendono chiuso il settimo sigillo: alla sua apertura si farà silenzio in cielo, perché la semplicità della fede e della sapienza di Cristo metterà a tacere ogni contraddizione e litigio tra vecchio e nuovo (ad Ap 5, 1).
Il consentire e la contraddizione compaiono insieme in altro luogo del poema, allorché Beatrice deve spiegare l’apparente contraddizione tra le proprie parole, secondo le quali Costanza d’Altavilla e Piccarda non ebbero un “volere intero” di ritornare alla vita religiosa da cui erano state strappate con la violenza, e quelle di Piccarda, che aveva invece testimoniato la volontà di osservare il voto col cuore da parte di Costanza. Beatrice chiarisce che lei parlava della volontà condizionata, che accetta il male consentendo a un danno minore per fuggire un pericolo ritenuto più grande, mentre Piccarda parlava della volontà assoluta, che “non consente al danno” (Par. IV, 91-114) [1]. Così, con un’argomentazione che non era stata contrapposta da Francesco al nero e “löico” cherubino venuto per portare a Minosse l’anima del Montefeltrano, la verità di Beatrice scioglie la contraddizione. Dante vede, come gli dice più avanti Giustiniano, “ogne contradizione e falsa e vera” (Par. VI, 19-21).
■ Il fiumicello, rosso per il sangue bollente, che esce dalla selva e se ne va per l’arena del sabbione, “quale del Bulicame esce ruscello / che parton poi tra lor le peccatrici”, è il Flegetonte (Inf. XIV, 76-81). Questo tartareo fiume di virgiliana memoria è insieme uno e partito, come lo Spirito increato. Che si tratti proprio dei doni dello Spirito, intesi in senso negativo, lo dimostra la presenza del verbo partire, appropriato all’acqua del ruscello che esce dal Bulicame, la sorgente sulfurea presso Viterbo: come si può vedere ad Ap 5, 6 (passo simmetrico ad Ap 1, 4, dove il secondo modo del dare, ivi trattato, proviene dai sette spiriti che stanno dinanzi al trono) [2], l’increato spirito di Cristo – che ha in sé la “plenitudo spiritualis fontalitatis”-, in sé uno e semplice, viene “partito”, cioè diviso, in sette doni. Una variante del medesimo tema è l’uscita nell’Eden da una sola sorgente di un’unica acqua (“d’una fontana”) che poi da sé si ‘diparte’ nel Lete e nell’Eunoè, assimilati al Tigri e all’Eufrate di Genesi 2, 14 (Purg. XXXIII, 112-117). Immagine che si ripercuote nel finale della Monarchia (III, xv, 15), per attestare che l’autorità del Monarca temporale discende direttamente dall’unico fonte dell’universale autorità, che da semplice si fa molteplice “ex habundantia bonitatis”.
Così il fiumicello, che è “uno” e poi “partito” tra le “peccatrici”, può designare i doni intellettuali che poi si volgono al peccato, secondo quando detto ad Ap 17, 3 degli ornamenti della donna seduta sopra la bestia scarlatta dalle sette teste e dieci corna (cfr. Inf. XIX, 109-111: “quella che con le sette teste nacque, / e da le diece corna ebbe argomento, / fin che virtute al suo marito piacque”).
Entrano in collazione altri passi, in particolare quelli relativi al fiume. Ad Ap 14, 20, parte finale della settima guerra, si dice che dal lago dell’ira divina, nel quale l’angelo ha gettato l’uva vendemmiata e che viene “calcato” fuori della città di Dio, “uscì sangue fino al morso dei cavalli per una distanza di 1600 stadi”. Appartengono a questo gruppo il torrente sulfureo (il “Bulicame”), l’uscita del sangue, il “parvum flumen” che diventa poi inguadabile.
Nella settima visione, a Giovanni viene mostrato il fiume nobilissimo che scorre nel mezzo della Gerusalemme celeste (Ap 22, 1). Designa l’abbondanza della gloria che Dio emana sui beati. Questo fiume che “procede dalla sede”, cioè dalla maestà di Dio e dell’Agnello, è lo Spirito Santo e tutta la sostanza della grazia e della gloria per la quale e nella quale la sostanza della somma Trinità deriva e viene comunicata a tutti i santi e soprattutto ai beati. Essa procede anche dall’Agnello che, in quanto uomo, la dispensa per merito. Viene detto “fiume” per la copiosità e continuità; “di acqua” perché rinfresca, lava e ristora; “viva” perché, secondo Riccardo di San Vittore, scorre sempre senza mai venir meno. Il Bulicame si presenterebbe in tal modo come la versione negativa di questo fiume paradisiaco, aspetto che potrebbe essere ancor più accentuato se si considera l’etimologia corrente di Viterbo, proposta da Giovanni Villani, come Vita Erbo, cioè “vita agl’infermi, ovvero città di vita”.
Ap 1, 5, passo in cui si tratta del quinto primato di Cristo uomo, “che ci lavò dai nostri peccati con il suo sangue”, presenta il motivo della colpa lavata dal bagno nel sangue caldo e (nel caso di Cristo) puro.
Ad Ap 17, 6 è esposta l’esegesi, qui sopra considerata, del fiume sanguigno nel paganesimo e nel cristianesimo. Il fiume designa la prostituta e le sue genti antiche e recenti che peccarono e, lavate dalla Grazia, caddero recidive.
Le “peccatrici” che si dividono l’acqua del Bulicame, assimilata al rosso e bollente Flegetonte, possono bene designare, come interpretato dall’Ottimo, le prostitute che curano le loro malattie. I fiumi Flegetonte e Lete sono accomunati nella risposta di Virgilio alla domanda del discepolo in Inf. XIV, 130-138; il Lete è “là dove vanno l’anime a lavarsi / quando la colpa pentuta è rimossa”.
A questo punto, tenuto conto della stretta connessione tra fiume, sangue, lavare e peccato proposta dall’esegesi, è da escludere la congettura “pettatrici” in luogo di “peccatrici” per indicare coloro, non prostitute ma lavoratrici della canapa, che si dividerebbero l’acqua del ruscello uscito dal Bulicame.
“Peccatrici” è infatti la lezione offerta dall’unanime tradizione manoscritta, e modificata per il solo fatto che le fonti storiche conosciute tacciono o non testimoniano con sufficiente sicurezza della presenza di meretrici che facessero uso per lavarsi dell’acqua termale.
***
[1] La distinzione tra i due tipi di volontà è nell’esegesi dell’istruzione data al vescovo di Laodicea, la settima chiesa d’Asia (LSA, cap. III, Ap 3, 15): «Increpans ergo eum, subdit (Ap 3, 15): “Scio opera tua”, id est scientia iudiciali et improbativa, “quia neque calidus es”, scilicet per caritatem, “neque frigidus”, per infidelitatem vel per omnimodam vite secularitatem, quasi dicat: solam fidem et quandam exterioris religionis speciem absque igne caritatis habes. […] Hunc autem caloris defectum exaggerat preferendo frigidum huic tepido. Unde subdit: “Utinam frigidus esses aut calidus” […] Sed videtur quod minus malum sit esse tepidum quam esse frigidum, quia frigidum plus distat a calido et plus contrariatur ei et difficilius calefit quam tepidum; tepidum etiam plus participat de calido quam frigidum. […] Sed adhuc obicitur contra hoc quod sub disiunctione optat eum esse frigidum, quia hoc est optare ipsum esse malum. Dicendum quod malum, in quantum secundum quid et respectu maioris mali habet quandam rationem boni, potest recte optari et sic est in proposito. Non enim simpliciter et absolute optat quod esset frigidus, id est quod semper fuisset secularis vel paganus, sed solum optat hoc comparative, tamquam minus malum suo tepore. Sicut enim minus bonum dicitur aliquando, secundum quid et comparative, esse malum respectu maioris boni, sic minus malum habet, secundum quid et comparative, quandam rationem boni respectu maioris mali».
[2] Purg. XXX inizia allorché i sette candelabri, che aprono la processione nell’Eden, si fermano. Essi sono definiti “il settentrïon del primo cielo, / che né occaso mai seppe né orto”, cioè l’Orsa dell’Empireo che, come l’Orsa terrestre, segna il cammino da percorrere. I sette candelabri designano i sette doni dello Spirito increato, che non ha principio né fine. Il “settentrion” rende ciascuno consapevole di quello che debba fare e, fermandosi, fa in modo che i ventiquattro seniori che lo seguono si volgano al carro. I seniori si volgono al carro “come a sua pace”, e uno di loro invoca l’arrivo di Beatrice cantando tre volte “Veni, sponsa, de Libano”. Il confronto è con l’esegesi di Ap 1, 4, dove si parla dei “sette spiriti che stanno dinanzi al suo trono”. Si precisa trattarsi dello Spirito increato, semplice per natura e settiforme per grazia, radice e forma esemplare dei sette stati della Chiesa che costituiscono l’oggetto principale del libro. Viene detto che i sette spiriti sono dinanzi al trono perché fanno stare nel cospetto di Dio e della sua sede coloro i quali ne sono pieni (il carro-Chiesa militante tirato dal grifone-Cristo), secondo le parole di san Paolo ai Romani (Rm 8, 26): “è lo stesso Spirito che domanda per noi”, perché ci fa domandare (i seniori invocano l’arrivo di Beatrice).
Tab. App. 1
Inf. VI, 64-65E quelli a me: “Dopo lunga tencione
|
Purg. XIV, 16-21, 25-27, 49-51E io: “Per mezza Toscana si spazia
|
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 3.5-6 (VIa visio)] “Et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam” (Ap 17, 3), id est sanguine et colore coccineo tinctam et rubricatam. Nota quod sicut quodlibet caput bestie aliquando dicitur bestia, aliquando vero distinguitur ab ea sicut caput a corpore vel sicut rex a sua gente, sic mulier ista in quantum est carnalis et bestialis dicitur bestia, in quantum vero quondam prefuit et regnavit super bestiales gentes mundi et adhuc super plures bestiales sibi subditas dominatur, dicitur sedere super bestiam. Que quidem bestia tempore paganorum et hereticorum fuit sanguine martirum cruentata, nunc autem sanguine seu strage animarum et impia persecutione spiritus et spiritualium et etiam quorumcumque quos impie affligit est cruentata, et etiam abhominando sanguine luxuriarum suarum. […] “Habentem capita septem et cornua decem”.
|
|
Inf. XV, 61-64Ma quello ingrato popolo maligno
|
Par. XVII, 61-69E quel che più ti graverà le spalle,
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (clausura VIIi sigilli)] Tertia ratio septem sigillorum quoad librum veteris testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. […] Septimum est sensuum veteris scripture fluctuans volubilitas et involucrorum seu tegumentorum figuralium umbrositas et obscura multiformitas, unde et sicut mare procellosum et vertiginosum et voraginosum et quasi non habens fundamentum seu fundum. Est etiam sicut nubes densa et tetra, nuncque rubescens nunc vero pallescens, nunc virens nunc albens, et nunc in uno loco et nunc in alio. Hanc autem aperit intellectualis nuditas et simplicitas fidei et sapientie Christi, prout Apostolus IIa ad Corinthios III° docet. Hanc autem plenius aperiet Christus, cum implebitur illud quod sub sexto angelo tuba canente iurat et clamat angelus tenens librum apertum, scilicet quod “in diebus septimi angeli, cum ceperit tuba canere, consumabitur”, id est ad plenum implebitur et explicabitur, “misterium Dei sicut evangelizavit per servos suos prophetas” (Ap 10, 6-7). Tunc enim omnis litigatio et contradictio inter vetus et novum omnino silebit, prout notat apertio septima (cfr. Ap 8, 1). |
|
Tab. App. 2
[LSA, cap. I, Ap 1, 4 (prohemium, salutatio)] Pro secundo dicit: “Et a septem spiritibus”. Hoc non potest hic stare pro spiritibus angelorum creatis, quia gratia non dicitur dari nobis a creatura vel ab angelis, sed solum quod ministerialiter cooperantur ad hoc ut nobis detur a Deo. Non etiam potest stare pro donis gratie creatis, quia tunc esset sermo nugatorius et ridiculosus, scilicet quod ab ipsis donis creatis darentur nobis ipsamet dona creata. Stat ergo pro increato Spiritu. Unde et Ricardus exponit: “a septem spiritibus”, id est a septiformi Spiritu, qui simplex est per naturam et septiformis per gratiam. Dividit enim dona singulis prout vult. Dicit etiam hoc appropriate referri ad personam Spiritus Sancti*. Significavit autem sic Spiritum increatum, tum ut insinuet eius causalem multiformitatem, tum ut ostendat eius multiformem et presentialem partici-pationem in variis donis ac si in eis partiretur et multiplicaretur, tum ut ostendat eius originalem radicem et rationem et exemplarem formam septem statuum ecclesie de quibus in hoc libro est intentio principalis. “Qui in conspectu troni eius sunt”, id est qui eos quos replent faciunt in conspectu Dei et sue sedis stare, iuxta quod ad Romanos VIII° (Rm 8, 26) dicitur quod “ipse Spiritus pro nobis postulat”, quia facit nos postulare. Pro quanto etiam est quasi idem cum donis a se influxis, dicitur stare ante Deum quia eius dona stant ante Deum et ad cultum scilicet eius. Ricardus tamen legit quod ipsi spiritus semper conspiciuntur per contemplationem a sanctis angelis et hominibus, qui sunt tronus Dei quia residet in eis sicut rex in suo trono**.* In Ap I, ii (PL 196, col. 696 B-C).** In Ap I, ii (PL 196, col. 696 C-D). |
Purg. XXX, 1-12Quando il settentrïon del primo cielo,
|
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 3.5-6 (VIa visio)] “Et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam” (Ap 17, 3) […] “Habentem capita septem et cornua decem”. […]
|
|
Inf. XIV, 76-81Tacendo divenimmo là ’ve spiccia
|
Purg. XXXIII, 112-117Dinanzi ad esse Ëufratès e Tigri
|
Monarchia, III, xv, 15: Sic ergo patet quod auctoritas temporalis Monarche sine ullo medio in ipsum de Fonte universalis auctoritatis descendit: qui quidem Fons, in arce sue simplicitatis unitus, in multiplices alveos influit ex habundantia bonitatis. |
[LSA, cap. V, Ap 5, 6-7 (radix IIe visionis)] Quarto ostenditur habere universalem plenitudinem sapientie et providentie et spiritualis fontalitatis omnis gratie ad universa regenda, cum subditur: “et oculos septem, qui sunt septem spiritus Dei missi in omnem terram”. “Oculi” vocantur propter intelli-gentiam omnium visivam, “spiritus” vero propter subtilem et spiritualem et agilem naturam et efficaciam. Licet autem increatus spiritus Christi sit in se unus et simplex, dicitur tamen esse “septem spiritus” propter septiformitatem septem donorum suorum et septem statuum, in quibus participatur et quibus secundum eorum partialem seu particularem proportionem assistit, ac si esset in eis partitus et particulatus.
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 20 (IVa visio, VIIum prelium)] De quo lacu subditur (Ap 14, 19): “Et misit in lacum ire Dei magnum”. Lacus inferni dicitur lacus ire Dei, quia ibi in penis impletur effectus ire et vindicte Dei. Magnus vero dicitur, quia omnes dampnatos, qui erunt quasi innumerabiles, intra se capiet. “Et calcatus est lacus extra civitatem” (Ap 14, 20), id est extra locum et collegium beatorum, propter quod et a Christo Matthei VIII° et XXII° (Mt 8, 12; 22, 13) tenebre huius laci vocantur tenebre exteriores. Et Matthei XIII° (Mt 13, 49-50) dicitur: “Exibunt angeli et separabunt malos de medio iustorum et mittent eos in caminum ignis”. Sequitur autem tropum civitatis Iherusalem quia extra ipsam est vallis Iosaphat, que secundum Ieronimum est inter montem Sion et montem Oliveti, in qua stabunt impii in die iudicii. Et etiam Isaie XXX° (Is 30, 33) dicitur quod vallis Tophet, que est extra Iherusalem, “est preparata, profunda et dilatata”, in qua est “ignis et ligna multa” et “flatus Domini sicut torrens sulphuris”, in qua incendi debebat rex Assiriorum cum exercitu suo. Sequitur: “Et exivit sanguis de lacu usque ad frenos equorum per stadia mille sescenta”. Secundum Ioachim, per hoc quod dicit sanguinem ascendere usque ad frenos equorum designat, per proportionem pene istorum dampnatorum ad culpas eorum, declarari quod malitia culpe eorum fuit intolerabilis et non amplius differenda puniri. In parvo enim flumine etiam parvus asinus transit; ex quo vero tangit frenos equorum, est discrimen non modicum transeunti. Quia vero duo sunt que excedunt modum ut non debeant tolerari, scilicet immensitas culpe et eius diuturnitas, ideo primum designatur in altitudine sanguinis usque ad frenos equorum, secundum vero in longitudine sui torrentis procedentis usque ad stadia mille sescenta. Sustinet enim Deus hunc torrentem malitie quamdiu equi ipsius ferre poterunt; quando autem non solum aselli sed etiam equi videntur periclitari, ita ut regnante Antichristo in errorem ducantur, si fieri potest, etiam electi (cfr. Mt 24, 24), non debet iudicium impiorum ulterius differri sed potius ad Deum clamari: “Exurge, Domine, non confortetur homo” (Ps 9, 20)*.* Expositio, pars IV, distinctio VII, ff. 176vb-177rb. |
|
Tab. App. 3
[LSA, cap. XIII, Ap 13, 18 (IVa visio, VIum prelium)] Quia vero numerus nominis bestie seu Antichristi continet in se magnum misterium, in cuius intelligentia est magna sapientia sanctis tunc ad sciendum valde utilis, ideo subditur (Ap 13, 18): “Hic”, id est in hoc loco seu numero, “sapientia est”, id est secretum magne sapientie; vel hic oportet haberi magnam sapientiam ad sciendum misterium predicti numeri.
|
|
Purg. XIV, 4-6, 22-24“Non so chi sia, ma so ch’e’ non è solo;
|
* In Ap IV, v (PL 196, col. 808 C-D). |
In greco, lingua nella quale venne scritta l’Apocalisse, i numeri si indicano per mezzo delle lettere dell’alfabeto. Il numero di un nome è il totale delle lettere. Il “numero del nome” della bestia o dell’Anticristo è un grande segreto che richiede sapienza d’intelletto per essere computato e conosciuto. Non è uno dei numeri eterni di Dio, né di un uomo spirituale, è piuttosto un numero carnale. Oltre ad “Antemos” (“contrario”), in greco esistono altri due nomi le cui lettere formino il numero 666: “Arnoyme” e “Teitan” (Ap 13, 18).
|
|