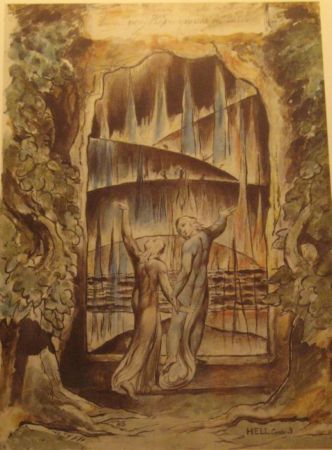La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuoriCanti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXXII, 124-XXXIII, 90
|
A mia madre
Premessa: 1. Dalla “nova terra”. 2. Parodia e Sacra Scrittura. 3. Dante profeta. 4. Il viaggio. 5. Il mistero del “sacrosanto segno”. 6. La “chiave di canto”: l’imitazione di Cristo. 7. Considerazioni sull’ordine di composizione dell’ Inferno. Testi e commento.
PREMESSA
1. Dalla “nova terra”
“Se si considerano le cose nella loro genesi, si ottiene di esse una migliore intelligenza”, scrive Aristotele nella Politica (I, 2, 1252a). È proprio di questa ricerca considerare la Commedia di Dante nella sua genesi confrontandola con un’opera contemporanea, la Lectura super Apocalipsim che il francescano Pietro di Giovanni Olivi portò a termine poco prima di morire a Narbonne nel 1298. Questo commento apocalittico, vessillo degli Spirituali francescani pervenuto subito in Italia nei primi anni del Trecento, fu la condizione necessaria per la decisione di scrivere la Commedia; esso creò “nuovi temi e interrogativi all’animo del poeta”.
Quando, nel 1995, l’autore della presente ricerca decise di dedicarsi al confronto testuale fra le opere di Dante e quelle di Olivi, non immaginava che gli sarebbe accaduto quanto scritto nel Convivio (II, xii, 5), che cioè talvolta “l’uomo va cercando argento e fuori della ’ntenzione truova oro, lo quale occulta cagione presenta; non forse sanza divino imperio”. Nel procedere della ricerca, l’autore si è trasformato in scriba di quanto i testi gli palesano, al filologo si è accompagnato l’archeologo che scava all’interno della Commedia, mettendo in luce la sua qualità di “grande parodia sacra” della Lectura super Apocalipsim del frate di Sérignan (qualche studioso più avanzato potrebbe spingersi a parlare di DNA del testo). “Grande”, perché diffusa per tutto il poema; “parodia”, in quanto metamorfosi di concetti dottrinali; “sacra” perché, attraverso tali concetti, inserisce la realtà umana nei disegni divini.
Alla parodia è connesso un procedimento di arte della memoria: parole-chiave, incardinate nel senso letterale del poema, operano sul lettore “spirituale” come imagines agentes che lo sollecitano verso un’opera di ampia dottrina, la Lectura oliviana che già conosce, ma che rilegge mentalmente parafrasata in volgare, profondamente aggiornata secondo gli intenti propri del poeta, in versi che le prestano “e piedi e mano” e la dotano di exempla contemporanei e noti. Nel senso letterale del “poema sacro” sono incardinati gli altri sensi interpretativi: allegorico, morale, anagogico (nell’Epistola a Cangrande definiti collettivamente “mistici” o “allegorici”). Dante mirava non solo a un pubblico di laici o, in generale, di chierici, ma anche di predicatori e riformatori della Chiesa – agli Spirituali francescani, e forse non solo ad essi, se la Lectura si fosse diffusa anche presso altri Ordini -, a coloro cioè che con la predicazione avrebbero potuto riformare la Chiesa e con la “lingua erudita” – il suo volgare – convertire il mondo. La riforma, come pure il ristretto pubblico che avrebbe dovuto attuarla, non si realizzò, per le note vicende che travolsero gli Spirituali e il loro stesso libro-vessillo.
La ricerca rovescia la vecchia regoletta del loicare, che Bruno Nardi adduceva a proposito delle presunte fonti dantesche: “a posse ad esse non datur illatio” [1]. Non inventa ipotesi ma mostra testi, non forzandoli né dolcemente sollecitandoli; essi, nel loro esse, argomentano e provano. Poiché non è timida amica della verità, non teme di “perder viver tra coloro / che questo tempo chiameranno antico” (Par. XVII, 118-120). I risultati, dettati dai testi sulla base di norme da essi stessi imposte, sono torre ferma su ferma rupe, che nessun soffiar di venti potrà far vacillare. Sulla nuova terra altre numerose scoperte verranno effettuate, ma nessuno potrà mai ignorarne o negarne l’esistenza se vorrà fregiarsi dell’insegna di storico di quei tempi.
Molti saggi sono apparsi su questo sito, inaugurato nel 2009, accompagnati da pubblicazioni a stampa. Nello stesso anno è stata edita la Lectura super Apocalispim (PDF), della quale è ora disponibile una versione in html. Alcuni canti sono stati esaminati per intero: Inferno II, III, IV, V, X [PDF], XXVI [PDF], XXXII-XXXIII (nell’episodio del conte Ugolino); Purgatorio III, XXVIII; Paradiso XI-XII, XXXIII. Dieci saggi sono dedicati al rapporto tra Dante e Gioacchino da Fiore.
Sostenuta incondizionatamente fin dall’inizio da Ovidio Capitani, e confortata da un fecondo carteggio con Guglielmo Gorni, la ricerca ha registrato per vent’anni il silenzio assordante del mondo accademico. Rimasti i più ignari della sua esistenza, essa certamente lascia sconcertati quanti ne sono consapevoli, fra i quali forse qualcuno si chiede chi sia costui che, estraneo ai circoli dove queste cose vengono sottilmente studiate, garrulus factus, ha intravisto da solo nella sabbia granelli d’oro dai quali la scienza può trarre molte conclusioni. Al di là dell’assoluta novità e complessità della ricerca, che traccia sentieri su una nuova terra ma che richiede fede e dedizione a chi intenda accingersi a una verifica o a una sua continuazione, i silenzi accademici nascono soprattutto da un problema di ambiti di competenza (possono essere trascurati i risibili tentativi di classificare la ricerca nel filone dell’esoterismo dantesco). I “dantisti” non conoscono se non superficialmente la Lectura dell’Olivi e non considerano, salvo rarissimi casi, l’arte della memoria: non sono dunque in grado di confermare o confutare alcunché. Viceversa, nel campo degli studi storici l’Olivi è confinato nell’ambito francescano, mentre Dante è appannaggio della storia della letteratura. Non ha poi giovato il fatto che la Lectura sia rimasta inedita per settecento anni e conosciuta soltanto per estratti, né invita al suo approfondimento la recente (pseudo) edizione critica di Warren Lewis [2]. Si deve aggiungere l’eclisse degli studi storico-religiosi, ben lontani dall’aver superato, dopo più di mezzo secolo, i lavori pionieristici di Raoul Manselli sull’argomento. Si continua così a parlare di Dante teologo e profeta, si cercano intertestualità con le fonti più disparate, si raffinano filologicamente le precedenti edizioni ma si trascura la somma opera escatologica a lui contemporanea, svuotando il poeta di spessore storico. Togliere la Lectura dalla ‘biblioteca’ di Dante, o non valutare compiutamente il gran peso che recò nella stesura del poema, equivale a concepire quella di Agostino senza le Historiae di Orosio, di Cervantes senza i romanzi cavallereschi, di Proust senza Ruskin e Bergson, di Italo Calvino senza Kipling e Conrad. Il confronto con la Lectura, “panno” da cui il buon sartore ha fatto “la gonna” (cfr. Par. XXXII, 139-141) e dunque vade mecum del poeta, riconduce la Commedia nell’ambito storico che l’ha determinata, quando l’escatologismo, come scriveva Arsenio Frugoni, “oltre che ideologia di lotta e di riforma del gruppo spirituale, era anche un vero e proprio sentimento storico” [3].
Giorgio Brugnoli scriveva, a proposito della possibilità che il poeta avesse aderito alle tesi dell’Olivi condannate dal Concilio di Vienne (1311-1312), della “solita censura ideologica e inquisizionale” operata dal “pietismo dantistico imperante” allo scopo di sottrarre Dante all’eterodossia [4]. Eppure sulla Lectura (censurata nel 1318-1319 e condannata da Giovanni XXII nel 1326) Dante ha confermato la propria vocazione di profeta, penetrando la “mira profunditas” del divino eloquio della quale scrive Agostino. All’opposto, sulla ricerca hanno gravato i timori dei guardiani del laicismo integrale su un possibile ‘farsi frate’ dell’autore della Monarchia. Costoro non hanno visto come i temi francescani siano stati nella Commedia, e non solo in essa, rivendicati dal saeculum humanum e, soggetti a una serie infinita di tecniche variazioni, trasferiti in una nuova composizione dove risuonano l’autonomia nell’uso del volgare, la definizione del regime politico, l’ambito della natura e della ragione, la valorizzazione degli autori classici, quelli cioè che sarebbero stati gli ideali laici del Rinascimento.
Dante, il quale non avrebbe mai pensato di non essere compreso, per quanto differentemente secondo i diversi livelli del pubblico lettore del suo poema polisemico, non sfugge alla presa, vuole essere vinto, per lui valgono le parole dell’aquila: “Regnum celorum violenza pate” (Par. XIX, 94). È dunque tempo che i migliori ingegni si pongano la domanda: Quo vadis, Dantes? e al modo dell’“astripeta” aquila ghermiscano i sensi più profondi del “poema sacro”, eseguendo il divino spartito sì che il loro suono, come quello udito da Giovanni a Patmos, diventi “voce di molte acque”.
2. Parodia e Sacra Scrittura
Il rapporto fra Commedia e Lectura si configura come parodia. Nella relazione fra l’ipertesto B (la Commedia) e l’ipotesto anteriore A (la Lectura super Apocalipsim), l’ordine è quello della metamorfosi, cioè della trasformazione: B non parla affatto di A, ma non esiste senza A, nel senso che l’autore lo ha scelto per trasformarlo, secondo norme precise e riscontrabili, dalla prosa latina nei versi in volgare.
Per la Commedia la Lectura super Apocalipsim non è una fonte, bensì il libro della storia delle illuminazioni sapienziali con cui tutto deve concordare. Con l’esegesi dell’ultimo libro canonico, esposta in una teologia della storia che comprende per settenari tutta la Scrittura, la quale a sua volta è forma, esempio e fine di ogni scienza, concorda ogni conoscenza, ogni esperienza, ogni soluzione indipendente data a questioni dottrinali. Virgilio, Ovidio o Lucano, Boezio, Aristotele, Alberto Magno o Tommaso d’Aquino, la stessa Scrittura in quanto tale, le più svariate esperienze poetiche o le conoscenze di astronomia sono, nel poema, tutte fonti ordinate alla Lectura.
Parodiare in versi la Lectura oliviana, storia del disegno provvidenziale, significò per Dante prendere consapevolezza della propria missione di inserire le vicende umane, particolari e generali, in quel disegno facendosi di esso portavoce. I fatti che si svolgono sull’“aiuola che ci fa tanto feroci” sono segni significanti la storia della Provvidenza, secondo quanto scritto nella Monarchia: “divina voluntas per signa querenda est” (Mon., II, ii, 8). Questo principio ha ispirato il lavorìo semantico condotto nei versi del poema, dove personaggi mitologici e storici, antichi e moderni, fenomeni naturali, questioni filosofiche o teologiche vengono fasciati dalla sacralità dei concetti escatologici espressi nella Lectura.
Come all’apertura del sesto sigillo i segnati si distinguono, perché amici di Dio, dalla volgare milizia, così Dante per l’amica Beatrice è uscito dalla “volgare schiera” dei poeti (Inf. II, 103-105). Dante è il nuovo Giovanni (Ap 10, 9-11), dottore della Chiesa che confuta i simoniaci come fossero eretici (6, 5), depositario dell’unica vera lingua (che fu di Heber e ora è nella casa di Pietro; prologo, Notabile XIII) – è la lingua erudita che regge le genti e corregge gli indomiti (11, 1) -; segue Virgilio come san Pietro seguì Cristo alla croce (7, 2), rompe il pozzetto battesimale per salvare dalle mortifere acque dell’erronea fede (8, 11), si rinnova come la pianta francescana (6, 12), percorre le tappe dell’apocalisse e perviene al traguardo prima della loro effettiva conclusione (15, 8). Come l’angelo ingiunge a Giovanni di predicare ancora senza timore a tutto il mondo dopo gli Apostoli, inviscerando il libro dal sapore amaro e dolce insieme, così a Dante, quasi alter Iohannes, viene ingiunto da Cacciaguida di rendere manifesta la sua visione nel “poema sacro”, nuova Apocalisse, anch’essa, come quella di Giovanni, amara nel primo gusto ma poi salutare (Par. XVII, 127-132).
Il volgare di Dante guarda al latino come modello ideale di una nuova lingua universale. Il latino era una lingua per pochi, non bastava più per tutte le necessità espressive. Il latino dell’esegesi scritturale è vicino al volgare; lavorando su questo latino umile – il sermo humilis del quale scrive Erich Auerbach -, Dante diede al volgare la “gloria de la lingua”. Facendo concordare con il libro che registra i segni divini nella storia umana ogni conoscenza, ogni esperienza, ogni soluzione di questioni dottrinali, il volgare della Commedia si pone quale vera clavis universalis del sapere. È la lingua del nuovo evangelista Giovanni, non più solo illustre ma di tutti; l’allegoria non è più finzione ma figura, cioè storia significante della prescienza e provvidenza divina. Il volgare è diventato una nuova “lingua gratiae” come fu l’ebraico, la lingua parlata dal Redentore nel suo avvento nella carne (cfr. De vulgari eloquentia, I, vi, 5-7).
3. Dante profeta
Parodiando la Lectura oliviana, il poeta si fece profeta, non tanto per la previsione di eventi futuri, quanto nel trasferire gli eventi particolari su un piano universale per poi tornare al particolare; un trascorrere fra io e noi proprio di Isaia, Ezechiele e Cristo stesso, che dalla prima terzina (“Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura”) dà la movenza profetica all’intero poema, nuova Apocalisse scritta da un nuovo Giovanni, nella quale il microcosmo toscano o italico o europeo viene elevato al macrocosmo dei disegni provvidenziali. Non a caso Ignaz von Döllinger, che nel 1887 pose per primo la questione di Dante profeta, concepì la Commedia come un’epica teodicea, un’esposizione del piano divino sull’universo [5].
Lo spirito profetico dà alle vicende un valore esemplare. Tutti i tre più gravi peccati capitali – “superbia, invidia e avarizia” -, secondo Ciacco, cooperano alle divisioni di Firenze, e ne sono concausa (Inf. VI, 74-75). Un particolare fatto cittadino assurge a modello di male universale. Nell’apostrofe che apre Inf. XXVI, il nome di Firenze “si spande” per l’inferno come la fama della città fatta “sì grande” batte le ali per mare e per terra. Il passaggio dal particolare all’universale è ribadito nel cielo di Venere da Folchetto di Marsiglia, che dilata il suo discorso al modo dei profeti: Firenze, pianta di Lucifero, “produce e spande il maladetto fiore”, la moneta che ha traviato il gregge cristiano trasformando i pastori in lupi (Par. IX, 127-132).
Le perverse qualità della donna che siede sulla bestia – Babilonia la grande, la madre delle prostituzioni e degli abomini della terra (Ap 17, 1) – sono appropriate a Bonifacio VIII, a Guido da Montefeltro, all’arcivescovo Ruggieri nella caccia al monte pisano, all’insaziabile Filippo il Bello. Se la confusione babilonica si mostra sul piano dei due poteri universali, il temporale e lo spirituale, essa nondimeno agisce anche a livello individuale dove, come afferma Olivi, ciascuno deve bruciare la propria meretrice interiore. Così la confusione è appropriata anche a Dante (Purg. XXXI, 7, 13), finito nella selva oscura dopo essersi tolto a Beatrice e dato ad altri, quasi specchio individuale della prostituta apocalittica.
Un’altra prerogativa dello spirito profetico, in questo caso tipica dell’autore dell’Apocalisse, è di applicare le figure e le sentenze dei profeti a tempi e fatti diversi da quelli veterotestamentari.
[LSA, prologus, notabile XIII] Tertio elucidat ipsam applicando figuras vel sententias eius ad alia facta et tempora quam in prophetis videantur applicari, ut verbi gratia quando prophete loquuntur de destructione Babilonis non applicant hoc expresse ad illam Babilonem de cuius dampnatione agit sexta visio huius libri, nec sibi aut bestie ipsam portanti ascribunt septem capita et septem reges secundum septem tempora ecclesiastica. […] Item quod Isaias et ceteri prophete dicunt de finali gloria populi Dei fienda sub magno messia, applicat septima visio huius libri ad celestem gloriam cum renovatione orbis post extremum iudicium fiendam. Et sic de ceteris consimilibus advertere potes.
La semantica propria dello spirito profetico, con il suo estendersi e coartarsi, crea lo “spazio esegetico polisemico, quello stesso dei testi sacri”, del quale scriveva Guglielmo Gorni. Così avviene con il “veltro allegorico”, per usare il titolo del celebre saggio dello storico napoletano Carlo Troya (1826). In quanto “veltro” (il cane che ucciderà la lupa, cioè la cupidigia), preso nel semplice senso letterale, appartiene alla fabula, all’allegoria dei poeti, “una veritade ascosa sotto bella menzogna”, come scrive Dante nel Convivio (II, i, 4). Ma la “gonna” del veltro è tessuta con il “panno” del profeta Elia, come offerto dalla Lectura super Apocalipsim. In essa, a seguito di una collazione tra vari passi scritturali, tratti dalla stessa Apocalisse (10, 11; 11, 3-13), da Matteo 17, 11 e da Malachia 4, 5-6, Olivi conclude che nel sesto stato della Chiesa (cioè nel tempo vissuto dal frate e dal poeta) il libro della sapienza cristiana dovrà essere compiutamente aperto, mangiato e nuovamente predicato a tutte le genti e che Elia, insieme all’altro testimone (Enoch), verrà prima del gran giorno del Signore per convertire i cuori dei padri verso i figli e dei figli verso i padri. Così il veltro dalla fabula trascorre alla historia, e l’allegoria dei poeti cede a quella dei teologi, che consiste vedere le vicende di Cristo e della Chiesa come prefigurate nei fatti e nei detti dei profeti dell’Antico Testamento.
Elia si presenta come un uomo spirituale vòlto alla conversione universale e alla generale restituzione di uno stato precedente, precursore dei tre avventi di Cristo (nella carne, nel suo Spirito, nel giudizio) in tre differenti persone, due allegoriche (Giovanni Battista e Francesco) e una letterale (Elia stesso, prima del terzo avvento che coincide con il giudizio finale). Ad Ap 7, 4, Olivi ricorda che quanto più letteralmente il senso dell’esegesi riguarda i beni o i fatti finali, tanto è più spirituale dei sensi allegorici che lo precedono, per cui più letteralmente e propriamente si dice che Dio è vita, sapienza, sommo bene piuttosto che leone o sole o rugiada; il detto più letterale è più spirituale e perfetto di quello traslato e allegorico. Virgilio, parlando del “veltro”, si esprime allegoricamente; dicendo “sapienza, amore e virtute” usa il senso letterale.
Elia invita al convivio spirituale che si svolge dopo la morte dell’Anticristo (Ap 19, 17-18). Incarna lo zelo del giudizio e della vendetta divina contro i peccatori nella casa di Dio. Secondo Gioacchino da Fiore, quello dei quattro animali che, nella quinta visione apocalittica, trasmette ai sette angeli le sette coppe d’oro ripiene dell’ira di Dio (Ap 15, 7) designa il quarto ordine, proprio degli eremiti, del quale fu padre Elia. Questi uccise i profeti di Baal, per comando divino unse Eliseo come profeta, il quale a sua volta unse, per comando di Elia, Ieu come re di Israele e Hazaèl come re di Siria, dicendogli il Signore: “Chiunque sfuggirà alla spada di Hazaèl, lo ucciderà Ieu, e chiunque sfuggirà alla spada di Ieu lo ucciderà Eliseo” (3 Rg 19, 17). A lui si addice pertanto rimettere la lupa nell’inferno (Inf. I, 109-111).
Al veltro è dunque appropriata la funzione di Elia, il quale nel sesto stato viene inviato come profeta di un altro avvento di Cristo (nello Spirito), per invitare al convivio spirituale, per restituire ogni cosa nel pristino stato e convertire i figli verso i padri e i padri verso i figli, per salvare l’Italia, alla quale gli opposti partiti, antichi e moderni, hanno dato i loro morti, giardino dell’Impero fattosi selva, ma infine condotta a umile conversione. Questo tema di pace universale si congiunge con quello della “radice di David”, per cui il veltro nascerà anch’egli, come Cristo, dalla progenie di David, radice di quanti vennero prima e dopo di lui, mediatore tra padri e figli, tra vecchio e nuovo. La nascita tra feltro e feltro – inter telam et telam (l’inciso è di Gioacchino da Fiore, citato da Olivi ad Ap 12, 6) – è concordia fra la Scrittura antica e nuova, e concordia fra i cieli, rotanti nella nuova migliore disposizione dopo la discesa nella carne, al tempo di Augusto, di Colui che li ha fatti (cfr. Convivio, IV, v, 7).
Pregno di tanti e tali significati, per i quali la lettera della parola racchiude immagini plurisense, il veltro perde il valore di allegoria dilettevole al modo dei poeti e assume quello di allegoria necessaria al modo dei teologi; non è più una verità nascosta sotto una bella menzogna, ma è “figura” di eventi storici. La parodia poetica, seguendo il metodo dell’autore dell’Apocalisse, applica a personaggi e situazioni diverse quanto nell’esegesi è proprio di Elia. Più personaggi sono apparsi nella storia della Chiesa in “figura” di Elia, prima Giovanni Battista, poi Francesco d’Assisi. Così il veltro potrà riferirsi a più soggetti.
Virgilio, nel pronunciare la profezia, non conosce il tempo della venuta del veltro; né tale tempo conosce Dante, il quale nel quinto girone della montagna, dove viene purgata la cupidigia della quale la lupa è simbolo, si rivolge al cielo invocando: “quando verrà per cui questa disceda?” (Purg. XX, 13-15). Certamente, però, l’antico poeta pagano che aveva cantato l’avvento del novum saeculum augusteo, e che ora rinnova la profezia nel moderno tempo cristiano, pensa a un imperatore. Non diversamente pensava il nuovo Virgilio, che componeva i versi quando si annunciavano grandi eventi, dopo che Enrico VII aveva conseguito ad Aquisgrana, il 6 gennaio 1309, la corona di Germania e si programmava la spedizione in Italia per conseguire la corona imperiale. Ed è ben verosimile che le nuove speranze di palingenesi universale trovassero conferma in un’opera come la Lectura super Apocalipsim di Olivi, storia della salvezza collettiva e preconio di un novum saeculum già operante, dando così vita al “grandioso discorso con se stesso e con gli uomini” sul quale si interrogava Antonino Pagliaro. Ma la vita terrena dell’“alto Arrigo” si concluse a Buonconvento il 24 agosto 1313, per cui Dante trasferì parte delle prerogative del veltro – come quelle di Elia – ad altra persona, a Cangrande della Scala, vicario imperiale.
Il veltro è in ogni caso allegoria imperiale. Il fatto che assuma qualità ‘spirituali’ (“Questi non ciberà terra né peltro, / ma sapïenza, amore e virtute”) non deve far pensare a un religioso o a un papa. Il Monarca possiede di per sé tali qualità. Per la sua autorità, infatti, risulta “remota cupiditate omnino”, con la conseguenza che prevale la carità, la quale dà vigore alla giustizia e alla “recta dilectio” degli uomini. Per mezzo della giustizia corroborata dalla carità, il Monarca realizza il vivere in pace, “inter alia bona hominis potissimum” (Monarchia, I, xi, 11-14). Anch’egli, a suo modo, partecipa dell’altissima paupertas preconizzata da Olivi.
Il veltro, “figura” di più persone operanti nella storia, è dunque soggetto alle mutazioni senza tregua della Fortuna, della quale dice Virgilio a Inf. VII, 73-96. Alla fine, però, tornerà “giustizia e primo tempo umano”, e la “maladetta lupa” sarà uccisa e rimessa nell’inferno, per opera del veltro non più allegorico ma letterale, come avverrà con il ritorno del reale profeta Elia, nella persona del Monarca la cui giurisdizione “terminatur Occeano solum” (Monarchia, I, xi, 12).
4. Il viaggio
La discesa per gradi dal vertice della perfezione al fondo, con la conseguente necessità di risalire alla carità originaria (caritas prima: [Ap 2, 4] “Per caritatem ergo primam intelligit non solum primam tempore, sed etiam maioritate et melioritate”), a poco a poco venuta meno, è uno dei temi più importanti dell’istruzione data al vescovo di Efeso, la prima e la metropolita delle sette chiese d’Asia, di cui tratta la prima visione apocalittica. Il tema, attorno al quale ruota una rosa ricca di motivi, è oggetto di molteplici variazioni nel poema, prestando in primo luogo un senso spirituale all’andamento del viaggio.
Nella selva Dante si ritrova. L’espressione “mi ritrovai” (Inf. I, 2) non ha solo il significato di casuale capitare in un luogo, ma corrisponde anche al ‘recuperare’ (il verbo è di Riccardo di San Vittore), ravvedendosi, il livello di carità iniziale cui viene esortato il metropolita efesino. Come ben vide il Pascoli, “a trentacinque anni si ritrovò. Ciò pare detto in tono di vergogna, di confessione amara, come se noi dovessimo aggiungere un ‘finalmente!’ che esso tace”. La diritta via, come sottolineato dal Landino, era “smarrita” e non “perduta”, quale quella di chi ritorna alla virtù dopo essere trascorso nel vizio: così da quanto Giovanni scrive alla chiesa di Efeso si desume chiaramente, secondo Olivi che commenta la fonte riccardiana, che la carità originaria può essere diminuita senza che si perda tutta.
Al termine del viaggio, Dante, nel cercare di comprendere come nella sua “vista nova” l’immagine umana di Cristo si convenga e trovi luogo nel cerchio, si descrive come il matematico tutto preso inutilmente a risolvere il problema della quadratura del cerchio. Le sue ali non sono capaci di tal volo, per cui egli riconosce umilmente la propria fragilità e nullità, ma un lampo percuote la sua mente facendole venire ciò che voleva, cioè la chiara visione del mistero dell’incarnazione. Il motivo del ritrovare proviene dal recuperare il grado di perfezione originario (l’aurea prima carità) al quale viene invitato il vescovo di Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia (Ap 2, 5; prima visione): il “non ritrova, pensando” del finale del poema (Par. XXXIII, 133-135) corrisponde così al “mi ritrovai per una selva oscura … che nel pensier rinova la paura” dell’inizio.
L’Inferno canta la durezza lapidea, l’impetrarsi, il parlare duro di cose dure a dirsi, il duro giudizio; è il luogo del senso duro della scritta al sommo della porta, dei duri lamenti, dei duri demoni, dei duri veli del gelo, della gravezza. Nelle virtù, come si sale per gradi al culmine, così si discende a poco a poco dal più alto all’infimo livello. Tale è la discesa graduale “giù per lo mondo sanza fine amaro”; come nella statua di Nabucodonosor ad un certo punto il rame sonoro si trasforma nel ferro aspro e duro. Esempio di questo discendere nel male per poi partirsene risalendo è Virgilio il quale, per allontanarsi dall’inferno, usa come scala il pelo di Lucifero, prima scendendo gradatamente “di vello in vello” con Dante avvinghiato al collo, poi capovolgendosi all’altezza del femore per risalire verso l’uscita (Inf. XXXIV, 70-84).
La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati della storia della Chiesa, cioè alle categorie con cui Olivi organizza la materia esegetica. Questo ordine interno è registrabile per zone progressive del poema dove prevale, tramite le parole-chiave, la semantica riferibile a un singolo stato. È un ordine dirompente i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ogni stato, che ha differenti inizi, è concatenato per concurrentia, come le maglie di un’armatura, con quello che precede e con quello che segue. Si possono in tal modo redigere mappe che comprendano l’ordine spirituale della Commedia. La ricerca, collocata su un sito per sfruttare gli spazi offerti dalla rete, è pervenuta a una Topografia spirituale della Commedia, dove per quasi ogni verso, o gruppo di versi, collegamenti ipertestuali conducono al “panno” esegetico fornito dalla Lectura super Apocalipsim, sul quale il “buon sartore” ha fatto “la gonna”.
La persistenza di un “panno” – cioè di un altro testo da cui trarre i significati spirituali del poema, materialmente elaborati attraverso le parole – è anche servita a mantenere l’unità e la coerenza interna dell’ordito. Si può supporre che il poema sia stato pubblicato per gruppi di canti non più modificabili: sempre stava innanzi al poeta la medesima esegesi teologica con le innumerevoli possibilità di variazioni tematiche e di sviluppi.
Il viaggio ultramondano, tessuto con figure di questo mondo, si rispecchia nei periodi della storia dei segni divini scritti nel Libro: l’Antico Testamento, chiuso nella sua durezza lapidea (Inferno); la vita della Chiesa nei suoi sette periodi (Purgatorio); lo stato delle anime beate in attesa della resurrezione (Paradiso).
■ Nell’Inferno vige l’imposizione data a Daniele dall’angelo sotto il sesto sigillo dell’Antico Testamento: “Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro fino al tempo stabilito” (Dn 12, 4), che era la sesta età nella quale apparve Cristo e in particolare il sesto stato della Chiesa nella quale il libro doveva essere più pienamente aperto, non però ai malevoli e ai maldisposti. Questa durezza è rotta dall’invito di Dante ai dannati perché parlino. Far parlare liberamente, per dettato interiore, è la principale prerogativa del sesto stato – la nuova età che tanto s’aspetta, quella che ode del “dolce stil novo” e delle “nove rime” -, ed è tema che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo, anche nella vecchia roccia infernale. Appartiene alla sesta chiesa il parlare liberamente di Cristo – ad essa è dato l’“ostium apertum”, che è “ostium sermonis” – , il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà. Appartiene alla sesta chiesa anche il far venire quelli che si dicono Giudei (coloro che glorificano Dio) senza esserlo, mutati nel cuore e disposti a farsi battezzare e governare. Questo far venire a parlare equivale all’invito dello Spirito di Cristo a convivare, a venire con desiderio e volontario consenso, con “disio” e con “velle”, in una pausa di pace nell’eterna dannazione. All’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono “dal voler portate” verso un momento di mutazione, sebbene limitata al successivo colloquio. Tutto l’Inferno è un contrappunto fra la durezza del giudizio e l’apertura per la parola dirompente, fin che essa dura, la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi per poi ricadere, sollevarsi da atti bestiali per ritornare a essi dopo aver parlato, come nel conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per sé stesse mosse, sta un solo desiderio, il vivere ancora nel libro che è stato altrui aperto.
■ Dopo le prime cinque età del mondo (corrispondenti all’Antico Testamento, la gioachimita età del Padre), che hanno segnato la discesa a spirale per i cinque cicli settenari dell’Inferno, con il Purgatorio inizia la sesta età, quella di Cristo (l’età del Figlio), divisa in sette periodi, corrispondenti ai sette stati della Chiesa. Dapprima, nel cosiddetto ‘antipurgatorio’, si registrano in successione temi prevalenti dei primi cinque stati. Il sesto stato della sesta età (con cui si apre l’età dello Spirito) inizia con l’apertura della porta di san Pietro (la porta del Purgatorio). Questo sesto stato procede anch’esso con andamento settenario, per cui ha sette momenti, coincidenti principalmente con un girone della montagna, ma non del tutto, perché sempre l’ordine spirituale del poema rompe i confini letterali e le divisioni materiali, concatenando i temi di uno stato prevalente con quelli dello stato che precede e con quelli dello stato che segue e intrecciandoli con temi di tutti gli altri stati.
È spiegato nel Notabile VII del prologo della Lectura che il sesto stato della Chiesa è il secondo stato di Cristo e ha i suoi sette tempi per cui la Chiesa, come fosse una sfera, si ricongiunge circolarmente al primo apostolico tempo. Il settimo dei sette momenti del sesto stato della Chiesa coincide con il settimo stato generale della Chiesa, che nel poema corrisponde in parte all’ultimo girone della montagna (il settimo, dove si purgano i lussuriosi) e in parte all’Eden, con cui si chiude la seconda cantica.
Il Purgatorio dunque, secondo il senso spirituale, è la storia della Chiesa che corre verso il suo sesto stato, punto di riferimento di tutte le vicende umane, antiche e moderne, che ad esso cooperano. Non è casuale che nel sesto girone della montagna sia chiarificata e riconosciuta, nel colloquio con Bonagiunta da Lucca, la poetica delle “nove rime” di Dante, già “sesto tra cotanto senno” cooptato nella “bella scola” dei poeti del Limbo.
La vasta zona dedicata al sesto momento del sesto stato della Chiesa ha il suo inizio nel forte terremoto che scuote la montagna mentre Dante e Virgilio si trovano ancora nel quinto girone (Purg. XX, 124-141).
Il settimo stato dell’Olivi si realizza parte in questa vita (come pregustazione in terra della gloria eterna, cioè fin sulla cima della montagna) e in parte nella futura (nel senso della quiete delle anime beate in attesa della resurrezione, che è la materia del Paradiso).
■ Il Primo Mobile è il nono e penultimo cielo, ma è il sesto se si parte dal cielo del Sole. È anche il cielo più segnato dal tema del “punto”, cui è assimilato il sesto stato. Questo consente di ricostruire l’ordine spirituale del Paradiso ponendo la cerniera nel quarto cielo del Sole. Con il terzo cielo di Venere termina infatti il cono d’ombra gettato dalla terra, secondo la dottrina di Alfragano (Par. IX, 118-119), mentre prima di descrivere l’ascesa al cielo del Sole il poeta invita il lettore a rivolgersi “a l’alte rote” (Par. X, 7-27). Senza la cesura recisa che, nella prima cantica, divide i dannati puniti all’interno della città di Dite da quelli che ne stanno fuori e, nella seconda cantica, separa le anime purganti nei sette gironi della montagna dalle anime che attendono fuori della porta (il cosiddetto ‘antipurgatorio’), anche nel Paradiso gli spiriti che si manifestano nei primi tre cieli della Luna, di Mercurio e di Venere (spiriti che mancarono ai voti, spiriti che furono attivi per conseguire onore e fama, spiriti amanti) si distinguono per minore perfezione rispetto a quelli che appaiono nei cieli seguenti.
I dieci cieli del Paradiso si mostrano pertanto ordinati in due gruppi di settenari, corrispondenti agli stati della Chiesa (e alle loro prerogative) secondo Olivi, parzialmente combacianti (da 1 a 7 e da 4 a 10: coincidono gli ultimi quattro numeri del primo gruppo e i primi quattro del secondo).
5. Il mistero del “sacrosanto segno”
Dante […] non si sarebbe mai sognato di non poter essere compreso. Che sia tanto difficile farlo, non dovrebbe condurci a rinunciarvi in favore di un arbitrio tutto calato nel punto di vista del lector. L’ermeneutica non può prescindere da un’ontologia della creazione poetica: se ne prescinde, è lettura del nulla. Questo è l’unico ma grandioso mistero, con cui ha a che fare ogni lettore di Dante (incomparabile con quei misteriucci da quattro soldi, con cui si sono misurati gli Aroux e i Guénon): il mistero del segno, o di quel sistema di segni, che ha racchiuso un mondo intero in un insieme d’immagini plurisense. Con questo mistero dobbiamo fare i conti.
|
Andare oltre la sfera letteraria offriva il mezzo grazie al quale Dante poteva rivendicare per la Commedia quel ruolo attivo nella storia che, normalmente, era al di là delle possibilità di un libro scritto da un autore umano. Offriva pure il modo […] per suggerire la posizione privilegiata che la poesia e, specificatamente, la Commedia, potevano legittimamente aspirare ad avere nella vita dell’umanità. I debiti che Dante ha nei riguardi della Bibbia e della sua allegoria sono enormi. Nessun scrittore umano poteva donare al poeta la possibilità di travalicare i confini della letteratura e, quindi, di intervenire in maniera diretta nella storia provvidenziale. Al tempo stesso […], senza l’esempio concreto di questi altri autori, egli non avrebbe mai potuto comporre la Commedia. Alludendo a loro e alle loro opere, Dante ricorda, sì, i limiti della scrittura umana, ma anche i suoi tantissimi pregi.ZYGMUNT G. BARANSKI, Dante e i segni. Saggi per una storia intellettuale di Dante Alighieri, Napoli 2000, p. 125. |
La Commedia è un universo di segni. I segni sono imagines agentes di un’ars memorandi riservata a un preciso pubblico, fra i molti possibili lettori del poema, e allo stesso autore. Il fatto che gruppi di terzine numericamente corrispondenti, a diversi stadi della Commedia, contengano parole-chiave che conducono alla medesima pagina esegetica sembra indicare che queste parole, se dovevano essere per il lettore spirituale signacula mnemonici di un altro testo, erano per il poeta anche segni del numero dei versi, ‘luogo’ dove collocare i medesimi signacula in forma e contesto diversi (cfr. alcuni esempi).
I segni inseriscono le vicende narrate dalla lettera dei versi in un sacro processo storico, sono segni della volontà e provvidenza divina. Quanto Olivi scrive della storia della Chiesa e della gloria di Cristo viene nella Commedia diffuso su tutte le persone e le forme, antiche e nuove, del nostro mondo con le sue passioni. Dante fece uscire, aggiornandola, la Lectura dal mondo francescano per riversarne i valori sul “saeculum humanum”, sulla sua letteratura e sulle sue nuove esigenze – la lingua, la filosofia, la dimensione politica, la valorizzazione degli autori classici – su quelli che sarebbero stati gli ideali laici del Rinascimento, mentre veniva meno il senso di una storia sacra della salvezza collettiva, della quale la Lectura fu l’estrema espressione.
Numerosi segni, dunque, aprono nei versi i significati dottrinali, chiari per chi già li conosce, cioè per chi possiede la chiave, che è la Lectura super Apocalipsim. Si tratta di passi esegetici ai quali si fa riferimento più volte nel poema, dove i temi subiscono numerose variazioni e intrecci con altri. Legare parole, scriveva Dante nel Convivio (IV, vi, 3-4), è per eccellenza “arte musaica”, propria cioè dei poeti. Quest’arte, nella Commedia, è diventata intreccio di segni, in un’opera il cui senso – come afferma il suo stesso autore (Epistola XIII, 20-22 [7]) -“non est simplex sensus, ymo dici potest polisemos, hoc est plurium sensuum; nam primus sensus est qui habetur per litteram, alius est qui habetur per significata per litteram”.
“Nel mezzo del cammin di nostra vita” racchiude, incardinato nel senso letterale riferito al trentacinquesimo anno dell’autore, il riferimento a Cristo mediatore, la cui vita deve essere dalla nostra perfettamente imitata e partecipata. “Mi ritrovai” fa segno del recupero della prima carità, smarrita ma non del tutto perduta (2, 5); “selva” significa la Giudea, ostinata e dura persecutrice di Cristo e della donna (la Chiesa), che da essa fugge (12, 6); “oscura … diritta” sono aggettivi che rinviano ai temi dell’oscurità e dell’erronea interpretazione della Scrittura propria degli eretici (6, 5); “smarrita … nel pensier rinova … Io non so … tant’era pien di sonno …” trasferisce sul personaggio-autore l’intorpidimento rimproverato al vescovo di Sardi, la quinta delle chiese d’Asia, che viene invitato a ripensare la prima grazia gratuitamente ricevuta (3, 3). Nel susseguirsi della notte angosciosa trascorsa nella selva, poi del mattino di riposo e di speranzosa salita al colle, e infine dell’incontro con Virgilio che lo invita a seguirlo per luoghi eterni (un viaggio che equivale a sostenere una guerra), Dante veste i panni di Pietro, il quale dopo aver trascorso una notte di tribolazione senza pescare, prova al mattino la gioia di una gran pesca e del pranzo, ma subito dopo Cristo lo invita a seguirlo, cioè alla croce: il parodiato passo di Giovanni 21, 4-19 è in una citazione dall’Expositio in Apocalypsim di Gioacchino da Fiore che apre l’esegesi oliviana dell’angelo del sesto sigillo (7, 2).
La fabula diventa subito historia sacra: il “pelago”, dall’“acqua perigliosa”, fa segno del senso letterale della Scrittura (4, 6); la fuga al “colle” o “dilettoso monte” ricalca la fuga ai monti di quanti vengono scossi per paura dal terremoto in apertura del sesto sigillo (6, 12-17); le tre fiere sono una soggetta a sviluppo (cfr. infra); la lupa, che le riassume tutte, è parodia della bestia saracena (il cavallo pallido in apertura del quarto sigillo: 6, 8); Virgilio incarna l’angelo del sesto sigillo che rimuove l’impedimento frapposto dagli angeli malvagi (7, 1-2); la parodia fregia con le prerogative del sesto angelo anche il tempo primaverile che invita alla salita solo concepita (7, 2); il poeta che nella tentata ascesa acquista, perde e piange ripete il lamento dei mercanti che hanno perduto ogni speranza di commercio con Babylon, la grande città incenerita (18, 10-11.19); il viaggio che è necessario egli compia per conseguire la salvezza rinnova l’uscita da Babilonia preconizzata dagli antichi profeti (18, 4); Virgilio lo trarrà “per loco etterno” come l’angelo trae Giovanni, “per verbum eruditionis”, alla comprensione di cose spirituali (17, 1).
Virgilio, l’“antico poeta”, si offre nella “diserta piaggia” vestito dei panni del Cristo uomo (cfr. infra). In quanto “fonte”, l’Eneide equivale a un libro della Scrittura, dal quale deriva “di parlar sì largo fiume” in quanti la commentano (aggiornandola; 8, 10). I versi di lode a Virgilio sono parodia di parte dell’esegesi dell’istruzione data a Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia, e al suo vescovo, minacciato dello spostamento del candelabro, cioè della “translatio” del primato ad altra chiesa; esse adombrano un’idea di onorevole “translatio” del primato poetico da Virgilio a Dante (2, 5).
Dante applica all’Impero la concezione che Olivi ha della Chiesa. La storia di Roma è la manifestazione dei segni di Dio, che attuano in terra la sua volontà, una con quella del cielo e con quella di Roma stessa. Questi segni, nelle parole di Giustiniano in Par. VI dettate dal “sacrosanto segno” dell’aquila, hanno un andamento settenario, quello proprio dei sette stati della Chiesa, per cui quanto anticamente avvenuto prima di Cristo si mostra come ordinata e progressiva prefigurazione della nuova storia, che è insieme della Chiesa e dell’Impero.
Un “victoriosus effectus” – la vittoria dei forti anacoreti del quarto stato della Chiesa (2, 26-28), “alti ” come le stelle (8, 12: quarta tromba) – uscì dalle imprese (“l’alto effetto”) di Enea, eletto nel cielo per padre dell’alma Roma e del suo impero, “lo quale al quale, a voler dir lo vero, / fu stabilito per lo loco santo / u’ siede il successor del maggior Piero”. Per questo Dio gli concesse di andare da vivo “ad immortale secolo” per ascoltare dal padre Anchise “cose che furon cagione / di sua vittoria e del papale ammanto” (Inf. II, 13-27). Al quarto stato appartengono le forti e virtuose opere corporali – le res gestae -, che invece difettano al sesto (lo stato in cui vive Dante), nel quale la “porta aperta” supplisce al difetto di forza e alla modica virtù (Ap 3, 7-8). Gaeta, il luogo al quale Enea diede il nome della sua nutrice, prefigura il tema della Chiesa nutrice dei fedeli (12, 14). Il veltro, figura imperiale, e l’Italia sono parodia di esegesi escatologica, cioè di storia sacra. La stessa Monarchia è essemplo umano dell’essemplare divino del voto evangelico di altissima povertà.
6. La “chiave di canto”: l’imitazione di Cristo
Il primo verso del poema – “Nel mezzo del cammin di nostra vita” – fa coincidere il riferimento letterale all’età anagrafica dell’autore (i trentacinque anni) con il fine stesso del viaggio: l’imitazione di Cristo, centro del tempo che sta in mezzo alla nostra vita e che cammina visitando con cura tutte le chiese presenti e future, cioè l’intera storia dei disegni divini che ricade sui tempi moderni. La singolare ed esemplare vita di Cristo, imposta agli Apostoli e scritta nei Vangeli, deve essere dalla nostra vita perfettamente imitata e partecipata e porsi come fine di ogni nostra azione (LSA, prologo, Notabile VII).
Poiché ‘ritrovare’ ha nell’esegesi il preciso significato di recuperare il perduto grado di perfezione originario (l’aurea prima carità: Ap 2, 5), le parole “nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai” fanno cenno del ritrovarsi in Cristo. Al termine del viaggio, il “non ritrova, pensando”, riferito al geometra tutto preso inutilmente a risolvere il problema della quadratura del cerchio (Par. XXXIII, 133-135), corrisponde al “mi ritrovai per una selva oscura … che nel pensier rinova la paura” dell’inizio. In entrambi i casi vi è l’intervento della Grazia, nel non nuocere della selva e nella mente del poeta che comprende come la figura umana, cioè Cristo incarnato, possa convenire al cerchio divino. Anche la filigrana dell’ultimo verso del poema – “L’amor che move il sole e l’altre stelle” – è fortemente cristocentrica: lo Spirito di Cristo, Dio e uomo, permea l’universo e gli uomini nella loro storia.
Cristo conosce bene ogni atto o pensiero, come colui che tiene tutti i vescovi sotto di sé, e come colui che sta in mezzo, visita, scruta, penetra subitamente, esamina. Egli è il loro giudice e signore onnipotente che li tiene e li esamina con circospezione. È il pio pastore che protegge e custodisce, e per questo li tiene e li visita camminando.
Il tema del “perambulare”, del visitare con la pietà del pastore che cura il proprio gregge, affiora nelle prime parole di Francesca, che si rivolge al poeta: “pius pastor eos … semper tenens et visitans – O animal grazïoso e benigno / che visitando vai per l’aere perso / noi che tignemmo il mondo di sanguigno … poi ch’hai pietà del nostro mal perverso” (Inf. V, 88-93).
Fra coloro che morirono di morte violenta e che purgano attendendo il tardivo pentimento, Buonconte da Montefeltro prega Dante di aiutare il proprio desiderio di pace “con buona pïetate”, procurandogli lui le preghiere che abbrevino la pena, poiché “Giovanna o altri non ha di me cura” (Purg. V, 85-90; da notare, al verso 89, il termine cura, simmetrico a visitando, posto al medesimo verso di Inf. V). L’accorata tristezza di Buonconte, che non ha più nessuno in terra che voglia pregare per lui, è memore delle parole di Matteo 9, 35-36 (citate ad Ap 22, 2 con riferimento al Lignum vitae di Bonaventura) su Cristo pietoso che “andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando e curando ogni languore, e vedendo le folle ne provò compassione, poiché erano come pecore senza pastore”. I personaggi incontrati vedono in Dante l’imitatore di Cristo.
La grande parodia fornisce, nel suo carattere polifonico, “e piedi e mano” alle perfezioni di Cristo sommo pastore, appropriandole liberamente ai dannati, come note dissonanti che suonano quanto è da Lui estraneo e diverso, ai purganti e ai beati; di esse si fregiano Virgilio, Caronte o Catone: manto (Ap 1, 13), capelli (1, 14), occhi (1, 14), piedi (1, 15). Il tema di Cristo radice di David e leone di Giuda che risorge ad aprire il libro segna Ezzelino da Romano, Cunizza e Sordello (5, 5). La virtù che ha fatto degno di reverenza il segno dell’Aquila “cominciò da l’ora / che Pallante morì per darli regno” (Par. VI, 34-36). Il figlio del re Evandro, che morì combattendo per Enea contro Turno, è figura di Cristo che, come affermato ad Ap 1, 6, ha sublimato l’uomo al suo regno e al sacerdozio e a cui spetta la gloria e l’impero nei secoli dei secoli (si tratta del sesto primato di Cristo in quanto uomo).
Cristo è duplice guida, dapprima voce esteriore e luce intellettuale, poi interiore gusto e sentimento d’amore (2, 7): si invera in Virgilio che nell’Eden lascia il campo a Beatrice. L’esperienza del gusto segna l’ascesa al cielo (19, 17-18). Al termine del viaggio, un’altra guida, san Bernardo, funge da “doctor anagogicus” che trae il discepolo all’alto monte del sovrasenso (21, 1-2.9).
La selva, “tant’ è amara che poco è più morte”, fa segno della passione di Cristo, che l’impaziente conte Ugolino non ha saputo sostenere (4, 6); le tre fiere designano gli eserciti contrari a Cristo (6, 3-4).
Virgilio è “simile” al Figlio dell’uomo (1, 13; 22, 16); dell’umanità di Cristo conserva la fragilità che deriva dall’essere soggetto a morte, passione, infermità, abiezione: “chi per lungo silenzio parea fioco” (Inf. I, 63); mantoano, si fregia del manto dell’efod sul quale sono rappresentati i “parentum magnalia” (1, 13); ha cantato il canto della giustizia e della pietas filiale (15, 2-4).
In un apposito studio si è evidenziato come la quantità dei temi esegetici, la loro idoneità ad essere rivissuti da un singolo individuo e appropriati ad altri, la contiguità nello spazio testuale, la peculiarità per cui l’Olivi non può essere confuso con altri autori insinuano il serio e legittimo dubbio che l’Expositio in Canticum Canticorum del frate di Sérignan sia stata il “panno” per la “gonna” della Vita Nova come, più tardi, la Lectura super Apocalipsim lo sarebbe stata per il “poema sacro”. Un lavorio intertestuale ancora acerbo, commisto con altre fonti (non escluse altre opere dello stesso Olivi, volutamente parodiate), volutamente criptico, e tuttavia segnante il decisivo passaggio dalla spersonalizzata e astorica esperienza stilnovistica al suo inserimento in un’organica storia, universale (perché tale è la storia di Cristo e della Chiesa) e insieme dell’individuo. La storia del nuovo amore per Beatrice, imitatrice di Cristo, e delle prove e battaglie interiori sostenute dall’anima del poeta ‘disponsata’ ad Amore, sarebbe diventata la storia del viaggio verso di lei, del nuovo visionario Giovanni che avrebbe predicato ancora al mondo le cose, che s’affrettano, necessarie alla salute. Il risultato non è un libro devozionale né un trattato sulla contemplazione – un nuovo Benjamin emulo di Riccardo di San Vittore -, ma una storia reale assurta a storia sacra della salvezza collettiva. La legge di Cristo, di cui dice Olivi esponendo Matteo 11, 4-6, è la legge di Beatrice, non una ‘santa’ qualsiasi, ma la vera imitatrice del Redentore.
L’imitazione di Cristo – il tema che impregna il primo verso del poema – non è intesa in un senso genericamente morale; essa ha valore storico, di un nuovo avvento in terra del Salvatore nella persona dei suoi discepoli mossi dallo Spirito, di un compimento della Redenzione per mezzo di una nuova lingua universale quale il latino, “lingua gratiae” al pari dell’ebraico, la lingua parlata da Cristo.
L’imitazione di Cristo, che si realizza nella parodia in versi della Lectura super Apocalipsim, opera ispirata dal cristocentrismo di Bonaventura, permea ogni aspetto del saeculum humanum dandogli una veste sacra. Non si tratta di ascetismo, come scrisse Benedetto Croce: “Ciò che nel Paradiso non si trova, perché è estraneo all’anima di Dante, è la fuga dal mondo, il rifugio assoluto in Dio, l’ascetismo. Egli non vuol fuggire il mondo, ma istruirlo e correggerlo e riformarlo, e dargli a compimento la beatitudine celeste” [6]. Tanto che perfino l’Empireo, “il ciel de la divina pace”, non si sottrae alla rimembranza dei feroci fatti della vita terrena quando Beatrice, mostrando il trono riservato all’“alto Arrigo”, vitupera l’ambiguo comportamento di Clemente V: “E fia prefetto nel foro divino / allora tal, che palese e coverto / non anderà con lui per un cammino” (Par. XXX, 142-144).
Né l’imitazione di Cristo è assimilabile alla devotio moderna di Gerardo Groote e di Tommaso da Kempis. La Lectura pone un nuovo rapporto tra l’universalità dei disegni divini e la persona umana. I sette stati non sono solo periodi storici relativi alla Chiesa nel suo complesso, ma anche modi di essere della persona, habitus. Così la storia della salvezza procede nei sette generali periodi della Chiesa crescendo e sviluppandosi come un individuo, rivolta alla perfezione della maturità più che ai suoi apostolici tempi iniziali. Non solo la Chiesa può essere considerata un individuo in sviluppo, ma anche lo stesso Ordine dei Minori. Alla terza apertura del sesto sigillo, nuovi Giovanni vengono inviati a predicare al mondo come al tempo degli Apostoli. Ma Giovanni non designa solo un Ordine, perché Olivi lascia aperta la possibilità di rivelazioni individuali, avute da “singulares persone”, perfetti imitatori di Cristo votati, con la loro “lingua erudita”, al compito della conversione universale (LSA, cap. X, Ap 10, 11). L’ultima opera di Olivi riguarda l’intera umanità e, al tempo stesso, gli individui nel loro sviluppo storico. Gli angeli apocalittici si incarnano in uomini angelici come Francesco; le perfezioni attribuite a Cristo possono essere appropriate per analogia alle persone (ibid., cap. I, Ap 1, 12-18); i seniori assistenti al soglio divino, in principio della seconda visione, possono designare i più sapienti in ogni tempo (ibid., cap. IV, Ap 4, 4). A proposito dell’eventualità, sostenuta da Olivi, che singole persone possano essere destinate, come l’autore dell’Apocalisse, alla conversione universale, non si può pertanto non menzionare la contemporanea visione di Dante esposta nel suo “poema sacro”.
Certamente la posterità di Olivi sarà tutta a favore dell’individuo. Quel gruppo di persone, o anche una sola persona illuminata, ascolterà una voce dal cielo che, secondo Gioacchino da Fiore, va al di là della stessa Scrittura (LSA, cap. X, Ap 10, 8). Quella stessa voce che per Olivi è pur sempre Scrittura data e spiegata interiormente, dallo Spirito interno dettatore, accenderà le rivelazioni ultra Scripturam di Arnaldo da Villanova, di Angela da Foligno, di Roberto di Uzès, di Giovanni da Rupescissa, di Maria Robine, dell’infante Pietro d’Aragona, di Caterina da Siena, di profeti e mistici nei quali “rivelazioni superiori alla Scrittura acquistano autorità perché si trasformano in eventi, i quali eventi nel loro stesso accadere dicono tutto sui piani di Dio sulla storia e sui doveri cristiani” [7].
Se vi sono alcuni aspetti comuni fra Olivi e la devotio moderna del XV secolo – l’interiorità di marca agostiniana, il sentimento del gusto, il valore francescano attribuito al Cristo uomo, il subentrare del dettato dello Spirito alla dottrina esteriore -, essi nella Lectura vengono inseriti in uno sviluppo storico-escatologico. Come l’individuo cresce gradualmente, così l’illuminazione procede nella storia per tappe sempre più ampie; la piena interiorità viene raggiunta soltanto nel sesto e settimo periodo della Chiesa. Nell’esegesi dei segni divini nella storia, il mistico Riccardo di San Vittore è sempre giustapposto e contemperato con la prospettiva storica di Gioacchino da Fiore.
Se per Olivi i veri valori sono dell’ordine dello Spirito, non per questo la sua teologia è antintellettualistica, come non lo fu la Scolastica alla quale apparteneva: “La ‘sagesse’ chrétienne des maîtres du XIIIe siècle, en plein évangélisme cependant, dans l’essor des Ordres mendiants, avait réalisé un équilibre que la ferveur su XVe siècle ne conçoit plus” [8]. Un intero periodo storico, il terzo stato della Chiesa, appartiene alla razionalità dei dottori, che confutano le eresie.
Olivi detesta Aristotele (in realtà il suo bersaglio è Tommaso d’Aquino, che l’ha introdotto nella filosofia cristiana), ma mostra di averne una conoscenza approfondita e di usarne le argomentazioni. Parodiando la Lectura super Apocalipsim, Dante dà una veste sacra allo Stagirita; il Monarca è assimilato al Cristo uomo, che per la sua umanità deve reverenza al Padre.
7. Considerazioni sull’ordine di composizione dell’ Inferno
Da quanto sopra esposto si traggono alcune brevi considerazioni, utili a porre il problema dell’ordine di composizione dell’Inferno. Non si tratta, ovviamente, di datazioni, ma di possibili momenti temporali.
a) La Commedia è parodia della Lectura super Apocalipsim.
b) La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che semanticamente corrispondono ai sette stati della storia della Chiesa secondo Olivi.
c) L’Inferno ha cinque cicli settenari. Il primo inizia con Inf. IV e si conclude con l’apertura della porta della città di Dite a Inf. IX. A partire dal secondo ciclo, in particolare da Inf. XII (dove prevalgono i temi del secondo stato, ma il ciclo si avvia subito dopo l’apertura della porta), la rete semantica riferibile ciclicamente ai sette stati oliviani è più estesa, organizzata e compatta. Lo è meno nel primo ciclo, dove accanto a blocchi più strutturati, come Inf. V, si registrano versi che non contengono parole-chiave che rinviano alla Lectura (sono riportati in una tabella). Questo fenomeno, non presente nelle cantiche successive, comporta o un’incertezza nel rapporto fra Commedia e Lectura nella prima fase, oppure, più probabilmente, è indice di una prima, parziale stesura estranea a tale rapporto, di una Ur-Commedia della quale restano tracce.
d) Redigendo l’Inferno, Dante si sarà da subito posto il problema dell’ordine dei peccati. Bisognava seguire i peccati capitali? In Inf. XI Virgilio espone l’ordine del primo regno non secondo i peccati capitali (come sarà invece, di fatto, nel Purgatorio); ma seguendo l’Etica di Aristotele nella triade “incontenenza, malizia e la matta / bestialitade”.
Dal rapporto con la Lectura (Ap 5, 1; 6, 1), Inf. XI trae due temi principali:
d.1) Il libro (l’Apocalisse) è “scritto dentro e fuori”.
d.2) Il “libro” è segnato (cioè chiuso) con 7 sigilli.
La combinazione di d.1) e d.2) fa sì che Dante concepisca una zona fuori della città di Dite (il cosiddetto “antinferno”) e un’altra dentro le mura della Città. Nella prima zona i peccati puniti sono 4 (lussuria, gola, avarizia/prodigalità, ira/accidia); nella seconda sono 3 (violenza, frode verso chi si non fida, frode verso chi si fida). Non vi sono, fra i sette peccati capitali, zone dedicate alla superbia e all’invidia (i primi due gironi del Purgatorio).
Alla visione dell’Inferno come “libro scritto dentro e fuori, segnato da sette sigilli”, si aggiunge nella semantica di Inf. XI un altro tema – “un tempo, due tempi e la metà di un tempo”, da Ap 12, 14.
e) In Inf. I e II la semantica che rinvia alla Lectura è molto più estesa e sviluppata che nei canti VI, VII, VIII, XI. Si può ipotizzare che Inf. XI sia stato scritto prima e, solo successivamente, siano stati redatti i due canti, proemio e prologo della grande parodia. Inf. I-II rinviano a numerosi luoghi della Lectura [per citare i principali – I: 1, 13; 2, 5; 2, 11; 3, 2-3; 4, 6; 6, 8; 6, 12-17; 7, 1-3; 7, 10.12; 8, 10; 10, 1; 12, 6; 12, 10-11; 15, 3-4; 17, 1-2; 17, 8.18; 18, 10.19; 18, 17.21.24; 22, 16 – II (luoghi ulteriori): 1, 17; 2, 7; 2, 8-10; 2, 26-28; 3, 7.10; 3, 12; 3, 14; 3, 18; 4, 2-3.5; 4, 7; 7, 7; 7, 13; 12, 4-5; 19, 1.4], per cui è ragionevole pensare che siano stati scritti quando il rapporto parodico aveva raggiunto la piena maturità.
Le reminiscenze del Convivio in Inf. I non provano che il proemio sia stato scritto per primo; stilemi del Fiore si rinvengono per tutto il poema, che non gli è certamente contemporaneo.
Da notare come l’esegesi di Ap 7, 1 (l’impedimento frapposto dai quattro angeli malvagi all’apertura del sesto sigillo, poi rimosso dall’angelo che sale da Oriente) venga parodiata nei primi due canti con riferimento alla lonza e alla lupa e alla rimozione per opera di Beatrice e di Virgilio; i quattro angeli si precisano nei canti seguenti come Caronte (III) – Minosse (V) – Cerbero (VI) – Pluto (VII), dove la parodia, soprattutto negli ultimi due canti, è meno intensa (con l’eccezione di Inf. V), quasi l’elaborazione di Ap 7, 1 sia intervenuta su una materia preesistente, sviluppata al momento della redazione di Inf. I-II.
_______________________________________________________________
La tabella individua i versi che, nei primi undici canti dell’Inferno, non registrano parole-chiave che rinviano alla Lectura. Così avviene per le parole di Virgilio ripetute a Inf. III, 95-96 e V, 23-24. Gli unici segni della dottrina esposta nella Lectura sono impedir a Inf. V, 22 (nel canto, per altro, l’elaborazione parodica dell’opera oliviana è assai estesa) e risponde … chi son quei a Inf. VIII, 8-9 (canto che presenta più versi privi di tale eleborazione).
Inf. III, 94-96, 103-108, 127-129E ’l duca lui: « Caron, non ti crucciare:
|
Inf. VIII, 1-9, 13-18, 28-30, 64-66Io dico, seguitando, ch’assai prima
|
[1] BRUNO NARDI, Pretese fonti della «Divina Commedia», in “Nuova Antologia” 90 (1955), pp. 383-398, ripubblicato in ID., Dal “Convivio” alla “Commedia”. Sei saggi danteschi, Roma 1960 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi Storici, 35-39), p. 356.
[2] Cfr. ALBERTO FORNI – PAOLO VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.
[3] ARSENIO FRUGONI, La Roma di Dante, tra il tempo e l’eterno, in ID., Pellegrini a Roma nel 1300. Cronache del primo Giubileo, presentazione di Chiara Frugoni, a cura e con Introduzione di Felice Accrocca, Casale Monferrato, 1999, pp. 102-103.
[4] GIORGIO BRUGNOLI, Tracce di Pierre de Jean Olieu nella Divina Commedia, in San Francesco e il francescanesimo nella letteratura italiana dal XIII al XV secolo. Atti del Convegno Nazionale (Assisi, 10-12 dicembre 1999), a cura di Stanislao da Campagnola e Pasquale Tuscano, Assisi 2001 (Accademia Properziana del Subasio), pp. 139-168.
[5] IGNAZ VON DÖLLINGER, Dante als Prophet in ID., Akademische Vorträge, I, Nördlingen, 1888, pp. 78-117. L’ormai plurisecolare storiografia sui rapporti tra Dante e gli Spirituali francescani viene ripercorsa da PAOLO VIAN, Dante, Pietro di Giovanni Olivi e lo spiritualismo minoritico: fra ipotesi e certezze, in Dante, Francesco e i Frati Minori. Atti del XLIX Convegno internazionale. Assisi, 14-16 ottobre 2021, Spoleto 2022 (Società Internazionale di Studi Francescani – Centro Interuniversitario di Studi Francescani), pp. 101-151.
[6] BENEDETTO CROCE, La poesia di Dante, Bari 19527 (19201), pp. 152-153.
[7] Cfr. FRANCESCO SANTI, La Bibbia e la letteratura profetico-apocalittica, in La Bibbia nel Medioevo, a cura di G. Cremascoli e C. Leonardi, Bologna 1996, pp. 402-408.
[8] MARIE -DOMINIQUE CHENU, Présentation de L’imitation de Jésus-Christ, traduction française de Lamennais, Paris 1989, pp. 7-38: 28.
____________________________________________________________________________________________________________________
TESTI E COMMENTO
Inferno I |
Legenda [3] : numero dei versi; in medio : collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo/i e versetto/i dell’Apocalisse [Ap]; Not. I : collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura; [*] : collegamento alla parte esplicativa dell’esegesi (il segno è posto accanto alla sola prima occorrenza). Varianti rispetto al testo del Petrocchi: che, ’ndurata.Qui di seguito viene esposto Inf. I con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim [html] [PDF] ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (PDF; introduzione in html). In quella sede è stato attribuito un diverso colore a ogni singolo status o gruppo di materia esegetica; in questo caso, nel testo sottostante come in quello riportato nelle tabelle, l’attribuzione dei colori segue il principio della maggiore evidenza. |
Nel mezzo del cammin di nostra vita Not. VII; 1, 13; 2, 1; 5, 6; 7, 17; 14, 4: in medio [*] – 13, 1 [*]
|
■ Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, Olivi suggerisce, nel prologo della Lectura, un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato sui sette stati (status), cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, prefigurate nell’Antico Testamento.
|
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
Nel mezzo del cammin di nostra vita |
1 |
In medio (2, 1) |
I |
mi ritrovai
|
2
|
2, 5
|
I |
per una selvaesta selva selvaggiaripresi via per la piaggia disertaQuando vidi costui nel gran disertose vuo’ campar d’esto loco selvaggio |
25296493 |
12, 6 → Inf. II, 62, 142 |
I |
per una selva oscura,
|
2
|
6, 5 → Inf. II, 6, 8 |
III |
era smarritaquanto a dir qual eranel pensier rinovaIo non so ben ridir com’ i’ v’intrai,tant’ era pien di sonno |
3461011 |
3, 2-3 → Inf. II, 64-66, 80 |
V |
Tant’ è amara che poco è più mortela notte ch’i passai con tanta pietauscito fuor del pelago a la riva,si volge a l’acqua perigliosa e guata,
|
7212324
|
4, 6 → Inf. II, 12, 108
|
R2 |
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai |
8 |
9, 4 |
V |
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte |
9 |
3, 8 |
VI |
Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giuntocosì l’animo mio, ch’ancor fuggivaacciò ch’io fugga questo male e peggiosì ch’io veggia la porta di san Pietro |
1325132134 |
6, 166, 15-17 → Inf. II, 110 |
VI |
che m’avea di paura il cor compunto |
15 |
8, 5 |
R3 |
Allor fu la paura un poco quetasi volse a retro a rimirar lo passo |
1926 |
Not. I |
VII |
che nel lago del cor m’era ’nduratapoi che ’l superbo Ilïón fu combustoaiutami da lei, famoso saggio |
207589 |
8, 7(5, 1); 8, 78, 7 |
IIV – II |
la notte ch’i’ passai con tanta pieta
|
2128313596
37
|
7, 2 → Inf. II, 47, 27, 27, 1 → Inf. II, 62, 957, 1
7, 2
|
VI |
e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle
|
38
|
3, 1→ Inf. II, 53, 55 |
V |
sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso |
30 |
Not. III; 2, 18; 3, 12 |
IV – VI |
una lonza leggera e presta molto,
|
32
|
18, 2 (13, 2) |
IV |
la vista che m’apparve d’un leonecon la test’ alta e con rabbiosa fame,
|
4547
|
9, 17-18; 10, 3 |
VI |
Ed una lupa, che di tutte brame
|
49
|
6, 8 → Inf. II, 63, 107 |
IV |
ch’io perdei la speranza de l’altezza.
|
54
|
18, 10
|
VI |
tal mi fece la bestia sanza pace,mi ripigneva là dove ’l sol tace |
5860 |
Not. III (9, 5) |
VII |
Mentre ch’i’ rovinava in basso loco |
61 |
3, 16 (2, 5) |
VII |
dinanzi a li occhi mi si fu offerto |
62 |
14, 14 (“similem Filio hominis”) |
VII |
chi per lungo silenzio parea fioco |
63 |
1, 5; 5, 12-13 (3, 5) |
R1.2 – V |
« qual che tu sii, od ombra od omo certo! ».
|
66
|
1, 13 (“similem Filio hominis”)
|
R1
|
nel tempo de li dèi falsi e bugiardiMolti son li animali a cui s’ammogliae trarrotti di qui per loco etterno |
72100114 |
17, 117, 217, 1 |
VI |
Poeta fui, e cantai di quel giusto
|
73
|
15, 3-4 |
R5 |
Ma tu perché ritorni a tanta noia?anima fia a ciò più di me degna |
76122 |
5, 4-55, 2 → Inf. II, 33 |
R2 |
perché non sali il dilettoso monte |
77 |
21, 10 |
VII visio |
Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte
|
79
|
Not. VI; 8, 10; 13, 1 |
III – VI |
rispuos’ io lui con vergognosa fronteoh felice colui cu’ ivi elegge! |
81129 |
7, 3 → Inf. II, 44-45, 61, 105, 122 |
VI |
A te convien tenere altro vïaggio |
91 |
18, 4 (1, 1) |
V |
rispuose, poi che lagrimar mi vide |
92 |
3, 18 (5, 5) → Inf. II, 116 |
VII |
se vuo’ campar d’esto loco selvaggio |
93 |
6, 2 → Inf. II, 68 |
I |
e più saranno ancora, infin che ’l veltro
|
101
|
Not. VIII; 10, 1 |
VI |
Questi non ciberà terra né peltro,
|
103
|
10, 1; 19, 17-18 |
VI |
e sua nazion sarà tra feltro e feltro |
105 |
5, 5 ; 12, 6 |
I |
Di quella umile Italia fia salute |
106 |
7, 10.12 (8, 7); 12, 10 |
VI – I – II |
per cui morì la vergine Cammilla,
|
107
|
7, 9.14; 12, 11 |
II – VI |
Questi la caccerà per ogne villa,
|
109
|
18, 17
|
VI |
ove udirai le disperate strida,
|
115
|
2, 11 (20, 6) |
II – VII visio |
ché quello imperador che là sù regna,
|
124
|
17, 8.18 |
VI |
Abbreviazioni e avvertenze
Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.
LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.
Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).
Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.
Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.
In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.
Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.
Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994. A partire da questo esame di Inf. I, si terrà conto della recente edizione a cura di G. INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA (esempio al v. 20: ’ndurata).
***
Nel mezzo del cammin di nostra vita
La singolare ed esemplare vita di Cristo, imposta agli Apostoli e scritta nei Vangeli, deve essere dalla nostra vita perfettamente imitata e partecipata e porsi come fine di ogni nostra azione (LSA, prologo, Notabile VII). Cristo è centro intimo della sfera-Chiesa, che si mostra a tutti e a cui guardano tutte le linee degli eletti (Ap 1, 13; 5, 6; cfr. Vita Nova, 5. 11: “Ego tanquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentie partes”). È “in medio vite”, cioè in mezzo alla vita e alla dottrina evangelica scritta dai quattro evangelisti (Ap 5, 6). È guida che mostra il cammino, che bisogna imitare e seguire partecipando delle sublimi perfezioni costituite dai suoi precetti e consigli (Ap 14, 4). È l’Agnello che sta in mezzo al trono e conduce alle fonti delle acque di eterna vita (Ap 7, 17). Conosce tutti gli atti e pensieri, ogni bene e male (Ap 2, 1). Tiene nella destra sette stelle (i vescovi), che rilucono sui sette candelabri (le chiese), ossia ha potestà sui principi e prelati di tutte le chiese storiche presenti e future, che percorre con la sua mediana “perambulatio” e visita nel suo cammino di guida, di signore e di pio pastore che tutto scruta e penetra (Ap 1, 13; 2, 1.5). Il suo corpo ha raggiunto per crescita la perfezione dell’età virile, come l’ordine evangelico, suo imitatore, nel sesto stato della Chiesa deve raggiungere la maturità (Ap 6, 12).
|
L’imitazione di Cristo
■ Più luoghi della Lectura super Apocalipsim possono essere collazionati tra loro, e questa è una delle norme fondamentali che regolano la sua metamorfosi nella Commedia. La scelta dei luoghi da collazionare non è arbitraria. Vi predispone lo stesso testo scritturale, poiché l’Apocalisse contiene espressioni, come Leitmotive, che ritornano più volte. È determinata da parole-chiave che collegano i passi da collazionare. È suggerita dallo stesso Olivi per una migliore intelligenza del significato del testo. La collazione dà vita a rose di parole aggregate intorno a un punto, che vengono variate e appropriate a diverse circostanze, anche lontanissime fra loro. Di qui derivano gli echi interni al poema [1], che ripercuotono i temi ripetuti in forma sempre nuova e rinviano la memoria del lettore alla dottrina dell’esegesi apocalittica oliviana cui i versi in volgare forniscono “e piedi e mano”. Le variazioni consentono di ‘torcere’ i fili del tessuto a congiunture diverse da quella di partenza estendendo lo spazio significante. Il risultato finale è un doppio linguaggio, esteriore e interiore, letterale e spirituale.
L’aggregazione dei luoghi dell’esegesi scritturale attorno al tema di Cristo mediatore forma una rosa i cui elementi semantici percorrono l’intero poema. Non si tratta di occorrenze più o meno casuali di parole, bensì di variazioni degli stessi elementi, la cui posizione nei versi impregna persone, cose e rapporti delle prerogative di Cristo, diversamente attribuite “unicuique suum” [2]. Nella sinossi fra i due testi è percepibile cosa intendesse Dante nel definire “sacro” il suo poema.
La materia teologica subisce variazioni anche profonde. Cristo è “in medio vite”, via di verità e di vita, verità che è anche centro. È centro della sfera, pastore che ‘tiene’ nella sua destra i vescovi (Ap 2, 1), che deve essere guardato con speranza e imitato come colui che conduce per il cammino, “dux et exemplator itineris” (Ap 7, 17; 14, 4); è anche “sol mundi” (Ap 7, 2). Per cui Virgilio, di lui perfetto imitatore, si rivolge fiducioso al sole perché conduca entro i gironi della montagna, ma prima “fece del destro lato a muover centro” (Purg. XIII, 13-21; da notare la corrispondenza fra “sacerdos legalis debebat semper sollicitam curam habere … esser dien sempre li tuoi raggi duci”, per cui Virgilio, che appartiene alla vecchia legge, fa tirocinio di vita evangelica nella nuova). Così Pier Damiani il quale, beato, non ha bisogno di torcere la sinistra parte come il poeta pagano, ma “del suo mezzo fece il lume centro” (Par. XXI, 80).
Non tutti imitano il sommo pastore, per cui i temi si trovano parzialmente appropriati anche nella bolgia dei simoniaci (“… le somme chiavi / che tu tenesti ne la vita lieta … Di voi pastor s’accorse il Vangelista”, Inf. XIX, 101-102, 106; particolare è il valore del ‘tenere’, che indica la potestà data al pastore, e della “vita”, che deve essere imitazione di Cristo). Oppure ai tre pastori di Trento, Brescia e Verona, i quali nel mezzo del Benaco (in un punto indeterminato) “segnar poria, s’e’ fesse quel cammino” (ma che invece non ‘perambulano’ e non visitano; Cristo è anche “in medio sancte Trinitatis”, Inf. XX, 67-69) [3].
Figura per eccellenza del sommo pastore, in tutte le sue manifestazioni, è Beatrice. Si ricordi anche solo il suo venire “quasi ammiraglio … a veder la gente che ministra” (Purg. XXX, 58-60), il suo “bell’occhio” che “tutto vede” del “viaggio”, cioè del corso della vita dell’amico (Inf. X, 130-132; ambulare, percurrere, visitare le chiese sono propri di Cristo exemplator itineris, e dunque anche dei suoi imitatori: si ricordino le parole di Francesca a Inf. V, 88-90: “O animal grazïoso e benigno / che visitando vai per l’aere perso / noi che tignemmo il mondo di sanguigno”); la parola di Beatrice va “dal centro al cerchio” (Par. XIV, 1-3), muove cioè dal mezzo, come Cristo è centro intimo della sfera-Chiesa, che si mostra a tutti e a cui guardano tutti i raggi degli eletti.
Cristo è la “perfetta vita” di cui dice Piccarda (Par. III, 97); la natura umana, peccando, “si torse / da via di verità e da sua vita”, come afferma Beatrice (Par. VII, 38-39); “e vedräi il tuo credere e ’l mio dire / nel vero farsi come centro in tondo”, secondo le parole di Tommaso d’Aquino a Dante (Par. XIII, 50-51).
Cristo è anche colui che conduce a termine, che guida nel cammino alle desiderabili acque della vita, verso la “dolce vita” dove il male non può più nuocere perché messo in oblio. Si tratta dell’esegesi di Ap 7, 17 (in fine dell’apertura del sesto sigillo), ricchissima di spunti, e collazionabile con altri luoghi (ad esempio con Ap 14, 4, dove è esposto il seguire l’Agnello dovunque vada da parte dei suoi compagni). Il motivo del “deducere” – come atto del guidare non distante dal termine e dall’obiettivo finale, ma piuttosto con esso immediatamente unito, il che mostra la sua eterna continuazione e durata (Ap 7, 17) -, è applicato dal poeta alla propria poesia incapace di esprimere il riso di Beatrice, lasciato “a maggior bando / che quel de la mia tuba, che deduce / l’ardüa sua matera terminando” (Par. XXX, 34-36). Terminare il desiderio e ‘assommare’ perfettamente il cammino (la “perfetta vita” di cui dice Piccarda con riferimento a Chiara d’Assisi) sono nel parlare di san Bernardo sul viaggio di Dante, ormai quasi compiuto (Par. XXXI, 64-66, 94-96; cfr., a Purg. XX, 38-39, il “compiér lo cammin corto / di quella vita ch’al termine vola”, detto dal poeta con riferimento alla vita terrena e cucito sul medesimo panno, nonché le parole di Beatrice a Purg. XXXI, 22-23).
Della “dolce vita” sperimentata nel “seguir Cristo”, e di quanto caro costi l’opposta, dice l’aquila di Traiano (Par. XX, 46-48). Poi (ibid., 58-60), di Costantino e della sua ‘donazione’, afferma: “ora conosce come il mal dedutto / dal suo bene operar non li è nocivo, / avvegna che sia ’l mondo indi distrutto”, utilizzando insieme, da Ap 7, 17, il tema del “deducere” (appropriato all’agire umano, che nel caso “sotto buona intenzion … fé mal frutto”) e quello della cancellazione (ad opera di Cristo guida alla “dolce vita”) di ogni memoria che reca pena o dolore (e invece è dolore “sanza termine” per “chi, per amor di cosa che non duri / etternalmente, quello amor si spoglia”, come detto a Par. XV, 10-12).
■ Dante stesso, imitatore di Cristo, pio buon pastore che visita le chiese presenti e future – come “chi prende sua croce e segue Cristo” (Par. XIV, 106) – visita i dannati, come gli dice Francesca (Inf. V, 89), con “buona pietate”, come attesta Buonconte da Montefeltro (Purg. V, 87). Pastore che imita Cristo, che “ama bene e bene spera” come dice di lui Beatrice al Vicario di Cristo in terra, al quale non sono occulti atti e pensieri altrui (Par. XXIV, 40-42).
La stessa definizione che Dante dà della forma della Chiesa, ossia della sua natura – “Forma autem Ecclesie nichil aliud est quam vita Cristi, tam in dictis quam in factis comprehensa: vita enim ipsius ydea fuit et exemplar militantis Ecclesie, presertim pastorum, maxime summi, cuius est pascere agnos et oves” (Monarchia III, xiv, 3) -, ben avrebbe potuto essere sottoscritta da Olivi, per il quale “Christi persona et vita fuit exemplar totius ecclesie future” (Lectura super Apocalipsim, cap. VI, Ap 6, 12).
■ La sesta prerogativa dei compagni che stanno con l’Agnello sul monte Sion è la familiarità con Cristo senza divisione o distanza, per cui essi “seguono l’Agnello ovunque vada” (Ap 14, 4; quarta visione: l’esegesi appartiene al sesto stato, e più precisamente a quanto segue dopo la sesta guerra, combattuta contro l’Anticristo). Olivi spiega che “seguire” significa imitare e partecipare. Chi imita Dio nelle perfezioni più alte e numerose più lo possiede e dunque più lo segue. Coloro che partecipano di tutte le sublimi e supererogative perfezioni dei mandati e dei consigli di Cristo, per quanto sia possibile agli uomini in questa vita, costoro “seguono l’Agnello ovunque vada”, condotti da Cristo, “dux et exemplator itineris”, guida e cammino, ad ogni atto di perfezione, ai meriti e ai premi corrispondenti. I santi seguono l’Agnello anche perché sempre a lui drizzano e tengono lo sguardo in modo da vederlo ovunque sempre presente.
Questi temi sono evidenti nel Primo Mobile (Par. XXVIII, 91-102), dove i cerchi dei Serafini e dei Cherubini “seguono” veloci il vincolo d’amore con Dio “per somigliarsi al punto quanto ponno”, per quanto cioè è possibile a una creatura farsi simile al Creatore, e tanto più possono quanto più la loro vista è sublime (l’essere sublimi nell’esegesi è proprio delle perfezioni evangeliche, nei versi del vedere da parte delle intelligenze angeliche). Il motivo del seguire appartiene a tutti i cerchi angelici, nei quali “l’incendio suo seguiva ogne scintilla” (v. 91). Il punto fisso che i cori angelici vedono, e a cui cercano di assomigliarsi, li tiene e li terrà sempre a li ubi, al luogo eternamente assegnato loro (variazione del tenere sempre lo sguardo in Dio e vederlo ovunque, ubique, da parte dei compagni dell’Agnello, v. 95).
Centrale è il significato di “punto”. Il sesto stato – iniziato con Francesco e non ancora terminato, corrisponde ai tempi moderni – è il “punto” da cui dipendono gli altri stati, perché appare nel testo dell’Apocalisse in modo più evidente degli altri, che da esso assumono chiarezza quanto alla loro manifestazione nella storia, come (nel senso aristotelico) l’intelligenza delle cose ordinate ad un fine dipende dal fine (prologo, Notabile VIII). Nel sesto tempo (che comprende anche il settimo e ultimo stato) la luce della luna è come quella del sole, e il sole della sapienza cristiana è luminoso della luce dei sette giorni, secondo l’espressione di Isaia 30, 26 con cui si apre il prologo della Lectura. Come il solenne inizio del Nuovo Testamento ebbe luogo nella sesta età del mondo, illuminando le cinque antiche età precedenti e l’intelligenza profetica relativa al primo avvento di Cristo, così il solenne inizio del sesto stato della Chiesa, preceduto dai primi cinque, chiarisce l’intelligenza del libro dell’Apocalisse e delle altre scritture profetiche quanto al triplice avvento di Cristo – nella carne (primo stato), nello Spirito (sesto) e nel giudizio (la parusia alla fine dei tempi) – e ai tempi che precedono sia il primo come il secondo avvento. Nel Primo Mobile Dante vede “un punto … che raggiava lume / acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca / chiuder conviensi per lo forte acume” (Par. XXVIII, 16-18). Intorno al punto, che designa la semplicità e indivisibilità di Dio, girano nove cerchi concentrici di fuoco via via meno veloci quanto più si allontanano da esso, che rappresentano le gerarchie angeliche. Come afferma Beatrice, “da quel punto / depende il cielo e tutta la natura” (vv. 41-42). A Dio, punto geometrico, è dunque appropriato il tema del sesto stato come “punto”, causa finale da cui dipendono gli stati ad esso ordinati (è da notare la presenza del verbo ‘dipendere’ nel Notabile VIII e nei versi, dove è hapax). Dei cieli il Primo Mobile è nono, ma è sesto, a partire dal cielo del Sole, dei pianeti senza il cono d’ombra proiettato dalla terra [4].
Altre forme di utilizzazione del tema del seguire l’Agnello ovunque vada sono il proporsi di Virgilio come guida da seguire (Inf. I, 113); la vista di Dante che segue Piccarda, per quanto possibile, finché svanisce (Par. III, 124-125); seguire il corso del cielo da parte dell’aquila dietro a Enea (Par. VI, 1-3); seguire Domenico, di cui dice Tommaso d’Aquino (“per che qual segue lui, com’ el comanda, / discerner puoi che buone merce carca”, Par. XI, 121-123, versi che rinviano anche ad Ap 7, 7); seguire il Figlio da parte di Maria nell’alto preconio dell’amore angelico rotante (Par. XXIII, 106-108) [5]; seguire con l’affetto da parte del poeta la preghiera di san Bernardo alla Vergine per poi drizzare, in virtù della grazia di costei, gli occhi al primo amore penetrando “quant’ è possibil per lo suo fulgore” (Par. XXXII, 142-150).
Seguire Beatrice equivale a seguire Cristo: la donna usa il verbo, variando l’esegesi di Ap 14, 4, allorché nell’Eden (Purg. XXXIII, 85-90) parla a Dante della sua trascorsa adesione a una filosofia che ritiene la ragione sufficiente a sé stessa; all’indistanza da Cristo subentra la distanza: «“Perché conoschi”, disse, “quella scuola / c’hai seguitata (“et sequuntur”), e veggi sua dottrina / come può seguitar («prout est hominibus huius vite possibile participant, “hii sequuntur …”») la mia parola; / e veggi vostra via (“ad quos Christus tamquam dux et exemplator itineris ipsos deducit”) da la divina / distar (“indistans ipsorum ad Christum familiaritas”) cotanto, quanto si discorda / da terra il ciel che più alto festina” (il Primo Mobile, dove a Dante apparirà il ‘punto’, causa finale della storia)». Qualunque sia la scuola di pensiero oggetto delle parole di Beatrice [6], essa viene indicata come all’opposto di Cristo, che dovrebbe essere guida.
Tenere lo sguardo sull’Agnello, in modo da vederlo ovunque sempre presente, è proprio di Beatrice che tiene lo sguardo fisso sui tre apostoli: “in lor tenea l’aspetto, / pur come sposa tacita e immota” (Par. XXV, 110-111). Il motivo della sposa (Beatrice) richiama quello del letiziare appropriato poco prima a san Giovanni, che si unisce (si mette “ne la rota”) a san Pietro e a san Giacomo “come surge e va ed entra in ballo / vergine lieta” (vv. 103-104): lieta e sposa sono parole-chiave che rinviano ad Ap 18, 22-23, al passo concernente la “vox sponsi” e la “vox mole”, collazionato con quello della “vox rotarum” di Ap 9, 9 (dal confronto si desume l’equivalenza tra “mola” e “rota”; v. anche altri esempi), per quanto i due contesti siano tutt’altro che paradisiaci, l’uno riferito alla condanna di Babylon (che non udrà più voce gioconda) [7], l’altro alle locuste del quinto stato (tumultuose e concitate come carri da guerra).
■ La ripetizione variata dei temi teologici nel poema, attraverso parole-chiave, doveva essere segnale menmonico per i destinatari del linguaggio più profondo. Lo “spirito” non è idea vaga ed estranea, o fumo o schiuma. È fatto di elementi semantici, di appropriazioni variate di parole significanti, di similitudini, di calembour. I sensi mistici, per noi, sono genericamente “allegoria”, simboli esterni al senso letterale, l’“intellectus spiritualis” è da noi inteso in senso idealistico. Per Dante, come per Tommaso d’Aquino, Bonaventura o Olivi, i sensi mistici erano interni al senso letterale, che ne costituisce il fondamento: quattro specie riunite in una di esse, cioè nella lettera, che il prudente esegeta variava secondo utilità, utilizzandone ora una ora l’altra come se scambiasse merci.
Come, attraverso la mnemotecnica, la struttura esteriore della Commedia offre luoghi e immagini, così quella interiore consente di percorrere ‘zone’ del poema (non coincidenti con le divisioni letterali) nelle quali sono collocate le parole-chiave che si riferiscono ai sette stati della Chiesa e alla loro esegesi.
All’obiezione che il “poema sacro” sia stato concepito per tutti e non per un pubblico ristretto quale potevano essere gli Spirituali francescani, per di più in modo ‘occulto’, si risponde che ciò è vero solo per il senso letterale. Nell’Epistola a Cangrande della Scala, Dante afferma che il significato del suo poema è “polisemos, hoc est plurium sensuum” (Ep. XIII, 20), cioè ha più significati. Questi significati sono i quattro usati dagli esegeti della Scrittura. Il primo significato è quello letterale. Gli altri significati – allegorico, morale, anagogico, definiti collettivamente “mistici” – sono comprensibili a partire dal senso letterale, in esso incardinati ma diversi. Dante dunque concepiva il suo “poema sacro”, nel quale descriveva una vera visione come quelle degli antichi profeti, come se fosse un libro della Bibbia. Come la Bibbia, il suo libro era pieno di metafore. Ma la metafora dei poeti, che rappresenta dilettando (il senso letterale), si trasformava nella metafora della Scrittura, necessaria [8], secondo Tommaso d’Aquino, utile e occulta per esercitare nello studio e contro le irrisioni degli infedeli [9].
Gli Spirituali francescani, che conoscevano a memoria la Lectura, dentro alle parole, dall’esegesi tratte variamente ai versi, avrebbero riconosciuto, ad esempio, le prerogative di Cristo sommo pastore (Ap 1, 13-17): dentro ai “crini”, il consiglio proprio della senile e lanosa sapienza e giustizia; dentro al “manto”, la santità e l’onestà, nonché la gloria dei “parenti”; dentro al “sole in viso che più trema”, la faccia di Cristo che nel sesto stato più riluce per aperta notizia della Scrittura e dei suoi arcani e che provoca in chi vede mutazione e oblio. Ben consapevoli del cristocentrismo del loro maestro spirituale, che riprendeva quello di Bonaventura, avrebbero riconosciuto che il poema si apre con il tema di Cristo mediatore. Ma questi destinatari dall’immediata intuizione mnemonica dell’altro nascosto nei versi, forti nella doppia lettura come i gloriosi Argonauti, i quali videro il loro duce Giasone trasformarsi da guerriero in agricoltore, scomparvero subito dalla storia, e con essi la chiave – la Lectura super Apocalipsim -, sepolta nell’oblio.
■ Nonostante il “panno” sul quale è stata fatta parodicamente la “gonna” sia francescano, quanto Olivi scrive della storia della Chiesa e della gloria di Cristo viene nella Commedia diffuso su tutte le persone e le forme, antiche e nuove, del nostro mondo con le sue passioni. Dante fece uscire, aggiornandola, la Lectura dal mondo francescano per riversarne i valori nel “saeculum humanum” e nelle sue nuove esigenze, nella lingua, nella filosofia, nella dimensione politica, nella valorizzazione degli autori classici – in quelli che sarebbero stati gli ideali laici del Rinascimento -, mentre veniva meno il senso di una storia sacra della salvezza collettiva, della quale la Lectura fu l’estrema espressione.
Lo spirito profetico
Il passaggio dall’universale al particolare, che nei primi due versi del poema porta da “Nel mezzo del cammin di nostra vita” a “mi ritrovai per una selva oscura”, corrisponde a una caratteristica dello spirito profetico di cui, ad Ap 13, 1, Olivi nota la capacità di salire dal particolare all’universale e di ricondurre questo al proprio particolare. L’ascendere all’universale avviene allorché lo spirito trova un luogo idoneo all’uscire per dilatarsi ed espandersi dalle cose speciali verso le generali. Così Isaia, parlando di Babilonia e del suo re, dilata il discorso rivolgendolo contro tutto il mondo simile a Babilonia e contro Lucifero re di tutti i superbi e i malvagi quasi fosse re della grande Babilonia (Is 14, 12). Così Ezechiele, parlando contro Tiro, si diffonde su tutto il mondo e sul supremo cherubino che sta nel mezzo delle pietre infuocate (Ez 28, 14-16). Così Cristo, che attribuisce tutti i mali provenienti da ogni generazione di reprobi alla particolare malvagia generazione dei reprobi Giudei del suo tempo, sulla quale ricade tutto il sangue versato dal tempo di Abele il giusto (Matteo 23, 35-36). Così Giovanni, autore dell’Apocalisse, toccando della bestia che sale dal mare (la bestia saracena: Ap 13, 1-10) si dilata a tutta la massa dei reprobi che dalla creazione alla fine del mondo combatte contro la Chiesa degli eletti e ha sette teste corrispondenti alle sette età.
Lo spirito profetico dà alle vicende un valore esemplare. Tutti i tre più gravi peccati capitali – “superbia, invidia e avarizia” -, secondo Ciacco, cooperano alle divisioni di Firenze, e ne sono concausa (Inf. VI, 74-75). Un particolare fatto cittadino viene elevato a modello di male universale, e questo espandersi verso l’universale al di là del proprio particolare, per poi ritornarvi, è appunto una caratteristica del modo tenuto dai grandi profeti, Isaia o Ezechiele.
Nell’apostrofe che apre Inf. XXVI, il nome di Firenze “si spande” per l’inferno come la fama della città fatta “sì grande” batte le ali per mare e per terra. Il passaggio dal particolare all’universale è ribadito nel cielo di Venere da Folchetto di Marsiglia, che dilata il suo discorso al modo dei profeti: Firenze, pianta di Lucifero, “produce e spande il maladetto fiore”, la moneta che ha traviato il gregge cristiano trasformando i pastori in lupi (Par. IX, 127-132).
In altro contesto, Virgilio è “quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume”, dotato anch’egli di spirito profetico (Inf. I, 79-80). L’uscire e il dilatarsi sono propri della mente di Dante la quale, come la folgore si dilata fuori della nuvola che la contiene, esce da sé stessa fatta più grande per i cibi spirituali offerti dalla visione del trionfo di Cristo nel cielo delle stelle fisse (Par. XXIII, 40-45).
Nell’Eden la “puttana sciolta” – la meretrice Babylon, la Chiesa carnale – viene mostrata darsi al gigante (il regno di Francia) e finir tratta nella selva: secondo gli esegeti, “Babylon confusio interpretatur”. Se la confusione babilonica si mostra sul piano dei due poteri universali, il temporale e lo spirituale, essa nondimeno agisce anche a livello individuale dove, come afferma Olivi, ciascuno deve bruciare la propria meretrice interiore [10]. Così la confusione è appropriata anche a Dante (Purg. XXXI, 7, 13), finito nella selva oscura dopo essersi tolto a Beatrice e dato ad altri, quasi specchio individuale della prostituta apocalittica (“questi si tolse a me, e diessi altrui … e come perché non li fosse tolta”: Purg. XXX, 126; XXXII, 151). La confusione agisce anche a livello cittadino: “Semper enim usque ad finem seculi erunt in hoc mundo aliqui babilonici, id est reprobi, a quorum peccatis est recedendum … Babilon enim confusio interpretatur – Sempre la confusion de le persone / principio fu del mal de la cittade (Ap 14, 8; 18, 4; Par. XVI, 67-69)”.
Come nella prima terzina del poema si scende da ciò che è comune al genere umano (“Nel mezzo del cammin di nostra vita”) al singolo individuo Dante (“mi ritrovai”), così all’inverso, nel rimprovero formulato da Beatrice nell’Eden, si sale da “quella scuola ch’hai seguitata”, che è all’opposto della “parola” della donna, alla “vostra via” che tanto dista da quella divina (Purg. XXXIII, 85-90) [11].
Dunque lo “spirito profetico”, nel suo trascorrere dall’individuale all’universale e viceversa, è, prima ancora che la prescienza tramite il lume divino di eventi futuri, lo strumento che consente di inserire fatti e personaggi contemporanei nel corso della storia provvidenziale; per esso il realismo radicato sull’“aiuola che ci fa tanto feroci” diventa “sacro” e la terra adombra il cielo [12].
La stessa imitazione di Cristo – il tema che impregna il primo verso del poema – non è intesa in un senso genericamente morale; essa ha valore storico, di un nuovo avvento in terra del Salvatore nella persona dei suoi discepoli mossi dallo Spirito, di un compimento della Redenzione per mezzo di una nuova lingua universale quale il latino, “lingua gratiae” al pari dell’ebraico, la lingua parlata da Cristo.
___________________________________________________________________________
[1] Cfr. GIANFRANCO CONTINI, Un’interpretazione di Dante (1965-1966), in Un’idea di Dante. Saggi danteschi, Torino 1970 e 1976, p. 91.
[2] Cfr. GIANFRANCO CONTINI, Filologia ed esegesi dantesca (1965), ibid., p. 135: “Di fronte, se mi si passa il traslato, all’integralismo teologico di Francesco sta la mondanità discretiva del Dante della Commedia, «unicuique suum»”.
[3] Che il “mezzo” del Benaco sia un punto indeterminato (e non l’Isola dei Frati, che oltretutto in mezzo non sta) è confermato dall’idea di Cristo mediatore al quale allude, corrispondendo così in terra al punto luminoso, centro dei cerchi della gerarchia angelica, che Dante vede nel Primo Mobile. Sulle origini di Mantova (Inf. XX, 52-102) cfr. Il terzo stato. La ragione contro l’errore, Appendice I.
[4] Cfr. Topografia spirituale della Commedia, introduzione al Paradiso.
[5] Cfr. Amore angelico (Par. XXIII, 103-111).
[6] ANNA MARIA CHIAVACCI LEONARDI, nel commento al Purgatorio, Milano 2007, p. 974, ritiene trattarsi «di quella passione filosofica esclusiva che prese Dante nella sua giovinezza e lo avvicinò alle posizioni averroistiche, che portavano a ritenere la ragione umana di per sé sufficiente a intendere la verità dell’universo». Diversamente GIORGIO INGLESE, in Dante Alighieri, Commedia. Revisione del testo e commento. Purgatorio, Roma 2011, p. 400, secondo il quale «si può cogliere … una polemica obiettiva con la dottrina avicenniano-albertina dell’ “uomo divino”, o uomo profetico» prospettata in Convivio IV, xxi, 10. I versi precedenti (76-81) rinviano ad Ap 13, 17, trasformando in senso positivo il tema del portare in mano o impresso sulla fronte il sigillo dell’Anticristo da parte dei suoi seguaci, che solo consente loro di “vendere” (predicare o insegnare) e di “comprare” (ascoltare o apprendere). A un brano antiaverroista nell’esegesi della quinta tromba (Ap 9, 1-2) rinviano le parole di Cavalcante “… Se per questo cieco / carcere vai per altezza d’ingegno …” (Inf. X, 58-59; cfr. Lectura Dantis, Inferno X, cap. VI). A quanto scritto in Convivio IV, xxi, 10 – «E sono alcuni di tale oppinione che dicono [che], se tutte le precedenti vertudi s’accordassero sovra la produzione d’un’anima nella loro ottima disposizione, che tanto discenderebbe in quella della deitade, che quasi sarebbe un altro Dio incarnato. E quasi questo è tutto ciò che per via naturale dicere si puote» -, cioè alla concezione di Avicenna e di Algazali, filtrata attraverso Alberto Magno, ripresa da Tommaso d’Aquino a Par. XIII, 73-87 e dal Nardi considerata uno dei fondamenti del profetismo dantesco (cfr. Dante Alighieri, Opere minori, I/II, a cura di C. Vasoli e di D. De Robertis, Milano-Napoli 1988, p. 770, nt. 10), non sembra possa applicarsi un’esegesi che tratta di conformità con Cristo o con il suo contrario, l’Anticristo. Ad essa ben si addice invece l’averroismo, già riprovato da Stazio nel sesto girone della montagna (Purg. XXV, 61-66) e poi, dopo le parole di Beatrice su “quella scuola c’hai seguitata”, demolito nel primo cielo dalla stessa donna sulla questione delle macchie lunari (Par. II, 49-148). In ogni caso il punto centrale è quello di Cristo, “dux et exemplator itineris”, cioè della guida, che Guido (e Dante, in un certo periodo) hanno disdegnato.
[7] Ricordando l’uccisione di Buondelmonte, Cacciaguida usa i motivi delle nozze e della letizia senza torcere in bonam partem l’esegesi, per cui Firenze-Babylon è da allora per sempre privata del suono della “vox sponsi et sponse”, cioè della “letitia nuptiarum” (Par. XVI, 136-144).
[8] IGNAZIO BALDELLI, Lingua e stile delle opere in volgare di Dante. Lingua e stile della Commedia, in Enciclopedia Dantesca, Appendice, Roma 19842, p. 96, sottolinea come la similitudine nella Commedia, in confronto al Convivio, sia «non esornativa, ma “necessaria”. In questo, la similitudine della Commedia travalica fortemente la similitudine epica classica, da cui per altro spesso si svolge, acquisendo la ‘necessità’ piuttosto dalla “necessità” del discorso biblico-strutturale».
[9] TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, qu. I, a. 9: «Convenit etiam sacrae Scripturae, quae communiter omnibus proponitur (secundum illud ad Rom. I, [14]: sapientibus et insipientibus debitor sum), ut spiritualia sub similitudinibus corporalium proponantur; ut saltem vel sic rudes eam capiant, qui ad intelligibilia secundum se capienda non sunt idonei. Ad primum ergo dicendum quod poeta utitur metaphoris propter repraesentationem: repraesentatio enim naturaliter homini delectabilis est. Sed sacra doctrina utitur metaphoris propter necessitatem et utilitatem, ut dictum est. Ad secundum dicendum quod radius divinae revelationis non destruitur propter figuras sensibiles quibus circumvelatur, ut dicit Dionysius, sed remanet in sua veritate; ut mentes quibus fit revelatio, non permittat in similitudinibus permanere, sed elevet eas ad cognitionem intelligibilium; et per eos quibus revelatio facta est, alii etiam circa haec instruantur. Unde ea quae in uno loco Scripturae traduntur sub metaphoris, in aliis locis expressius exponuntur. Et ipsa etiam occultatio figurarum utilis est, ad exercitium studiosorum, et contra irrisiones infidelium, de quibus dicitur, Matth. 7, [6]: nolite sanctum dare canibus».
[10] LSA, cap. XIX, Ap 19, 10: «Nota quod, secundum morale misterium, meretrix Babilon est concupiscentia carnis vel mens pravis concupiscentiis a Deo aversa. Bestia vero, supra quam sedet, est bestialis voluptas vel prava et bestialia obiecta concupiscentie prave, vel bestialis societas menti carnali subiecta et serviens. Septem autem capita bestie sunt septem genera principalium obiectorum concupiscentie prave, que distinguuntur secundum septem genera capitalium vitiorum. Nam unumquodque habet suum formale et proprium et principale obiectum. In sexta autem etate mortalis hominis, scilicet in senio, ceciderunt quinque reges, scilicet quinque sensus. Tunc tamen precipue regnat sextus, id est avaritia, quem secuturus est septimus, scilicet intolerabilis et desperatus timor et tristitia de mortis imminentia et de mundialis vite nimium dilecte deficientia.
Decem autem reges et cornua meretricem cremantia sunt decem genera penarum infernalium, quarum quinque sunt sensibiles, secundum quinque sensus corporis quos affligunt, alia vero quinque sunt intellectualia.
Primum est certitudo interminabilis eternitatis pene.
Secundum est intimus sensus reprobative <despectionis> et ire et inimicitie Dei et omnium sanctorum ad dampnatos.
Tertium est corrosivus remorsus conscientie, quia ex culpa propria et pro complacentia vili et transitoria tantam penam promeruerunt et in tanta dampna et supplicia se precipitaverunt.
Quartum est tabescentia invidie dampnatorum ad beatos et ad gloriam eorum.
Quintum est crepatio importabilis impatientie in summas sui ipsius maledictiones et proprie adnichilationis exoptationes et in Dei et sanctorum et etiam omnium blasphemationes se incessabiliter eviscerantis.
Qui autem per horum decem compunctivam et contritivam considerationem in se ipso comburit et occidit prefatam meretricem et reddit ei duplicia secundum demerita eius (cfr. Ap 18, 6), iste cantat quater alleluia et intrat ad nuptias Agni».
[11] Cfr. supra, nota 6. Cfr. GENNARO SASSO, Le autobiografie di Dante, Napoli 2008, p. 92: «Il passaggio dalla seconda persona singolare alla seconda plurale non può essere casuale. E, posto che, soggettivamente, lo fosse stato, scendere verso la radice della personalità, o dell’anima, di Dante, per cogliervi la non casuale ragione di questa casualità, non solo non sarebbe illegittimo. Ma sarebbe necessario. Dimostrerebbe infatti, questa discesa verso la radice, come in determinati momenti della narrazione, quando questa s’innalzava verso vertici di particolare intensità intellettuale e morale, il viandante dell’al di là riassumesse in sé tutto il genere umano, che in lui, appunto, si identificava». In realtà il viandante riassumeva sempre tutto il genere umano e non solo in determinati momenti. Tale è appunto il senso di essere “alter Ioannes” che deve predicare ancora a tutto il mondo, la cui storia egli ripercorre nel suo viaggio, fino alla fine del tempo, e di cui si fa carico. L’individuo Dante è ascritto all’“ordo evangelicus et contemplativus” degli ultimi tempi, sul quale ricadono tutte le illuminazioni passate, che sostiene vittoriosamente tutto il male precedente ridondante su quello attuale e che può così reggere, nuovo Enea, le genti “in virga ferrea”, cioè con la sua poesia che piega anche i cuori più duri.
[12] Cfr. ibid., p. 222 e nota 54, dove si sottolinea con nettezza il limite della tesi sostenuta da Bruno Nardi, che cioè l’idea della profezia colga il carattere essenziale della Commedia: «La Commedia è un’apocalisse che via via si realizza fino a conseguire il traguardo. […] Nel suo senso più profondo, la Commedia è, non una profezia, ma la storia del tempo in cui il tempo finisce; e perciò nel senso più volte chiarito, e con le conseguenze che ne discendono, un’apocalisse. Non annunziata, ma vissuta e realizzata». Ma l’Apocalisse – la “profezia” per eccellenza – è, appunto, storia della salvezza.
Scriveva ERNESTO SESTAN, Dante a Firenze, in Italia medievale, Napoli 1966, pp. 270-291: p. 273: «Fra i fatti che punteggiarono la vita politica fiorentina negli anni della presenza di Dante in Firenze, gli storici non esitano a porre in particolare rilievo, come tipici di Firenze, l’istituzione del priorato delle arti, le lotte anti-magnatizie, la figura e l’azione di un Giano della Bella e di un Corso Donati; e anche le lotte feroci fra Bianchi e Neri, che colpirono personalmente il poeta, sebbene esse, sotto gli stessi nomi o analoghi, si ritrovino in moltissime città italiane del tempo, fenomeno di rivalità e di disgregazione nei gruppi dirigenti, appoggiantisi a forze esterne, si chiamino papato, impero o altrimenti: nulla di tipicamente fiorentino: solo la fama di Dante ha fatto sì che assurgessero, nella storiografia, a una notorietà e singolarità che veramente non meritano». Più che la fama di Dante, è stato il suo profetismo, per il quale il microcosmo toscano è asceso a esemplare di storia universale.
___________________________________________________________________________
Tab. I.a
[LSA, cap. II, Ap 2, 1.5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Secundum est Christi alloquentis hanc ecclesiam et eius episcopum introductio, cum subditur (Ap 2, 1): “Hec dicit qui tenet septem stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum”. Utitur autem tentione stellarum, id est episcoporum, et perambulatione candelabrorum, id est ecclesiarum, triplici ex causa.
|
||
Par. III, 97-102“Perfetta vita e alto merto inciela
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 12 (apertio VIi sigilli)] Secunda ratio est quia persone Christi corespondet in sexta apertione unus ordo plurium personarum sic secun-dum suam proportionem augendus, sicut Christus secundum suum corpus fuit usque ad perfectam etatem viriliter auctus.
|
|
[LSA, prologus, Notabile VII] Secunda (ratio) est eius singularis et exemplaris vita, quam apostolis imposuit et in se ipso exemplavit et in libris evangelicis sollempniter scribi fecit. Huius autem vite perfecta imitatio et participatio est et debet esse finis totius nostre actionis et vite. […]
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 6 (radix IIe visionis)] Deinde ostenditur quomodo Christus aperuit librum. Primo tamen describitur virtus eius ad aperiendum. Ubi primo ostenditur quod ipse est totius ecclesie mediator et quasi centrale medium ad quod tota spera ecclesie et omnes linee electorum suorum aspiciunt sicut ad medium centrum. Unde ait (Ap 5, 6): “Et vidi”, scilicet hoc quod sequitur, “et ecce in medio troni”, id est totius ecclesie; “et in medio quattuor animalium”, id est quattuor ordinum, scilicet apostolorum, martirum, confessorum, virgi-num; “et in medio seniorum”, id est sanctorum patrum quattuor ordin<ibus> presidentium. Vel “in medio troni”, id est in medio sancte Trinitatis, tamquam persona media sedens in eadem maiestate trium personarum quasi in eadem sede; “et in medio quattuor animalium”, id est vite et doctrine evangelice per quattuor evangelistas conscripte. Numquam enim recessit a medio alicuius virtutis aut veritatis, immo stetit semper in intimo medio. “Et in medio seniorum”, scilicet primorum patrum et doctorum legis, quasi eis subiectus et tamquam eorum filius, unde ad Galatas IIII° dicitur (Gal 4, 4-5) “factus sub lege, ut eos qui sub lege erant redimeret”. “Exinanivit” enim “se formam servi accipiens”, prout dicitur ad Philippenses II° (Ph 2, 7); stetit etiam “in medio” discipulorum “sicut qui ministrat”, prout dicitur Luche XXII° (Lc 22, 27).
|
|
Inf. X, 127-132“La mente tua conservi quel ch’udito
|
[Ap 2, 1] […] ille qui bene scit omnes vestros actus et cogitatus […] et etiam quod habent ipsum amare et in ipso sperare et ex eius amore et spe omnia verba eius servare, quia ipse est eorum iudex et dominus ipsos prepotenter tenens et circumspectissime exa-minans. Ipse etiam est pius pastor eos protegens et custodiens, et pro eorum custodia eos semper tenens et visitans. […] Tentio enim significat potestatem et perambulatio vero curam.
|
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 17 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] “Quoniam Agnus, qui in medio troni est” (Ap 7, 17), tamquam scilicet media persona in Trinitate et tamquam mediator inter nos et Deum. Vel est “in medio troni”, id est in intimo sinu Patris, vel in intimo ecclesie quasi centrum ipsius. “Reget illos”, tali scilicet regimine quod non permittet eos aliquo modo affligi; “et deducet eos ad vite fontes aquarum”, id est ad plene hauriendum et bibendum immensos fontes aquarum beatissime vite Dei et que est ipse Deus. Unde pluraliter dicit “fontes aquarum”, ad designandum immensam multiformitatem dulcorum et desiderabilium bonitatum unius simplicissimi Dei. Dicit autem de futuro “reget et deducet”, ut monstret eternam continuationem et perdurationem istorum actuum. Deducere autem non significat hic actum distantem a finali termino et obiecto, sed potius immediate coniunctum termino et obiecto.
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 4 (IVa visio)] Unde et sextum preconium prerogative ipsorum est indivisibilis et indistans ipsorum ad Christum familiaritas, propter quod subditur: “Et sequuntur Agnum quocumque ierit”. Quantum unusquisque Deum imitatur et participat, in tantum sequitur eum. Qui ergo pluribus et altioribus seu maioribus perfectionibus ipsum imitantur et possident altius et multo fortius ipsum sequuntur. Qui ergo secundum omnes sublimes et supererogativas perfectiones mandatorum et consi-liorum Christi ipsum prout est hominibus huius vite possibile participant, “hii sequuntur Agnum quo-cumque ierit”, id est ad omnes actus perfectionum et meritorum ac premiorum eis correspondentium, ad quos Christus tamquam dux et exemplator itineris ipsos deducit. |
|
Purg. XX, 37-39Non fia sanza mercé la tua parola,
|
Par. XX, 46-48, 55-60 (cfr. Par. IV, 35; XXV, 93)ora conosce quanto caro costa
|
|
Tab. I.b
[LSA, prologus, Notabile VIII] Rursus quinque membra sic distincte et interscalariter currunt inter radicem visionum et inter sextum membrum, quod ex hoc ipso aperte insinuatur per ipsa designari quinque sollempnia tempora cum suis sollempnibus statibus et operibus ordinate percurrentibus ab initio ecclesie usque ad sextum tempus ipsius. Que autem essent illa tempora vel opera, aut in quo puncto inchoarentur et finirentur, non potuit a nobis communiter sciri vel investigari nisi per realem et manifestum adventum ipsorum ac per preclaram et sollempnem initiationem status sexti. Et ideo sicut sollempnis initiatio novi testamenti facta in sexta mundi etate cum precursione quinque etatum elucidat intellectum prophetarum quoad primum Christi adventum et quoad tempora ipsum precurrentia, sic sollempnis initiatio sexti status ecclesie cum precursione quinque priorum elucidat intelligentiam huius libri et ceterorum prophetalium quoad trinum Christi adventum et quoad tempora precurrentia tam primum quam secundum adventum, propter quod in ipso sexto tempore erit sol sapientie christiane septempliciter lucens sicut lux septem dierum (cfr. Is 30, 26). […] Ex predictis autem patet quod principalis intelligentia sexti et septimi membri visionum huius libri fortius probatur et probari potest quam intelligentia membrorum intermediorum inter primum et sextum seu inter radicem et sextum, unde et clara intelligentia ipsorum dependet ab intelligentia sexti, sicut et ratio eorum que sunt ad finem dependet a fine. |
||
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 4 (IVa visio)] Unde et sextum preconium prerogative ipsorum est indivisibilis et indistans ipsorum ad Christum familiaritas, propter quod subditur: “Et sequuntur Agnum quocumque ierit”. Quantum unusquisque Deum imitatur et participat, in tantum sequitur eum. Qui ergo pluribus et altioribus seu maioribus perfectionibus ipsum imitantur et possident altius et multo fortius ipsum sequuntur. Qui ergo secundum omnes sublimes et supererogativas perfectiones mandatorum et consiliorum Christi ipsum prout est hominibus huius vite possibile participant, “hii sequuntur Agnum quocumque ierit”, id est ad omnes actus perfectionum et meritorum ac premiorum eis correspondentium, ad quos Christus tamquam dux et exemplator itineris ipsos deducit.
|
||
Inf. I, 112-113Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno
|
Par. XI, 121-123 (cfr. v. 102)
e questo fu il nostro patrïarca;
per che qual segue lui, com’ el comanda, 7, 7
discerner puoi che buone merce carca.
Par. XXVIII, 22-27, 40-42, 91-102
Forse cotanto quanto pare appresso
alo cigner la luce che ’l dipigne 1, 13
quando ’l vapor che ’l porta più è spesso,
distante intorno al punto un cerchio d’igne
si girava sì ratto, ch’avria vinto
quel moto che più tosto il mondo cigne
La donna mia, che mi vedëa in cura
forte sospeso, disse: “Da quel punto
depende il cielo e tutta la natura”.
L’incendio suo seguiva ogne scintilla;
ed eran tante, che ’l numero loro
più che ’l doppiar de li scacchi s’inmilla.
Io sentiva osannar di coro in coro
al punto fisso che li tiene a li ubi,
e terrà sempre, ne’ quai sempre fuoro.
E quella che vedëa i pensier dubi
ne la mia mente, disse: “I cerchi primi
t’hanno mostrato Serafi e Cherubi.
Così veloci seguono i suoi vimi,
per somigliarsi al punto quanto ponno;
e posson quanto a veder son soblimi”.
Purg. XXXIII, 85-90
“Perché conoschi”, disse, “quella scuola
c’hai seguitata, e veggi sua dottrina
come può seguitar la mia parola;
e veggi vostra via da la divina
distar cotanto, quanto si discorda
da terra il ciel che più alto festina”.
Par. III, 124-126
La vista mia, che tanto lei seguio
quanto possibil fu, poi che la perse,
volsesi al segno di maggior disio
Par. VI, 1-3
Poscia che Costantin l’aquila volse
contr’ al corso del ciel, ch’ella seguio
dietro a l’antico che Lavina tolse
Par. XXXII, 142-150
e drizzeremo li occhi al primo amore,
sì che, guardando verso lui, penètri
quant’ è possibil per lo suo fulgore.
Veramente, ne forse tu t’arretri
movendo l’ali tue, credendo oltrarti,
orando grazia conven che s’impetri
grazia da quella che puote aiutarti;
e tu mi seguirai con l’affezione,
sì che dal dicer mio lo cor non parti.
[LSA, cap. IX, Ap 9, 9 (IIIa visio, Va tuba)] Pro septima (mala proprietate locustarum) dicit (Ap 9, 9): “Et vox alarum earum sicut vox curruum equorum multorum currentium in bellum”, id est fama et sonus tumultuosi volatus e<a>rum ad sua opera maligna est sicut tumultuosus sonus quadrigarum et equestrium exercituum magnorum et mult<o>rum impetuosissime currentium ad bellum. […] “Vox” autem “alarum” (Ap 9, 9), id est suarum sententiarum quas altissimas et prevolantes esse presumunt, est sicut vox rotarum et tumultuosi exercitus currentis in bellum contra omnem sententiam contrariam quantumcumque veram.
[LSA, Ap 18, 22-23 (VIa visio)] Deinde ostendit quomodo (Babilon) omni iocundo cantico seu gaudio, et omni utili et etiam curioso opere et artificio, et iocunda luce et nuptiis erit ex tunc omnino et in eternum privata, unde subdit: “Et vox citharedorum” et cetera; “et vox”, id est sonus, “mole”, molentis scilicet triticum vel alia utilia, et cetera; “et vox sponsi et sponse”, id est letitia nuptiarum, “non audietur adhuc”, id est amplius seu de cetero, “in te”.
Par. XXV, 103-111
E come surge e va ed entra in ballo
vergine lieta, sol per fare onore
a la novizia, non per alcun fallo,
così vid’ io lo schiarato splendore
venire a’ due che si volgieno a nota
qual conveniesi al loro ardente amore.
Misesi lì nel canto e ne la rota;
e la mia donna in lor tenea l’aspetto,
pur come sposa tacita e immota.
[Ap 14, 4] Item “sequuntur” ipsum “quocumque ierit”, quia sic semper dirigunt et tenent suum aspectum in ipsum quod ipsum semper et ubique presentialiter vident vel speculantur quasi presen-tem.
Tab. I.c
[LSA, cap. XIII, Ap 13, 1 (IVa visio, Vum prelium)] Tertio nota quod mos est scripture prophetice, dum de uno speciali agit sub quo spiritus propheticus invenit locum idoneum ad exeundum et dilatandum se, a specialibus ad generalia ascendere et expandi ad illa, iuxta quod Isaias, loquendo de Babilone et eius rege, dilatat se ad loquendum contra totum orbem Babiloni similem et contra Luciferum regem omnium superborum et malorum quasi regem magne Babilonis (cfr. Is 14, 12-21). Sic etiam Ezechiel, loquendo contra Tirum, diffundit se ad totum orbem et ad supremum Cherub de medio lapidum ignitorum, id est sanctorum angelorum, deiectum (Ez 28, 14-19). Sic etiam Christus Matthei XXIII° (Mt 23, 35-36) ascribit omnia mala totius generationis omnium reproborum generationi male Iudeorum sui temporis, tamquam a particulari ascendens ad generale et tamquam universale reducens ad suum particulare, cum ait quod omnis sanguis iustorum impie effusus a sanguine Abel iusti usque ad sanguinem Zacharie veniet super generationem istam. Sic ergo in proposito, occasione bestie sarracenice, dilatatur spiritus propheticus ad totam bestialem catervam omnium reproborum, que ab initio mundi usque ad finem pugnat contra corpus seu ecclesiam electorum et per septem etates seculi habet capita septem; specialiter tamen a Christo usque ad finem mundi per septem ecclesiastica tempora habet septem principalia capita contra septem ecclesie spiritales status et exercitus. |
|||
Inf. XXVI, 1-3Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande,
|
Purg. XXXIII, 85-90“Perché conoschi”, disse, “quella scuola
|
||
Inf. I, 79-80Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte
|
Par. XXIII, 40-45
Come foco di nube si diserra
per dilatarsi sì che non vi cape,
e fuor di sua natura in giù s’atterra,
la mente mia così, tra quelle dape
fatta più grande, di sé stessa uscìo,
e che si fesse rimembrar non sape.
***
mi ritrovai
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
mi ritrovai
|
2
|
2, 5
|
I |
Ritrovare la carità originaria
La discesa per gradi dal vertice della perfezione al fondo, con la conseguente necessità di risalire alla carità originaria, a poco a poco venuta meno, è uno dei temi più importanti dell’istruzione data al vescovo di Efeso, la prima e la metropolita delle sette chiese d’Asia, di cui tratta la prima visione. Il tema, attorno al quale ruota una rosa ricca di motivi, si presta a molteplici variazioni nel poema, in primo luogo con il dare un senso spirituale all’andamento del viaggio.
L’istruzione del metropolita inizia con parole di lode, sia per elevarlo con queste a cose migliori e confortarlo a perseverare con fermezza nel bene, sia perché venga disposto nell’animo a ricevere il successivo rimprovero, come il chirurgo prudente prima palpa in modo soave le membra sane cosicché il malato sopporti poi in modo più tranquillo l’intervento sulla parte inferma.
Dopo le lodi per il bene operare (Ap 2, 1-3), è il momento dei rimproveri per il vescovo della chiesa di Efeso (Ap 2, 4-5). Non deve infatti insuperbire per le lodi tributategli, né credersi privo di difetti, cessando dal timore di cadere. Per questo viene accusato di aver abbandonato la primitiva carità e di amare meno Dio e il prossimo. Non si dice in modo assoluto che ha del tutto perduto la carità originaria e migliore, ma che se ne è allontanato per negligenza dovuta a eccesso di sicurezza nella grazia ricevuta, cadendo dal culmine della perfezione a un grado minore e defettivo (Ap 2, 4). Dio pertanto lo esorta a pentirsi e a recuperare il livello perduto: “ricorda dunque da dove sei caduto, fa penitenza e compi le prime opere”, quasi intendendo dire: ‘guarda da quale vertice di perfezione sei venuto meno cadendo all’infimo grado: ravvediti della tua negligenza e compiendo le prime opere ritrova (“recupera”) la prima grazia’ (Ap 2, 5).
La diminuzione della prima carità, con la caduta dal fervido amore iniziale rimproverata al vescovo di Efeso (tema che Olivi trae da Riccardo di San Vittore), viene contestata da Beatrice a Dante nel Paradiso terrestre. Dopo la morte, dice la donna, “fu’ io a lui men cara e men gradita”, proprio “quando di carne a spirto era salita, / e bellezza e virtù cresciuta m’era” (Purg. XXX, 127-129). Al salire in virtù di lei aveva fatto riscontro il cadere dell’amico tanto giù che l’unico rimedio per la sua salute era stato quello di mostrargli le perdute genti (vv. 136-138).
Come il bene operato con la prima carità, seguìto con desiderio e con diletto, si colloca al vertice della perfezione e diventa defettivo se da essa si allontana, così al termine del viaggio tutto il bene a cui tende la volontà s’accoglie nella luce divina e fuori da lei diventa defettivo. Non è consentito a chi guarda la luce divina, nella quale è tutto l’oggetto della nostra beatitudine, “volgersi da lei per altro aspetto”, togliersi da lei per darsi ad altri, come ha fatto Dante nei confronti di Beatrice (Par. XXXIII, 100-105; cfr. anche l’esegesi della sesta vittoria, ad Ap 3, 12).
Dante, nel cadere giù diminuendo nell’amore per Beatrice, “si tolse” a lei per darsi ad altri (Purg. XXX, 124-126): il togliersi è variazione in senso riflessivo dell’“evellere”, in un contesto che appare segnato dalla tematica della prima chiesa alla quale, in difetto di correzione, viene minacciata la traslazione del candelabro.
Il vescovo di Efeso non deve insuperbire per le lodi tributategli, né credersi privo di difetti, cessando dal timore di cadere. Parodia dell’esegesi “ut nos propter multa bona non cessemus formidare nos esse in pluribus et gravibus defectivos et reos” sono le parole di Virgilio a Inf. IV, 40-41: “Per tai difetti, non per altro rio, / semo perduti …” (cfr. la presenza del tema a Purg. X, 128, congiunto con quello della superbia, tipico dell’istruzione alla prima chiesa, e collazionato con l’esegesi della quinta vittoria ad Ap 3, 5).
Nella selva Dante si ritrova. L’espressione “mi ritrovai” (Inf. I, 2) non ha solo il significato di casuale capitare in un luogo, ma corrisponde anche al ‘recuperare’ (il verbo è di Riccardo di San Vittore), ravvedendosi, il livello di carità iniziale a cui viene esortato il metropolita efesino. Come ben vide il Pascoli, “a trentacinque anni si ritrovò. Ciò pare detto in tono di vergogna, di confessione amara, come se noi dovessimo aggiungere un ‘finalmente!’ che esso tace”. La diritta via, come sottolineato dal Landino, era “smarrita” e non “perduta”, quale quella di chi ritorna alla virtù dopo essere trascorso nel vizio: così da quanto Giovanni scrive alla chiesa di Efeso si desume chiaramente, secondo Olivi che commenta la fonte riccardiana, che la carità originaria può essere diminuita senza che si perda tutta.
|
Altre occorrenze del ‘ritrovare’ mostrano connessioni con l’esegesi di Ap 2, 5 (e la sua ‘rosa’ semantica: ut recuperet … recupera … fac): il ritrovarsi, “disfatto”, con Virgilio il quale, come duce e pastore, deve avere nella sua destra le sette stelle (Inf. VIII, 97-102; Ap 2, 1); Forlì che “sotto le branche verdi si ritrova” degli Oderlaffi (Inf. XXVII, 43-45, e sarà da intendere in senso positivo, dopo che “fé già la lunga prova, / e di Franceschi sanguinoso mucchio”).
Gli elementi semantici sono scomposti in Ieptè (Par. V, 64-72), “cui più si convenia dicer ‘Mal feci’”, che avrebbe cioè fatto meglio a risalire, pentendosi del suo voto sconsiderato, “a la sua prima mancia” (la figlia che aveva fatto voto di sacrificare, intesa come il primo dono, che sembra equivalere alla “prima gratia” perduta, nei confronti della quale fu ingiusto), “che, servando, far peggio”, cadendo ancor più in basso (il ‘ritrovare’ è congiunto con Agamennone, altro esempio di voto stolto). Da notare, nelle tre terzine, la presenza insistente delle forme del verbo fare (far, feci, far, fé), accostate a prima e a ritrovar, tutti elementi semantici che rinviano ad Ap 2, 5.
A Par. II, 97-105 (da notare la coincidenza numerica dei versi con Inf. VIII), nell’esperimento proposto, Beatrice invita il poeta a ‘ritrovare’ con lo sguardo uno specchio posto più distante in mezzo ad altri due collocati a uguale distanza. La luce che illumina i tre specchi, riflettendosi, sarà nello specchio mediano quantitativamente meno estesa che negli altri due ma uguale nello splendere. Per quanto poco perspicuo nel passaggio dei significati spirituali, l’esperimento sembra da connettere con Ap 2, 5, nel senso della “prima gratia” che si estende senza perdersi del tutto fino al fondo della scala, fino “a l’ultime potenze” (cfr. Par. XIII, 61-63), e che può essere ritrovata risalendo i gradi.
Tab. II.a
Inf. IV, 40-42Per tai difetti, non per altro rio,
|
Purg. XXX, 121-132, 136-138
|
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 4-5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Attende autem quod de tantis virtutibus et earum operibus commendatum confestim increpat, tum ut de tantis bonis et de tanta laude non superbiat, tum ne propter tanta bona credat se in nullo deficientem nec de aliquo increpandum, tum ut se emendet, tum ut nos propter multa bona non cessemus formidare nos esse in pluribus et gravibus defectivos et reos.
|
||
Inf. XXVII, 43-45La terra che fé già la lunga prova
|
Par. II, 97-105Tre specchi prenderai; e i due rimovi
|
|
[LSA, cap. I, Ap 2, 1 (Ia visio, Ia ecclesia)] Secundum est Christi alloquentis hanc ecclesiam et eius episcopum introductio, cum subditur (Ap 2, 1): “Hec dicit qui tenet septem stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum”. Utitur autem tentione stellarum, id est episcoporum, et perambulatione candelabrorum, id est ecclesiarum, triplici ex causa.
|
||
Scendere di grado in grado
A differenza che nell’esegesi delle altre chiese d’Asia, nell’istruzione data a Efeso, la prima di esse, Riccardo di San Vittore è utilizzato in modo insistente (cfr. Lectura super Apocalipsim e Commedia. Le norme del rispondersi, cap. 2). Ma non si tratta della solita Expositio in Apocalipsim, stavolta Olivi cambia in parte la sua consueta fonte. Riccardo di San Vittore, nel De eruditione hominis interioris (citata come Super Danielem), che Olivi segue nell’esegesi di Ap 2, 5, adduce l’esempio della statua sognata da Nabucodonosor di cui parla il profeta Daniele, che discendeva di grado in grado dall’oro all’argento al rame al ferro e infine alla terracotta (Dn 2, 31-45). L’oro del capo indica il fulgore del fervido desiderio delle cose celesti, l’argento del petto e delle braccia la certezza del retto consiglio e il retto operare, le membra di rame la simulazione, quelle di ferro l’indignazione, quelle di terracotta la fiacchezza dissoluta. L’oro designa pure la devozione, l’argento la discrezione. Nelle virtù, come si sale per gradi al culmine, così si discende a poco a poco dal più alto all’infimo livello. Nessuno diviene turpe immediatamente, ma scivolando a poco a poco a partire dalla minima negligenza iniziale. Lo si può vedere in quanti sono all’inizio della conversione gioiosi di speranza, pazienti nella tribolazione, solleciti nell’operare, studiosi nella lettura, devoti nella preghiera, aurei per la carità, e che poi nel tempo della tentazione si tirano indietro, non però subito sprofondandosi ma cadendo prima dal bene in un bene minore e di qui nel male e infine nel peggio, secondo quanto si dice in Giobbe 14, 18-19: “un monte che cade scivola a poco a poco e la terra viene consumata dall’alluvione”. Costoro, che intiepidiscono il primo fervore e raffreddano la prima carità, seguono il bene non con desiderio e diletto, ma unicamente per deliberazione, passando dall’oro, che è ottimo, all’argento, che è solo buono. Piegano il capo aureo sul petto argenteo. Se è buono possedere l’argento, è però stolto permutare con esso l’oro che si possiede. Per questo Cristo in Luca 9, 62 ammonisce che “chi mette mano all’aratro e si volge indietro non è adatto per il regno di Dio”.
Perciò al vescovo di Efeso viene minacciata una caduta totale, in mancanza di correzione: “Diversamente, vengo da te” – il presente serve ad accentuare il terrore per l’imminente avvento – “e muoverò il tuo candelabro dal suo luogo, se non farai penitenza”, cioè lo rimuoverò da me e dalla mia fede. Muovere il candelabro significa togliere il primato alla chiesa e trasferirlo ad altra (Efeso è sede metropolitana) e gettare nella morte eterna pastore e gregge.
Tre sono i motivi di tale minaccia. Il primo (proposto da Olivi) è perché la caduta dal bene maggiore a uno minore suole essere sottovalutata, mentre Dio vuole invece mostrare che il pericolo non deve essere disprezzato ma assai temuto.
In secondo luogo, come afferma Riccardo di San Vittore, perché colui che si trova in uno stato di carità inferiore a quella originaria non può a lungo restare in tale stato o nascondere la propria condizione: o ritorna presto alla carità prima, oppure precipita in situazioni ancor più deteriori. Così la buona intenzione nell’operare il bene, designata dal candelabro e dalla sua luce, si muta in mala luce e intenzione; l’argenteo operare diventa di rame, perché quello che prima veniva fatto per la verità viene poi fatto per l’umano favore. Ma ciò non può venire nascosto a lungo, perché iniziano ad apparire il ventre e le cosce, si denudano cioè la turpitudine e la malizia. Giorno dopo giorno costui diventa sempre più sozzo e vile agli occhi di quanti lo avevano prima lodato e a cui si era studiato di piacere, verso i quali ora si adira e indigna perseguitandoli con crudeltà: così il rame sonoro si muta nel ferro aspro e duro. Ma la prontezza e l’audacia nell’arrecare il male si trasforma ancora in pusillanimità e impazienza, designata dalla terracotta. Questa è la caduta lamentata da Geremia: “Gli incliti figli di Sion, rivestiti di oro fino, come sono stimati quali vasi di creta, opera delle mani di un vasaio!” (Lamentazioni 4, 2).
Il terzo motivo (ancora di Olivi) adombra la caduta della Chiesa primitiva, troppo giudaizzante e, per questo mescolare culto di Cristo e vecchia legge, intiepidita nella sua carità originaria datale con la fervida effusione dello Spirito Santo. Oppure allude al primato di Gerusalemme, mantenuto finché vi stette san Pietro, poi traslato a Roma dallo stesso Pietro, come la primogenitura di Ruben, il figlio di Giacobbe e di Lia che contaminò il letto paterno con l’ancella Bila, venne trasferita in parte a Giuda in parte a Giuseppe (Genesi 49, 3-4).
Nella discesa graduale del precipizio dall’aurea carità iniziale, ad un certo punto il rame sonoro si trasforma nel ferro aspro e duro (Riccardo di San Vittore). Si tratta di una trasformazione che il poeta prova allorché si trova “giù nel pozzo scuro”, nel fondo dell’inferno, “dove Cocito la freddura serra”. È un luogo del quale è duro parlare, a meno di non possedere “le rime aspre e chiocce”, adatte “al tristo buco / sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce”. Il poeta dichiara di non possederle, e confessa il proprio timore di non riuscire a esprimersi chiaramente: “non sanza tema a dicer mi conduco; / ché non è impresa da pigliare a gabbo / discriver fondo a tutto l’universo, / né da lingua che chiami mamma o babbo” (Inf. XXXII, 1-9, 13-14). Teme di non essere adeguato alla materia che impone una caduta di stile, e non sottovaluta il pericolo, come il vescovo di Efeso non deve prendere alla leggera la caduta verso un bene minore (Olivi).
|
■ L’immagine della statua vista in sogno da Nabucodonosor (secondo l’esegesi di Riccardo di San Vittore) passa in quella del Veglio di Creta (Inf. XIV, 106-111), e il discendere progressivo della statua dal capo di fino oro iniziale al destro piede di terracotta designa il progressivo corrompersi dell’umana virtù: il “fin oro” corrisponde all’“aurum primum” degli incliti figli di Sion, dei quali Geremia lamenta l’essere stimati quali vasi di creta. La statua discendeva “gradatim”; Minosse “cignesi con la coda tante volte / quantunque gradi vuol che giù sia messa” (Inf. V, 11-12).
■ Molti dei temi qui trattati sono racchiusi nei versi che descrivono il volo di Gerione, in groppa al quale Dante e Virgilio discendono verso Malebolge (Inf. XVII, 79-136). Per ordine di Virgilio, il fiero animale si muove e si toglie dal luogo dove stava: “Gerïon, moviti omai … Come la navicella esce di loco … sì quindi si tolse”, che è variazione da «“et movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi penitentiam egeris”, id est evellam a me et a fide mea in quo es fundata». La bestia va “in dietro in dietro” dalla riva e, quando si sente a suo agio nel muoversi, “là ’v’ era ’l petto, la coda rivolse”, muove questa tesa come anguilla “e con le branche l’aere a sé raccolse”: ad essere variato è il tema del respicere retro e del commutare tratto da Luca 9, 62 (presente a Purg. IX, 131-132 e a Par. V, 55-60). Come la barca volge la prua dove era la poppa, così Gerione muta il petto per la coda, non però l’oro per l’argento, ma l’argento (il petto e le braccia, cioè le “branche”) per la simulazione rappresentata dalla coda (che nell’esegesi riccardiana è designata con il rame). Dopo questo volgersi, il volo si svolge per gradi, lentamente, come la discesa progressiva dalla somma carità del vescovo di Efeso secondo il Vittorino: “le rote larghe, e lo scender sia poco”, come comanda Virgilio, memore del paulatim defluere di Giobbe 14, 18-19. E la fiera “sen va notando lenta lenta; / rota e discende”, senza che il poeta se ne accorga. Dante ha paura, si fa “più timido a lo stoscio”, cioè alla caduta. Si tratta di una paura maggiore di quella provata da Fetonte nel momento in cui si accorse di non poter più governare il carro del Sole, o da Icaro nel sentire sciogliersi la cera delle ali fabbricate dal padre. È la paura che giustamente si deve avere della caduta progressiva nel precipizio e che costituisce uno dei motivi dei rimproveri e delle minacce fatte alla prima chiesa. Al termine della lenta discesa, Dante vede “li gran mali / che s’appressavan da diversi canti”, come al vescovo di Efeso viene annunciato, perché ne abbia più terrore, l’imminenza del giudizio divino. Gerione pone i due poeti al fondo come un falcone che “discende lasso onde si move isnello”: un’immagine contenente la parola lapsus, che interpreta il nome della prima chiesa, calata dalla sua iniziale sollecitudine come l’uccello dal luogo dove si muove con agilità. Il porsi del falcone in modo “disdegnoso e fello”, lontano dal suo maestro che ha scontentato calando senza preda, corrisponde all’indignarsi e adirarsi di chi discende dal bene al male verso coloro ai quali si era prima studiato di piacere e che lo avevano lodato (il falconiere), ma che poi scoprono la sua viltà (l’incapacità del falcone di recare una preda).
■ Una parte di questo gruppo di temi viene parodiato nella descrizione della discesa lungo il corpo di Lucifero, che fa da scala per cui “conviensi dipartir da tanto male”, cioè dal male dell’inferno (Inf. XXXIV, 70-84; Ap 2, 2-3). Con Dante avvinghiato al collo, Virgilio prende “di tempo e loco poste”: nel fuggire il male esamina le circostanze (tema del quinto motivo di lode per il vescovo di Efeso). Quando le ali sono “aperte assai”, il poeta pagano si aggrappa alle “coste” scendendo giù “di vello in vello”. Arrivato all’anca di Lucifero, al “punto” in cui la coscia si curva e che è anche il centro della terra, Virgilio, “con fatica e con angoscia” (tema del secondo motivo di lode, il travaglio corporale), si capovolge e risale, sempre aggrappato al pelo. Ansima “com’ uom lasso”, dove l’aggettivo, che ripete il motivo della fatica, concorda con il significato del nome ‘Efeso’ (“lapsus”, ossia “caduta”, e quindi stanchezza rispetto al fervore originario). Scendere per gradi dal culmine della carità e delle virtù al fondo (“di vello in vello”), perdendole progressivamente per poi recuperarle risalendo sempre gradualmente, è tema principale della successiva esegesi di Ap 2, 5.
Dante ascrive sé stesso fra coloro i quali, secondo Riccardo di San Vittore, all’inizio della conversione sono gioiosi di speranza, pazienti nella tribolazione, solleciti nell’operare, studiosi nella lettura, devoti nella preghiera, aurei per la carità, e che poi nel tempo della tentazione si tirano indietro, non però subito sprofondandosi ma cadendo prima dal bene in un bene minore e di qui nel male e infine nel peggio, secondo quanto si dice in Giobbe 14, 18-19: “un monte che cade scivola a poco a poco e la terra viene consumata dall’alluvione”: «[…] nemo repente fit turpissimus, sed qui minima negligit paulatim defluit. Sicut enim quibusdam profectuum gradibus ad alta conscenditur, sic rursus gradatim ad ima descenditur […] Quosdam videmus in initio sue conversionis spe gaudentes […] Sed sunt multi qui in tempore temptationis recedunt, non tamen statim se in infima demergunt, sed primum de bono in minus bonum et dehinc de minus bono in malum et deinde de malo in deterius corruunt, secundum illud Iob: “Mons cadens paulatim defluit, et terra alluvione consumitur” (Jb 14, 18-19). Tales enim paulatim incipiunt a pristino desiderio tepescere et a priori fervore magis magisque deficere» – “ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto … sì ch’a bene sperar m’era cagione / di quella fiera a la gaetta pelle / l’ora del tempo e la dolce stagione … che, venendomi ’ncontro, a poco a poco / mi ripigneva là dove ’l sol tace. / Mentre ch’i’ rovinava in basso loco” (Inf. I, 36, 41-43, 59-61; cfr. Ap 3, 16). Efeso è nome che designa una fervida volontà poi rilassata (Ap 2, 1); il corpo del poeta è “lasso”, la sua volontà non mantiene le promesse iniziali: “E qual è quei che volontieri acquista, / e giugne ’l tempo che perder lo face” (Inf. I, 28, 55-56; cfr. Inf. II, 37-42, 139 dove i temi sono collazionati con l’esegesi, ad Ap 3, 1, del nome della quinta chiesa – Sardi -, interpretato da Riccardo di San Vittore come “bel principio non condotto a termine”).
|
Tab. II.b
Inf. II, 37-42, 139E qual è quei che disvuol ciò che volle
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 1; Ia visio, Va ecclesia ] Respectu vero quinti status ecclesiastici, talem se proponit quia quintus status est respectu quattuor statuum precedentium generalis, et ideo universitatem spirituum seu donorum et stellarum seu rectorum et officiorum se habere testatur, ut qualis debeat esse ipsius ordinis institutio tacite innotescat. Diciturque hec ei non quia dignus erat muneribus ipsis, sed quia ipsi et semini eius erant, si dignus esset, divinitus preparata. Unde et Ricardus dat aliam rationem quare hec ecclesia dicta est “Sardis”, id est principium pulchritudinis, quia scilicet sola initia boni non autem consumationem habuit, et solum nomen sanctitatis potius quam rem*. Supra vero fuit alia ratio data.* In Ap I, xi (PL 196, col. 742 C). |
|
Inf. V, 11-12cignesi con la coda tante volte
|
[LSA, cap. II; Ap 2, 1 (Ia ecclesia)] Et ideo prima ecclesia Asie innuitur habuisse primo fervidam caritatem et cecidisse ab eius primo fervore. Sic etiam primitiva ecclesia sub apostolis cecidit a primo fervore nimis iudaizando et zelando legalia. Unde et congrue vocatur Ephesus, id est voluntas mea in ea; vel lapsus, quia dum ferveret fuit voluntas Christi in ea ut matris in tenera et novella prole, cum vero lapsa est recte dicitur lapsus.Inf. XIV, 106-111La sua testa è di fin oro formata,
|
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Item Ricardus, super Danielem, in expositione sompnii Nabucodonosor, ostendit quod sicut statua Nabucodonosor gradatim descendebat ab auro in argentum, deinde in es ac deinde in ferrum et ultimo in testam luteam, sic aliquando gradatim descenditur a supremo virtutum ad ima. Unde ibidem ait: «Puto quod nemo repente fit turpissimus, sed qui minima negligit paulatim defluit. Sicut enim quibusdam profectuum gradibus ad alta conscenditur, sic rursus gradatim ad ima descenditur»1. Et ibidem subdit: «Quosdam videmus in initio sue conversionis spe gaudentes, in tribulatione patientes, sollicitos in opere, studiosos in lectione, devotos in oratione, qui quidem in auro operantur sicut et ille cui dictum est a Christo: “Novi opera tua et caritatem tuam” et cetera (Ap 2, 19). Sed sunt multi qui in tempore temptationis recedunt, non tamen statim se in infima demergunt, sed primum de bono in minus bonum et dehinc de minus bono in malum et deinde de malo in deterius corruunt, secundum illud Iob: “Mons cadens paulatim defluit, et terra alluvione consumitur” (Jb 14, 18-19). Tales enim paulatim incipiunt a pristino desiderio tepescere et a priori fervore magis magisque deficere2. Refrigescente namque caritate, operantur bona ex deliberatione. Maius autem est bonum sequi ex desiderio et cum magna delectatione quam ex solo consilio et deliberatione; istud quidem bonum, sed illud optimum, istud pertinet ad argentum, illud autem ad aurum. Bonum est argento huiusmodi habundare, sed non minus stultum aurum suum in argentum mutare: “mittens enim manum ad aratrum et respiciens retro non est aptus regno Dei” (Lc 9, 62). Unde sermo divinus per increpationem ferit eum qui aureum opus in argentum commutat. “Scio”, inquit, “opera tua et laborem et patientiam tuam” (Ap 2, 2): ecce brachia, ecce pectus argenteum. Sed vide quid subinfertur: “Sed habeo adversum te, quod caritatem tuam primam <r>eliquisti” (Ap 2, 4). Arguitur ergo qui adhuc bonum agit, quod caritatem primam <reliquit>, et aureum caput in pectus argenteum deflexit»3. Item infra: «In capite aureo intelligitur devotio, in membris argenteis discretio, in ereis simulatio, in ferreis indignatio, in testeis dissolutio»4. Item infra: «Quid est fulgor capitis aurei nisi fervor celestis desiderii, et claritas argentei pectoris et brachii quam certitudo recti consilii et rectitudo operis certi? Sancta itaque desideria faciunt caput aureum, recta autem consilia et opera pectus et brachium argenteum»5.
|
||
Inf. X, 118-123ché tra li avelli fiamme erano sparte,
|
Inf. XXXII, 1-9, 13-14S’ïo avessi le rime aspre e chiocce,
|
|
1. Riccardo di San Vittore, De eruditione hominis interioris, I, xxiii (PL 196, col. 1270 B).
|
||
Tab. II.c
[LSA, cap. II; Ap 2, 1 (Ia ecclesia)] Et ideo prima ecclesia Asie innuitur habuisse primo fervidam caritatem et cecidisse ab eius primo fervore. Sic etiam primitiva ecclesia sub apostolis cecidit a primo fervore nimis iudaizando et zelando legalia. Unde et congrue vocatur Ephesus, id est voluntas mea in ea; vel lapsus, quia dum ferveret fuit voluntas Christi in ea ut matris in tenera et novella prole, cum vero lapsa est recte dicitur lapsus. |
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 4-5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Attende autem quod de tantis virtutibus et earum operibus commendatum confestim increpat, tum ut de tantis bonis et de tanta laude non superbiat, tum ne propter tanta bona credat se in nullo deficientem nec de aliquo increpandum, tum ut se emendet, tum ut nos propter multa bona non cessemus formidare nos esse in pluribus et gravibus defectivos et reos. […]
|
Purg. X, 121-129O superbi cristian, miseri lassi,
|
Tab. II.d
O de li altri poeti onore e lume, [v. 82]
Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore, [vv. 85-87]
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi
lo bello stilo che m’ha fatto onore.
Questi versi di lode a Virgilio sono parodia di parte dell’esegesi dell’istruzione data a Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia, e al suo vescovo. Costui viene minacciato dello spostamento del candelabro, cioè della “translatio” del primato ad altra chiesa, come avvenne alla troppo giudaizzante e superba chiesa di Gerusalemme poi trasferita a Roma, qualora nel suo allontanarsi, discendendo in basso, non ritorni, risalendo, alla carità originaria: “Memor esto itaque unde excideris et age penitentiam et prima opera fac. Sin autem, venio tibi et movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi penitentiam egeris” (Ap 2, 5). I temi propri del primato della chiesa di Gerusalemme, onorata maestra illuminatrice e per lungo tempo sola depositaria della legge divina e del culto, si trovano nelle parole che Dante rivolge a Virgilio subito dopo l’apparizione di questi nella “diserta piaggia”: egli è “onore e lume” degli altri poeti, solo maestro da cui il fiorentino ha tolto “lo bello stilo che m’ha fatto onore”, cioè lo stile tragico o elevato (Inf. I, 82-87). Considerato che questa esegesi viene parodiata nelle parole del già superbo Oderisi da Gubbio sul passaggio dell’onore, nell’arte della miniatura (l’alluminar), da sé stesso a Franco Bolognese; del primato nella pittura da Cimabue a Giotto; della “gloria de la lingua” da l’un Guido (Guinizzelli) all’altro (Cavalcanti) e ad altri ancora (a chi fu “sesto tra cotanto senno”), non è escluso che le parole di Dante a Virgilio adombrino un’idea di onorevole “translatio” del primato dall’antico poeta al nuovo (senza, ovviamente, alcun riferimento alla superbia).
***
per una selva
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
per una selvaesta selva selvaggiaripresi via per la piaggia disertaQuando vidi costui nel gran disertose vuo’ campar d’esto loco selvaggio |
25296493 |
12, 6 → Inf. II, 62, 142 |
I |
I temi del deserto e del fuggire (soggetti a numerose variazioni), da Ap 12, 6, percorrono l’inizio del poema: Dante si volge indietro a guardare la “selva selvaggia” (“silvam … silvestrescet”), che egli ‘fugge’ ancora con l’animo (Inf. I, 5, 25-27); riposatosi un poco, riprende “via per la piaggia diserta” (vv. 28-29), vede Virgilio “nel gran diserto” (v. 64), entra “per lo cammino alto e silvestro” (Inf. II, 142); la “diserta piaggia” è pure nelle parole di Beatrice al poeta pagano (v. 62). Queste immagini corrispondono alla fuga dalla Giudea, giardino trasformato in selva, ostinata persecutrice di Cristo e della donna vestita di sole (la Vergine, la Chiesa).
Il motivo del deserto, applicato al Purgatorio, indica il luogo dove il poeta, come la donna, ascende nel nutrimento delle cose divine e si nasconde dalle tentazioni. La montagna del purgatorio possiede le caratteristiche del “deserto” della Gentilità, subentrata alla fuga dalla durezza giudaica. Se la Giudea si farà silvestre, il deserto rifiorirà nel Carmelo, pingue di grazie come lo era stata prima la Giudea, “e nella solitudine abiterà il giudizio e la giustizia” (Isaia 32, 15-16). La selva dell’Eden, foresta fiorita e campagna santa (ad Ap 6, 2 Cristo esce “in campo” su un cavallo bianco), si oppone alla “selva selvaggia” che il poeta fugge all’inizio del poema (l’ostinata Giudea persecutrice di Cristo), mentre s’ingiglia il “deserto” dei Gentili, al quale la donna (la Chiesa) vola con le due ali di una grande aquila (Ap 12, 14).
***
per una selva oscura,
che la diritta via era smarrita
Cfr. Appendice
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
per una selva oscura,
|
2
|
6, 5 → Inf. II, 6, 8 |
III |
***
che la diritta via era smarrita
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
era smarritaquanto a dir qual eranel pensier rinovaIo non so ben ridir com’ i’ v’intrai,tant’ era pien di sonno |
3461011 |
3, 2-3 → Inf. II, 64-66, 80 |
V |
Ad Ap 3, 3 il vescovo di Sardi, la quinta chiesa d’Asia, viene invitato a ricordare con la mente quale fosse la “prima grazia” e il suo stato e a conservarla facendo penitenza, cioè la grazia ricevuta da Dio e ascoltata tramite la predicazione evangelica. Da quanto gli viene detto, si deduce che costui era tanto intorpidito nell’ozio da non ricordare più il primo stato di grazia e di perfezione. Se non si ravvedrà vigilando, il giudizio divino verrà da lui come un ladro.
La rosa dei temi contenuti nell’esegesi di Ap 3, 2-3 percorre il poema con multiformi variazioni. Smarrirsi (“Ille enim dormit, qui in peccatis quiescit quasi sopitus … sic fuit otiosus et torpens, quod in mente non habuit qualiter acceperit et audierit statum et gratiam sue perfectionis, et quod ideo sic corruit”), non sapere («“et horam nescies qua veniam ad te” … qui se ipsum per negligentiam et torporem nescit»), tardare (“optat se diu in prosperitate victurum et Dei iudicium diu esse tardandum”), ripensare attentamente un primo stato di grazia, qual era («“In mente ergo habe”, id est attente recogita, “qualiter acceperis”, scilicet a Deo priorem gratiam … si digne recogitaveris gratiam tibi prius impensam et qualiter prius accepisti eandem»), udire (“illa que per predicationem audisti et per influxum gratie a Deo primitus accepisti”), vigilare (“Si ergo non vigilaveris … Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed vigilemus et sobrii simus”), serbare la fede acquisita per proprio consenso («Vel recogita qualiter per proprium consensum accepisti fidem et gratiam et statum eius … “Et serva”»): sono temi che si ritrovano alternati, intrecciati e variati in più luoghi della Commedia.
I temi si rinvengono nello smarrimento di Dante nella “selva oscura” (Inf. I, 1-12) e nella “diserta piaggia”, di cui ha udito Beatrice che teme di aver tardato nel soccorso (Inf. II, 61-66). Il torpore di cui è accusato il vescovo di Sardi è lo stesso di Dante, ignaro del suo essersi ritrovato nella selva oscura, descritto in apertura del poema: “Io non so ben ridir com’i’ v’intrai, / tant’ era pien di sonno a quel punto / che la verace via abbandonai” (Inf. I, 10-12). “Vago” è il poeta di percorrere la divina foresta dell’Eden (Purg. XXVIII, 1-2). Ma non si tratta di un cammino come quello da cui si volse Ulisse, “dove, per lui, perduto, a morir gissi” (Inf. XXVI, 84), né di uno smarrirsi nella selva (nonostante la simmetria tra “tanto, ch’io / non potea rivedere ond’ io mi ’ntrassi” e “Io non so ben ridir com’i’ v’intrai, / tant’ era pien di sonno a quel punto / che la verace via abbandonai”), perché, dopo aver visto “il temporal foco e l’etterno”, il suo arbitrio è “libero, dritto e sano” e può prendere per guida il proprio piacere (Purg. XXVII, 131), che non è più la “dulcis voluptas” delle cose mondane di cui era piena la “dolce serena” apparsagli nel secondo sogno fatto sulla montagna. |
***
Tant’ è amara che poco è più morte
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
Tant’ è amara che poco è più morte
|
7
|
4, 6 → Inf. II, 12, 108
|
R2 |
La selva oscura “tant’è amara che poco è più morte” (Inf. I, 7); è “pelago … acqua” (vv. 23-24); uscendone il poeta “si volse a retro a rimirar lo passo / che non lasciò già mai persona viva” (vv. 25-27). I motivi dell’amarezza, del pelago, dell’acqua e del patire sono propri della sede divina descritta ad Ap 4, 6: “Dinanzi alla sede era come un mare vitreo simile a cristallo”. Il mare designa l’amara e quasi infinita passione di Cristo, il lavacro battesimale, la contrizione penitenziale, la tolleranza dei martìri e il pelago della Scrittura: tutte cose vitree per purezza, chiarezza, trasparenza e cristalline per solidità. Tutte sono ordinate all’utilità della Chiesa e al culto e alla gloria della maestà di Dio. La Scrittura resta dinanzi alla Chiesa in modo che gli eletti possano in essa guardare l’aspetto del proprio volto e conoscano quali essi siano, e anche possano comprendere le cose invisibili di Dio come in uno specchio e per mezzo di esso. Questi temi, compiutamente esaminati altrove, sono appropriati al conte Ugolino (Inf. XXXIII, 47-48, 51, 56-57), si ritrovano nell’Eden (Purg. XXIX, 67-69; XXX, 73, 91-92) e nel “pelago … pan de li angeli” in principio di Par. II.
|
Un altro attributo della Scrittura è di essere assimilata al collirio. Il tema è introdotto ad Ap 3, 18, nel corso dell’istruzione data alla chiesa di Laodicea, la settima delle chiese d’Asia. Il collirio, che all’inizio punge gli occhi in modo amaro e provoca le lacrime e le fa uscire, rendendo però alla fine chiara la vista, designa l’amara compunzione dei propri peccati. Così la Scrittura è come il collirio, perché il precetto del Signore è lucente e illumina gli occhi. Temi, esaminati altrove, che fasciano Beatrice (Inf. II, 116; Purg. XXVII, 136-137; XXX, 141) e Dante (Inf. I, 91-93; Purg. I, 127). |
Tab. III
Peter of John Olivi. On the Bible. Principia quinque in Sacram Scripturam (ed. D. Flood – G. Gál), III, De doctrina Scripturae, p. 93: 46. De quarta apertione potest exponi quod in Psalmo (77, 23-25) legitur: Ianuas caeli aperuit, et pluit illis manna ad manducandum. Panem angelorum manducavit homo. In hac enim apertione, in qua sentitur abundanter manna absconditum et refectio Dei et angelorum et deliciae paradisi, quidquid occurrit in Scripturis quod sapiat iucunditatem et felicitatem carnalem, confestim transfertur a spiritu in dulcorem caelestem. |
Par. II, 1-15O voi che siete in piccioletta barca,
|
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 6 (radix IIe visionis)] “Et in conspectu sedis”, scilicet erat, “tamquam mare vitreum simile cristallo”. Per mare designatur Christi amara et quasi infinita passio et lavacrum baptismale et penitentialis contritio et martiriorum perpessio et pelagus sacre scripture. Quodlibet enim horum est puritate et claritate et pervia perspicuitate vitreum et soliditate cristallinum. Hec omnia etiam sunt ad utilitatem ecclesie ordinata et ad cultum et gloriam maiestatis Dei. Scriptura etiam ideo manet in conspectu ecclesie, ut in ea valeant electi species facierum suarum prospicere ad cognoscendum se quales sint, et etiam ut in ipsa tamquam in speculo et per speculum possint intelligere invisibilia Dei.
|
||
Inf. XXXIII, 43-58Già eran desti, e l’ora s’appressava
|
Purg. XXIX, 67-69, 91-93L’acqua imprendëa dal sinistro fianco,
|
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 18 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Deinde monet <quartum> defectum expelli, subdens: “et collirio unge oculos tuos ut videas”. Collirium est unctio facta ad purgandum feces oculorum, et est in principio communiter oculorum pungitivum et amaricativum et lacrimarum provocativum et emissivum sed tandem visus clarificativum, et ideo per ipsum designatur amara compunctio de suis peccatis. Hec enim continue tenet aspectum et sensum cordis intime reflexum super se et super suos defectus, et ideo includit et auget primam illuminationem cordis, que est cognitio sui et suorum defectuum includens timoratam considerationem iudiciorum Dei ac sue reverende et tremende simul et piissime maiestatis. Hec autem directe contrariatur presumptioni premisse. Per collirium etiam designatur scriptura sacra: preceptum enim Domini est lucidum illuminans oculos. |
||
Inf. II, 79-81, 115-117; Purg. XXVII, 136-137; XXX, 139-145tanto m’aggrada il tuo comandamento,
|
Purg. I, 94-99, 121-129Va dunque, e fa che tu costui ricinghe
|
|
***
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai |
8 |
9, 4 |
V |
Nella selva Dante trova del bene (Inf. I, 8); non gli nuoce “lo passo / che non lasciò già mai persona viva”. Glielo ricorda Virgilio al momento di lasciare la quarta bolgia (Inf. XX, 128-129).
Alle locuste, che escono dal fumoso pozzo dell’abisso aperto al suono della quinta tromba (Ap 9, 1-2), viene detto di non danneggiare né fieno né verde erba né alberi, ma soltanto gli uomini che non hanno il sigillo di Dio sulla fronte (Ap 9, 4). Con questa proibizione, diffusa su tutte e tre le tentazioni del quinto periodo della storia della Chiesa, si intende che Dio non permette che i semplici, i quali conservano l’umiltà e il verdeggiare della fede (lasciando ai chierici le dispute su di essa) e di una vita onesta e pia (il fieno e l’erba), e i perfetti e più solidi che danno grandi frutti (gli alberi) siano lesi, a meno che non intervenga un loro pravo consenso al male. La tentazione non potrà loro nuocere, anzi gli gioverà. Tale è la condizione di Dante. Le parole di Brunetto Latini “ma lungi fia dal becco l’erba” è un esempio di trasposizione poetica di questo tema, riferito al sottrarsi di Dante dal popolo fiorentino, di parte bianca o nera, fattosi a lui nemico per il suo bene operare. Il poeta è in questo caso erba e albero, visto che il suo maestro sentenzia che “tra li lazzi sorbi / si disconvien fruttare al dolce fico” (Inf. XV, 64-66, 70-72).
I temi sono appropriati a Virgilio, al quale non nuocciono i Malebranche (il poeta pagano ha il sigillo divino sulla fronte: Inf. XXI, 66, 72; l’esegesi si intreccia con quella della “signatio” ad Ap 7, 3); ad Enrico III d’Inghilterra (“il re de la semplice vita”: Purg. VII, 130-131); a Dante, baccelliere di fronte al maestro san Pietro che lo interroga sulla fede (Par. XXIV, 46-48), agnello nell’ovile fiorentino “nimico ai lupi che gli danno guerra”, ma al quale il principe degli apostoli ha ‘girato la fronte’ (Par. XXV, 5-6, 10-12; cfr. Ap 7, 3); a Beatrice, “donna onesta che permane / di sé sicura”, ma si fa timida e arrossisce ad ascoltare l’invettiva di san Pietro contro il papato corrotto (Par. XXVII, 31-33).
Tab. IV
|
Inf. XX, 127-129e già iernotte fu la luna tonda:
|
|
[LSA, cap. IX, Ap 9, 4 (IIIa visio, Va tuba)]
|
||
Inf. XV, 64-66, 70-72ti si farà, per tuo ben far, nimico;
|
Purg. VII, 130-132Vedete il re de la semplice vita
|
|
***
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte |
9 |
3, 8 |
VI |
Il riferire ad altri partecipa del tema della porta aperta data alla sesta chiesa (Ap 3, 8), che equivale alla libertà di parlare. Di questa porta aperta dice san Paolo ai Corinzi, citato da Olivi nell’esegesi: “Mi fermerò a Efeso, perché mi si è aperta una porta grande ed evidente” (1 Cor 16, 8-9), e ai Colossesi: “Pregate, figli, per noi, perché Dio apra la porta della predicazione e possiamo parlare del mistero di Cristo” (Col 4, 3). E negli Atti degli Apostoli si dice che Paolo e Barnaba, tornati ad Antiochia, “riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto alle genti la porta della fede” (Ac 14, 26). Il tema della porta aperta al libero parlare subisce importanti sviluppi.
***
Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giuntocosì l’animo mio, ch’ancor fuggivaacciò ch’io fugga questo male e peggiosì ch’io veggia la porta di san Pietro |
1325132134 |
6, 166, 15-17 → Inf. II, 110 |
VI |
che m’avea di paura il cor compunto |
15 |
8, 5 |
R3 |
All’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12-17; un esame più approfondito è stato condotto altrove) un grande terremoto – interpretato sia come eventi naturali che come sovvertimenti politici (un passo simmetrico è, fra gli altri, nell’esegesi di Ap 8, 5) – provocherà terrore negli uomini senza distinzione di stirpe o di grado, le coscienze saranno sconvolte e si convertiranno o si induriranno maggiormente. Quanti saranno indotti alla penitenza si rifugeranno fra i sassi e le spelonche dei monti petrosi – che si faranno pietosi, condiscendenti e misericordiosi -, cioè chiederanno ausilio ai santi fermi nella fede fuggendo l’irato volto di Cristo giudice: «Dixeruntque “montibus et petris” (Ap 6, 16), id est sanctis sublimibus et firmis in fide: “Cadite super nos”, per piam scilicet affectionem et condescensionem, “et abscondite nos”, per vestram scilicet intercessionem». Cristo stesso predisse mali simili, dicendo: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me ma su voi stesse” (Luca 23, 28), e ancora: “allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci” (ibid., 23, 30). Guerre e sedizioni, all’apertura del sesto sigillo, sovvertiranno le isole e i monti, cioè le città e i regni (Ap 6, 14); le isole si muoveranno e i monti saranno traslati (Ap 16, 20); verrà cioè sconvolto, in modo imprevedibile, quel che vi è di più stabile e adatto all’umana quiete in mare, oppure di più sicuro ed eminente in terra.
La paura, il fuggire ai monti e ai colli, la compunzione provocata dal terremoto percorrono Inf. I, 13-27: «(Ap 6, 14-17) fuerunt vehementer perterriti … Ex ipso etiam timore fugient et abscondent se “in speluncis” et inter saxa montium … “Tunc incipient dicere montibus: Cadite super nos, et collibus : Cooperite nos” [Lc 23, 30] … (Ap 8, 5) “Et terremotus” … mota sunt corda hominum ad compunctionem, et mutata vita priori conversi sunt ad Christum … – Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto, / là dove terminava quella valle / che m’avea di paura il cor compunto … Allor fu la paura un poco queta … così l’animo mio, ch’ancor fuggiva … [vv. 77-78] perché non sali il dilettoso monte / ch’è principio e cagion di tutta gioia?» (cfr. infra). Il fuggire alle pietre viene recitato da Dante stesso in Inf. I, 130-135, nel chiedere a Virgilio di condurlo alla porta di san Pietro (la porta del Purgatorio), “acciò ch’io fugga questo male e peggio”. |
In tutt’altra situazione, Farinata che muove il capo sospirando, mentre prima “non mosse collo né piegò sua costa”, è indice di un terremoto interiore nella “statua” che, come scrisse De Sanctis, si fa uomo (Inf. X, 73-75, 88; cfr. Lectura Dantis, Inferno X, pp. 82-89).
Tab. V
[LSA, cap. VI, Ap 6, 15-17 (IIa visio, apertio VIi sigilli, IIum initium)] Rursus viris evangelicis in sui adventus primordio zelantibus et predicantibus fervide contra ista, evidentius inclaruerunt omnibus mala predicta, ipsisque alte comminantibus et preconizantibus iram et adventum iudicis in ianua esse, multi “reges” et “principes” et “divites” et pauperes fuerunt vehementer perterriti, propter quod “absconderunt se in speluncis et petris montium” (Ap 6, 15), id est in secreta et firma conversatione sublimium sanctorum recurrendo, scilicet humiliter, ad eorum refugium. Dixeruntque “montibus et petris” (Ap 6, 16), id est sanctis sublimibus et firmis in fide: “Cadite super nos”, per piam scilicet affectionem et condescensionem, “et abscondite nos”, per vestram scilicet intercessionem, “a facie”, id est ab animadversione, “sedentis super tronum”, id est deitatis regnantis, “et ab ira Agni”, id est Christi hominis. “Et quis poterit stare” (Ap 6, 17), scilicet coram sic terribili et irata facie tanti iudicis, quasi dicat: vix etiam ipsi iusti, quanto magis nos impii?
|
[Ap 6, 13-14 (IIIum initium)] Quantum etiam ad tertium initium sexte apertionis, fiet utique grandis terremotus subvertens fidem plurium contra evangelice regule veritatem et contra spiritum vite eius, et ideo tunc “sol” plenius fiet “niger”, et “luna” crudelis ut “sanguis” tam in electos quam in se invicem per seditiones et bella. Unde suscitationem spiritus preibunt in ecclesia quedam bella subvertentia insulas et montes (cfr. Ap 6, 14), id est urbes et regna. […] propter que omnia plures non solum boni, sed etiam mali fortiter perterrebuntur non solum a visu et perpessione tantorum malorum, sed etiam suspicione et expectatione longe maiorum (cfr. Ap 6, 13). Tunc etiam plures signabuntur ad militiam spiritalem, quamvis sint pauci respectu multitudinis reproborum.
|
|
[Ap 6, 14-17 (IVum initium)] Tunc etiam montes, id est regna ecclesie, et “insule”, id est monasteria et magne ecclesie in hoc mundo quasi in solo seu mari site, movebuntur “de locis suis” (Ap 6, 14), id est subvertentur et eorum populi in mortem vel in captivitatem ducentur. Tunc etiam, tam propter illud temporale exterminium quod sibi a Dei iudicio velint nolint sentient supervenisse, quam propter desperatum timorem iudicii eterni eis post mortem superventuri, sic erunt omnes, tam maiores quam medii et minores, horribiliter atoniti et perterriti quod preeligerent montes et saxa repente cadere super eos. Ex ipso etiam timore fugient et abscondent se “in speluncis” et inter saxa montium (cfr. Ap 6, 15-17). Est enim tunc nova Babilon sic iudicanda sicut fuit carnalis Iherusalem, quia Christum non recepit, immo reprobavit et crucifixit. Unde Luche XXII<I>° predicit ei Christus mala consimilia istis, dicens (Lc 23, 28): “Filie Iherusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete”, et paulo post (23, 30): “Tunc incipient dicere montibus: Cadite super nos, et collibus: Cooperite nos”.
|
Inf. X, 73-75Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta
|
|
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 5 (radix IIIe visionis)] “Et terremotus”, quia visis tot signis et miraculis et sanctitatis exemplis, et auditis tam altis tamque discretis et fulgurativis Dei eloquiis, mota sunt corda hominum ad compunctionem, et mutata vita priori conversi sunt ad Christum; in pertinacibus vero, factus est terremotus peioris subversionis et iracunde commotionis et persecutionis fidei Christi et doctorum eius. Possunt etiam predicta de missione ignis et de tonitruis et terremot<u> referri ad ignitam predicationem Christi que magnum terremotum causavit in tota Iudea, unde Luche XXIII° (Lc 23, 5) principes sacerdotum contra ipsum allegant: “Commovet populum docens per universam Iudeam” et cetera. Usquequo enim Christus baptizatus est et predicavit, non apparuit implevisse de igne altaris turibulum sue humanitatis. |
||
***
Allor fu la paura un poco queta
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
Allor fu la paura un poco quetasi volse a retro a rimirar lo passo |
1926 |
Not. I |
VII |
Il settimo e ultimo stato della storia della Chiesa si svolge parte in questa vita, parte nell’altra. In questa vita consiste nella “quieta et mira participatio future glorie”, come se si vedesse la Gerusalemme celeste discendere in terra, nel pregustare in questo secolo la vita eterna poco prima della fine del mondo; nell’altra corrisponde alla resurrezione dei corpi, alla glorificazione dei santi e alla consumazione finale di tutte le cose. Può anche essere inteso come il periodo in cui le anime sante stanno in quiete prima della resurrezione dei loro corpi (in questo senso coincide con la situazione del Paradiso), e in tal modo la settima età inizia dal sabato o dalla quiete dell’anima di Cristo e la resurrezione costituisce l’ottava età, concorde con il mistero per cui Cristo risorse l’ottavo giorno. Nel primo senso, il settimo stato inizia in questa vita con la morte del grande Anticristo e nell’altra con il giudizio finale (prologo, Notabili I, VIII).
Se il sesto stato è “cristiforme” nella vita, il settimo è “deiforme” nella gloria che pregusta. Al sesto appartiene il frutto della carità, al settimo il gusto della felicità (prologo, Notabile I) e la pace (Notabile XIII). Come in ciascuno stato esiste qualcosa di cristiforme, che lo apparenta al sesto, così in qualsiasi stato è comunque presente un quietarsi dello spirito in Dio e un certo gusto di Dio, e ciascun periodo ha un proprio momento di pace dopo la notte trascorsa nelle avversità (prologo, Notabile III).
Il tema del gustare in questa vita la pace futura definisce san Bernardo, “colui che ’n questo mondo, / contemplando, gustò di quella pace’” (Par. XXXI, 109-111; da notare il ‘mirare’ appropriato al poeta). Anche Arnaut Daniel, che purga nel fuoco la lussuria, pregusta in qualche modo la gloria futura: “e vei jausen lo joi qu’esper, denan” (Purg. XXVI, 144).
La “quietatio” dopo l’avversità della notte è nella paura di Dante, “un poco queta” all’uscita della selva oscura, dinanzi al colle illuminato dal sole, dopo “la notte ch’i’ passai con tanta pieta” (Inf. I, 19-21; da notare il ‘rimirare’ la selva al v. 26, proprio del poeta). |
Altri luoghi sono esposti e commentati altrove.
Tab. VI
[LSA, prologus, Notabile I] Septimus vero (status), prout spectat ad vitam istam, est quedam quieta et mira participatio future glorie ac si celestis Iherusalem videatur descendisse in terra<m>; prout tamen spectat ad aliam vitam, est status generalis resurrectionis et glorificationis sanctorum et finalis consumationis omnium. Potest etiam sumi pro beata quiete sanctarum animarum ante resumptionem suorum corporum, et hoc modo est idem quod septima etas inchoata a sabbato seu quiete anime Christi, et hoc modo generalis resurrectio stat pro octava, in cuius misterium Christus resurrexit die octavo. […]
|
||
|
Par. XXXI, 109-111tal era io mirando la vivace
|
|
***
che nel lago del cor m’era ’ndurata
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
che nel lago del cor m’era ’nduratapoi che ’l superbo Ilïón fu combustoaiutami da lei, famoso saggio |
207589 |
8, 7(5, 1); 8, 78, 7 |
IIV – II |
Il tema della durezza giudaica percorre tutta l’esegesi della prima tromba (Ap 8, 7; terza visione: il passo è esposto compiutamente altrove). Il primo angelo, cioè l’ordine dei dottori del primo stato, suonò la tromba predicando nella Giudea. Come conseguenza della dottrina dottorale sui pertinaci Giudei, “fu fatta grandine mista a fuoco e a sangue e fu mandata a terra”. La “grandine” designa la durezza e la pertinacia dei Giudei, induriti e congelati ancor più per la predicazione di Cristo, come il cuore di Faraone si fece più duro alle parole di Mosè. Il “fuoco” indica lo zelo e la fiamma della maligna ira e invidia con cui arsero in modo acre contro Cristo e i suoi; il “sangue” significa la persecuzione ad essi inflitta. La “terra” è la Giudea la quale, come la terra abitabile venne da Dio separata dal mare e liberata dalle acque affinché per utilità dell’uomo potesse dare erbe e alberi fruttiferi, così venne separata dal mare delle nazioni e delle genti infedeli affinché gli uomini potessero dedicarsi in quiete al culto divino e produrre i frutti delle buone opere ed essere ivi semplici nel bene come erbe verdeggianti e perfetti come alberi grandi, solidi e fruttuosi. Il miscuglio di grandine, fuoco e sangue “fu mandato a terra” dall’alto zelo di Dio e della sua legge, cadendo con forte impeto. Si può anche intendere che fu conseguenza della celeste dottrina e dell’opera di Cristo.
Uscito fuori della selva, aspra e dura come il fondo dell’inferno, Dante scorge il colle illuminato dal sole, e questo gli quieta la paura che aveva provato durante la precedente notte di angoscia. Il confronto con gli sviluppi dell’esegesi di Ap 8, 7 – “sicut ad Moysi verba et signa Pharao fortius induravit cor suum” – impone di considerare con attenzione la variante, scartata dal Petrocchi perché minoritaria nelle testimonianze, “che nel lago del cor m’era (i)ndurata”, rispetto a “durata” (“perseverata” come spiega Boccaccio), nel senso che la paura gli si era ghiacciata dentro al cuore (Inf. I, 19-21; ma cfr. ora l’edizione di Giorgio Inglese). Come il “lago del cor” di Dante smarrito nella selva, così Cocito, “loco onde parlare è duro”, è “un lago che per gelo / avea di vetro e non d’acqua sembiante” (Inf. XXXII, 23-24). |
Al suono della prima tromba (Ap 8, 7) fu combusta la terza parte della terra e degli alberi, e ogni erba verde (questa, secondo Gioacchino, designa i lapsi, quanti cioè si sono volti indietro e vengono rimproverati nell’istruzione data alla prima chiesa). I temi di questa esegesi sono parodiati nel primo presentarsi di Virgilio – “poi che ’l superbo Ilïón fu combusto” (Inf. I, 75) -; si ritrovano, con variazioni, in Pier della Vigna (Inf. XIII, 32, 40); nello ‘sviare’ del carro del Sole guidato da Fetonte (Inf. XXIX, 118); nel primo girone della montagna, dove si purgano i superbi, in un contesto dedicato alla parodia semantica dei motivi propri del primo stato della Chiesa (Purg. X, 121, 123; XI, 15: prima chiesa; XI, 92, 115-117: prima tromba).
Tab. VII.a
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7 (IIIa visio, Ia tuba)] […] Per “terram” autem significatur hic Iudea, quia sicut terra habitabilis fuit segregata a mari et discooperta aquis, ut posset homo habitare in ea et ut ipsa ad usum hominis posset fructificare et herbas et arbores fructiferas ferre, sic Deus mare infidelium nationum et gentium separaverat a terra et plebe Iudeorum, ut quiete colerent Deum et facerent fructum bonorum operum, et ut essent ibi simplices in bono virentes ut herbe, et perfecti essent ut arbores grandes <et> solide et fructuose. […] Quantum autem malum fecerint in Iudeis predicta ostendit subdens: “Et tertia pars terre combusta est, et tertia pars arborum concremata est, et omne fenum viride combustum est”. […]
|
||
Inf. XIII, 7-9, 31-33, 40-44
|
Purg. XXIX, 115-120Non che Roma di carro così bello
|
|
Secondo una delle interpretazioni proposte ad Ap 8, 7, nessuno che non sia fermo nella fede e nella carità come la terra o un albero può vincere quella che fu la tentazione giudaica contro Cristo, forte di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’ della Sinagoga e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo. A questa tentazione non può resistere chi è fragile e instabile come l’erba che inaridisce.
Equivale alla tentazione giudaica contro Cristo, forte di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’, e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo, il ritenere, come fanno gli stolti, Giraut de Bornelh (“quel di Lemosì”) superiore nella poesia ad Arnaut Daniel, che invece soverchiò tutti nei versi d’amore e nelle prose dei romanzi. Le parole con cui, nel settimo e ultimo girone del purgatorio, Guido Guinizzelli assegna il vero primato (Purg. XXVI, 115-126; cfr. Purg. VI, 4: “con l’altro se ne va tutta la gente”) sono parodia dei temi dell’esegesi di Ap 8, 7 (prima tromba) collazionata con quella di Ap 13, 18 (sesta guerra), in cui la tentazione causata nei santi dall’Anticristo mistico, nel momento in cui sale la bestia dalla terra, sta nell’avere questa dalla sua la sentenza dei maestri e dei dottori e l’opinione della moltitudine cui appare stolto, insano ed eretico contraddire. Quanto avvenuto con Giraut de Bornelh, considerato a torto il più grande dei trovatori, è capitato anche con Guittone d’Arezzo, al quale “molti antichi” (lo stesso aggettivo dei sapienti della Sinagoga) hanno dato pregio esclusivo, “di grido in grido” fino a che la verità è apparsa evidente con poeti a lui superiori. La poesia di Guittone sta al dolce stil novo come la Sinagoga alla Chiesa di Cristo, o come la Chiesa del quinto stato a quella del sesto (che ha il primato sul terzo stato generale del mondo, appropriato allo Spirito; cfr. le parole di Oderisi da Gubbio) e quanti “a voce più ch’al ver drizzan li volti” sono assimilati ai falsi profeti che fanno adorare l’immagine della bestia, il falso papa al quale dicono bisogna credere più che a Cristo e al Vangelo.
Incidentalmente si può notare come i motivi della malignità, del mal frutto, dell’essere antichi, provenienti dall’esegesi della prima tromba e della terza parte della terra combusta (Ap 8, 7), uniti a quello della durezza del cuore fatto di pietra, sempre applicato ai Giudei ad Ap 4, 1, siano appropriati ai Fiorentini nelle parole di Brunetto Latini: “Ma quello ingrato popolo maligno / che discese di Fiesole ab antico, / e tiene ancor del monte e del macigno (la “lapidea durities sensus obtusi” da Ap 4, 1)”, “lazzi sorbi” fra i quali “si disconvien fruttare al dolce fico” (Inf. XV, 61-66).
La parodia incide in senso positivo fasciando Virgilio, “famoso saggio”, al quale si rivolge per aiuto Dante (Inf. I, 89); sul poeta pagano sono stati travasati nei versi precedenti temi dall’esegesi della prima chiesa (vv. 82, 85-87). |
Tab. VII.b
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7 (IIIa visio, Ia tuba)] Vel per hanc tertiam partem terre potest intelligi littera cerimonialium legum et figuralium promissionum et documentorum et prophetarum et totius veteris testamenti, que quidem in spiritualibus per spiritalem intelligentiam sunt “terra” bona et fructifera, sed in malignis Iudeis per impium zelum et per carnalem intellectum est “combusta”, id est fructu et virtute vite et veritatis evacuata et in errorem mortiferum transducta. […]
|
||
Inf. XV, 61-66Ma quello ingrato popolo maligno
|
Purg. VI, 4-6con l’altro se ne va tutta la gente;
|
|
[→] Secund<o> universalis sententie omnium magistrorum et doctorum suorum, et etiam totius multitudinis, seu communis opinionis omnium, cui contradicere videbitur stultum et insanum et etiam hereticum.
|
||
***
la notte ch’i’ passai con tanta pieta
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
la notte ch’i’ passai con tanta pieta
|
2128313596
37
|
7, 2 → Inf. II, 47, 27, 27, 1 → Inf. II, 62, 957, 1
7, 2
|
VI |
■ Dante, alter Iohannes, si fregia anche delle prerogative dell’angelo che sale da oriente (“ascendens ab ortu solis”) all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 2), che Olivi identifica in Francesco. Tema così importante, che lo si ritrova già nei primi versi del poema. Segna la salita di Dante al “dilettoso monte”, “quasi al cominciar de l’erta”, lì dove la lonza gli impedisce il cammino: l’ora è il “principio del mattino” («“ascendens ab ortu solis”, id est ab illa vita quam Christus sol mundi in suo “ortu”, id est in primo suo adventu, attulit nobis. Nam decem umbratiles lineas orologii Acaz Christus in Francisco reascendit usque ad illud mane in quo Christus est ortus [4 Rg 20, 9-11; Is 38, 8]»); il sole sorge (“montava ’n sù” rende “ascendens”) nel segno primaverile dell’Ariete, costellazione che si riteneva occupasse anche al momento della creazione, “quando l’amor divino / mosse di prima quelle cose belle” (Inf. I, 37-40).
|
L’angelo del sesto sigillo, ascendendo (Ap 7, 2), rimuove un impedimento (Ap 7, 1). Questo è frapposto dai quattro angeli che stanno sopra i quattro angoli della terra: designano i demoni i quali, dopo il giudizio e lo sterminio della Chiesa carnale intervenuti con il terremoto nell’apertura del sigillo (Ap 6, 12-17), cercano di impedire ai quattro venti di soffiare, cioè di impedire la predicazione della fede, la conversione delle genti e anche il conservarsi dei fedeli nella fede già accolta. Possono anche designare gli angeli buoni, che trattengono il soffiare della grazia per esigenza della giustizia divina. In quanto demoni, prestano panno a Caronte, Minosse, Cerbero, Pluto (cfr. infra).
Rimosso l’impedimento, il segno è posto sulla fronte, non vergognosa ma liberamente magnanima, degli eletti amici di Dio, difensori della fede fino al martirio da lui conosciuti per nome e ascritti alla più alta milizia dei baroni, dei decurioni, dei cavalieri che si distingue da quella volgare dei fanti (Ap 7, 3-4). Questa esegesi, nella quale il sesto stato corrisponde agli ultimi sei anni della costruzione del Tempio dopo la cattività in Babilonia, è una sacra sinfonia militare i cui temi trascorrono in più luoghi della Commedia: dalla “signatio” poetica di Dante, amico di Beatrice e “sesto tra cotanto senno” nella schiera dei sommi poeti del Limbo, alla “signatio” apostolica nelle virtù teologali di fronte a Pietro, Giacomo e Giovanni; dall’impossibile amicizia con Dio di Francesca e Paolo (anch’essi in una schiera) alle famiglie fiorentine, menzionate da Cacciaguida, che portano la “bella insegna” del marchese Ugo di Toscana, assunte a una milizia più alta rispetto a Giano della Bella, l’autore dei famosi Ordinamenti di giustizia (1293) anch’egli di essa insignito (la quale “fascia col fregio”), ma che oggi si raduna col popolo, corrispondente alla volgare e pedestre milizia che viene dopo i segnati. Questi eletti ‘sesti’ amati da Dio sono lo sviluppo sacro di coloro (De vulgari eloquentia, II, iv, 10-11) che Virgilio, nel sesto dell’Eneide, definisce “Dei dilectos”, i poeti tragici innalzati al cielo per ardente virtù (Aen., VI, 129-131: “Pauci, quos aequus amavit / Iuppiter”), designati dall’“astripeta aquila”.
Il tema della “signatio” sulla fronte degli eletti e amici di Dio, difensori pubblici della fede, si mostra nel primo canto del poema, nella “vergognosa fronte” con cui Dante risponde a Virgilio (Inf. I, 81; cfr. III, 79). Anche l’espressione di Virgilio al v. 129 – “oh felice colui cu’ ivi elegge!” – fa parte del gruppo tematico.
Il tema dell’amicizia divina contrapposto alla volgare milizia è presente nelle accorate parole con cui Lucia invita Beatrice a soccorrere Dante, “ch’uscì per te de la volgare schiera” dei poeti (Inf. II, 103-105), che la stessa Beatrice, rivolgendosi a Virgilio, definisce “l’amico mio, e non de la ventura” (v. 61; da notare, nello stesso canto [vv. 44-45], il contrasto tra il “magnanimo” Virgilio e la “viltade” da cui è offesa l’anima di Dante). Virgilio, mosso da Beatrice, rimuove l’“impedimento” frapposto dalla lupa a Dante nel salire il “dilettoso monte”; svolge anch’egli in qualche modo la funzione dell’angelo del sesto sigillo.
Tab. VIII.a
LSA, cap. VII, [Ap 7, 1-3 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] “Post hec vidi” et cetera (Ap 7, 1). Hic ostenditur quomodo, post prefatum iudicium et exterminium carnalis ecclesie, nitentur demones et homines impii impedire predicationem fidei et conversionem gentium ad fidem et etiam conservationem fidelium in fide iam suscepta. Unde ait: “Post hec”, id est post predictum iudicium, “vidi quattuor angelos stantes super quattuor angulos terre”.
|
|
Inf. I, 34-36, 94-96; II, 61-63, 94-96; III, 94-98e non mi si partia dinanzi al volto,
|
Inf. V, 4, 21-24; VI, 28-33; VII, 3-6Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia … … Minosse
|
1 In Ap II, ix (PL 196, col. 770 C).2 Expositio, pars II, f. 120va. |
3 Expositio, pars II, ff. 120vb-121ra.4 In Ap II, ix (PL 196, col. 771 B). |
L’esegesi dell’angelo del sesto sigillo, che rimuove l’impedimento frapposto dai quattro angeli malvagi quietandoli, viene appropriata a Virgilio che rimuove gli impedimenti posti dalla lupa e da quattro antichi demoni (Caronte, Minosse, Cerbero, Pluto). Cfr. infra. Da notare la corrispondenza numerica delle terzine nei primi due canti del poema (cfr. altri esempi: Ap 5, 8; 7, 3-4; 7, 13-14). |
|
Inf. I, 94-96 [32]
|
Inf. II, 94-96
|
Tab. VIII.b
[LSA, cap. VI, Ap 7, 2 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Sequitur tertia pars, scilicet prohibitio predicti impedimenti per subscriptum angelum facta (Ap 7, 2): “Et vidi alterum angelum”, alterum scilicet a quattuor iam premissis, et alterum non tantum in persona sed etiam in virtute et officio. Nam illi mali et impeditivi boni, iste vero in utroque contrarius eis. De hoc dicit hic Ioachim: Angelus iste est ille, quem Christus per concordiam respicit, futurus in principio tertii status. «Ascendet autem “ab ortu solis”, quia ut casus presentis vite non timeatur, predicabit certis indiciis veri solis adventum et vicinam iustorum omnium resurrectionem. Ad cuius clamoris virtutem adversarie potestates quiescent, et gaudium quod in sexta parte libri inter casum Babilonis et inter prelium bestie et regum terre contra sedentem in equo albo demonstratur futurum permittent fieri vel inviti, quatinus fideles acies, signo crucis instructe ad complendum numerum electorum, quod reliquum erit prelii expedire percurrant. |
||
Sicut et Petrus, post piscationem centum quinquaginta trium piscium magnorum, vocatus est ad prandium Christi sed mox, peracto prandio, audivit Christum dicentem sibi: “Sequere me”, scilicet ad crucem (cfr. Jo 21, 3-19). Nox enim illa in qua frustra usque mane piscatus est Petrus designat tribulationem primam, prandium autem quod post piscationem celebratum est mane designat gaudium quod noctis huius <tribulationem> sequetur, quo consumato mox incipiet prelium illud magnum de quo in sexta parte libri, capitulo scilicet XIX°, dicitur: “Vidi bestiam et reges terre et exercitus eorum congregatos ad faciendum prelium cum illo, qui sedebat in equo, et cum exercitu eius” (Ap 19, 19)». Usque huc Ioachim*.
|
|
|
[→] Sequitur: “habentem signum Dei vivi”, tam scilicet in stigmatibus sibi a Christo impressis quam in tota vita interiori et exteriori, et in statu professionis et in concordia temporis et officii singulariter Christo assimilatum et eius similitudini consignatum. […] Signatio hec (Ap 7, 3) fit per administrationem fidei et caritatis et per assumptionem ac professionem sacramentorum Christi distinctivam fidelium ab infidelibus. In hac etiam signatione includitur fides et devotio ad Christi passionem adorandam et imitandam et exaltandam. Fit autem “in frontibus”, quando signatis datur constans et magnanimis libertas ad Christi fidem publice confitendam et observandam et predicandam et defendendam. In fronte enim apparet signum audacie et strenuitatis vel formidolositatis et inhertie, et signum gloriationis vel erubescentie. […] Igitur per hunc numerum (Ap 7, 4), prout est certus et diffinitus, designatur singularis dignitas signatorum. Hii enim, qui sub certo nomine et numero et scriptura a regibus ad suam militiam vel curiam aut ad sua grandia vel dona ascribuntur, sunt digniores ceteris, qui absque scriptura et numero ad vulgarem et pedestrem militiam vel familiam eliguntur. Sicut etiam Deus, in signum familiarissime notitie et amicitie, Exodi XXXIII° (Ex 33, 17) dicit Moysi: “Novi te ex nomine”, cum tamen omnes electos suos communiter noverit ut amicos et hoc modo solos reprobos dicatur nescire, sic per hanc specialem et prefixam numerationem et consignationem designatur familiarior signatio et notitia et amicitia apud Deum. |
||
[LSA, cap. III, Ap 3, 10-11 (Ia visio, VIa ecclesia)] Hoc quod subditur, scilicet “Quoniam servasti” et cetera (Ap 3, 10), refert Ricardus tam ad verbum premissum quam ad subsequens, ut reddatur hic ratio propter quam dilectus est a Deo et etiam servatur a temptatione ventura. Dicit ergo: “Quoniam servasti verbum patientie mee”. Ricardus: «“verbum”, id est preceptum, “servasti” dum adversa propter me patienter sustinuisti»*, id est ideo dilexi te et ideo servabo te a temptatione ventura, quia tu patienter sustinuisti persecutiones ut servares fidem meam et mea precepta, seu ut servares patientiam quam ego precepi et in me habui tamquam exemplarem omnis patientie vestre. Vel “verbum patientie” Christi est comminatio seu predictio temptationis future, quam Deus patienter distulit pro eo quod patienter expectavit peccatores ad penitentiam prolongando eis tempus penitentie. “Verbum” etiam “patientie” Christi est promissio singularis gratie electis tunc temporis dande, totumque orbem conversure et propter rationem premissam diu prolongate. Quorum utrumque iste servavit, quia a fervida et solida fide et spe verbi predicti non defecit, immo ac si esset presens vel presentialiter imminens ipsum tenuit et se ad ipsum digne et salubriter suscipiendum continue preparavit.
|
||
***
e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle
|
38
|
3, 1→ Inf. II, 53, 55 |
V |
A Inf. I, 37-40 non si parla di angelo né di sesto sigillo, ma sono presenti tutte le prerogative per cui questo angelo designa un momento di quiete. Intervengono alcuni temi dello stato precedente al sesto (ogni stato inizia e si forma sotto il regime di quello che precede).
Le “stelle”, che in numero di sette Cristo tiene nella mano destra, nell’Apocalisse designano i vescovi (Ap 1, 16). Costoro infatti illuminano e presiedono le chiese come la luce di una lucerna sta sul candelabro del santuario. In questo senso si dice che Cristo tiene nella mano destra sette stelle, perché come sommo re e pontefice percorre e visita tutte le chiese presenti e future (Ap 2, 1). Le stelle indicano anche lo Spirito di Cristo che, pur essendo increato e semplicissimo, si divide in sette doni, corrispondenti ai sette stati della Chiesa, che sono messi in ogni terra (Ap 5, 6).
La chiesa (delle sette d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione) che per eccellenza possiede tutte le perfezioni stellari è la quinta, quella di Sardi, assimilata alla sede romana (Ap 3, 1). Il suo nome viene interpretato come “principio di bellezza”, poiché fu bella nei suoi inizi e poi si corruppe, e in molti luoghi il poeta ricorre ai suoi temi per dare panno al vagheggiare un’età di innocenza e di bellezza perduta. L’angelo del sesto sigillo ascende appunto dalla chiesa romana (Ap 7, 2) e la pienezza stellare della quinta chiesa corrisponde allo Spirito increato, cioè alla pienezza dei doni e delle grazie (Ap 3, 1).
Così l’intreccio nei versi dei motivi propri dell’angelo del sesto sigillo (Ap 7, 2: salire, sole, mattino) con quelli della quinta chiesa – “dal principio”, con la rima “stelle” / “belle” (Ap 3, 1) – è nella descrizione del tempo primaverile e mattutino che ripete il mattino primordiale della creazione (Inf. I, 37-40) e ancora in rima al termine della prima cantica, nel salire e uscire “a riveder le stelle” (Inf. XXXIV, 136-139). Altri luoghi sono Inf. XXVI, 7.20.23; Purg. IV, 53-54; IX, 2.7.14.15.30 (alla quinta chiesa appartiene il riguardare, l’avere a memoria: Ap 3, 3). |
“Belle … stelle” sono le quattro virtù cardinali che nell’Eden conducono il poeta agli occhi di Beatrice, nei quali però potrà vedere solo per intervento delle tre virtù teologali, “che miran più profondo” (Purg. XXXI, 103-111). In apertura della seconda cantica, il poeta ‘pone mente’ al polo antartico, e vede “quattro stelle / non viste mai fuor ch’a la prima gente” (le quattro virtù cardinali, Purg. I, 22-24; le tre teologali, anch’esse stelle, saliranno al posto delle prime a Purg. VIII, 89-93): nei versi è presente il tema del ripensare a un ‘prima’ (la prima grazia) secondo l’invito fatto al vescovo di Sardi (Ap 3, 3).
La rima stella/bella si rinviene nel parlare di Brunetto Latini (Inf. XV, 55/57; i temi sono congiunti non in rima nelle “belle stelle” di cui dicono i tre fiorentini sodomiti a Inf. XVI, 83: tutta la ‘zona’ dei sodomiti registra la prevalenza dei temi del quinto stato). È appropriata a Beatrice nel racconto di Virgilio a Inf. II, 53/55 e all’angelo dell’umiltà che conduce i due poeti alla salita dal primo al secondo girone della montagna (Purg. XII, 88/90).
All’arrivo al cielo della Luna, Beatrice, “sì lieta come bella”, dice a Dante: “Drizza la mente (il ‘porre mente’ cui viene invitato il vescovo di Sardi) in Dio grata … / che n’ha congiunti con la prima stella (che corrisponde alla ‘prima grazia’)” (Par. II, 28-30; altri versi sono esaminati altrove; cfr. la rima “stella / bella” sulla soglia dell’Empireo, a Par. XXX, 5/9).
Tab. VIII.c
[LSA, cap. VI, Ap 7, 2 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] […] De hoc dicit hic Ioachim: Angelus iste est ille, quem Christus per concordiam respicit, futurus in principio tertii status. «Ascendet autem “ab ortu solis”, quia ut casus presentis vite non timeatur, predicabit certis indiciis veri solis adventum et vicinam iustorum omnium resurrectionem. […]».
|
Inf. XXXIV, 136-139salimmo sù, el primo e io secondo,
|
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 1.3 (Ia visio, Va ecclesia)] Hiis autem premittitur Christus loquens, cum dicitur (Ap 3, 1): “Hec dicit qui habet septem spiritus Dei et septem stellas”, id est qui occulta omnium videt et fervido zelo spiritus iudicat tamquam habens “septem spiritus Dei”, qui prout infra dicitur “in omnem terram sunt missi” (cfr. Ap 5, 6); et etiam qui potest omnes malos quantumcumque potentes punire tamquam in sua manu, id est sub sua potentia, habens “septem stellas”, id est universos prelatos omnium ecclesiarum. Quid per septem spiritus significetur tactum est supra, capitulo primo, super prohemio huius libri. […] Unde et Ricardus dat aliam rationem quare hec ecclesia dicta est “Sardis”, id est principium pulchritudinis, quia scilicet sola initia boni non autem consumationem habuit, et solum nomen sanctitatis potius quam rem. Supra vero fuit alia ratio data. Respectu etiam prave multitudinis tam huius quinte ecclesie quam quinti status, prefert se habere “septem spiritus Dei et septem stellas”, id est fontalem plenitudinem donorum et gratiarum Spiritus Sancti et continentiam omnium sanctorum episcoporum quasi stellarum, tum ut istos de predictorum carentia et de sua opposita immunditia plus confundat, tum ut ad eam rehabendam fortius attrahat. […]
|
||
Inf. II, 52-55Io era tra color che son sospesi,
|
Purg. XII, 88-90A noi venìa la creatura bella,
|
|
***
sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso |
30 |
Not. III; 2, 18; 3, 12 |
IV – VI |
Nella salita al “dilettoso monte”, “’l piè fermo sempre era ’l più basso” (Inf. I, 30), era cioè il piede che sostiene, come una colonna, la spinta nel salire. Il contesto esegetico al quale il verso si riferisce viene esaminato compiutamente altrove. La pertinace fermezza è propria del quarto stato, assimilato alla stabile età virile e caratterizzato dall’ascendere degli anacoreti. Contro questo stare fermo, inteso in senso negativo in quanto impedisce l’ascesa, si appunta il severo zelo proprio del quarto periodo (prologo, Notabile III: “quarto contra pertinaciam quasi in loco virilis et stabilis etatis se firmantem”). Dante è deciso nel voler salire il monte, ma è subito impedito dalla lonza (“ed ecco, quasi al cominciar de l’erta”). Il verso esprime un atto concepito e iniziato (il salire) “al cominciar de l’erta” e subito interrotto (un tentativo di salita deve esserci pur stato, visto che poi la lupa respinge Dante facendolo rovinare “in basso loco”).
***
una lonza leggera e presta molto
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
una lonza leggera e presta molto,
|
32
|
18, 2 (13, 2) |
IV |
Ad Ap 18, 2 (sesta visione), di Babylon si dice “fatta nido di demoni e covo di ogni spirito immondo e di ogni uccello sozzo e odioso”. I demoni sono detti “spiriti” per la natura sottile, “uccelli” per l’agilità, la velocità e la superbia, “immondi” per le macchie dei vizi, “odiosi” per la grande malizia, empietà e arroganza; pilosi (Isaia, 13, 21). Sono motivi parodiati nella lonza: “propter agilem velocitatem … propter maculas suorum vitiorum … pilosi – una lonza leggera e presta molto, / che di pel macolato era coverta … di quella fiera a la gaetta pelle” (Inf. I, 32-33, 42). |
“Et facta est habitatio … propter excessum malitie” sembra ritrovarsi nelle parole di Brunetto Latini su Firenze: “quando / fu fatto il nido di malizia tanta” (Inf. XV, 77-78; cfr. anche l’espressione, dal Notabile V del prologo, “dignum et quasi necessarium est tantam malitiam et ingratitudinem condempnari”, sempre riferita a Babylon).
Il tema degli uccelli immondi appartiene alle “brutte Arpie”, le quali fanno il loro nido nella selva dei suicidi (Inf. XIII, 10-15). In questo caso l’esegesi di Ap 18, 2 è da confrontare con quella di Ap 19, 17-18 (sesta visione; il passo serve altri luoghi), relativa all’angelo che, dopo la sconfitta dell’Anticristo, grida a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo l’invito a radunarsi al grande convivio spirituale e a mangiare la carne peritura. Con questo banchetto viene designato il gaudio dei santi a motivo della glorificazione di Cristo e della rimozione di quanto impediva il perfetto culto di Dio che ora, dopo la condanna dei reprobi, si mostra in modo più chiaro, secondo quanto detto in Isaia – “usciranno e vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me, e saranno le viste sazie per tutti” (Is 66, 24) –, e in Giobbe – “dove sono cadaveri, là l’aquila si trova” (Jb 39, 30). Riccardo di San Vittore interpreta gli uccelli che volano in mezzo al cielo come i demoni che godono della dannazione degli uomini e li tormentano nell’inferno, quasi mangiandoli. Così Giuseppe interpretò il sogno del capo dei panettieri del Faraone – il quale aveva visto gli uccelli mangiare dal canestro che portava sul capo –, nel senso che egli sarebbe stato appeso e che gli uccelli avrebbero lacerato le sue carni (Genesi 40, 17-19). E Agostino (tale ritenuto da Olivi), commentando Genesi 15, 11 – “gli uccelli calavano sui cadaveri e Abramo li cacciava” –, identifica gli uccelli con i demoni e i cadaveri con gli uomini carnali che sono tentati e lacerati dai demoni. Le Arpie, come spiega Pier della Vigna, mangiano le foglie delle piante silvestri che imprigionano le anime dei suicidi. Costoro, il giorno del giudizio, andranno come gli altri a riprendersi i propri corpi nella valle di Giosafat, ma non se ne rivestiranno, perché li trascineranno nella selva, dove saranno appesi “ciascuno al prun de l’ombra sua molesta” (Inf. XIII, 100-108).
Il tema del lacerare, proprio degli uccelli, torna nel medesimo canto con gli scialacquatori, che corrono per la selva inseguiti da nere cagne che li dilacerano “a brano a brano” (vv. 124-129). Si innesta qui il tema dei cani che lacerano, da Ap 22, 15 (settima visione), dove sono enumerati sette crimini, a causa dei quali gli empi saranno esclusi dalla gloria della città celeste. «“Foris”, scilicet sunt vel erunt, “canes”, id est immundi et sanctorum vitam detractoriis latratibus lacerantes». Tutto l’inciso è da confrontare con almeno altri due luoghi. A Inf. VI, 13-15, 19, con il latrare “caninamente” di Cerbero insieme all’urlare “come cani” dei golosi battuti dalla pioggia. I quali sono definiti “miseri profani” (v. 21; hapax nel poema): non sarà casuale che il termine sia contenuto in un altro elenco di crimini, per i quali verrà comminata l’esclusione dalla gloria, anch’esso proprio della settima visione (Ap 21, 8): “[…] “exsecratis”, qui scilicet sacra violant vel tamquam profani sunt a sacris anathematizati sive reiecti iudicio divino vel ecclesiastico”.
Ancora, «“Foris”, scilicet sunt vel erunt, “canes”, id est immundi et sanctorum vitam detractoriis latratibus lacerantes» si può leggere in controluce nel verso “forsennata latrò sì come cane”, relativo a Ecuba nel vedere morti i suoi figli Polissena e Polidoro (Inf. XXX, 20), come avrebbe potuto fare un esperto lettore dell’Apocalisse e della sua esegesi con la quale, nei versi danteschi, si concorda Ovidio (Met. XIII, 569).
Tab. IX.a
[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 2-3 (VIa visio)] “Et facta est habitatio demoniorum et custodia omnis spiritus immundi et custodia omnis volucris immunde et odibilis” (Ap 18, 2). Demones sunt “spiritus” propter nature subtilitatem, et “volucres” propter agilem velocitatem et superbiam; “immundi” autem sunt propter maculas suorum vitiorum, “odibiles” vero propter excessum malitie et impietatis et arrogantie. Babilon autem erit eorum habitatio et custodia, quia sicut ipsis in culpa per consensum et imitationem fuit subiecta et associata, quasi domicilium eorum, sic erit et in pena eterna. Servatque in hoc Iohannes typum Isaie, capitulo XIII° dicentis: “Et erit Babilon illa” civitas “gloriosa in regnis, sicut subvertit Dominus Sodomam; et replebuntur domus eorum drachonibus, et habitabunt ibi strutiones, et pilosi saltabunt ibi” (Is 13, 19.21). Et idem dicitur Ieremie L° (Jr 50, 39).
|
||
|
Inf. XII, 76; XVI, 86-87Noi ci appressammo a quelle fiere isnelle
|
|
Tab. IX.b
[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 2-3 (VIa visio)] “Et facta est habitatio demoniorum et custodia omnis spiritus immundi et custodia omnis volucris immunde et odibilis” (Ap 18, 2). Demones sunt “spiritus” propter nature subtilitatem, et “volucres” propter agilem velocitatem et superbiam; “immundi” autem sunt propter maculas suorum vitiorum, “odibiles” vero propter excessum malitie et impietatis et arrogantie. Babilon autem erit eorum habitatio et custodia, quia sicut ipsis in culpa per consensum et imitationem fuit subiecta et associata, quasi domicilium eorum, sic erit et in pena eterna. Servatque in hoc Iohannes typum Isaie, capitulo XIII° dicentis: “Et erit Babilon illa” civitas “gloriosa in regnis, sicut subvertit Dominus Sodomam; et replebuntur domus eorum drachonibus, et habitabunt ibi strutiones, et pilosi saltabunt ibi” (Is 13, 19/21). Et idem dicitur Ieremie L° (Jr 50, 39). |
Inf. XV, 73-78Faccian le bestie fiesolane strame
|
[LSA, cap. XIX, Ap 19, 17-18 (VIa visio)] Quantum autem ad Antichristum et eius complices tunc dampnatos, prefata manducatio carnium eorum designat gaudium sanctorum de glorificatione Christi et de ablatione impedimentorum perfecti cultus Dei ex condempnatione reproborum consurgente et clarius illuscente, unde Isaie ultimo dicit Deus quod sancti “egredientur et videbunt cadavera virorum, qui prevaricati sunt in me, et erunt usque ad satietatem visionis omni carni” (Is 66, 24), id est omni homini. Pro utroque autem sensu est illud Iob XXXIX°, ubi de aquila dicitur: “Ubicumque cadaver fuerit, statim adest” (Jb 39, 30).
|
|
Inf. XIII, 10-12, 100-108, 124-129Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,
|
Inf. VI, 13-15, 19-21; XXX, 16-21Cerbero, fiera crudele e diversa,
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 8 (VIIa visio)] Deinde subdit octo crimina reproborum quibus non dabitur gloria sed potius pena eterna, dicens (Ap 21, 8): “Timidis autem”, qui scilicet timore mortis seu pene temporalis fidem negant vel accipere fugiunt; “et incredulis”, qui scilicet ex duritia sue infidelitatis non credunt Deum vel eius bona futura; “exsecratis”, qui scilicet sacra violant vel tamquam profani sunt a sacris anathematizati sive reiecti iudicio divino vel ecclesiastico; “homicidis”, scilicet voluntate vel inductione vel opere; “fornicatoribus”, id est carnali voluptati turpiter subiectis; “venefic<is>”, qui scilicet per veneni potiones alios proditorie nituntur occidere, vel qui veneno doctrine erronee vel mali exempli animas hominum necant; “idolatris”, in quibus et subintelliguntur avari secundum Apostolum (cfr. Eph 5, 5); “et omnibus mendacibus”, scilicet pernicioso mendacio.[LSA, cap. XXII, Ap 22, 15 (VIIa visio)] Quarto loquitur ut comminator sive iudiciarius reiector impiorum a prefata gloria, dicens (Ap 22, 15): “Foris”, scilicet sunt vel erunt, “canes”, id est immundi et sanctorum vitam detractoriis latratibus lacerantes, “et impudici” et cetera. Septem ponit; nam ultimum, scilicet “mendacium”, duplicat prout est in affectu et effectu. Per hec autem septem intelligit omnia peccata mortalia, et semper hic et alibi intellige hec dici de finaliter impenitentibus. |
|
***
la vista che m’apparve d’un leone
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
la vista che m’apparve d’un leonecon la test’ alta e con rabbiosa fame,
|
4547
|
9, 17-18; 10, 3 |
VI |
Il leone cuce più parti del tessuto della Lectura. Da Ap 9, 17-19, esegesi parodiata anche altrove: «“Et capita equorum erant quasi capita leonum” … rabies vero iracundie terribilis et crudelis … ad flectendum et subiciendum omnes pusillanimes … – ma non sì che paura non mi desse / la vista che m’apparve d’un leone … con la test’alta e con rabbiosa fame».
Da Ap 10, 3, anche in questo caso luogo soggetto a molteplici variazioni: «“Clamaturus autem est sicut leo rugiens” … contremescere faciat … cum leonina esurie … – con rabbiosa fame, / sì che parea che l’aere ne tremesse». L’esegesi concerne l’angelo dal volto solare il quale, ruggendo come un leone, scuote dal velo del sonno alla vita della fede. Olivi identifica l’angelo con Francesco; la parodia applica i temi a situazioni e personaggi diversi: si vedano le distanti variazioni a Inf. IV, 1-3, 27 e a Purg. XXXII, 71-72.
Da Ap 4, 5: «“et tonitrua” … altiorum et spiritualium documentorum … tonitrua vero in celo seu ethere – con la test’alta … / sì che parea che l’aere ne tremesse». Il tuono, tema principale, è assente nel leone della selva, al quale sono però applicati i motivi derivati; risuona nella variazione a Inf. IV, 1-2, 27.
Tab. X
[LSA, cap. X, Ap 10, 3 (IIIa visio, VIa tuba)] Clamaturus autem est sicut leo rugiens (Ap 10, 3). Primo quia contra errores et vitia obduratorum cum forti indignatione et increpatione loquetur, et terribile iudicium Dei eis in proximo venturum cum summa auctoritate et terribili comminatione predicet, ita ut bestias, id est bestiales, contremescere faciat. Ratio autem magnitudinis sue indignationis erit ex hoc, quia cum clausus erat liber videbantur aliquantulam excusationem habere, ex quo autem est apertus nullum velamen excusationis relinquitur eis. Alia ratio est propter nimiam resistentiam et nimiam multitudinem obduratorum. Tertia est <propter> superfervidum zelum excitandi eos a sompno mortis ad vitam fidei.
|
|
[LSA, cap. IX, Ap 9, 17 (IIIa visio, VIa tuba)] “Et capita equorum erant quasi capita leonum” (Ap 9, 17), id est animosa et impavida et ferocia et fortissima ad insiliendum et devorandum.[LSA, cap. IX, Ap 9, 19 (IIIa visio, VIa tuba)] Rabies vero iracundie terribilis et crudelis et commi-nationum eius est apta ad flectendum et subiciendum omnes pusillanimes ad illorum votum et sectam. |
[LSA, cap. IV, Ap 4, 5 (IIa visio, radix)] “Et de trono procedebant” (Ap 4, 5), vel secundum aliam litteram “procedunt”, “fulgura et voces et tonitrua”, quia tam a Deo quam ab eius ecclesia et quam a sanctis, qui sunt sedes Dei, procedunt “fulgura” miraculorum, quorum claritas longe lateque coruscat sicut fulgura discurrentia; et “voces” rationabilis ac temperate predicationis, “et tonitrua” terribilium commi-nationum, vel tonitrua altiorum et spiritualium documentorum, que competunt perfectioribus. Voces enim in terra fiunt, tonitrua vero in celo seu ethere, vocesque sunt modice respectu tonitruorum. |
Inf. I, 44-48ma non sì che paura non mi desse
|
Inf. IV, 1-3, 25-27Ruppemi l’alto sonno ne la testa
|
***
Ed una lupa, che di tutte brame / sembiava carca ne la sua magrezza
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
Ed una lupa, che di tutte brame
|
49
|
6, 8 → Inf. II, 63, 107 |
IV |
Nella selva, scriveva Benedetto Croce, “s’incontrano tre fiere, che sono e non sono fiere, e la più minaccevole di esse è magra per le brame che la divorano e, non si sa come, ‘fa vivere grame molte genti’” [1].
Nella seconda visione apocalittica, l’esegesi oliviana dell’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 3-4) – esposta nella Lectura super Apocalipsim – si estende in generale ai primi quattro sigilli. All’apertura del primo appare Cristo vittorioso che esce in campo sul cavallo bianco (Ap 6, 1-2), mentre nei successivi tre sigilli vengono specificati gli eserciti contrari a Cristo e alle sue tre perfezioni (potenza, sapienza, santità), designati rispettivamente con il cavallo rosso (secondo sigillo), nero (terzo sigillo) e pallido (quarto sigillo). Secondo Gioacchino da Fiore (Expositio in Apocalypsim), i quattro cavalli corrispondono alle quattro bestie di Daniele 7, 3-7, considerate in una prospettiva storica rispetto al futuro regno dell’Anticristo: la leonessa dalle ali di aquila (leena: i Giudei), l’orso (ursus: i pagani), la pantera (pardus: le eresie), la quarta bestia ‘diversa’ (bestia quarta dissimilis ceteris: i Saraceni) [2].
Olivi opera un confronto anche con quanto detto sulla bestia dalle sette teste e dieci corna, che sale dal mare all’inizio del capitolo XIII: simile a una pantera, con i piedi di orso e la bocca di leone, questa bestia riunisce in sé qualità prese da tutte e quattro le bestie della visione di Daniele (Ap 13, 1-2), secondo un modo tipico dell’autore dell’Apocalisse.
Quanto nell’esegesi è attribuito polemicamente agli Ebrei, ai pagani o all’Islam viene da Dante rovesciato sui Cristiani. La durezza della Giudea persecutrice di Cristo, che da giardino s’è fatta selva, è figura dell’Italia, già giardino dell’Impero e ora deserto (Purg. VI, 105), la quale, come la Giudea, verrà umilmente condotta a convertirsi per ultima. I Gentili, affannati per la carnalità e fluttuosi nei cuori come un mare tempestoso, sempre in guerra tra loro, uccisori di parenti e vicini, passano parodiati nella moderna ‘gentilità’, vestono l’amore gentile di Francesca o la Romagna senza pace di Guido da Montefeltro o di Guido del Duca.
La quarta bestia di Daniele (Dn 7, 7), ‘diversa’ dalle altre, corrisponde al cavallo pallido del quarto sigillo (e al terzo esercito contrario a Cristo), che designa la morte recata dai Saraceni e dal loro profeta Maometto (Ap 6, 7-8). La legge finta e carnale da questi stabilita impugna infatti la legge e la vita dei santi. Il cavallo pallido indica, oltre all’ipocrisia, anche l’ambizione del primato che vi siede sopra, che si fa forte di una superficiale austerità e macerazione quasi di un corpo pallido, ma che in realtà una volta conseguito il primato mostra apertamente la vita infernale e a lei conduce.
La lupa – la cupidigia universale, ma in primo luogo cristiana – possiede tutte le caratteristiche del cavallo pallido e macerato per l’ipocrisia che appare all’apertura del quarto sigillo, cioè della bestia saracena (Ap 6, 8). Ad essa è dato il potere “sulle quattro parti della terra”, che esercita tramite la spada, la fame, la morte e le bestie. Questi quattro strumenti alla lettera significano i vari modi di debellare i nemici, uccisi in battaglia campale, o per fame negli assedi di città che poi, abbandonate dagli uomini, diventano deserti devastati da bestie selvagge. La “spada” designa pure il terrore che questa bestia, che molte terre ha occupato, incute penetrando nell’intimo del cuore e della carne con la paura che deriva dalla sua forza militare; la “fame” denota l’assenza del verbo ristoratore di Cristo; la “morte” indica la mortifera legge di Maometto; le “bestie” la compagnia delle genti bestiali. La vista della lupa nella sua magrezza (che, a differenza delle altre due fiere, è chiamata “bestia”: Inf. I, 58, 88, 94), la quale “molte genti fé già viver grame”, incute paura, essa “fa tremar le vene e i polsi” (vv. 49-53, 90); dopo il pasto ha piú fame che prima (v. 99); impedisce al punto di uccidere chiunque tenti di passare per la sua via (vv. 94-96).
Beatrice, scesa al Limbo da Virgilio, asserisce che Dante “ne la diserta piaggia è impedito / sì nel cammin, che vòlt’ è per paura” (Inf. II, 62-63); le ha detto infatti Lucia: “non vedi tu la morte che ’l combatte / su la fiumana ove ’l mar non ha vanto?” (vv. 107-108; la stessa selva “tant’ è amara che poco è più morte“: Inf. I, 7). Il fiume che non può essere vinto dal mare, cioè che non sfocia e scompare in esso, non è un fiume specifico, sia il Giordano o altro; corrisponde a quanto ad Ap 6, 3 si dice della bestia saracena, che non accetta la Scrittura (il “mare” o “pelago”, ad Ap 4, 6), contro la quale non è possibile usare argomenti razionali e che perdura fino all’Anticristo, a differenza di quanto avvenuto con i Giudei, i pagani e gli eretici, i quali combatterono contro il cristianesimo per un certo periodo e poi vi confluirono e sparirono: “confluxerunt ad tempus cum fidelibus Christi et tandem disperierunt”. Al v. 108 la variante onde (Inglese) è di gran lunga preferibile a ove (Petrocchi): ‘il fiume dal quale il mare non trae vantaggio’, che cioè non confluisce in esso e poi sparisce.
Giudei, pagani ed eretici non ebbero una legge di per sé contraria a quella di Cristo. La legge giudaica non si può dire contraria a Cristo, anzi fu sua; i pagani seguirono civilmente la legge di natura, gli eretici mossero interpretando in modo erroneo la legge di Cristo. I Saraceni seguono invece una legge carnale e falsa del tutto dissimile, che non accetta le Scritture cristiane e contro la quale non è possibile una qualsiasi confutazione sulla base di queste, come con i Giudei e con gli eretici. Né è possibile argomentare contro sulla base della ragione naturale, come contro i pagani, in quanto i Saraceni non credono in più dèi, ma in un solo Dio. Inoltre i loro sapienti, afferma Olivi, da lungo tempo si dedicano agli studi filosofici e in particolare di Aristotele, tanto che i cristiani latini hanno ricevuto da essi i commenti ad Aristotele e altre opere, soprattutto di medicina e di astronomia, con cui hanno farcito e insozzato i propri scritti teologici. Ancora, la bestia saracena, a differenza delle prime tre, non tollera che la fede di Cristo venga predicata tra i seguaci della sua setta o che venga detto qualcosa contro la sua legge, pena la morte immediata. Tolta la polemica antiaristotelica (che forse sarebbe meglio definire antitomista), tutta oliviana e che Dante non può accettare (correzione importante, ma che non fa venire meno l’adesione del poeta alla teologia della storia del frate di Sérignan parodiata nella Commedia, dove anche lo Stagirita è fasciato con temi escatologici), per il resto le prerogative della bestia saracena sono appropriate alla lupa, cioè all’avarizia dei cristiani. Dopo la lupa, tessuta con i fili della bestia saracena, non ci si stupirà di vedere in filigrana, nelle parole di Francesca – “Amor, ch’a nullo amato amar perdona … Amor condusse noi ad una morte” -, il motivo della legge carnale di Maometto che non tollera confutazione razionale, che non perdona ma uccide, armatura teologica che fascia la regola, esposta nel De amore di Andrea Cappellano, per cui amore non tollera che chi è amato non riami.
Di qui il valore storico delle tre fiere che impediscono a Dante la salita del “dilettoso monte”. Esse possono dirsi allegoria soltanto nel senso dell’allegoria dei teologi; non sono cioè fabula o fictio ma figure di realtà storiche. Giudei, pagani, eretici sparirono, appunto, come sparisce la lonza e subentra il leone, sparisce il leone e subentra, restando, la lupa, cioè la bestia saracena. Sono i mutevoli aspetti dell’unico corpo dei reprobi, dell’unica prostituta le cui varie colpe ridondano sull’ultima parte della storia umana come l’acqua di un fiume muta ma il fiume resta uno (cfr. Ap 17, 6). Nonostante le articolazioni settenarie che percorrono la storia, una è la Chiesa e uno il suo avversario: “[…] quarta visio demonstrat in omnibus septem statibus unam esse ecclesiam electorum quasi unam mulierem sole amictam attamen habentem variam prolem et varios exercitus correspondentes septem capitibus drachonis; sexta vero docet totam catervam reproborum esse unam meretricem et unam Babilonem et unam bestiam habentem tamen capita septem” (LSA, prologo, Notabile V) [3].
Un’esegesi fortemente gioachimita – ma filtrata attraverso l’Olivi – permea dunque punti essenziali dei primi canti del poema. Il senso interiore – marcato nella lettera dei versi da parole che sono segni mnemonici verso il testo dottrinale (magrezza, grame, paura, fa tremar, bestia, fame, uccide, diserta, morte) – doveva essere ben chiaro a un lettore spirituale possessore della Lectura super Apocalipsim. Non si sarebbe arrovellato troppo nello scorgere nella lupa la bestia saracena; non avrebbe certo, di fronte alle fiere che sono e non sono tali, favoleggiato di inesistenti allegorie. L’essere “sanza pace” della lupa (Inf. I, 58) è tra i mali predetti dall’Apostolo nella seconda lettera a Timoteo (2 Tm 3, 1-6), dove parla dei tempi perigliosi che incombono sugli ultimi giorni, allorché ci saranno uomini pieni di ogni vizio che penetrano nelle case e catturano le “muliercule”, passo riferito all’ultimo periodo del quinto stato della Chiesa allorché più grave è il dolore provocato dalle locuste (Ap 9, 5-6). Se ne ricorderà bene Ugo Capeto predicendo l’attentato di Anagni: “sunt qui penetrant domos et captivas ducunt mulierculas – veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, / e nel vicario suo Cristo esser catto” (Purg. XX, 86-87). Prima che Ugo Capeto chieda vendetta sulla propria discendenza, è ancora la lupa ad essere maledetta da Dante. Qui interessa l’interpretazione data, ad Ap 13, 18, del terremoto che avviene in apertura del sesto sigillo. Olivi rimette alla volontà divina l’avverarsi dell’opinione che l’Anticristo mistico nasca dal seme di Federico II. Ricorda tuttavia che i sostenitori di questa tesi affermano pure che la ‘caduta’ del regno di Francia avverrà in coincidenza con il terremoto che segna l’apertura del sesto sigillo, e che allora si verificherà quanto dice l’Apostolo ai Tessalonicesi sul fatto che l’apostasia, il discedere dall’obbedienza del vero papa per seguire il falso papa non eletto canonicamente, scismatico ed errante contro la verità della povertà e della perfezione evangelica, dovrà venire prima del ritorno di Cristo nella parusia (2 Th 2, 3). L’espressione paolina – “nisi venerit discessio primum” – si rispecchia nel verso che conclude l’invettiva contro la lupa – “quando verrà per cui questa disceda?” – nel quale il ‘discedere’ è appropriato alla lupa e il ‘venire’ al veltro. L’invettiva è collocata all’inizio di Purg. XX (vv. 13-15), canto che si chiude con il terremoto sentito “come cosa che cada” e che fa tremare la montagna (vv. 124-141). Stazio spiegherà che il terremoto si verifica allorché un’anima purgante si sente monda e libera nella sua volontà di salire al cielo (Purg. XXI, 58-72). Tra l’invettiva contro la lupa e il terremoto sta appunto Ugo Capeto, il quale chiede vendetta a Dio sulla “mala pianta” di cui fu radice. Il terremoto – che assume testualmente, comunque, le caratteristiche dell’apertura del sesto sigillo –, al di là dei motivi dati da Stazio (anch’essi propri del sesto stato), è allusione alla futura caduta del regno di Francia per mano imperiale.
Ottone di Frisinga, in ben altre condizioni di certezza dell’autorità imperiale, aveva definito Ottone II, pur sconfitto a Rossano dagli Arabi nel 982, “pallida mors Sarracenorum” [4]. In Dante, che è della generazione che registrò la caduta di San Giovanni d’Acri nel 1291, la morte pallida diventa la malizia del mondo. Nell’esegesi di Ap 18, 7 (la condanna di Babylon) la superba gloria (il leone) e la voluttà carnale (la lonza) stimolano la brama di ricchezze (la lupa): in questi tre vizi, che già secondo gli antichi commentatori corrispondono alle tre fiere, consiste tutta la malizia del mondo figurata dalla prostituta apocalittica, come affermato nella prima epistola di san Giovanni (1 Jo 2, 16: le ricchezze corrispondono alla “concupiscentia oculorum”, che si aggiunge alla “concupiscentia carnis” e alla “superbia vitae”):
Quia vero non solum (Babilon) punietur pro malis que fecit in sanctos vel in proximos, sed etiam pro hiis quibus se ipsam vanificavit et fedavit, ideo pro hiis subditur (Ap 18, 7): “Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum”. Le “tantum” non significat hic absolutam equalitatem quantitatis, sed equalitatem proportionis et iustitie. Signanter autem notat eius culpam de duobus, scilicet de superba gloria et de carnali voluptate, quia hec duo sunt radices omnium aliorum. Nullus enim, secundum Ieronimum, querit divitias nisi pro hiis duobus. In hiis autem <tribus>, secundum Iohannem, consistit radicaliter tota malitia mundi (cfr. 1 Jo 2, 16).
I commentatori sogliono indicare la fonte delle tre fiere nel passo di Geremia 5, 6: “Idcirco percussit eos leo de silva, lupus ad vesperam vastavit eos, pardus vigilans super civitates eorum”. Il confronto fra Commedia e Lectura super Apocalipsim mostra una situazione più complessa (che non esclude la conoscenza, da parte di Dante, del passo di Geremia) Le tre fiere, che in Inf. I impediscono al poeta la salita del “dilettoso monte”, si presentano ciascuna con qualità molteplici che assommano quelle delle varie bestie scritturali.
La lonza ha in parte le caratteristiche della prima bestia di Daniele 7, 3-7, la “leena” (la leonessa) crudele che si contrappone al leone come la carne allo spirito e come il sesso femminile a quello maschile: essa infatti designa la concupiscenza della carne, o la lussuria. La lonza ha però, nel pelo macchiato (la “gaetta pelle”), l’astuzia dolosa della pantera, ossia della terza bestia di Daniele, che corrisponde al cavallo nero nell’apertura del terzo sigillo apocalittico e che si ritrova, insieme all’orso e al leone, nella bestia che sale dal mare in Ap 13, 1-2. Si può aggiungere che, nella carnalità, ha anche qualcosa dell’orso.
Il leone corrisponde alla bestia di Ap 13, 2 che con rapace voracità uccide i santi, ma anche all’orso che con ferocia conculca. La “test’alta”, che designa l’audacia, esclude invece ogni riferimento alla dolosa astuzia.
La lupa, oltre ad avvicinarsi assai alla quarta bestia di Daniele, diversa dalle altre, ha in sé elementi dell’orso (la concupiscenza o carnalità), del leone (la voracità) e della pantera (la magrezza con cui si presenta, nonostante la sua fame senza fine, può essere anche considerata come indizio di frode).
Il modo di procedere proprio dell’autore dell’Apocalisse, il quale nella bestia che sale dal mare di Ap 13, 1-2 ha concentrato elementi propri di tutte le bestie della visione di Daniele 7, 3-7, non si ritrova unicamente nelle tre fiere dantesche. Anche nella figura di Cerbero (Inf. VI, 13-18) sono riunite qualità di differente provenienza. Il mostro infernale è collocato in una zona in cui prevalgono temi propri del terzo stato della Chiesa, dei quali è quasi emblema nel graffiare, iscoiare e isquatrare le anime. Esso tuttavia contiene elementi che caratterizzano l’apertura di tutti e tre sigilli in cui compaiono eserciti contrari a Cristo. Gli occhi “vermigli” e le mani “unghiate” sono propri del secondo sigillo (il cavallo rosso, l’orso), la “barba unta e atra” del terzo (il cavallo nero), il “ventre largo” è qualità dei Saraceni dei quali, nell’esegesi della quarta chiesa (Ap 2, 22) si dice con san Paolo che “hanno il ventre per loro Dio e per loro gloria” (Ph 3, 19). Inoltre Cerbero, che latra con “tre gole”, è “fiera crudele e diversa”, cioè “bestia dissimilis”, come la quarta bestia di Daniele lo è dalle altre tre precedenti. “uomini diversi d’ogne costume” sono pure definiti i Genovesi in Inf. XXXIII, 151-152.
I tre eserciti contrari a Cristo, designati rispettivamente all’apertura del secondo, del terzo e del quarto sigillo con il cavallo rosso, il cavallo nero e il cavallo pallido, si trasformano nelle tre facce di Lucifero (Inf. XXXIV, 39-45): la prima vermiglia, la seconda nera, la terza tra bianca e gialla.
[1] BENEDETTO CROCE, La poesia di Dante, Bari 19527 [19201] (Scritti di storia letteraria e politica, XVII), p. 67.
[2] Viene qui in parte ripreso quanto pubblicato nel saggio «Pallida mors Sarracenorum». La lupa, la morte e l’Islam (2014), al quale si rinvia più volte.
[3] Il confronto fra la Commedia e la parodiata Lectura super Apocalipsim conferma quanto scritto da Guglielmo Gorni sull’essere le tre fiere in realtà una soggetta a sviluppo e trasformazione (G. GORNI, Canto I, in Lectura Dantis Turicensis, a cura di Georges Güntert e Michelangelo Picone, I, Inferno, Firenze 2011, pp. 27-38: 28-32).
[4] Chronica sive Historia de duabus civitatibus, lib. VI, cap. xxvi; ed. Adolf Hofmeister, MGH, Script. rer. germ. [45], p. 292.
Tab. XI
[LSA, cap. VI, Ap 6, 8 (IIa visio, apertio IVi sigilli)] “Et ecce equus pallidus”, id est, secundum Ricardum, ypocritarum cetus per nimiam carnis macerationem pallidus et moribundus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet diabolus, qui per pravam intentionem ypocritarum sedet in eis et per eos malitiam suam exercet, “nomen illi mors”. Hoc enim nomen bene diabolo convenit, quia per eum mors incepit et alios ad mortem trahere non cessat. “Et infernus”, id est omnes in inferno dampnandi, “sequeb<atur> eum”, quia omnes tales eum imitantur*. […]
|
|
Inf. I, 49-54, 58, 88-90, 91-99; II, 61-63, 107-108Ed una lupa, che di tutte brame
|
[LSA, cap. XIII, Ap 13, 3 (IVa visio, VIum prelium)] Ad hoc dicit Ioachim, qui hic accipit septimum caput bestie non pro uno rege sed pro gente sarracenica, prout superius recitavi, quod non dicit hic Iohannes quin et alia capita, scilicet gentem iudaicam et paganicam et quattuor gentes Arrianorum, viderit occisa, sed quia hoc solum vidit quasi occisum in mortem et post hoc a plaga mortis curatum. Iudeos autem, postquam contriti sunt a Romanis, nusquam audivimus pro legis defensione contra christianos arma levasse; et similiter nullum regnum paganorum pro cultura idolorum, post Iuliani obitum, contra christianos pugnasse; et similiter Gothos, Vandalos, Longobardos ad veram fidem conversos non audivimus ad antiquam perfidiam remeasse; Sarracenorum vero ex tot annis inchoata perfidia perseverat in malo et ubique christianum nomen impugnare pro viribus non desistit. Caput istud mori non potuit usque ad presens**.* In Ap II, vii (PL 196, col. 767 C-D).* Expositio, pars II, f. 116va-b.** Expositio, pars IV, distinctio IV, ff. 164vb-165ra.Inf. I, 7Tant’ è amara che poco è più morte |
[LSA, cap. VI, Ap 6, 3 (IIa visio, in apertione IIi sigilli)] Sicut etiam per equum pallidum, cuius sessor est mors, designatur Sarracenorum populus et eius propheta mortiferus, scilicet Mahomet, sic et per quartam bestiam dissimilem ceteris. Hec enim est dissimilis ceteris in tribus. Primo scilicet quia Iudeorum regnum et paganorum et hereticorum confluxerunt ad tempus cum fidelibus Christi et tandem disperierunt, sed bestia sarracenica surgens in quarto tempore confligit et perdurat in toto quinto et pertinget usque ad sectam Antichristi, propter quod hic dicitur quod “infernus”, id est infernalis secta Antichristi, “sequebatur eum”, scilicet equum pallidum et sessorem eius (Ap 6, 8).
|
|
***
ch’io perdei la speranza de l’altezza
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
ch’io perdei la speranza de l’altezza.
|
54
|
18, 10
|
VI |
I mercanti piangono la perdita del lucro acquistato nei commerci con Babilonia, ora che è caduta (Ap 18, 10-14, 17.19). Il linguaggio mercantile – l’acquistare e il tristo perdere, il perdere ogni speranza di guadagni, l’equivoco tra merce (il lucro) e mercede (il premio), il navigare per vie più o meno gravi verso porti più o meno lontani, la fine delle delizie di Babilonia, desideri per anime sensuali – segna molti luoghi dei primi canti del poema: Dante che prima acquista e poi perde piangendo, a causa della lupa, la salita del “dilettoso monte”, “ch’io perdei la speranza de l’altezza” (Inf. I, 52-60); al quale Caronte dice che dovrà passare “per altra via, per altri porti”, portato da “più lieve legno” (Inf. III, 88-93); le ultime parole scritte sulla porta, “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate” (v. 9); le anime del Limbo, delle quali dice Virgilio che non peccarono, ma se hanno meriti (“mercedi”) non basta, perché non furono battezzate, cui è pertanto applicato il tema della speranza perduta – “Per tai difetti, non per altro rio, / semo perduti, e sol di tanto offesi / che sanza speme vivemo in disio” (Inf. IV, 31-42; quest’ultimo, più che al carnale appetito delle delizie perdute è da ricondurre al desiderio dei santi padri dell’Antico Testamento, i quali nel Limbo piangono e sospirano con desiderio affinché il libro della vita venga loro aperto, secondo quanto si dice ad Ap 5, 4). La variazione più distante dal tema originale è per l’ottavo cielo, dove discendono trionfalmente le schiere di Cristo e la Vergine: “Quivi si vive e gode del tesoro / che s’acquistò piangendo ne lo essilio / di Babillòn, ove si lasciò l’oro” (Par. XXIII, 133-135; cfr. le parole di san Pietro a Par. XXVII, 40-42).
***
tal mi fece la bestia sanza pace
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
tal mi fece la bestia sanza pace,mi ripigneva là dove ’l sol tace |
5860 |
Not. III (9, 5) |
VII |
La rima “pace / tace”, si registra in opposte e distanti variazioni a Inf. I, 58/60 (la lupa, “bestia sanza pace”, respinge Dante nella selva, “là dove ’l sol tace”, dove cioè tace Cristo, “sol mundi”) e a Purg. X, 35/39 (l’angelo dell’annunciazione).
Essere sine pace è fra i mali predetti e descritti dall’Apostolo nella seconda lettera a Timoteo (2 Tm 3, 1-6), lì dove parla dei tempi perigliosi che incombono sugli ultimi giorni, allorché ci saranno uomini cupidi pieni di ogni vizio, che penetrano nelle case e catturano le “muliercule” (Ap 9, 5-6). Così il fiordaliso entra ad Anagni e cattura Cristo nel suo vicario (Purg. XX, 85-93).
Come ogni stato, e quindi ogni momento della storia umana, ha una sua “quietatio”, una pausa di pace, di quiete, di silenzio propria del settimo e ultimo degli stati, così Francesca parla e ascolta “mentre che ’l vento, come fa, ci tace”, per quanto dalla sua terra, Ravenna, la pace sia stata tolta (Inf. V, 92/96).
***
Mentre ch’i’ rovinava in basso loco
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
Mentre ch’i’ rovinava in basso loco |
61 |
3, 16 (2, 5) |
VII |
Il vomito nei confronti di chi è tiepido non avviene in modo repentino, ma a poco a poco, perché è gradualmente che si discende dalla sommità al basso e poi si rovina precipitando. Per questo Cristo non dice al vescovo di Laodicea (la settima chiesa d’Asia), per la sua apostasia da un alto stato o per avere grande disposizione ad essa, “ti vomiterò”, bensì “inizierò a vomitarti” (Ap 3, 16), nel senso che se finora lo ha tollerato, d’ora innanzi non potrà più farlo, come un cibo fatto abominevole e intollerabile. Il medesimo tema è proposto al vescovo della prima chiesa (Efeso) disceso dal primo grado di fervida carità (Ap 2, 5). Il tepore rimproverato al primo vescovo precede tuttavia l’ingresso dei sette spiriti malvagi, mentre quello rimproverato al settimo si verifica dopo che tale ingresso si è compiuto, di cui dice Cristo: “la nuova condizione di quell’uomo è peggiore della prima” (Matteo 12, 45). Il primo degli spiriti malvagi è lo spirito di presunzione, che è radice e sede della superbia. Per questo, a sottolineare l’arrogante e intollerabile presunzione del vescovo di Laodicea, si afferma: “Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla” (Ap 3, 17). Egli si ritiene infatti ricco, di ricchezze ereditate o acquisite con la sua virtù, per la scienza, per la predicazione delle scritture, per l’eloquenza, per l’amministrare i sacramenti, per la dignità pontificale, per il favore e la lode del volgo.
L’esegesi relativa a Laodicea viene ampiamente sviluppata nell’episodio degli ignavi (da notare, a Inf. III, 41, l’espressione “né lo profondo li riceve”, parodia dell’“horrenda reiectio” minacciata al vescovo di Laodicea; di conseguenza acquista maggior rilievo la variante antica “orror” (Inglese) anziché “error” (Petrocchi) al v. 31, nel senso che anche il poeta prova l’orrore che induce il vomito).
Il rovinare in basso a poco a poco è proprio di Dante, impedito dalla lupa, “bestia sanza pace”, nella salita al dilettoso monte e respinto verso la selva oscura, “là dove ’l sol tace” (Inf. I, 58-61; la pace e il tacere sono temi del settimo stato: cfr. supra). |
L’essere disposto a trista e progressiva rovina è proprio di Firenze, come detto dal poeta a Forese Donati (Purg. XXIV, 79-81).
Tab. XII
[LSA, cap. III, Ap 3, 16-17 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Deinde comminatur ei horrendam reiectionem eius a Dei societate, quam per nomen vomitus designat, tum quia vomitus est horribilissima reiectio cibi prius transglutiti, tum quia tepida solent plus provocare vomitum quam frigida vel calida. Unde subdit (Ap 3, 16): “Sed, quia tepidus es, et nec frigidus nec calidus, incipiam te evomere ex ore meo”.
|
||
[Ap 3, 15] Nam tepiditas hic sumpta aut includit realem apostasiam ab alto statu aut maximam dispositionem et appropinquationem ad illam.
|
Inf. III, 31, 40-42
|
|
***
dinanzi a li occhi mi si fu offerto / chi per lungo silenzio parea fioco
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
dinanzi a li occhi mi si fu offerto |
62 |
14, 14 (“similem Filio hominis”) |
VII |
chi per lungo silenzio parea fioco |
63 |
1, 5; 5, 12-13 (3, 5) |
R1.2 – V |
Virgilio, che appare a Dante “nel gran diserto”, è parodia dell’immagine del Salvatore. Si fregia della seconda proprietà di Cristo sommo pastore (nella parte ‘radicale’ della prima visione) cioè la conformità con la natura umana, ovvero l’umiltà e l’umanità condiscendente verso quanti gli sono soggetti, per cui viene definito “simile al Figlio dell’uomo” (Ap 1, 13).
In altro punto del testo apocalittico Giovanni descrive la visione di un angelo simile nell’aspetto al Figlio dell’uomo: si tratta dell’angelo che sta seduto su una nube bianca con sul capo una corona d’oro e in mano una falce affilata (Ap 14, 14). Questo angelo, secondo Gioacchino da Fiore citato da Olivi, designa un ordine di giusti a cui è dato di imitare Cristo in modo perfetto e che possiede una “lingua erudita” per diffondere il Vangelo del regno di Dio e per raccogliere sulla terra l’ultima messe. A differenza dell’angelo che esce dal tempio, cioè dagli arcani del cielo dove sta nascosto (Ap 14, 17), appare manifesto perché coloro che sono destinati all’erudizione delle plebi sono dati di fronte agli occhi in modo che esse possano ricevere gli ammonimenti salutari e i pii esempi di comportamento. Così Virgilio, che viene offerto dinanzi agli occhi di Dante per la sua salute (Inf. I, 61-63). Per la sua “parola ornata”, il “parlare onesto”, Beatrice fiduciosa lo fa andare al soccorso dell’amico nella “diserta piaggia” (Inf. II, 67, 113-114).
All’umanità di Cristo è associata la fragilità che deriva dall’essere soggetto a morte, passione, infermità, abiezione (cfr. l’esegesi ad Ap 1, 5 e 5, 12-13, luogo, quest’ultimo, dove l’apparire infermo e abietto di Cristo è una delle cause per cui i sigilli sono chiusi). La fragilità di Cristo viene meno nella gloria; resta in Virgilio, “chi per lungo silenzio parea fioco” (Inf. I, 63). Il motivo dell’essere fragili e disprezzabili a causa della mortalità è presente anche in altri punti della Lectura. All’apertura del quarto sigillo (Ap 5, 1; 6, 8), la fragilità dell’uomo è connessa con il pallore della morte. Ad Ap 11, 7-11 i due testimoni (Elia e Enoch) vengono vinti e uccisi dall’Anticristo e i loro corpi giacciono insepolti nella piazza della grande città, da tutti disprezzati: ma si tratta di vittoria secondo l’apparenza umana, perché dopo tre giorni e mezzo i due risorgono. Così l’esser “fioco” di Virgilio, per il lungo silenzio dovuto alla morte, è solo apparente agli occhi corporei di Dante, non ancora sollevato a una visione spirituale.
***
qual che tu sii, od ombra od omo certo!
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
« qual che tu sii, od ombra od omo certo! ».
|
66
|
1, 13 (“similem Filio hominis”)
|
R1
|
■ Il tema della conformità di Cristo con la natura umana è presente nell’apparizione di Virgilio “nel gran diserto” (cfr. supra). A Dante che gli chiede se sia “od ombra od omo certo” Virgilio risponde: “Non omo, omo già fui”, dove l’insistenza sulla locuzione “omo”, ripetuta per tre volte in due versi, indica che l’ombra è conforme alla natura umana e mantiene la somiglianza con la forma assunta nella precedente vita mortale (Inf. I, 64-67). Se si collaziona Ap 1, 13 con Ap 22, 16, l’espressione di Cristo “fui homo mortalis”, per cui si definisce “stella splendida”, illuminatrice dei santi, e “matutina”, che promette, predica e mostra la luce futura dell’eterno giorno (il sole della sua divinità), sembra coincidere con l’“omo già fui” detto dal poeta pagano che, se pure può paragonarsi a Cristo solo per questo, è anch’egli “stella matutina” perché il suo parlare, prospettando a Dante il viaggio nell’oltretomba, è promessa di tanto bene (Inf. II, 126). Se l’angelo che appare a Giovanni è autorevole in quanto si presenta somigliante al Salvatore, Virgilio è l’“autore” di Dante (Inf. I, 85), e questi a lui si dà per la sua salute (Purg. XXX, 51).
■ Virgilio, che incarna molte qualità del Figlio dell’uomo, anzi gli è “simile” (Ap 1, 13), si fregia altresì della santità del manto sacerdotale (Ap 1, 13), elemento che non manca all’indovina ‘Manto’, fondatrice della sua città e dannata nella quarta bolgia.
La terza perfezione di Cristo sommo pastore consiste nell’appartenenza all’ordine sacerdotale e pontificale, cui si addicono santità, integrità, castità e onestà, per designare la quale si afferma: “vestito con un abito lungo fino ai piedi” (Ap 1, 13). La veste è la “poderis” di lino, propria dei sacerdoti, lunga fino ai piedi (“poderis” è vocabolo di origine greca che equivale a “pedalis”). È assimilata al manto dell’efod da cui era avvolto Aronne, la “tunica superhumeralis” sovrapposta al pettorale del giudizio (il “rationale” con incisi i nomi degli Israeliti), di color giacinto, sulle cui frange erano sonagli aurei (“tintinabula”, Esodo 28, 31-35). Di questo manto si dice nella Sapienza (Sap 18, 24): “Sulla sua veste lunga fino ai piedi vi era tutto il mondo e la grandezza dei parenti era scolpita su quattro ordini di pietre preziose”.
Il tema del manto avvolge la figura di Virgilio dal “parlare onesto” (Inf. II, 113). Mantova, patria del poeta latino, concorda con “manto” nel suono e anche nel significare i “parentum magnalia”, la grandezza dei padri. Così Virgilio si presenta a Dante dicendo: “e li parenti miei furon lombardi, / mantoani per patrïa ambedui” (Inf. I, 68-69).
***
nel tempo de li dèi falsi e bugiardi
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
nel tempo de li dèi falsi e bugiardiMolti son li animali a cui s’ammoglia
|
72100114 |
17, 117, 217, 1 |
VI |
La meretrice designa la gente e l’impero dei Romani sia nello stato del paganesimo sia in quello cristiano, durante il quale colpevolmente fornicò molto con questo mondo. Viene chiamata “grande meretrice” (Ap 17, 1) poiché venendo meno al culto fedele, al sincero amore e ai piaceri del suo sposo aderisce alle ricchezze e alle delizie di questo mondo e al diavolo, come pure ai re, ai magnati, ai prelati e a quanti amano questo secolo. Inoltre, nello stato del paganesimo, adorò falsi dèi quasi fossero suoi mariti adulterini (gli “dèi falsi e bugiardi” al tempo dei quali visse Virgilio, Inf. I, 71-72). L’unirsi dei carnali alla prostituta per molte colpe (Ap 17, 2) corrisponde all’ammogliarsi della lupa con molti animali (Inf. I, 100).
Come, ad Ap 17, 1, l’angelo invita Giovanni a vedere la dannazione e la malizia della meretrice, perché ciò giova assai, in quanto chi non le conosce viene facilmente ingannato dai cenni dei suoi occhi e dalla sua gloria, così nell’Eden Beatrice invita Dante a tenere gli occhi sul carro della Chiesa e a scrivere poi, una volta ritornato di là, quel che ha visto “in pro del mondo che mal vive” (Purg. XXXII, 103-105; passo riconducibile anche ai vari luoghi dell’Apocalisse in cui a Giovanni si ingiunge di scrivere).
Ancora, la funzione dell’angelo che trae i discepoli all’insegnamento spirituale viene svolta da Virgilio nell’offrirsi come guida: “Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno / che tu mi segui, e io sarò tua guida, / e trarrotti di qui per loco etterno; / ove udirai le disperate strida, / vedrai li antichi spiriti dolenti, / ch’a la seconda morte ciascun grida” (Inf. I, 112-117).
“Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi” (v. 70). Virgilio, nato nel 70 a.C., aveva solo ventisei anni nel 44 a.C. Tardare, nell’esegesi di Ap 3, 3, è congiunto con la morte improvvisa (“repentinus interitus”) che può impedire la conversione; il passo è soggetto nei versi a numerose variazioni (ad esso fanno riferimento le parole di Virgilio in Purg. VII, 25-27 e quelle di Adriano V in Purg. XIX, 106-108, dove la rima tarda/bugiarda è consonante con tardi/bugiardi di Inf. I, 70.72; cfr. anche Beatrice a Inf. II, 65). In questo caso può significare che Virgilio non visse sub Iulio a causa del suo assassinio, ma sotto ‘l buono Augusto.
***
Poeta fui, e cantai di quel giusto / figliuol d’Anchise che venne di Troia
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
Poeta fui, e cantai di quel giusto
|
73
|
15, 3-4 |
R5 |
Ad Ap 15, 3-4 il canto dell’Agnello, di pietà, d’amore e di libertà designa la pietà del figlio mitissimo che ama il padre e si contrappone al canto di Mosè, di terrore per il giudizio divino e di servitù: si tratta delle due vie di Dio, della giustizia e della misericordia; entrambe, la giustizia e la pietas filiale, si ritrovano nel “cantai di quel giusto / figliuol d’Anchise che venne di Troia” ad Inf. I, 73-74 (di queste due vie dicono Virgilio, Beatrice, l’aquila e san Bernardo rispettivamente a Purg. XI, 37, Par. VII, 103-105, XIX, 13, XXXII, 117).
Di Cristo è proprio il primato dell’amore con il quale ci lavò dai peccati (Ap 1, 5), con la differenza che l’amore di Cristo non è dovuto, come quello di Ulisse verso la sposa, ma proviene dalla sua gratuita carità (cfr. la “vox sponsi et sponse” ad Ap 18, 22-23, interpretata come “letitia nuptiarum”). Non c’è carità in Ulisse: “né dolcezza di figlio, né la pieta / del vecchio padre, né ’l debito amore / lo qual dovea Penelopè far lieta, / vincer potero dentro a me l’ardore / ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto / e de li vizi umani e del valore” (Inf. XXVI, 94-99). Anche il richiamo agli affetti familiari è permeato, in senso negativo, di temi propri di Cristo, cui appartiene la dolcezza: Cristo insegnò infatti con dolcezza quasi cantando un canto dolce mentre Giovanni Battista usò un tono terribile come lamentando e minacciando il “guai!” dell’eterna dannazione (Ap 14, 6-9).
Tab. XIII
[LSA, cap. XV, Ap 15, 2-4 (Va visio, radix)] Unde subditur: “(Ap 15, 2) Habentes citharas Dei (Ap 15, 3) et cantantes canticum Moysi servi Dei et canticum Agni”. Canticum utriusque in hoc convenit, quod uterque cantavit de pia liberatione electorum et de terribili submersione seu perditione hostium. Differunt autem in hoc, quod canticum Moysi fuit sicut servi, cuius est timere Dominum terribilem in iudiciis; canticum vero Agni fuit vere filii mitissimi, cuius est filialiter amare patrem et consequi eius hereditatem. Ergo isti cantant simul canticum timoris ut servi et amoris ut filii, et hoc ipsum patet ex materia cantici eorum, unde subditur: “dicentes: Magna”, scilicet in se, “et mirabilia”, scilicet contemplantibus, “sunt opera tua, Domine Deus omnipotens”. Pro operibus autem seu iudiciis iustitie, subdunt: “Iuste et vere vie tue”, id est opera tua, “rex seculorum. (Ap 15, 4) Quis non timebit te, Domine, et magnificabit nomen tuum?”. Pro operibus vero misericordie, subdunt: “Quia solus pius es”, scilicet per se et substantialiter et summe; “quoniam omnes gentes venient”, scilicet ad te tamquam a te misericorditer vocate et tracte, “et adorabunt in conspectu tuo, quoniam iudicia tua manifesta sunt”, scilicet per evidentes effectus perditionis Antichristi et suorum et salvationis electorum.[LSA, cap. XIV, Ap 14, 6-9 (IVa visio)] […] iuxta quod Christus suaviter docuit, quasi cantans canticum dulce; Iohannes vero Baptista terribilius, quasi lamentans et comminans ve dampnationis eterne […]. |
||
Purg. XI, 37-39
|
Inf. XXVI, 94-99né dolcezza di figlio, né la pieta
|
|
***
Ma tu perché ritorni a tanta noia?
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
Ma tu perché ritorni a tanta noia?anima fia a ciò più di me degna |
76122 |
5, 4-55, 2 → Inf. II, 33 |
R2 |
Nessuno, se non Cristo, può fondare o promuovere il pieno sviluppo dei sette stati che si succedono nella storia umana, caratterizzati da sigilli che chiudono, totalmente o parzialmente, le illuminazioni divine. Per questo Giovanni dice: “Vidi un angelo forte che predicava a gran voce: ‘chi è degno di aprire il libro e di scioglierne i sette sigilli?’ (Ap 5, 2)”. Oltre che gli spiriti angelici, questo angelo designa i santi profeti, e in particolare Giovanni Battista, che predicarono l’impossibilità che una semplice creatura aprisse il libro. Il Battista infatti disse per sé e per tutti gli altri: “verrà uno più forte di me al quale io non sono degno di sciogliere il laccio del sandalo” (Mc 1, 7; Jo 1, 27).
Il tema della propria indegnità è cantato prima da Virgilio, che dice a Dante che lo lascerà con anima più degna, quella di Beatrice, quando vorrà salire alle beate genti (Inf. I, 121-123). Poi è Dante stesso a non ritenersi degno di andare “ad immortale secolo” dopo Enea e san Paolo (Inf. II, 31-33).
Alla constatazione di impotenza e di indegnità fa seguito il gemito di Giovanni che proviene dal desiderio che il libro venga aperto. Egli dice infatti: “Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo” (Ap 5, 4). Questo pianto, sostiene Olivi, è proprio dei momenti (al tempo degli apostoli, delle grandi eresie quando fu lutto per la Chiesa, e dell’Anticristo) nei quali quanti sono inconsapevoli della ragione che permette le tribolazioni e le “pressure” causate dalle eresie, nonché il terrore provocato dall’imminenza dei pericoli, piangono e sospirano affinché il libro segnato da sette sigilli venga aperto, almeno per la parte che è consentito aprire in quel tempo. Virgilio mostra di non comprendere la ragione della ‘pressura’ di Dante, nuovo Giovanni che piange nella “diserta piaggia”: “Ma tu perché ritorni a tanta noia?” (Inf. I, 57, 76).
***
perché non sali il dilettoso monte
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
perché non sali il dilettoso monte |
77 |
21, 10 |
VII visio |
Il “monte” è “colle” al v. 13, con riferimento all’esegesi di Ap 6, 14-17. Per quanto con “monte” Virgilio intenda la montagna del purgatorio, sulla cui sommità terminerà la sua funzione di guida, l’immagine della montagna, come si sviluppa nell’esegesi di Ap 21, 10 (la Gerusalemme celeste, l’alto monte della contemplazione e dell’anagogia al quale viene elevato Giovanni) viene sviluppata anche nella descrizione del paradiso.
Il v. 78 – “ch’è principio e cagion di tutta gioia” – cuce parte del Salmo 136, 6: “in principio laetitiae meae”, riferito a Gerusalemme, con l’Etica di Aristotele (Eth. Nic. 1102a, 1-4): “Felicitas principium et causa bonorum”.
***
Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume?
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte
|
79
|
Not. VI; 8, 10; 13, 1 |
III |
All’inizio della sua digressione sulle origini di Mantova, nella quarta bolgia, Virgilio utilizza il motivo – proprio della terza tromba – delle acque che dalle fonti si fanno fiume (Ap 8, 10; Inf. XX, 64, 75). Per “fonti” si possono intendere i libri canonici della Scrittura e i loro autori, come i profeti e gli apostoli. Con i “fiumi”, che derivano dalle fonti, vengono designati i commenti ai libri canonici e i loro espositori o editori: tali commenti sono infatti quantitativamente maggiori dei libri canonici, al pari dei fiumi che rispetto alle fonti contengono più acqua, derivante da più fonti.
Nel “gran diserto” Dante si rivolge a Virgilio, suo maestro e “autore”, definendolo “quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume” (Inf. I, 79-80), ‘scrittura’ antica dai molti commenti. I due versi, oltre che con Ap 8, 10, possono essere confrontati anche con quanto, nel Notabile VI del prologo, si afferma di Cristo, definito fonte, medio e termine della Chiesa e dei suoi stati. Per i primi cinque stati la Chiesa procede nella storia come uno stretto condotto derivato dalla fonte; al sesto l’acqua dal condotto si diffonde in un grande lago, al modo di un albero che da una radice e da un tronco si espanda poi largamente in rami fruttuosi. Espandersi dal particolare all’universale è proprio dello spirito profetico (cfr. supra). |
Nel lago Benaco (il lago di Garda) “stagna” l’acqua che deriva “da mille fonti … e più”, della quale “si bagna” tutta la zona “tra Garda e Val Camonica e Pennino” (Inf. XX, 61-66). A Peschiera, dove la riva del lago più discende, tutta l’acqua che non può essere contenuta nel Benaco cade giù facendosi fiume “per verdi paschi” (vv. 73-75). Nei versi è da notare l’intreccio di temi provenienti da passi diversi. Lo ‘stagnare’ dell’acqua nel lago proviene da Ap 18, 17, dove “lago” viene appunto interpretato come “stagno di acque dolci”. Il ‘bagnarsi’ della zona alpina ha un suo riferimento, ad Ap 1, 5, nel lavare i peccati degli uomini ad opera della redenzione di Cristo (si tratta dell’unica presenza di “balneum” nella Lectura: il motivo del sangue, altrove utilizzato nel poema, è qui taciuto). Ancora a una prerogativa di Cristo, il potere salutare di elevare dalla morte alla vita eterna (Ap 1, 18), sono connesse la prima e l’ultima parola della terzina formata dai versi 61-63: “Suso in Italia bella … c’ha nome Benaco”. Il corrispondere dell’avverbio e della prima parte del nome del lago con il “bene possum te … sublevare” non appare interpretazione forzata se si confronta con altre utilizzazioni del medesimo passo.
Da notare l’accostamento, nella terzina ai versi 70-72, dell’espressione “Siede Peschiera” (il quinto stato viene assimilato alla “sede” romana: prologo, Notabile V) al discendere della riva del lago Benaco, per indicare il luogo dove “convien che tutto quanto caschi / ciò che ’n grembo a Benaco star non può”, prima di farsi fiume, allusione parodica alla difficoltà a mantenersi in uno stato tanto arduo come il quarto e alla necessità di una vita “condescensiva” nel quinto (vv. 73-75; ma già il Benaco è “a piè de l’Alpe”; cfr. il discendere del Chiascio a Par. XI, 43). Il quinto stato corrisponde al quinto giorno della creazione, nel quale Dio disse agli uccelli (i monaci, più spirituali) e ai pesci (i chierici, commisti alle genti): “crescete e moltiplicatevi” (Genesi 1, 22). Così i monasteri e le chiese si sono propagati nella chiesa occidentale, e la vita, pur non tanto chiara per fama come nel quarto stato, si è svolta però con un “senso vivo e tenero della pietà”, al modo con cui gli uccelli e i pesci sono più dotati nel sentire dei “luminaria celi”, cioè del sole, della luna e delle stelle assimilati ai contemplativi del quarto tempo (prologo, Notabile XIII). Il Benaco, dunque, il discendere della sua riva e della sua acqua fino a Peschiera e oltre (“e fassi fiume giù per verdi paschi”) sono figure geografiche che designano il quinto stato della Chiesa nel suo bell’inizio (“in Italia bella… bello e forte arnese”: Ap 2, 1), condescensivo, aperto alle moltitudini (i pesci) riunite attorno alla sede romana, cui “Peschiera” allude. Al quinto stato appartiene, a differenza del solitario quarto stato che lo precede, la capacità di ricevere le moltitudini, cioè la vita associata (prologo, Notabile V), e corrisponde nei versi al “Gìà fuor le genti sue dentro più spesse”, espressione riferita agli abitanti di Mantova, “prima che la mattia da Casalodi / da Pinamonte inganno ricevesse” (vv. 94-96).
Tab. XIV
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 10 (IIIa visio, IIIa tuba)] Nota autem quod per “fontes” possunt intelligi libri sacri canonis et scriptores eorum, scilicet prophete et apostoli. Per “flumina” vero, que de fontibus trahuntur, possunt intelligi subsequentes expo-sitiones librorum canonis et expositores seu editores earum. Ille enim sunt instar fluminum quantitate maiores et aquam plurium fontium in se continentes. |
|
|
[LSA, prologus, Notabile VI] Dicendum quod cum in visionibus huius libri agatur de primordiali ac medio et finali statu ecclesie, Christus autem, prout in principio et fine huius libri dicitur esse “alpha et o” (cfr. Ap 1, 8; 21, 6; 22, 13), id est principium et finis, per <que> tamquam per extrema subintelligitur quod etiam ipse est medium et mediator, satis decuit quod in hiis visionibus premitteretur Christus tamquam radicale et fontale principium totius ecclesie et omnium statuum eius, ac deinde quod in medio processu statuum refulgeret eius mediatio, et in fine quod ipse est omnium consumator et finis.
|
||
[LSA, cap. I, Ap 1, 17-18 (radix Ie visionis)] Deinde explicat sibi illas suas perfectiones ex quarum fide et notitia amplius poterat confortari. Subdit ergo tres binarios suarum perfectionum. Primus est: “Ego sum primus et novissimus” (Ap 1, 17), id est omnium principium et finis, seu principiator et consumator, vel “primus” dignitate et eternitate “et novissimus” humilitate, per quam usque ad mortem crucis me humiliavi.
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (Ia visio, Va ecclesia)] Vocatur autem congrue hec ecclesia Sardis, id est principium pulchritudinis, tum quia in suis paucis incoinquinatis habet singularem gloriam pulchri-tudinis, quia difficillimum et arduissimum est inter tot suorum luxuriantes se omnino servare mundum; tum quia primi institutores quinti status fuerunt in se et in suis omnis munditie singulares zelatores, suorumque collegiorum regularis institutio, diversa membra et officia conectens et secundum suas proportiones ordinans sub regula unitatis condescendente proportioni membrorum, habet mire pulchritudinis formam toti generali ecclesie competentem, que est sicut regina aurea veste unitive caritatis ornata et in variis donis et gratiis diversorum membrorum circumdata varietate.Inf. XX, 61-66, 70-75Suso in Italia bella giace un laco,
|
|
***
rispuos’ io lui con vergognosa fronte
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
rispuos’ io lui con vergognosa fronteoh felice colui cu’ ivi elegge! |
81129 |
7, 3 → Inf. II, 44-45, 61, 105, 122 |
VI |
Il riferimento è all’esegesi della “signatio” (Ap 7, 3-4), i cui temi sono soggetti nel poema a numerose variazioni.
***
A te convien tenere altro vïaggio
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
A te convien tenere altro vïaggio |
91 |
18, 4 (1, 1) |
V |
Si tratta della necessità di uscire da Babylon (la Chiesa carnale) per non essere contaminati dai suoi mali (Ap 18, 4), tema che risuona, oltre che nelle parole di Virgilio, anche in quelle di Brunetto Latini e di Cacciaguida (Inf. XV, Par. XVII: da notare la coincidenza nel numero dei versi: 61-69).
***
rispuose, poi che lagrimar mi vide
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
rispuose, poi che lagrimar mi vide |
92 |
3, 18 (5, 5) → Inf. II, 116 |
VII |
Cfr. supra.
***
se vuo’ campar d’esto loco selvaggio
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
se vuo’ campar d’esto loco selvaggio |
93 |
6, 2 → Inf. II, 68 |
I |
“Campare”, nel senso di ‘salvarsi’, è parodia del tema del “campo” nell’esegesi di Ap 6, 2, esaminata altrove.
***
e più saranno ancora, infin che ’l veltro / verrà
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
e più saranno ancora, infin che ’l veltro
|
101
|
Not. VIII; 10, 1 |
VI |
Questi non ciberà terra né peltro,
|
103
|
10, 1; 19, 17-18 |
VI |
La figura di Elia compare in più punti della Lectura super Apocalipsim. Il profeta ha un ruolo particolare da svolgere nel corso del sesto stato della Chiesa, cioè nei tempi moderni. Nel Notabile VIII del Prologo, a seguito di una collazione tra vari passi scritturali, tratti dalla stessa Apocalisse (10, 11; 11, 3-13), da Matteo 17, 11 e da Malachia 4, 5-6, si conclude che nel sesto stato il libro della sapienza cristiana dovrà essere compiutamente aperto, mangiato e nuovamente predicato a tutte le genti e che Elia, insieme all’altro testimone, verrà prima del gran giorno del Signore per convertire i cuori dei padri verso i figli e dei figli verso i padri, cioè convertirà i cuori dei Giudei alla fede e all’intelligenza dei santi padri e dei profeti. Egli ristabilirà ogni cosa e verrà ucciso insieme con l’altro testimone dalla bestia che sale dall’abisso, ma solo secondo l’umana apparenza, perché i due risorgeranno dopo tre giorni e mezzo per ascendere al cielo, mentre un grande terremoto farà perire settemila nemici e farà sì che gli altri, presi da terrore, rendano gloria al Dio del cielo convertendosi (Ap 11, 7-13).
Con Elia (o anche con Enoch, il testimone associato), Gioacchino da Fiore identifica l’angelo della sesta tromba di Ap 10, 1, che ha la faccia come il sole, anche se soggiunge che questo “magnus predicator” spiritualmente può essere riferito a più futuri uomini spirituali di quel tempo. Olivi vede nell’angelo Francesco, che apparve nel carro di fuoco trasfigurato nel sole per mostrare di essere venuto nello spirito e nell’immagine di Elia. L’identificazione con Francesco accentua il tema dell’altissima povertà, designata nel suo essere oscuro e umile dalla nube che avvolge l’angelo (cfr. Par. XI, 64-72).
Nel capitolo XIX dell’Apocalisse, nella parte che tratta della dannazione della bestia e dello pseudoprofeta dopo la battaglia finale contro l’Anticristo – che si verificherà appunto nel sesto stato -, Giovanni vede un angelo che fissa gli occhi al sole: rappresenta gli alti e preclari contemplativi, la cui mente e la cui vita sono tutte fisse nella solare luce di Cristo e delle sacre scritture (Ap 19, 17-18: “E vidi un angelo che stava nel sole”; esegesi fondamentale nella descrizione dell’ascesa al cielo in Par. I). L’angelo “gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volavano in mezzo al cielo”, cioè a tutti gli uomini evangelici e contemplativi di quel tempo: “venite, radunatevi alla gran cena di Dio”. Questo angelo – secondo Gioacchino da Fiore (Expositio in Apocalipsim) si tratta di Elia, che anche Gregorio Magno chiama “convivantium invitator” – invita allo spirituale e serotino convivio di Cristo dove verrà divorata la carne soggetta a corruzione, che passerà, in modo che resti ciò che è spirituale. Per questo dice: “mangiate le carni dei re, le carni dei tribuni, le carni dei forti, le carni dei cavalli e le carni degli uomini, liberi e servi, pusilli e grandi”. L’invito alla spirituale divorazione significa l’incorporare in Cristo e nella sua Chiesa i popoli e i re, al modo con cui negli Atti degli Apostoli viene detto a Pietro di uccidere e mangiare quadrupedi, serpenti e volatili visti in un gran vaso (Ac 10, 9-16). I santi saranno ristorati dal gaudio, dall’amore e dalla dolcezza per la conversione dei Gentili e di Israele che avrà luogo dopo la morte dell’Anticristo.
Elia si presenta come un uomo spirituale vòlto alla conversione universale e alla generale restituzione di uno stato precedente, precursore dei tre avventi di Cristo (nella carne, nello Spirito, nel giudizio) in tre differenti persone, due allegoriche (Giovanni Battista e Francesco) e una letterale (Elia stesso, prima del terzo avvento che coincide con il giudizio finale). Ad Ap 7, 4, Olivi ricorda che quanto più letteralmente il senso dell’esegesi riguarda i beni o i fatti finali, tanto è più spirituale dei sensi allegorici che lo precedono, per cui più letteralmente e propriamente si dice che Dio è vita, sapienza, sommo bene piuttosto che leone o sole o rugiada; il detto più letterale è più spirituale e perfetto di quello traslato e allegorico. Virgilio, parlando del “veltro”, si esprime allegoricamente; dicendo “sapienza, amore e virtute” usa il senso letterale.
Il veltro, allegoria che si presenta anch’essa con indubbia veste spirituale, potrebbe essere un acronimo costruito su Matteo 17, 11: V(enturus) EL(ias) (e)T R(estituet) O(mnia).
La rima feltro–veltro–peltro è nel Serventese romagnolo 41-43 (fra il 1276 e il 1283), riferito a Guido da Montefeltro dove, però, il veltro appare assalito (dal leone) e non assalitore (della lupa):
Fol ne stia en statu, – ched a lui è nula Feltro!
En levere s’è avançatu, – e ’l leone asalì lu veltro,
ché paragunato – s’è l’oro e peltru
del sapere [1].
La stessa scelta del “veltro”, il cane da caccia contrapposto alla lupa che ispira “gravezza”, deriva dall’agilità e dalla velocità, caratteristiche che nella Lectura sono connesse ai significati di ‘spirituale’ (anche nel senso di spiriti immondi, come ad Ap 18, 2), ‘sottile’ (Ap 5, 6), ‘povero’ (Ap 10, 1).
Amore e sapienza sono, ad Ap 7, 12, nella lode resa a Dio dagli angeli, dai seniori e dai quattro animali, le due principali perfezioni divine alle quali tutte le altre si riconducono. Esse includono la “virtù”, cioè la virtuale potenza ad operare effetti miracolosi e soprannaturali [2]. “Sapienza, amore e virtute”, di cui si ciberà il veltro, sono comunque attributi dell’angelo della sesta tromba che ha la faccia come il sole: Francesco fu infatti singolarmente forte in ogni virtù; sarà avvolto nel suo discendere da una nube, cioè dalla scienza delle Scritture, la quale sarà spiritualmente nella carità e nella sapienza di Dio come il sole che irradia alla fine tutta la terra formando il giorno solare del terzo stato generale del mondo (Ap 10, 1). La citazione di Gioacchino da Fiore, ad Ap 10, 1, incide sul risveglio dal sonno nell’Eden (Purg. XXXII, 70-78); l’esegesi è parodiata nel panegirico di Francesco a Par. XI.
Muovendo da un principio di coerenza interna al poema, una parte di queste prerogative dell’angelo del capitolo X si ritrova in Cangrande, come descritto da Cacciaguida. Gli sono propri l’essere forte nella virtù e nelle opere e libero da ogni peso temporale, impresso da una “stella forte” (quella di Marte) che renderà “notabili” le sue opere, anche se finora le genti non si sono accorte di lui “per la novella età, ché pur nove anni / son queste rote intorno di lui torte” (Cangrande nacque nel 1291). La sua virtù, di cui “parran faville”, consisterà “in non curar d’argento né d’affanni”, cioè nel disprezzo delle ricchezze e delle sollecitudini temporali (Par. XVII, 76-84). Farà inoltre cambiare a molti condizione sociale: “per lui fia trasmutata molta gente, / cambiando condizion ricchi e mendici” (vv. 89-90). Quest’ultima qualità potrebbe assimilarlo a Elia che verrà a ristabilire tutto. Il “restituet omnia” di Matteo 17, 11 va collazionato con il passo del Notabile VII del prologo della Lectura, relativo alla “commutatio” del pontificato, inizialmente povero, poi ricco a partire da Costantino e infine prossimo a tornare povero.
Al veltro è dedicato un saggio pubblicato su questo sito; cfr. anche supra, nella premessa.
[1] Cfr. Poeti del Duecento, a cura di Gianfranco Contini, I/2, Milano-Napoli 19952 (1960), p. 881.
[2] LSA, cap. VII, Ap 7, 12: «Vel potest dici quod quia in Deo sunt due principales perfectiones ad quas cetere reducuntur, tamquam generales ad suas specificas aut tamquam ipsarum duarum efficaciam vel efficientiam vel precellentiam exprimentes, ille autem due sunt amor superoptimus et sapientia summe lucens, ideo primo attrib<uunt> ei generaliter rationem summi boni ab omnibus benedicibilis, cum dicunt “benedictio”; secundo generalem rationem summe lucis, cum dicunt “et claritas”; tertio specificam rationem huius secundi, cum dicunt “et sapientia”; quarto multiplicem effectum ipsorum, et specialiter primi, subinnuendo specificam rationem eius, cum dicunt “et gratiarum actio”, que est pro bonis a summo bono ex summa et summe gratuita caritate influxis et receptis, et etiam pro ipsa caritate Dei ad eos. Ex hiis enim debent semper agere et referre summas gratias Deo. Summam autem dominationem et precellentiam super omnes et super omnia exprimunt, et etiam actum venerationis ei debitum tangunt, cum dicunt “et honor”. Deinde virtualem potentiam seu efficaciam in Dei sapientia et voluntate inclusam tangunt, distinguendo eam in duas rationes sive respectus. Primo scilicet respectu supernaturalium effectuum et respectu supernaturalis seu transcendentis modi agendi, cum dicunt “et virtus”, que in scriptura sacra semper sumitur pro miraculosis effectibus et pro potentia effectiva ipsorum. Secundo respectu recte et ordinate et viriliter ac imperturbabiliter agendorum, et hoc videtur tangere cum subdunt “et fortitudo”».
Tab. XV
[LSA, prologus, Notabile VIII] Item sub sexto angelo tuba canente scribitur descendere angelus habens faciem solis et in manu sua librum apertum, qui scilicet liber erat prius visus septem signaculis clausus, et clamavit quod in tempore septimi angeli tuba canentis consumabitur misterium Dei per suos prophetas evangelizatum (Ap 10, 1-7), datoque libro Iohanni, id est contemplativo et evangelico statui per Iohannem designato, dixit sibi: “Oportet te iterum prophetare populis et gentibus et linguis et regibus multis” (Ap 10, 11); subditque de civitate sancta calcanda mensibus quadraginta duobus (Ap 11, 2) et de duobus testibus eodem tempore prophetaturis et prodigia magna facturis et tandem de occisione et resurrectione ipsorum (Ap 11, 3-12) et quod, preter septem milia hostium tunc a Deo occisa, “reliqui in timorem sunt missi et dederunt gloriam Deo” (Ap 11, 13), id est conversi sunt ad Christum. Christus autem Matthei XVII° dicit quod “Helias venturus est et restituet omnia” (Mt 17, 11), iuxta quod et Malachie ultimo dicitur: “Ecce ego mittam vobis Heliam prophetam, antequam veniat dies Domini magnus, et convertet cor patrum ad filios et cor filiorum ad patres” (Ml 4, 5-6). Ergo ex istorum mutua collatione habetur quod in sexto tempore ecclesie debet liber christiane sapientie aperiri plenius et comedi et universis gentibus iterum predicari, et quod Helias cum altero conteste sibi consociato sit tunc venturus ad convertendum corda Iudeorum ad fidem et intelligentiam sanctorum patrum et prophetarum et, ut Christus asserit, venturus est ad omnia restituenda, sicque cum suo conteste occidetur a bestia que ascendit de abisso, prout dicit Iohannes ibidem (Ap 11, 7). |
|
V(enturus est) EL(ias) (e)T R(estituet) O(mnia)
|
|
Inf. I, 100-105Molti son li animali a cui s’ammoglia,
|
Purg. XXXII, 70-78Però trascorro a quando mi svegliai,
|
[LSA, cap. X, Ap 10, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] Et subdit (Ioachim): «Ego autem angelum istum secundum litteram aut Enoch fore puto aut Heliam. Verum, prout hoc Deus melius novit, unum dico pro certo, quod hic angelus significat personaliter magnum aliquem predicatorem, quamvis spiritaliter ad multos viros spiritales tunc temporis futuros competenter valeat intorqueri. Sane facies angeli similis est soli, quia in hoc sexto tempore oportet Dei contemplationem in modum solis splendescere et perduci ad notitiam eorum qui designantur in Petro et Iacobo et Iohanne, id est Latinorum et Grecorum et Hebreorum, primo quidem Latinorum, deinde Grecorum, tertio Hebreorum, ut fiant novissimi qui erant primi et e contrario». Hec Ioachim*.
|
|
***
e sua nazion sarà tra feltro e feltro
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
e sua nazion sarà tra feltro e feltro |
105 |
5, 5; 12, 6 |
I |
La concordia fra dissimili è per Gioacchino da Fiore la chiave per comprendere il rapporto tra Vecchio e Nuovo Testamento, come dimostra l’ampia citazione che Olivi considera ad Ap 12, 6. Gioacchino sostiene che la concordia non è esigibile in modo assoluto. Come la persona del figlio è simile a quella del padre, e tuttavia altra è la natura del padre e altra quella del figlio, così il Nuovo Testamento è simile al Vecchio, ma ha diversa natura. I due Testamenti sono come alberi simili nel tronco ma dissimili nei rami e nelle foglie, ed è pertanto fallace volerli legare con un’unica legge di concordia. Colui che ha condotto con sapienza le cose, dove ha voluto ha inserito tra i fili generali vari colori, così da decorare in modo diverso la superficie delle tele e da far apparire la diversità tra tela e tela.
Nel cielo di Venere, Carlo Martello, affermato il principio aristotelico che un ordinato vivere civile comporta la differenziazione delle indoli e degli uffici, sostiene che “le radici” dell’operare umano debbono essere diverse in ciascuno, per cui c’è chi nasce legislatore, come Solone, e chi guerriero, come Serse; chi sacerdote, come Melchisedech, e chi artefice, come Dedalo. La natura dei figli sarebbe sempre simile a quella dei padri (le tele, l’antica e la nuova, sarebbero sempre uguali) se la provvidenza divina non intervenisse a rendere dissimili le indoli per mezzo degli influssi celesti (i fili di colori diversi) come, si dirà due canti dopo, ha reso dissimili i due moti del cielo, uno dei quali “si dirama” dall’altro (gli alberi sono simili nelle radici, dissimili nei rami e nelle foglie; Par. X, 13-15). In tal modo i cieli imprimono nei singoli uomini il suggello di una particolare indole, non distinguendo da casa a casa: così è avvenuto che Esaù sia stato diverso dal gemello Giacobbe fin nel concepimento e che un eroe, Romolo, sia nato da un padre di così vili origini da doverlo poi considerare generato da Marte (Par. VIII, 118-135).
Le parole di Carlo Martello in Par. VIII, se lette alla luce del commento apocalittico oliviano, sono una potente conferma della più antica tesi relativa al veltro (già propria di Jacopo Alighieri: 1322), secondo la quale “tra feltro e feltro” (Inf. I, 105) significherebbe ‘tra cielo e cielo’. Virgilio intende dire che il veltro nascerà in un’ottima disposizione degli influssi celesti. Non diversamente Dante parla nel Convivio (IV, v, 3-9) della “radice di David”, per dimostrare che il disegno divino di inviare un “celestiale rege” da una progenie purissima – quella di Iesse padre di David, secondo la profezia di Isaia – dalla quale nascesse Maria, “la baldezza e l’onore dell’umana generazione”, coincise con l’altro disegno, la divina elezione dell’impero romano: David nacque infatti nello stesso tempo in cui nacque Roma, cioè in cui Enea venne da Troia in Italia. Ad Ap 5, 5 si afferma che Cristo nascerà dalla radice di David in quanto radice di tutta la vita spirituale precedente e successiva, sia dei fedeli venuti dopo di lui, sia dei santi padri che precedettero. Come tutti i rami di un albero procedono dalla radice e in essa trovano solidità, così tutto l’albero dei santi padri del Vecchio e del Nuovo Testamento procede da Cristo e da lui prende vigore. Il veltro nascerà dunque anch’egli, come Cristo, dalla progenie di David, radice di quanti vennero prima e dopo di lui, mediatore tra padri e figli, tra vecchio e nuovo, “tra feltro e feltro”.
L’antico poeta non conosce, però, il momento preciso, per cui genericamente dice “tra feltro e feltro – inter telam et telam”, fa cioè riferimento a tele ancora prive del suggello del sommo artefice. Lo stesso Dante, d’altronde, mostra di ignorare tale momento allorché, maledicendo l’“antica lupa” e rivolgendosi proprio al cielo, lamenta a Purg. XX, 13-15: “O ciel, nel cui girar par che si creda / le condizion di qua giù trasmutarsi, / quando verrà per cui questa disceda?”.
Né questa tesi contrasta con quella per cui il veltro-Elia verrà, in un serotino convivio spirituale, a riconciliare Antico e Nuovo Testamento, padri e figli (cf. Matteo, 17, 11). Con il “cielo” viene infatti indicata la Sacra Scrittura: “per celum designatur hic ecclesia et scriptura sacra”, come scritto nell’esegesi di Ap 4, 2. L’intelligenza spirituale di questa, chiusa nella durezza del senso umano fino alla resurrezione di Cristo, sarà ancor più aperta nel sesto stato, il tempo moderno del secondo avvento nei suoi discepoli spirituali, nel quale sta già operando un novum saeculum [1].
San Bernardo varia il tema gioachimita, da Ap 12, 6, nell’esporre il motivo per cui, nella rosa celeste, i bambini sono collocati in gradi differenti: come nella creazione Dio assegna a suo piacimento alle anime una diversa dote di grazia, il che appare evidente nei due gemelli Esaù e Giacobbe i quali, l’uno inviso a Dio e l’altro eletto, furono discordi già nel grembo materno, così in proporzione di tal dono – “secondo il color d’i capelli” – i bambini vengono assegnati a diversi gradi di beatitudine non in base al merito che deriva dal loro operare ma in base alla differenza “nel primiero acume” loro innato, che è la disposizione a vedere Dio da questi data per grazia (Par. XXXII, 61-75).
I motivi dell’albero e del volere divino (Ap 12, 6) sono accostati in Purg. VII, 121-123, a sostegno del principio che la nobiltà umana non si trasmette per via di sangue, ma è dono di Dio ai singoli individui: “Rade volte risurge per li rami / l’umana probitate; e questo vole / quei che la dà, perché da lui si chiami”.
Il tema dell’essere i Testamenti simili e al tempo stesso dissimili, uno e insieme due, è presente parodisticamente rovesciato nei due ladri Cianfa Donati, già trasformato in serpente, e Agnolo Brunelleschi, ancora uomo, i quali mischiano il loro colore in modo che né l’uno né l’altro paia quello che era ed essi non siano né due né uno: così il colore bruno, che procede innanzi al fuoco su un foglio acceso, non è ancora nero ma il bianco si perde (Inf. XXV, 61-69). Nella successiva trasformazione del serpente in uomo e dell’uomo in serpente, operata fra Guercio Cavalcanti e Buoso, il fumo che emana dai due “vela di color novo” entrambi (vv. 118-119).
Il motivo della varietà dei colori è proprio di Gerione, che ha il dorso, il petto e i fianchi “dipinti … di nodi e di rotelle” con tanta ricchezza di colori come mai furono i drappi dei Tartari o dei Turchi, e con tanta complessità nel disegno come mai Aracne impose le sue tele (Inf. XVII, 14-18).
Proprio il riferimento ad Aracne conduce di nuovo ai luoghi sopra citati del cielo di Venere, dove dopo Carlo Martello parla Cunizza, la quale utilizza il tema della tela per profetizzare la trama che s’appresta contro Rizzardo da Camino, il signore di Treviso e vicario imperiale ucciso a tradimento nel 1312: “e dove Sile e Cagnan s’accompagna, / tal signoreggia e va con la testa alta, / che già per lui carpir si fa la ragna” (Par. IX, 49-51). Da notare la corrispondenza tra “qui cuncta fecit in sapientia”, della citazione di Gioacchino da Fiore sulle due tele decorate da fili di diversi colori, e “non fer mai drappi Tartari né Turchi … si fa la ragna”. Non sarà casuale che, subito dopo, Cunizza passi ad altra profezia che riguarda Feltro : “Piangerà Feltro ancora la difalta / de l’empio suo pastor, che sarà sconcia / sì, che per simil non s’entrò in malta”, piangerà cioè il tradimento perpetrato dal vescovo francescano di Feltre Alessandro Novello, nel luglio 1314, contro i fuorusciti ferraresi (vv. 52-54). Feltro, alludendo alla tela, perpetua la tematica del “si fa la ragna” della precedente profezia e concatena le due terzine (strettamente congiunte, concernendo entrambe i Da Camino e la Marca Trevigiana).
Ciò non significa che “tra feltro e feltro”, luogo natale del veltro, debba intendersi ‘tra Feltre e Montefeltro’, secondo una nota e antica interpretazione. La medesima esegesi è stata utilizzata sia per Inf. I, 105 come per Par. IX, 52. In questo secondo caso, “Feltro” (nome di luogo) ha assunto un valore significante (ragna–Feltro [tela]) per quei versi in cui la citazione del luogo è collocata. Ma è ben più difficile che “feltro” (nome di cosa) possa indicare due distinte località geografiche. In ogni caso, la conferma dell’interpretazione “tra feltro e feltro” come ‘tra cielo e cielo’ esclude l’interpretazione topografica.
Cunizza (Par. IX, 25-36) racconta di sé con i motivi della radice di David, del vecchio e del nuovo (Ap 5, 5; 22, 16). Sorella di Ezzelino da Romano – di “una facella / che fece a la contrada un grande assalto” – è una con lui nello stipite: “D’una radice nacqui e io ed ella”. Il forte contrasto tra il feroce tiranno punito nel Flegetonte che bolle di sangue (Inf. XII, 109-110) e la sorella vinta in terra dall’inclinazione amorosa, per influsso di Venere, stella dove ora rifulge, sembra accennare ai due Testamenti, il Vecchio e il Nuovo, che hanno entrambi una sola radice in Cristo. Più avanti nel canto, Folchetto di Marsiglia riprende il motivo dei due diversi Testamenti di una stessa Scrittura allorché, per precisare con complessa perifrasi il proprio luogo di origine, parla dei “discordanti liti” dell’Europa e dell’Africa, fra i quali è compresa “la maggior valle in che l’acqua si spanda … fuor di quel mar che la terra inghirlanda”, cioè il Mediterraneo (Par. IX, 82-84), precisando che Buggea (Bougie) in Africa e Marsiglia in Europa siano “ad un occaso quasi e ad un orto”, si trovino cioè sullo stesso meridiano (vv. 91-93). Non è l’unico caso in cui una descrizione geografica concorda con i sensi spirituali contenuti nella Lectura (basti ricordare, per tutte, la descrizione che Tommaso d’Aquino fa di Assisi a Par. XI, 43-54) [2].
[1] Cfr. Il sesto sigillo, 12.3. Il Veltro (PDF).
[2] Cfr. ALBERTO FORNI, Francesco e Domenico sulla soglia di una nuova era. Il tessuto apocalittico di Paradiso XI e XII nella Commedia di Dante, in “Collectanea Franciscana” 90 (2020), pp. 420-464: 446-450, 458-460.
Tab. XVI
Par. VIII, 118-135; IX, 31-33, 49-54, 82-87“E puot’ elli esser, se giù non si vive
|
Par. XXXII, 61-75Lo rege per cui questo regno pausa
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio)] Item, circa initium eiusdem partis, (Ioachim) dicit: «Sciendum quod concordia non secundum totum exigenda est, sed secundum id quod clarius et evidentius est; nec secundum cursum ystoriarum, sed secundum aliquid. Neque enim quod inter Abraam et Zachariam et inter Isaac et Iohannem Baptistam et inter Iacob et hominem Christum assignamus concordiam, idcirco querendus est in Zacharia filius ancille, sicut fuit in Abraam, aut in Iohanne et Christo uxores et filii carnis, sicut in Isaac et Iacob. Ut enim persona Filii similis est persone Patris, et tamen alia est Patris proprietas, alia Filii, ita Novum Testamentum est simile Veteri, tamen alia est proprietas Veteris et alia Novi. In quibus proprietatibus non est similitudo, quatinus in hoc quod est simile pateat Novum procedere a Veteri, et in hoc quod est dissimile intelligantur non esse unum sed duo. Sicut enim arbores sunt plerumque in stipitibus similes sed in ramis foliisque dissimiles, sic et duo Testamenta sunt in rebus generalibus similia sed in specialibus dissimilia, et ideo velle sub una concordie lege cuncta ligare decipere est. Nec enim debitum est ut non liceret ei, qu<i> cuncta fecit in sapientia, ire quo vellet, et generalibus, ut ita dixerim, filis interserere diversos colores, qui varietate sua telarum superficiem multo amplius decorarent et appareret quid differat inter telam et telam»*.* Concordia, IV 1, c. 2; Patschovsky 2, pp. 341, 14-342, 16. |
|
Inf. I, 100-105Molti son li animali a cui s’ammoglia,
|
Inf. XVII, 16-18Con più color, sommesse e sovraposte
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 5 (radix IIe visionis)] Deinde subditur consolatoria promissio: “Et unus de senioribus dixit michi: Ne fleveris: ecce vicit”, id est victoriose promeruit et etiam per triumphalem potentiam prevaluit, “leo de tribu Iuda”, id est Christus de tribu Iuda natus ac invincibilis et prepotens et ad predam potenter resurgens sicut leo. “Radix David”, id est radix totius spiritualis vite non solum fidelium qui post Christum fuerunt, sed etiam omnium sanctorum patrum precedentium. Sicut enim rami totius arboris prodeunt a radice et firmantur in ea, sic tota arbor sanctorum Veteris et Novi Testamenti prodit a Christo et firmatur in eo. Dicit autem “radix David” potius quam aliorum sanctorum patrum, tum ut innuat quod fuit fundamentalis radix et causa totius regni davitici et cultus Dei per eum instituti, tum ut ex hoc magis pateat Christum habere regiam dignitatem et potestatem super preteritos et futuros, tum quia singulariter fuit ei promissus, et hoc sic quod Christus nasciturus ex ipso constitueret et consumaret templum et regnum et cultum Dei; tum quia clavis David, id est spiritalis iubilatio psalmodie, est precipua clavis aperiens librum. |
|
***
Di quella umile Italia fia salute
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
Di quella umile Italia fia salute |
106 |
7, 10.12 (8, 7); 12, 10 |
VI – II |
per cui morì la vergine Cammilla,
|
107
|
12, 11; 7, 9.14 |
II – VI |
L’Italia, parodia della verdeggiante Giudea fattasi deserto e poi ultima umile convertenda, è stata considerata altrove.
***
Questi la caccerà per ogne villa
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
Questi la caccerà per ogne villa,
|
109
|
18, 17
|
VI |
L’esegesi è esposta altrove.
***
ove udirai le disperate strida
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
ove udirai le disperate strida,
|
115
|
2, 11 (20, 6) |
II – VII visio |
L’esegesi è esposta altrove.
***
ché quello imperador che là sù regna
parole-chiave |
vv. |
LSA |
status |
ché quello imperador che là sù regna,
|
124
|
17, 8.18 |
VI |
Il capitolo XVII della Lectura si chiude con un riferimento a Roma: “La donna che hai visto è la grande città che regna su tutti i re della terra” (Ap 17, 18). Ai tempi di Giovanni, Roma, “civitas magna”, imperava con la sua gente su tutto il mondo, e per tutto il periodo che san Paolo definisce “pienezza delle genti” (Rm 11, 25-26), fino all’Anticristo, Cristo ha stabilito in questa città la sede principale e universale del suo potere imperiale su tutte le chiese e su tutto il mondo, anche se molti le si ribellano contro. Le sette teste della bestia sulla quale siede la prostituta sono sette monti (Ap 17, 9), secondo il senso letterale corrispondono ai sette colli di Roma; designano anche i regni, come in Daniele 2, 34.35.44 la pietra staccatasi dal monte che distrugge la statua e si trasforma in un grande monte indica il regno eterno che distruggerà gli altri regni.
Se dopo l’Anticristo e l’incenerimento operato dai dieci re (Ap 17, 16) questa città venga di nuovo riparata, cosicché ritorni ad essere la principale sede di Cristo fino alla fine del mondo, oppure se Cristo riconduca la sua sede al luogo di origine, ad esempio a Gerusalemme, è problema che Olivi lascia decidere ai disegni divini, non trovando su questo punto alcuna certezza nei testi sacri o nei dogmi di fede.
“An … Christus post Antichristum reducat sedem suam ad locum unde manavit ad urbem Romam”: la “Roma onde Cristo è romano” è il paradiso e di esso – afferma Beatrice nell’Eden – Dante sarà con lei “sanza fine cive” (Purg. XXXII, 100-102). A questa Roma celestiale fanno riferimento le parole di Virgilio a Inf. I, 124-128, parodia dell’esegesi di Ap 17, 9.18: “imperabat, sedem suam, civitas, rebellent – imperador, regna, ribellante, sua città (2), impera, seggio”. |
Onde, parola-chiave di cui la tabella mostra numerose variazioni, in contrappunto con altri temi della medesima esegesi (si noti in particolare l’uso del verbo riparare), può avere sia un valore causale (la Roma di cui Cristo è primo cittadino), sia di moto da luogo (il luogo di elezione del romano impero). Lo stesso avverbio è presente in quanto Giustiniano dice di Cesare, con il quale il “sacrosanto segno” dell’aquila “Antandro e Simeonta, onde si mosse, / rivide e là dov’ Ettore si cuba”, rivide cioè la Troade da dove era salpato Enea per venire in Italia (Par. VI, 67-68). Nell’esegesi è presente un’idea di “translatio” del primato, da Gerusalemme a Roma e poi alla nuova Gerusalemme (non identificabile topograficamente tramite le Scritture), non estranea a Dante, se lo stesso Giustiniano afferma (ibid., 1-9) che l’aquila passò “di mano in mano”, ed anzi fu volta da Costantino “contr’ al corso del ciel, ch’ella seguio / dietro a l’antico che Lavina tolse” (e anche questo andare da Occidente a Oriente rientrò certamente nei disegni provvidenziali).
Tab. XVII
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 16 (VIa visio)] “Et decem cornua, que vidisti, et bestia” (Ap 17, 16), et etiam bestia seu rex bestie seu, secundum Ricardum, “et bestia”, id est diabolus*; “hii”, scilicet decem reges per cornua designati, “odient fornicariam et desolatam facient illam”, scilicet suis aquis seu populis in quibus consolatorie quiescebat, “et nudam”, scilicet suis ornamentis et divitiis, “et carnes eius manducabunt”, <id est crudeliter dilacerabunt et occident, “et ipsam igni concremabunt”,> id est eius urbes et terras cremabunt et incinerabunt, ut quasi non sit memoria vel signum prioris status vel glorie eius. * In Ap V, ix (PL 196, col. 835 C).[LSA, cap. XVII, Ap 17, 18 (VIa visio)] Deinde breviter insinuat que est hec mulier de qua et propter quam tanta dixit, unde subdit: “Et mulier, quam vidisti, est civitas magna, que habet regnum super reges terre”. Nimis constat quod Roma et gens Romanorum imperabat toti orbi tempore Iohannis et huius visionis, et etiam quod per totum tempus plenitudinis gentium usque ad Antichristum seu usque ad tempus istorum decem regum fixit Christus in ea principalem et universalem sedem et potestatem imperii sui super omnes ecclesias et super totum orbem. An autem post Antichristum hec urbs iterum reparetur, ut ibi usque ad finem seculi stet principalis sedes Christi sicut fuit a tempore Christi et citra, aut Christus post Antichristum reducat sedem suam ad locum unde manavit ad urbem Romam, puta in Iherusalem vel alibi, sue dispositioni est relinquendum. Neutrum enim horum potest certificari ex sacro textu nec ex aliquo certo et catholico dogmate fidei christiane.[LSA, cap. XVII, Ap 17, 9 (VIa visio)] Quod autem per montes designentur aliquando regna patet Danielis II° (Dn 2, 34-35, 44), ubi lapis confringens statuam et tandem crescens in montem magnum dicit Daniel significare regnum quod in eternum non dissipa<bi>tur et quod conteret et consumet universa alia regna. Dicitur autem mulier, id est civitas magna, sedere super hos septem montes, quia tempore Christi et Iohannis et usque ad tempora Gothorum et Sarracenorum presidebat omnibus gentibus et regnis mundi, et etiam quia, pro quanto in ea est principalis sedes et auctoritas Christi, est de iure omnium domina, licet plures sibi rebellent et tandem ipsam crement. In huius autem figuram est Roma, ad litteram fundata super septem montes, qui sunt Tarpeius, Aventinus, Juminalis, Quirinalis, Celius, Esquilinus, Palatinus. |
||
Inf. XI, 64-66; XXXIV, 28onde nel cerchio minore, ov’ è ’l punto
|
Par. VI, 1-6, 67-72Poscia che Costantin l’aquila volse
|
|
APPENDICE
per una selva oscura,
che la diritta via era smarrita
Oscura e diritta sono due parole chiave che rinviano all’esegesi del terzo sigillo (Ap 6, 5), i cui signacula percorrono l’intero poema.
All’apertura del terzo sigillo, mostratagli dal terzo animale, quello che ha il volto di uomo, Giovanni vede un cavallo nero, che designa l’esercito degli eretici, oscuro per fallace astuzia e fatto nero per gli errori contrari alla luce di Cristo (Ap 6, 5). Colui che siede sopra di esso – designante gli imperatori o i vescovi ariani – ha in mano una bilancia. La stadera misura la quantità dei pesi, e qui sta ad indicare la misurazione degli articoli di fede. Quando la misurazione avviene secondo la retta e infallibile regola di Cristo, allora il peso è giusto, come si dice nei Proverbi: “Il peso e la bilancia sono i giudizi del Signore” (Pro 16, 11) e nell’Ecclesiastico: “Le parole dei prudenti sono pesate sulla bilancia” (Ecli 21, 28). Quando invece la misurazione si fonda sull’errore e sul falso e torto accoglimento della Scrittura, allora la stadera è dolosa, e a questa si riferiscono i Proverbi: “La bilancia falsa è in abominio al Signore” (Pro 11, 1), i Salmi: “Sono una menzogna tutti gli uomini sulla bilancia” (Ps 61, 10) e Michea: “Potrò giustificare le false bilance e il sacchetto dei pesi falsi?” (Mic 6, 11) [1].
Questi temi si mostrano nelle cinque ‘zone’ dell’Inferno già individuate per i temi della terza chiesa:
1) Il tema della bilancia o del peso è nei “gravi pesi” sotto cui i Neri fiorentini terranno la parte bianca per lungo tempo, dei quali profetizza Ciacco in Inf. VI, 70-72. È anticipato dalle parole del fiorentino: “La tua città, ch’è piena / d’invidia sì che già trabocca il sacco (“Numquid iustificabo stateram impiam et sac<c>elli pondera dolosa”, vv. 49-50), e da quelle di Dante: “Ciacco, il tuo affanno / mi pesa sì, ch’a lagrimar mi ’nvita” (vv. 58-59). Nel medesimo episodio si trova anche il tema del dritto e del torto, appropriato al dannato che “li diritti occhi torse allora in biechi” (vv. 91). La parola, che con il suo spontaneo aprirsi al passaggio del poeta, aveva dato adito alla rettitudine, cioè a un giusto ed equilibrato discorso, equidistante da entrambi i partiti, alla ricerca razionale della causa della discordia cittadina, cessa. Ciacco, dice Virgilio, non si riprenderà più fino al giudizio universale. Ciò significa che, fino alla fine dei tempi, nessuno farà più un viaggio simile a quello di Dante, capace con la poesia di destare i morti e di farli parlare come uomini razionali.
Il motivo del cavallo nero ha più applicazioni: la grandine “per l’aere tenebroso si riversa” (vv. 10-11); Cerbero ha “la barba unta e atra” (v. 16) [2]; Ciacco dice a Dante che “Farinata e ’l Tegghiaio … / Iacopo Rusticucci, Arrigo e ’l Mosca / … son tra l’anime più nere” (v. 85).
2) L’aver indotto Dante a distendere la mano per troncare “qualche fraschetta d’una d’este piante” – dice Virgilio a Pier della Vigna – è “ovra ch’a me stesso pesa” (Inf. XIII, 51). Lo spirito suicida incarcerato nel tronco risponde con lo stesso motivo: “e voi non gravi / perch’ ïo un poco a ragionar m’inveschi” (vv. 56-57). Il tema del dritto e del torto è presente nella definizione che il consigliere di Federico II dà dell’invidia – “La meretrice che mai da l’ospizio / di Cesare non torse li occhi putti” (vv. 64-65) – e anche nei rami “nodosi e ’nvolti” della selva (v. 5).
Si ritrova con insistenza il colore nero: la selva dei suicidi ha “non fronda verde, ma di color fosco” (v. 4); il ramoscello che il poeta schianta e scerpe dal gran pruno di Pier della Vigna si fa “di sangue bruno” (v. 34; si intrecciano temi dalla seconda [Ap 16, 3] e dalla terza coppa [Ap 16, 4], dove in entrambi i casi è detto: “et factus est sanguis”); “nere cagne” inseguono per la selva gli scialacquatori (vv. 124-125).
3) Nella terza bolgia, le gambe dei simoniaci confitti a capo in giù nei fori della pietra guizzano così forte, per la fiamma che si muove sulle piante dei piedi, “che spezzate averien ritorte e strambe”, cioè legami attorcigliati o funi (Inf. XIX, 25-27). Dante domanda chi sia colui che si cruccia guizzando più degli altri, e Virgilio risponde che, una volta portato là giù nel fondo della bolgia, da lui saprà “di sé e de’ suoi torti” (v. 36). Invitata dal poeta a parlare, l’anima confitta di Niccolò III, che crede erroneamente sia arrivato Bonifacio VIII a prendere il suo posto, grida proseguendo le variazioni del tema della retta e torta misurazione della Scrittura: «Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto, / se’ tu già costì ritto, Bonifazio? / Di parecchi anni mi mentì lo scritto”» (vv. 52-54). Lo stare “ritto”, che nell’esegesi teologica corrisponde al giusto peso che misura secondo la retta e infallibile regola di Cristo (ma “lo scritto” ha mentito al papa Orsini), si contrappone alla pena comminata per i “torti”, e il tema viene ripreso poco dopo dallo spirito che, chiarito l’equivoco in seguito alla risposta di Dante imposta da Virgilio, “tutti storse i piedi” (v. 64).
Lo “scritto” menzognero non è solo il libro del futuro nel quale i dannati leggono l’avvenire, oppure un vaticinio anti-Orsini come Genus nequam [3]. I simoniaci hanno male pesato la regola evangelica, quella osservata da Cristo, imposta agli apostoli e scritta nel Vangelo. Questa regola o scritto è quella francescana, come solennemente attestato dalla Lectura nell’esordio dell’esegesi relativa all’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12, passo simmetrico ad Ap 6, 5 per il comune riferimento alla vera scrittura o regola di Cristo). L’angelo del sesto sigillo, che sale da oriente e che ha il segno del Dio vivente (Ap 7, 2), viene infatti identificato con Francesco piagato dalle stimmate, totalmente trasformato in Cristo e a lui configurato, secondo una tradizione che Olivi ascoltò da san Bonaventura predicante nel 1266 a Parigi nel capitolo generale dei Frati minori. Che la regola di Francesco sia quella veramente evangelica risulta da inconfutabili testimonianze dei libri del Vangelo e delle altre sante scritture. Ne consegue che l’imporre agli apostoli la regola evangelica, come detto ad Ap 6, 12, si trasforma nell’imporre di Virgilio a Dante la risposta a Niccolò III che ripristina la verità dello scritto: «Allor Virgilio disse: “Dilli tosto: / ‘Non son colui, non son colui che credi’”; / e io rispuosi come a me fu imposto» (Inf. XIX, 61-63).
Nella terza età del mondo, a causa della superba torre di Babele, le lingue furono confuse e divise e la lingua prima e retta rimase nella casa di Eber e degli Ebrei, e poi, mentre le altre lingue precipitavano nell’idolatria diabolica, la fede e il culto di un solo vero Dio rimase nella casa di Abramo; così nel terzo stato della Chiesa, a causa della superbia di molti fedeli, la lingua e la confessione della sola vera fede di Cristo venne divisa e confusa in più eresie, mentre la prima e vera lingua e confessione rimase nella casa di Pietro (prologo, Notabile XIII). Più avanti nel canto, rispondendo ancora a Niccolò III, il poeta prorompe in “parole … gravi” contro i papi simoniaci: il cantare tali note al pontefice che fu in vita “veramente … figliuol de l’orsa” è “suon de le parole vere espresse” (Inf. XIX, 70, 103, 123), confessione dell’unica fede di Cristo nella lingua vera che è quella che rimase nella casa di Eber, poi in quella di Abramo, e che avrebbe dovuto essere custodita nella casa romana di Pietro [4].
È proprio dei dottori del terzo stato della Chiesa suonare la tromba (prologo, Notabile I), e ai simoniaci che stanno nella terza bolgia il poeta dichiara che “or convien che per voi suoni la tromba” (vv. 5-6). È probabile che alla stessa tematica appartengano l’atteggiarsi di Dante, piegato col capo sul dannato confitto come palo nel foro della pietra, a frate confessore del “perfido assessin” e il suo restare ‘scornato’, cioè confuso, alle prime incomprensibili parole di Niccolò che l’ha scambiato per Bonifacio VIII arrivato a prendere il suo posto prima del tempo (vv. 49-51, 58-60). “Scornati” è infatti termine singolarmente consonante con l’interpretazione (“dividens cornua”) del nome (Pergamo) della terza chiesa d’Asia, la chiesa dello stato dei dottori che confondono, appunto, l’eresia.
La presenza dei motivi dell’angelo del sesto sigillo (Ap 6, 12) concorda con l’essere Dante figura che impersona l’Ordine evangelico dei discepoli di Francesco suscitati dallo Spirito nel terzo e nel quarto inizio dell’apertura del sesto sigillo, inviati a fondare e a governare la nuova Chiesa di Cristo. Tema importante, quello dell’angelo che sale da oriente, e che dovette essere decisivo per l’incontro spirituale tra il frate e il poeta se lo si ritrova già nei primi versi del poema (cfr. supra).
Dante sta dunque di fronte al papa simoniaco come sta un dottore della Chiesa, che possiede la verità evangelica scritta e imposta da Cristo, di fronte a un eresiarca. Ancor più, parla a un pontefice romano in quanto depositario di quella “prima et vera lingua et confessio fidei” che avrebbe dovuto essere custodita “in domo Petri”. Virgilio partecipa di quest’alto patrimonio nell’imporre al discepolo la retta risposta, come Cristo impose ai discepoli la regola evangelica [5].
Dante canta “cotai note” all’Orsini consapevole di portare su di sé il «“signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi», conforme all’angelo del sesto sigillo, “piaghe” e “segni” come verranno definite da Virgilio nel corso dell’ascesa della montagna della purgazione.
Il tema del cavallo nero è già nella seconda bolgia, dove gli adulatori stanno attuffati nello sterco: “Lo fondo è cupo sì, che non ci basta / loco a veder …” (Inf. XVIII, 109-110). Nella successiva terza bolgia, la pietra delle coste e del fondo è “livida di fóri” (Inf. XIX, 13-14); Niccolò III afferma che il posto nel foro in cui è confitto come palo coi piedi all’insù verrà preso da Bonifacio VIII, che vi rimarrà però per un periodo di tempo inferiore al suo: “ché dopo lui verrà di più laida opra, / di ver’ ponente, un pastor sanza legge”, Clemente V (vv. 82-83; ad Ap 2, 6 gli eretici Nicolaiti vengono definiti “spurcissimi”; sul passo cfr. anche l’esegesi di Ap 12, 14).
Tutto Inf. XIX è percorso dai temi del terzo stato, propri dei dottori che confutano le eresie: l’espressione “di più laida opra” sarà dunque da confrontare con le “laide colpe” delle quali Beatrice riprende volgendo in fuga la volpe incuneatasi nel carro-Chiesa a Purg. XXXII, 118-123 (sono le sole due occorrenze dell’aggettivo nel poema; anche il volgere in fuga è tema proprio dei dottori, ad Ap 2, 17).
4) L’anima di Bertran de Born, del quale nella nona bolgia il poeta vede “un busto sanza capo andar sì come / andavan li altri de la trista greggia” dei seminatori di scandalo e di scisma, contiene in sé il tema della bilancia nel tenere il capo tronco per le chiome, “pesol con mano a guisa di lanterna”, con il quale “di sé facea a sé stesso lucerna”, e anche il tema della retta interpretazione della Scrittura nell’essere “diritto al piè del ponte” da dove, levando il braccio in alto con tutta la testa, parla della sua “pena molesta” (Inf. XXVIII, 118-130).
All’inizio del canto, nella similitudine delle guerre che insanguinarono il mezzogiorno d’Italia con la sozza pena dei dannati dalle membra mozze, è proposto il tema della vera e non erronea scrittura nel verso “come Livïo scrive, che non erra” a proposito della “lunga guerra / che de l’anella fé sì alte spoglie” (vv. 10-12), cioè della seconda guerra punica, durata diciassette anni e in particolare della battaglia di Canne, allorché i Cartaginesi tolsero in bottino tanti anelli ai Romani caduti (Livio, XXIII, 12, 1; cfr. Convivio, IV, v, 19). Una guerra che è sacra prefigurazione di successivi certami, come quello dei martiri nel secondo stato della Chiesa, di cui l’esegesi teologica riporta l’essere stato diuturno (trecento anni: prologo, Notabile XII) e feroce tanto che da Pietro a Silvestro furono martirizzati trentaquattro papi (Ap 6, 4). La storia dei Romani è per Dante storia sacra, stabilita dal volere divino insieme al “decreto / de la molt’anni lagrimata pace” portato dall’angelo in terra (Purg. X, 34-36). È la manifestazione dei segni di Dio nella storia umana, che attuano in terra la sua volontà, una con quella del cielo e con quella di Roma stessa: “divina voluntas per signa querenda est” (Monarchia II, ii, 8). Questi segni hanno un andamento settenario, quello proprio dei sette stati della Chiesa, per cui quanto avvenuto prima di Cristo si mostra come ordinata e progressiva prefigurazione della storia della Chiesa. Ciò è chiaramente dimostrato dai versi con cui, in Par. VI, il “sacrosanto segno” dell’aquila parla per bocca di Giustiniano, che possono essere confrontati con quanto nella Lectura si dice sulle cause di un ordine della storia umana fondato sui sette stati.
Il Mosca, che ha le mani tagliate, grida “levando i moncherin per l’aura fosca, / sì che ’l sangue facea la faccia sozza” (Inf. XXVIII, 103-105; cfr. infra).
La tematica del terzo sigillo si può trovare risalendo fin verso la fine del canto antecedente (i consiglieri di frode latini, segnati dai motivi del secondo stato), allorché “un d’i neri cherubini” (allusione al cavallo nero) contende vittoriosamente a Francesco («li disse: “Non portar; non mi far torto”») l’anima di Guido da Montefeltro, che in vita diede a Bonifacio VIII il consiglio fraudolento su come conquistare Palestrina: il torcere è proprio sia della coda di Minosse cui Guido viene portato, sia dell’acuto corno del “foco furo” che fascia il Montefeltrano (Inf. XXVII, 113-114, 124-125, 132; nei versi intervengono temi da Ap 16, 15).
5) Nella Giudecca Lucifero appare dapprima come un mulino a vento, “quando l’emisperio nostro annotta” (Inf. XXXIV, 5-6; cfr. v. 68: “Ma la notte risurge”); Dite ha tre facce, che nei colori seguono l’esegesi dei cavalli (designanti i tre eserciti contrari a Cristo) all’apertura del secondo sigillo (rossa), del terzo (il “nero ceffo”, come quello degli Etiopi), del quarto (“tra bianca e gialla”, cioè pallida, vv. 39-45, 65).
Bruto – “quel che pende dal nero ceffo” di Lucifero, “si storce, e non fa motto” (vv. 65-66) – riassume in sé quasi tutti i temi propri dell’apertura del terzo sigillo.
Prima di lasciare l’inferno, Dante, che sta seduto sull’orlo del foro nella roccia da cui Virgilio è uscito, si leva in piedi e prega il maestro di dargli spiegazioni su situazioni singolari (non vede più il ghiaccio, scorge Lucifero con le gambe all’insù, il tempo è trascorso velocemente dalla sera alla mattina): «… diss’ io quando fui dritto, / “a trarmi d’erro un poco mi favella”» (vv. 101-102). Lo stare dritto del poeta non designa unicamente l’alzarsi da una posizione seduta, ma si inserisce nella tematica spirituale del trarsi dall’errore (secondo l’esercizio spirituale tipico del terzo stato: Ap 2, 1). Virgilio spiega al discepolo che egli si trova nell’altro emisfero celeste, opposto a quello che copre le terre abitate, al quale è passato nel suo capovolgersi sull’anca di Lucifero, centro della terra e punto di equilibrio di una bilancia del mondo: “tu passasti ’l punto / al qual si traggon d’ogne parte i pesi” (vv. 110-111).
Qui sopra sono stati esaminati i temi di parte dell’esegesi dell’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5) ai quali fanno principalmente riferimento cinque zone dell’Inferno. Questi temi sono tuttavia presenti anche altrove, a cominciare da Inf. I, 2-3, pur se non si tratta di una zona in cui prevale la semantica relativa al terzo stato [6]. Inoltre, nelle menzionate cinque zone infernali non sono riscontrabili unicamente i motivi propri dell’apertura del terzo sigillo, ma anche quelli, ad esempio, della terza chiesa d’Asia (Pergamo: Ap 2, 12-17). È proprio dei dottori della terza chiesa tagliare, dividere, rompere o scindere: il tema si rinviene in diverse zone, quasi fosse un motivo dall’andamento interno, sotterraneo e insieme ciclico. Cerbero (Inf. VI), nel graffiare, scuoiare e squartare i peccatori, è figura che anticipa il colloquio tra Dante e Ciacco sulle divisioni politiche fiorentine. Nella prima cantica, la tematica torna in evidenza nella selva dei suicidi, la cui anima feroce si è divisa dal corpo (Inf. XIII); nella terza bolgia dei simoniaci, che hanno straziato “la bella donna”, cioè la Chiesa (Inf. XIX); nella nona dei seminatori di scandalo e di scisma, dove sta anche il Mosca che fu causa delle discordie fiorentine (Inf. XXVIII); in Lucifero che con ognuna delle sue tre bocche “dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla”, cioè il traditore di Cristo e i traditori del volere di Roma (Inf. XXXIV, 55-67). Questo dividere in sostanza l’uomo, nei suoi vari aspetti, da Dio e dalla sua giustizia è assimilabile alle eresie, che divisero l’umanità di Dio dalla sua divinità, degradando la prima o confondendola con la seconda, come quelle di Ario e di Sabellio, i quali, secondo quanto dice Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole, “furon come spade a le Scritture / in render torti li diritti volti” (Par. XIII, 127-129).
_________________________________________________________________________________________________________________
[1] Michea 6, 3: “Popule meus, quid feci tibi?” costituiva l’incipit di una lettera perduta di Dante, ricordata dal Bruni.
[2] Nella figura di Cerbero (Inf. VI, 13-18) sono riunite qualità di differente provenienza. Il mostro infernale è collocato in una zona in cui prevalgono temi propri del terzo stato della Chiesa, dei quali è quasi emblema nel graffiare, iscoiare e isquatrare le anime. Esso tuttavia contiene elementi che caratterizzano l’apertura di tutti e tre sigilli in cui compaiono eserciti contrari a Cristo. Gli occhi “vermigli” e le mani “unghiate” sono propri del secondo sigillo (il cavallo rosso, l’orso), la “barba unta e atra” del terzo (il cavallo nero), il “ventre largo” è qualità dei Saraceni dei quali, nell’esegesi della quarta chiesa (Ap 2, 22) si dice con san Paolo che “hanno il ventre per loro Dio e per loro gloria” (Ph 3, 19). Inoltre Cerbero, che latra con “tre gole”, è “fiera crudele e diversa”, cioè “dissimilis”, come la quarta bestia di Daniele lo è dalle altre tre precedenti (“Uomini diversi d’ogne costume” sono pure definiti i Genovesi in Inf. XXXIII, 151-152).
[3] Cfr. GIAN LUCA POTESTA’, Dante profeta e i vaticini papali, in “Rivista di Storia del Cristianesimo” 1 (2004), pp. 67-88.
[4] L’espressione di Niccolò “e qui me misi in borsa” (Inf. XIX, 72) fa riferimento al passo di Michea citato nell’esegesi di Ap 6, 5: “Numquid iustificabo stateram impiam et sac<c>elli pondera dolosa” (Mic 6, 11). Anche il rispondergli “a questo metro” da parte di Dante (v. 89) rientra nella tematica della bilancia che misura correttamente la quantità dei pesi.
[5] È noto che Dante perverrà a sostenere, in contrasto con il De vulgari eloquentia (I, vi, 4-7), e anche con la Lectura (prologo, Notabile XIII), che la lingua di Adamo non fosse di origine divina, sopravvissuta nell’ebraico dopo la confusione babelica. Quell’idioma – dice lo stesso progenitore (Par. XXVI, 124-138) – fu spento prima dell’opera della gente di Nembrot; non poté durare, come tutti gli altri effetti del razionale agire umano. Ogni lingua è instabile nell’uso; quella “vera” e perpetua, che consente di parlare gravemente con evangelico suono ai papi simoniaci, è propria della Sacra Scrittura, di cui la Commedia è la versione moderna dell’ultimo libro.
[6] Se “mi ritrovai” è da connettere in quanto cerniera, oltre a “per una selva oscura”, anche a “nel mezzo del cammin di nostra vita” (nel senso di ritrovare in Cristo mediatore la “prima carità” smarrita ma non del tutto perduta), allora al v. 3 – “che la diritta via era smarrita” – che non ha un valore causale, ma di luogo (“in cui”; cfr. Inglese, ad loc.).
Tab. XVIII.a
[LSA, cap. VI, Ap 6, 5 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal” (Ap 6, 5), scilicet quod habebat faciem hominis, “dicens: Veni”, scilicet per maiorem attentionem vel per imitationem fidei doctorum hic per hominem designatorum, “et vide. Et ecce equus niger”, id est hereticorum et precipue arrianorum exercitus astutia fallaci obscurus et erroribus luci Christi contrariis denigratus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet imperatores et episcopi arriani, “habebat stateram in manu sua”. Cum statera mensuratur quantitas ponderum, et ideo per stateram designatur hic mensuratio articulorum fidei, que quando fit per rectam et infallibilem regulam Christi et scripturarum suarum est recta statera, de qua Proverbiorum XVI° dicitur: “Pondus et statera iudicia Domini sunt” (Pro 16, 11), et Ecclesiastici XXI°: “Verba prudentium statera ponderabuntur” (Ecli 21, 28); quando vero fit per rationem erroneam et per falsam et intortam acceptionem scripture est statera dolosa, de qua Proverbiorum XI° dicitur: “Statera dolosa abhominatio est apud Deum” (Pro 11, 1), et in Psalmo: “Mendaces filii hominum in stateris” (Ps 61, 10), et Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram impiam et sac<c>elli pondera dolosa” (Mic 6, 11). |
||
Inf. VII, 25-27, 31-32, 40-42, 52-54Qui vid’ i’ gente più ch’altrove troppa,
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 3 (IIIum sigillum)] Secundo sequitur presumptio erronee mensurans et iudicans aliena dicta et facta, unde tenet stateram librantem aliorum vitam. Solent enim noviter conversi, post aliquas macerationes proprie carnis, aliorum vitam presumptuose despicere et diiu-dicare.Inf. XIV, 43-57I’ cominciai: “Maestro, tu che vinci
|
|
Tab. XVIII.b
Inf. VI, 10-16, 49-51, 58-59, 64-72, 85-87, 91-93
|
Inf. XII, 52-54
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 5 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal” (Ap 6, 5), scilicet quod habebat faciem hominis, “dicens: Veni”, scilicet per maiorem attentionem vel per imitationem fidei doctorum hic per hominem designatorum, “et vide. Et ecce equus niger”, id est hereticorum et precipue arrianorum exercitus astutia fallaci obscurus et erroribus luci Christi contrariis denigratus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet imperatores et episcopi arriani, “habebat stateram in manu sua”. Cum statera mensuratur quantitas ponderum, et ideo per stateram designatur hic mensuratio articulorum fidei, que quando fit per rectam et infallibilem regulam Christi et scripturarum suarum est recta statera, de qua Proverbiorum XVI° dicitur: “Pondus et statera iudicia Domini sunt” (Pro 16, 11), et Ecclesiastici XXI°: “Verba prudentium statera ponderabuntur” (Ecli 21, 28); quando vero fit per rationem erroneam et per falsam et intortam acceptionem scripture est statera dolosa, de qua Proverbiorum XI° dicitur: “Statera dolosa abhominatio est apud Deum” (Pro 11, 1), et in Psalmo: “Mendaces filii hominum in stateris” (Ps 61, 10), et Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram impiam et sac<c>elli pondera dolosa” (Mic 6, 11). |
|
Inf. XXVII, 112-114, 124-125, 130-132; XXVIII, 7-12, 103-105, 118-129“Francesco venne poi, com’ io fu’ morto,
|
Inf. XXXIV, 4-5, 64-69, 100-102, 110-111
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 4 (apertio IIi sigilli)] Deinde exprimitur persecutionis quantitas, cum subditur: “et datus est ei gladius magnus”, id est magna potestas occidendi sanctos, tum quia per universum orbem, tum quia quasi per trecentos annos, tum quia sevissime et per plurima tormenta quasi innumerabiles martirizaverunt, ita ut et sub Diocletiano intra solam urbem romanam decem et septem milia martirum in non multis diebus cesa legantur. Item a Petro sub Nerone passo usque ad Silvestrum, quotquot romane prefuerunt ecclesie triginta quattuor martires asseruntur fuisse, prout in cronicis scribitur. Quidam tamen excipiunt unum istorum a martirio, prout refert Ioachim libro V° Concordie, ubi misteriat gesta Helie. |
|
Tab. XVIII.c
[LSA, prologus, Notabile I (III status)] Tertius (status) est confessorum seu doctorum, homini rationali appropriatus. […] In tertio (statu) sonus predicationis seu eruditionis et tuba magistralis.[LSA, prologus, Notabile XIII (III status)] Sicut etiam tunc propter superbiam turris Babel confuse et divise sunt lingue, remanente recta et prima lingua in domo Heber et Hebreorum, ac deinde linguis ceteris in idolatriam demonum ruentibus in sola domo Abraam fides et cultus unius veri Dei remansit, sic propter superbiam plurium ad fidem introductorum lingua et confessio unius vere fidei Christi est in plures hereses divisa et confusa, remanente prima et vera lingua et confessione fidei in domo Petri.[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (IIIa ecclesia)] Tertia autem commendatur de servando et confitendo fidem inter magistros erroris, in quibus quasi in cathedra pestilentie Sathanas sedet. Increpatur tamen quia ex quorundam suorum negligentia quosdam hereticos habebat. Competunt autem hec tempori tertio, scilicet doctorum. Tunc enim aliqui catholici nimis participabant cum aliquibus hereticis, quamvis ceteri essent constantissimi contra eos. Hec autem ecclesia congrue vocatur Pergamus, id est dividens cornua, quia superbam potentiam et scissuram hereticorum potentissime frangebat et dissolvebat. |
Inf. XIX, 5-6, 49-50, 58-60, 70-72, 121-123or convien che per voi suoni la tromba,
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 5 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal” (Ap 6, 5), scilicet quod habebat faciem hominis, “dicens: Veni”, scilicet per maiorem attentionem vel per imitationem fidei doctorum hic per hominem designatorum, “et vide. Et ecce equus niger”, id est hereticorum et precipue arrianorum exercitus astutia fallaci obscurus et erroribus luci Christi contrariis denigratus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet imperatores et episcopi arriani, “habebat stateram in manu sua”. Cum statera mensuratur quantitas ponderum, et ideo per stateram designatur hic mensuratio articulorum fidei, que quando fit per rectam et infallibilem regulam Christi et scripturarum suarum est recta statera, de qua Proverbiorum XVI° dicitur: “Pondus et statera iudicia Domini sunt” (Pro 16, 11), et Ecclesiastici XXI°: “Verba prudentium statera ponderabuntur” (Ecli 21, 28); quando vero fit per rationem erroneam et per falsam et intortam acceptionem scripture est statera dolosa, de qua Proverbiorum XI° dicitur: “Statera dolosa abhominatio est apud Deum” (Pro 11, 1), et in Psalmo: “Mendaces filii hominum in stateris” (Ps 61, 10), et Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram impiam et sac<c>elli pondera dolosa” (Mic 6, 11).Inf. II, 3-6, 8
|
Inf. XIX, 25-27, 34-36, 52-54, 61-64, 70-72, 88-89Le piante erano a tutti accese intrambe;
|
[LSA, prologus, Notabile VII] Secunda (ratio) est eius singularis et exemplaris vita, quam apostolis imposuit et in se ipso exemplavit et in libris evangelicis sollempniter scribi fecit. Huius autem vite perfecta imitatio et participatio est et debet esse finis totius nostre actionis et vite.[LSA, cap. VI, Ap 6, 12 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Ad evidentiam autem huius sexte apertionis est primo ad memoriam reducendum quod supra in principio est in tredecim notabilibus prenotatum, et specialiter illa in quibus est monstratum quia vita Christi erat in sexto et septimo statu ecclesie singulariter glorificanda et in finali consumatione ecclesie et in omnis Israelis ac totius orbis conversione magnificanda. Ex quo igitur, per romane ecclesie autenticam testificationem et confirmationem, constat regulam Minorum, per beatum Franciscum editam, esse vere et proprie illam evangelicam quam Christus in se ipso servavit et apostolis imposuit et in evangeliis suis conscribi fecit, et nichilominus constat hoc per irrefragabilia testimonia librorum evangelicorum et ceterarum scripturarum sanctarum et per sanctos expositores earum, prout alibi est superhabunde monstratum, constat etiam hoc per indubitabile testimonium sanctissimi Francisci ineffabili sanctitate et innumeris Dei miraculis confirmatum. Et precipue gloriosissimis stigmatibus sibi a Christo impressis patet ipsum fore angelum apertionis sexti signaculi “habentem signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi, et etiam signum totalis transformationis et configurationis ipsius ad Christum et in Christum. Et hoc ipsum per claram et fide dignam revelationem est habitum, prout a fratre Bonaventura, sollempnissimo sacre theologie magistro ac nostri ordinis quondam generali ministro, fuit Parisius in fratrum minorum capitulo me audiente sollempniter predicatum. |
|
Tab. XVIII.c.1 [nota]
[LSA, cap. X, Ap 10, 5-7 (IIIa visio, VIa tuba)] Sequitur (Ap 10, 5): “Et angelus, quem vidi stantem supra mare et supra terram, levavit manum suam in celum (Ap 10, 6) et iuravit per viventem in secula seculorum, qui creavit celum et ea que in illo sunt, et terram et ea que in ea sunt, et mare et ea que in eo sunt, quia tempus amplius non erit; (Ap 10, 7) sed in diebus vocis septimi angeli, cum ceperit tuba canere, consumabitur misterium Dei, sicut evangelizavit per servos suos prophetas”. Iuramentum hoc designat vehementem certitudinem et assertionem quod tempus huius seculi omnino finietur in tempore septime tube. Non enim intendit quod post hoc iuramentum suum non sit tempus amplius, sed quod in voce septimi angeli consumabitur. Iurat autem hoc ita fortiter, tum ad fortius perterrendum malos et terrendo convertendum ad penitentiam, tum ad consolandum electos multiplicibus persecutionibus et miseriis vexaturos et de exilio et carcere huius vite cupientes exire et ad eternam patriam iugiter suspirantes. […]
|
|
Purg. XXXIII, 40-41ch’io veggio certamente, e però il narro,
|
Inf. XXVIII, 103-108E un ch’avea l’una e l’altra man mozza,
|
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 17 (Va visio, VIIa phiala)] “Et septimus angelus effudit phialam suam in aerem, et exivit vox magna de templo a trono dicens: Factum est” (Ap 16, 17), id est, secundum Ricardum, post mortem Antichristi septimus et ultimus ordo predicatorum effundet phialam suam “in aerem”, id est in collegium demonum in hoc aere habitantium, quia in tempore predicationis eius graviter affligentur pre timore imminentis iudicii et supplicii sempiterni. Scient enim certissime instare diem iudicii et adventum Christi. Unde de instantia utriusque dicitur: “Et exivit vox” et cetera “dicens: Factum est”, quasi dicat: consumata sunt omnia, adest finis mundi. Que vox dicitur “magna”, quia magnum est quod per eam nuntiatur. Hec Ricardus [In Ap V, ix (PL 196, col. 830 A-C)]. |
|
[Nota] Nel sesto stato viene predicata, come con giuramento, la brevità del tempo e quasi la sua fine poiché da questo apparirà chiaro agli eletti che la fine del mondo è prossima e che le opere di Dio sono propinque alla consumazione finale. Come noi giuriamo levando e ponendo la mano sull’altare o sul libro dei Vangeli, così l’angelo dal volto solare, al suono della sesta tromba, giura che al suono della settima tromba non ci sarà più il tempo. Giura levando la mano al cielo, cioè con l’alta attestazione della Chiesa celeste e di Dio che abita in essa e anche perché la dimostrazione della celeste dimora e dell’eternità conferma che il tempo di questo mondo passerà velocemente. Per lo stesso motivo giura per Colui che vive in eterno, ove specifica in particolare i tre elementi da lui creati, cioè il cielo come luogo che gli eletti devono cercare e in cui deve essere consumata la loro gloria; la terra con le creature che in essa vivono; il mare con le creature che vi vivono; come dica: ‘giuro per Colui che creò la terra dei fedeli e il mare delle nazioni infedeli; e ad ambedue ora mi rivolgo invitandoli alla gloria eterna’ (Ap 10, 5-7; l’esegesi è stata compiutamente esaminata altrove). Per questo teneva un piede sulla terra e un altro sul mare (Ap 10, 3).
|
|
La Tabella XVIII.d.1 mostra come i motivi da Ap 6, 5 (apertura del terzo sigillo, con l’apparizione del cavallo nero) possono essere collazionati con altri da Ap 2, 24-25 (istruzione data a Tiàtira, la quarta chiesa d’Asia). Se ad Ap 6, 5 si tratta della bilancia e del pesare in modo retto o torto e mendace la Scrittura, alla chiesa del quarto stato viene detto che non verrà messo o imposto su di essa altro peso più grave e importabile (come è invece proprio dell’alta superbia di Satana), bastandole ciò che già ha, cioè la legge evangelica.
I risultati si registrano sia in zone nelle quali prevalgono i temi del terzo stato (Inf. VI, XXXIV; Par. VIII-IX), sia in altre zone dedicate ad altri stati.
Si noterà, in particolare:
■ Gli ipocriti della sesta bolgia sono ammantati di cappe dorate di fuori ma dentro di piombo, “e gravi tanto, / che Federigo le mettea di paglia”: gravata dal peso imposto, “quella gente stanca” (tema del cavallo pallido che si mostra all’apertura del quarto sigillo: Ap 6, 8) procede tanto piano che i due poeti si trovano accanto sempre nuovi dannati (Inf. XXIII, 61-72). Gravame che si accompagna al motivo della bilancia: “Le cappe rance / son di piombo sì grosse, che li pesi / fan così cigolar le lor bilance” (vv. 100-102). Il passaggio dalla quinta bolgia (dei barattieri) alla sesta (degli ipocriti) costituisce una delle più significative metamorfosi dei temi relativi all’apertura del sesto sigillo (vv. 34-57: Ap 6, 12-17). Nella ‘zona’ sesta degli ipocriti si trovano anche temi propri di altri stati (secondo il principio della “concurrentia” fra essi); fra questi è lo storcersi di Caifa al vedere Dante (v. 112), del tutto simile a quello dei piedi del simoniaco Niccolò III al sentirlo parlare come imposto da Virgilio (Inf. XIX, 64) e a quello di Bruto “che pende dal nero ceffo” di Lucifero (Inf. XXXIV, 64-66): tutti e tre interpretarono in modo distorto la Scrittura, rispettivamente contro la Chiesa, Cristo, Cesare.
■ Le parole di Carlo Martello – “sì ch’a sua barca / carcata più d’incarco non si pogna” -, riferite a suo fratello Roberto che dovrebbe fuggire “l’avara povertà di Catalogna” (Par. VIII, 76-81), derivano da «“dico” quod “non mittam”, id est non imponam, “super vos aliud pondus”» (Ap 2, 24). Per cui sarà da considerare la variante s’impogna, giudicata dal Petrocchi “in sé parimenti soddisfacente … ma documentariamente meno salda” (accolta però nell’edizione Inglese). I temi del terzo sigillo (Ap 6, 5) segnano versi del canto seguente (Par. IX, 10-12, 55-57); a Par. V, 61-63 si intrecciano con l’esegesi del “valor”, sempre relativa al terzo sigillo (Ap 5, 1), mentre il verso 76 – “Avete il novo e ’l vecchio Testamento” – è parodia di un inciso dall’esegesi di Ap 2, 25 – «“Tantum id quod habetis”, scilicet evangelium meum et meam evangelicam legem, “tenete donec veniam”».
Tab. XVIII.d.1
[LSA, cap. VI, Ap 6, 5 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal” (Ap 6, 5), scilicet quod habebat faciem hominis, “dicens: Veni”, scilicet per maiorem attentionem vel per imitationem fidei doctorum hic per hominem designatorum, “et vide. Et ecce equus niger”, id est hereticorum et precipue arrianorum exercitus astutia fallaci obscurus et erroribus luci Christi contrariis denigratus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet imperatores et episcopi arriani, “habebat stateram in manu sua”. Cum statera mensuratur quantitas ponderum, et ideo per stateram designatur hic mensuratio articulorum fidei, que quando fit per rectam et infallibilem regulam Christi et scripturarum suarum est recta statera, de qua Proverbiorum XVI° dicitur: “Pondus et statera iudicia Domini sunt” (Pro 16, 11), et Ecclesiastici XXI°: “Verba prudentium statera ponderabuntur” (Ecli 21, 28); quando vero fit per rationem erroneam et per falsam et intortam acceptionem scripture est statera dolosa, de qua Proverbiorum XI° dicitur: “Statera dolosa abhominatio est apud Deum” (Pro 11, 1), et in Psalmo: “Mendaces filii hominum in stateris” (Ps 61, 10), et Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram impiam et sac<c>elli pondera dolosa” (Mic 6, 11). |
|
Inf. VI, 49-51, 58-59, 64-72, 85-87, 91-93Ed elli a me: “La tua città, ch’è piena
|
Inf. XXIII, 61-72, 76-78, 88-90, 100-102, 109-113, 118-120Elli avean cappe con cappucci bassi
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 24-25 (Ia visio, IVa ecclesia)] Ne autem boni propter tantam severitatem iudiciorum Dei credant se ad alia graviora et quasi importabilia teneri, ideo hoc excludit subdens (Ap 2, 24): “Vobis autem dico ceteris qui Tyatire estis”, id est ceteris huius ecclesie qui erant alii a predictis eiusdem ecclesie: “Quicumque non habent doctrinam hanc”, scilicet Iesabelis docentis fornicari et comessari; “qui non cognoverunt”, scilicet affectu et opere, “altitudinem Sathane”, id est altam superbiam et profundam malitiam diaboli; “vobis”, inquam talibus, “dico” quod “non mittam”, id est non imponam, “super vos aliud pondus”, scilicet preceptorum, “quemadmodum dicunt”, scilicet quidam deceptores. Ricardus: “quemadmodum dicunt”, id est sicut vobis minantur, quidam pseudoapostoli de Iudea. “Non mittam super vos aliud pondus”, id est non exigam a vobis veteres observationes legis*, cuius contrarium ipsi dicunt. “Tantum id quod habetis” (Ap 2, 25), scilicet evangelium meum et meam evangelicam legem, “tenete donec veniam”, scilicet ad vos remunerandos, id est usque ad mortem. Vel forte ad alia superstitiosa vel importabilia et supra vires eorum existentia dicebant eos teneri, quod Christus hic excludit.* In Ap I, viii (PL 196, col. 727 C). |
|
Pape Satàn, pape Satàn, aleppe!
■ La compresenza nell’esegesi di Ap 2, 24 di “doctrina”, “Sathanas”, “alta superbia” conduce alle parole – “Pape Satàn, pape Satàn, aleppe!” – pronunciate da Pluto con la voce chioccia in apertura di Inf. VII, sulla soglia del quarto cerchio dove gli avari e i prodighi vanno “voltando pesi per forza di poppa”.
“Pape”, come interpretato da Pietro di Dante, è “interiectio admirantis” – dal greco παπαί -, che esprime uno stato di meraviglia.
“Satàn” è il nome ebraico (che significa “avversario”), del “diavolo”, a sua volta nome greco che significa “accusatore”, oppure, con etimologia da “deorsum fluens”, “colui che cadde dall’alto”, come detto ad Ap 12, 9, nell’esegesi del punto della seconda guerra in cui “fu gettato a terra quel drago grande, serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana”. E Pluto, trovato dai due poeti nel punto dove la strada discende dal terzo al quarto cerchio, è “il gran nemico” (Inf. VI, 115), cioè l’avversario che sempre si oppone.
“Aleppe” deriva da aleph, la prima lettera dell’alfabeto ebraico, che significa “dottrina”. Le lettere dell’alfabeto ebraico sono associate ai versi delle Lamentazioni di Geremia, testo ben conosciuto da Dante [1], del quale Olivi redasse un commento.
Il significato della frase di Pluto – cinque parole di cui due ripetute: una latina trasposta dal greco e due ebraiche – sarebbe pertanto: “Oh Satana, oh Satana, dottrina!”.
Virgilio, “quel savio gentil, che tutto seppe” (Inf. VII, 3; il conoscere tutto è attributo di Cristo, che ad Ap 2, 23 si propone alla quarta chiesa come colui che scruta le reni e i cuori), risponde a Pluto: “Taci, maladetto lupo! / consuma dentro te con la tua rabbia” (vv. 8-9), parodia di un tema dell’esegesi della quinta coppa, dove i figli della superbia, impediti dagli spirituali nell’ottenimento di quello che vogliono, per il dolore nel cuore e per impazienza prorompono in detrazione di coloro che li rimproverano mordendosi le proprie lingue, corrodendo e distruggendo dentro di sé ogni quieto sapore di gioia (Ap 16, 11). L’espressione del poeta pagano – “consuma dentro te con la tua rabbia” – anticipa gli iracondi e gli accidiosi fitti nel limo della palude Stigia, i quali vissero “portando dentro accidïoso fummo” (Inf. VII, 121-126); l’“ira accolta” di Flegiàs (Inf. VIII, 22-24), Filippo Argenti che “in sé medesmo si volvea co’ denti” (ibid., 62-63; cfr. lo sviluppo dei temi da Ap 16, 11 nel conte Ugolino).
Virgilio quindi spiega, come già fatto con Caronte e Minosse, che “non è sanza cagion l’andare al cupo”, poiché “vuolsi ne l’alto, là dove Michele / fé la vendetta del superbo strupo” (Inf. VII, 10-12). Da notare la vicinanza degli aggettivi “alto” e “superbo”, che nell’esegesi di Ap 2, 24 sono riferiti alla dottrina di Satana, mentre nei versi il primo designa il cielo, dove l’arcangelo Michele punì la superbia degli angeli ribelli. Michele è il principe vittorioso della seconda guerra della Chiesa, nella quale “fu gettato a terra quel drago grande, serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana” (Ap 12, 9). Alle parole di Virgilio, Pluto, “la fiera crudele”, cade a terra, “quali dal vento le gonfiate vele / caggiono avvolte, poi che l’alber fiacca” (vv. 13-15). Il “fiaccare” è tema del quarto sigillo (Ap 6, 8).
■ Pluto si pone come un impedimento al viaggio di Dante, impedimento rimosso da Virgilio. Nell’esegesi dell’apertura del sesto sigillo, ad Ap 7, 1, i quattro angeli che “stanno” sopra i quattro angoli della terra designano i demoni e gli uomini empi che, dopo il giudizio e lo sterminio della chiesa carnale intervenuti con il terremoto nell’apertura del sigillo, cercano di impedire la predicazione della fede, la conversione delle genti e anche il conservarsi dei fedeli nella fede già accolta. Secondo Riccardo di San Vittore sono i principali demoni cupidi di possedere tutto il mondo nei suoi quattro angoli, che stanno fissi nel considerare quanti possano divorare. Secondo Gioacchino da Fiore i quattro angeli designano le genti infedeli o gli eretici, che stanno attorno alla Chiesa impedendo che i dottori cristiani predichino ai popoli soggetti il verbo divino. Possono essere interpretati anche, in senso positivo, come i quattro generi di predicatori ai quali è concesso di nuocere cessando dalla predicazione a causa dei peccati. Al versetto successivo (Ap 7, 2), l’impedimento viene rimosso dalla proibizione di un angelo diverso dagli altri quattro, che ostacolano il bene, e contrario ad essi. Si tratta dell’angelo del sesto sigillo, che sale da oriente: come afferma Gioacchino, affinché non si tema il tramonto di questa vita, predicherà i sicuri indizi dell’avvento del vero sole e la prossima resurrezione di tutti i giusti. Di fronte alla virtù del suo grido il potere degli avversari si acquieterà.
Nella salita al dilettoso monte, il poeta è impedito dalle tre fiere: la lonza “’mpediva tanto il mio cammino” (il tempo, al principio del mattino, è il medesimo nel quale interviene l’angelo del sesto sigillo), la vista del leone gli incute paura, la lupa “non lascia altrui passar per la sua via, / ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide” (Inf. I, 35, 44-45, 95-96). Virgilio viene mandato da Beatrice a rimuovere l’impedimento (Inf. II, 61-63, 94-96).
Entrato il poeta “per lo cammino alto e silvestro” (Inf. II, 142), dapprima Caronte si rifiuta di traghettarlo, perché “anima viva”, al di là dell’Acheronte, ma le parole di Virgilio rendono “quete le lanose gote / al nocchier de la livida palude” (Inf. III, 88-99). Sulla soglia del secondo cerchio, “stavvi Minòs orribilmente, e ringhia” (Inf. V, 4; cfr. “stavvi” con l’essere i quattro angeli “stantes”): anch’egli cerca di impedire il “fatale andare” del poeta, ma Virgilio, con le stesse parole dette a Caronte, rimuove l’impedimento (vv. 22-24). Nel terzo cerchio Cerbero, alla vista dei due poeti, “le bocche aperse e mostrocci le sanne”, ma lo racqueta la terra gettata da Virgilio dentro le bramose canne (Inf. VI, 22-33). Con Pluto, terzo dei demoni, le parole del poeta pagano sono diverse da quelle pronuciate verso Caronte e Minosse, ma l’effetto è il medesimo perché il demonio sta lì per nuocere e per impedire la discesa “ne la quarta lacca”. Confortando il discepolo, Virgilio si comporta ancora come l’angelo del sesto sigillo che acquieta ciò che può nuocere da parte dei quattro angeli di Ap 7, 1: “Non ti noccia / la tua paura; ché, poder ch’elli abbia, / non ci torrà lo scender questa roccia” (Inf. VII, 4-6). Completa il quadro il forte terremoto che scuote la “buia campagna” al momento del passaggio dell’Acheronte, che corrisponde al terremoto che si verifica all’apertura del sesto sigillo (Inf. III, 130-132).
■ La meraviglia espressa da Pluto con l’interiezione “pape” è tema che pure è possibile ritrovare nella Lectura, nella interrogazione fatta ad Ap 5, 2 dall’angelo forte che chiede: “Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?”, un modo di domandare, come sottolinea l’Olivi, che indica l’alta ammirazione di colui che domanda e la rarità, la difficoltà e l’arditezza delle cose richieste. Il passo, collazionato con l’esegesi del sesto sigillo ad Ap 7, 13, dove uno dei seniori si rivolge a Giovanni chiedendogli “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e donde vengono?”, è la fonte di numerosi luoghi del poema. Le parole di Pluto non sono molto dissimili da quelle pronunciate dalla donna santa e presta che eccita Virgilio a mostrare a Dante la vera natura della femmina balba: “‘O Virgilio, Virgilio, chi è questa?’, / fieramente dicea”, cioè con sdegno, solo che nel caso di Pluto il tono è rabbioso (Purg. XIX, 28-29). Il demonio sembra voler dire: ‘Oh Satana, oh Satana, questi chi sono?’, ricorrendo alla dottrina (aleph) di Satana.
La presenza di questi temi – meravigliarsi, domandare, ricorrere alla dottrina -, in tutt’altro contesto, conduce all’Empireo: invitato da san Bernardo a guardare nel volto della Vergine, il poeta si meraviglia per l’allegrezza portata su di lei dagli angeli (“che quantunque io avea visto davante, / di tanta ammirazion non mi sospese”, Par. XXXII, 91-92), domanda chi sia l’angelo che primo discende cantando “Ave, Maria, gratïa plena”, e lo fa ricorrendo alla dottrina di san Bernardo (“qual è quell’ angel che con tanto gioco … Così ricorsi ancora a la dottrina / di colui ch’abbelliva di Maria, / come del sole stella mattutina”, vv. 103-108).
Si possono ancora ricordare i negligenti morti per violenza, i quali, accortisi che il corpo di Dante non lascia trapassare i raggi del sole, “mutar lor canto in un ‘oh!’ lungo e roco” – che equivale al “pape” detto da Pluto “con la voce chioccia” – e due di loro si recano come messaggeri a chiedere chi siano i due poeti (Purg. V, 25-30).
■ Pluto, dicendo “pape”, esprime meraviglia. L’interiezione tuttavia allude anche ad altro significato. Nell’esegesi della sesta tromba (Ap 9, 14), fra le varie interpretazioni date al fiume Eufrate, nel quale sono legati i quattro angeli che una voce comune dai quattro lati dell’altare d’oro comanda al sesto angelo di sciogliere in modo che distruggano Babilonia, una volta disseccate le acque del fiume – che corrispondono ai quattro angeli che ad Ap 7, 1 “stanno” sopra i quattro angoli della terra e sono di impedimento -, c’è quella che vede nel grande fiume il potere papale, cui obbediscono le plebi numerose, che impedisce il passaggio e l’assalto degli avversari dello stato evangelico. Lo scioglimento dei quattro angeli legati nel fiume significa pertanto che viene a cessare il favore del papa verso lo stato evangelico, impersonato dall’ordine francescano. Questa interpretazione passa nel cielo di Venere, dove Folchetto di Marsiglia presenta la luce più fulgida, quella di Raab, la meretrice di Gerico la quale, ricevendo nella sua casa gli esploratori inviati da Giosuè, favorì la vittoria di questi in Terrasanta, nei luoghi che oggi non sono nel cuore del papa (Par. IX, 124-126). Il termine “favor”, che nel testo teologico è collegato alla persona del papa, nella terzina viene appropriato a Raab, restando sempre il riferimento polemico alla scarsa memoria (e dunque allo scarso favore) del pontefice verso i casi di Terrasanta. Folchetto, sviluppando il tema della cessazione del favore papale verso lo stato evangelico, procede quindi a deplorare che, per brama di ricchezza (del fiorino, “il maledetto fiore” prodotto e sparso da Firenze, patria di Lucifero), il pastore si sia trasformato in lupo e il Vangelo e i Padri e Dottori della Chiesa siano abbandonati a solo vantaggio dello studio delle Decretali, alle quali attendono il papa e i cardinali: “non vanno i lor pensieri a Nazarette, / là dove Gabrïello aperse l’ali” (vv. 127-138).
Un’altra interpretazione è che lo scioglimento dei quattro angeli legati nel fiume Eufrate designa l’abbandono, da parte di quasi tutti, dell’obbedienza dovuta al sommo pontefice, di cui dice l’apostolo ai Tessalonicesi: “Prima dovrà venire la defezione e dovrà essere rivelato l’uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e s’innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o che è oggetto di culto” (2 Th 2, 3-4). Il tema è riproposto al termine del capitolo XIII (Ap 13, 18). Pluto, “il gran nemico”, che pone opposizione col suo potere al discendere dei due poeti, uomini evangelici, corrisponde al figlio della perdizione “qui adversatur et extollitur supra omne quod dicitur Deus aut quod colitur” del testo paolino. Così “pape” è particella grammaticale che esprime meraviglia, ma concorda pure in modo equivoco con “papa”, alludendo alla cessazione del favore papale verso gli uomini evangelici, trasformatosi in impedimento al loro passaggio. Il confronto tra Pluto e Virgilio è un opporsi della dottrina di Cristo a quella di Satana: con il prevalere della prima cadono i vecchi precetti e le vecchie osservanze che con alta superbia il demonio Pluto vuole imporre.
È da notare che il riferimento a Lucifero è presente sia nelle parole di Folchetto sia nella risposta di Virgilio a Pluto. Una variazione del tema paolino della “discessio” è appropriato in Purg. XX, 15 alla “maladetta … antica lupa”, cioè alla cupidigia, nella domanda del poeta rivolta al cielo: “quando verrà per cui questa disceda?”. L’invettiva contro la lupa si colloca nel quinto girone della montagna, dove si purgano gli opposti peccati di avarizia e di prodigalità, gli stessi eternamente puniti nel cerchio infernale guardato da Pluto.
■ Pluto parla un linguaggio simulato, e ciò corrisponde al motivo dell’ipocrisia proprio del quarto stato e lo avvicina alla figura di Gezabele che col suo potere e con la sua falsa profezia e dottrina traeva e seduceva i servi di Cristo (Ap 2, 22). Dopo le parole di Virgilio cade a terra come le vele gonfiate dal vento “caggiono avvolte, poi che l’alber fiacca”: l’essere involuto è proprio della fluttuante volubilità del Vecchio Testamento, involuto nelle ombre oscure delle figure che lo coprono, come un mare procelloso e vertiginoso la cui voragine non abbia fondo. Un’oscurità che viene aperta dal nudo intelletto e dalla semplicità della fede e della sapienza di Cristo, cosicché taccia ogni contraddizione o litigio tra Vecchio e Nuovo Testamento (Ap 5, 1).
I temi tratti da Ap 2, 24 si trovano anche nella salita dei due poeti al primo balzo della montagna del purgatorio (Purg. IV, 40-42), alla cui sommità e al cui pendio (la “costa”) vengono appropriati gli aggettivi “alto” e “superbo”, i medesimi contenuti nella risposta di Virgilio a Pluto – “vuolsi ne l’alto, là dove Michele / fé la vendetta del superbo strupo” (Inf. VII, 11-12). La montagna, come spiega Virgilio, “sempre al cominciar di sotto è grave; / e quant’ om più va sù, e men fa male” (Purg. IV, 88-90). Significa che man mano che si sale il monte viene progressivamente meno il peso imposto, che nell’esegesi corrisponde all’osservanza della vecchia legge. Poco prima il poeta pagano ha spiegato che la strada percorsa dal sole nel suo moto diurno procede, rispetto al purgatorio, da destra a sinistra, all’opposto di quanto avviene rispetto a Gerusalemme, quasi alludendo a un ‘cammin nuovo’ del sole rispetto a un “cammin vecchio”. La posizione astronomica di Gerusalemme e della montagna del purgatorio, poste agli antipodi e nel mezzo di due emisferi opposti, come descritta da Virgilio in Purg. IV, 61-84, è figura della concorrenza del terzo e del quarto stato, ed è variante positiva di quanto avviene nel volgersi degli avari e dei prodighi nel quarto cerchio infernale, i quali “voltando pesi per forza di poppa” giungono ai due punti del cerchio che distinguono la loro pena e segnano anche la concorrenza delle due schiere, quasi entrambe abbiano un solo orizzonte e diversi emisferi (Inf. VII, 25-35). Dottori e anacoreti concorrono nel meriggio (prologo, Notabile X), e il tema del sole al meridiano conclude Purg. IV, dopo però che Belacqua ha introdotto i temi del quinto stato che accompagneranno i versi fino alla porta del purgatorio, la cui apertura segna l’inizio del sesto stato della sesta età, ovvero dell’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore.
[1] Cfr. Vita Nova, 19. 8: “Poi che fue partita da questo secolo, rimase tutta la sopradecta cittade quasi vedova dispogliata da ogni dignitade. Onde io, ancora lagrimando in questa desolata cittade, scrissi alli principi della terra alquanto della sua conditione, pigliando quello cominciamento di Yeremia profeta Quomodo sedet sola civitas”.
Tab. XVIII.d.2
[LSA, cap. II, Ap 2, 24-25 (Ia visio, IVa ecclesia)] Ne autem boni propter tantam severitatem iudiciorum Dei credant se ad alia graviora et quasi importabilia teneri, ideo hoc excludit subdens (Ap 2, 24): “Vobis autem dico ceteris qui Tyatire estis”, id est ceteris huius ecclesie qui erant alii a predictis eiusdem ecclesie: “Quicumque non habent doctrinam hanc”, scilicet Iesabelis docentis fornicari et comessari; “qui non cognoverunt”, scilicet affectu et opere, “altitudinem Sathane”, id est altam superbiam et profundam malitiam diaboli; “vobis”, inquam talibus, “dico” quod “non mittam”, id est non imponam, “super vos aliud pondus”, scilicet preceptorum, “quemadmodum dicunt”, scilicet quidam deceptores. Ricardus: “quemadmodum dicunt”, id est sicut vobis minantur, quidam pseudoapostoli de Iudea. “Non mittam super vos aliud pondus”, id est non exigam a vobis veteres observationes legis, cuius contrarium ipsi dicunt. “Tantum id quod habetis” (Ap 2, 25), scilicet evangelium meum et meam evangelicam legem, “tenete donec veniam”, scilicet ad vos remunerandos, id est usque ad mortem. Vel forte ad alia superstitiosa vel importabilia et supra vires eorum existentia dicebant eos teneri, quod Christus hic excludit. |
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 2 (radix IIe visionis) Loquitur etiam interrogando seu inquirendo, dicendo scilicet: “Quis est” et cetera, tum ut insinuet instans desiderium angelorum et sanctorum patrum quod liber aperiretur et quod aliquis dignus aperire reperiretur, tum quia doctores solent per huiusmodi interrogationes excitare et exigere discipulos suos ad querendum et ad addi<s>cendum, tum quia talis modus querendi sensibilius designat altam admi-rationem querentis et raritatem ac difficultatem et arduitatem inventionis rei quesite. |
[LSA, cap. VII, Ap 7, 13 (IIa visio apertio VIi sigilli)] “Et dixit michi: Hii, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis, “et unde venerunt”, id est ex quibus meritis et per quam viam sanctitatis ad tantam gloriam pervenerunt?
|
Inf. VI, 70-72; 112-115; VII, 1-15, 25-30
|
[…] aleph enim interpretatur doctrina […]
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 9; IVa visio (IIum prelium)] “Et proiectus est” (Ap 12, 9), scilicet a predicta dominatione et potestate, “dracho ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur Diabolus et Sathanas”.
|
|
Tab. XVIII.d.3
La semantica presente in tre passi relativi al quinto periodo (status) della storia della Chiesa (quinto sigillo: 5, 1, quinta tromba: 9, 2.5.8, quinta coppa: 16, 11), collazionati fra loro, si ritrova con variazioni in più luoghi del poema. Uno dei temi, l’ira, può essere a sua volta collazionato con la rabies da Ap 9, 19-20 (si noti il comune inciso Et non egerunt penitentiam ex operibus suis / neque penitentiam egerunt de operibus manuum suarum), per cui l’esegesi contenente i temi da variare viene ampliata (si notino il parlare interrotto degli accidiosi a Inf. VII, 126 e la “parola tronca” di Virgilio irato a Inf. IX, 14-15). |
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1; clausura Vi sigilli] Quintus (defectus claudens) est ad omne arduum et divinum tristissima et laboriosa difficultas, ac per consequens torpens et languens accidiositas. […] In quinta (apertione) autem, contra torporem accidie et otii quinti temporis, quod est sentina luxurie et omnis iniquitatis, clamant sancti martires eorum sanguinem, id est penales labores et dolores usque ad mortem, vindicari in illos.[LSA, cap. IX, Ap 9, 2.5.8; IIIa visio, Va tuba] Secundo tangitur gravitas mali de aperto iam puteo exeuntis, cum ait: “et ascendit fumus putei sicut fumus fornacis magne, et obscuratus est <sol et> aer de fumo putei” (Ap 9, 2). Fumus iste est omne extrinsecum malum opus et signum de cordali flamma luxurie et avaritie et superbie et ire et invidie et malitiose astutie procedens. Et quanto iste fumus est maior et gro<ss>ior et de maiori ac peiori flamma exiens, tanto plus pungit et confundit oculos intuentium, et tanto plus non solum coram fidelibus sed etiam coram infidelibus diffamat et obscurat solarem claritatem fidei et ecclesie et religionis perducentis ad cultum veri solis Christi, sicut aer sua perspicuitate perducit nostrum visum ad solem et radios solis usque ad oculum nostrum. Vel per hoc designatur quod multi prelati ecclesiarum et religionum, qui prius erant quasi sol, et multi spirituales, qui prius erant quasi aer purus a sole illuminatus, corrumpuntur et denigrantur a fumo tante laxationis. […]
|
|
Inf. VII, 7-9, 109-126Poi si rivolse a quella ’nfiata labbia,
|
Inf. VIII, 22-24, 61-63, 121-123; IX, 7-9, 13-15Qual è colui che grande inganno ascolta
|
[Ap 9, 19-20; IIIa visio, VIa tuba] (Ap 9, 19) Rabies vero iracundie terribilis et crudelis et comminationum eius est apta ad flectendum et subiciendum omnes pusillanimes ad illorum votum et sectam. […]
|
|
Le Tabelle XVIII e, f mostrano l’elaborazione tematica dell’esegesi di Ap 6, 5 nel Purgatorio e nel Paradiso. Qui di seguito vengono illustrati alcuni dei numerosi luoghi cosicché il paziente lettore possa da solo indagare gli altri.
■ A Purg. III, 16-24, la luce del sole è “rotta” dalla persona del poeta (terza chiesa, Ap 2, 12), e l’ombra rende oscura dinanzi a lui la terra (il cavallo nero all’apertura del terzo sigillo, Ap 6, 5). Questo passo è stato esaminato altrove.
■ I temi dell’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5) ritornano nel terzo girone del purgatorio che, seconda dopo Purg. III delle zone ad esso dedicate, costituisce forse il culmine delle variazioni dei temi dello stato dei dottori. Al cavallo nero va ricondotto il “fummo … come la notte oscuro” degli iracondi, “notte privata d’ogne pianeto … di nuvol tenebrata” (Purg. XV, 142-143; XVI, 1-3). I temi sono presenti nella salita, allorché Virgilio interpreta le parole di Guido del Duca sul desiderio umano dei beni temporali che non soffrono di essere divisi per compagnia (“Ma se l’amor de la spera supprema / torcesse in suso il disiderio vostro”, Purg. XV, 52-53). Si ritrovano nelle parole di Marco Lombardo: “Per montar sù dirittamente vai” (Purg. XVI, 49). Percorrono la divisione delle anime nei gironi della montagna argomentata da Virgilio, sulla base del concetto di amore, all’arrivo nel quarto girone (che risente ancora dei motivi del terzo stato): “L’amor del bene, scemo / del suo dover, quiritta si ristora”, detto con riferimento agli accidiosi (Purg. XVII, 85-86: “quiritta”, come anche nel caso di Belacqua in Purg. IV, 125, non significa solo ‘giusto qui’, ma ha anche un valore che lo inquadra nell’antinomia dei motivi ‘dritto’ / ‘torto’ propri dell’esegesi di Ap 6, 5); la differenza tra amore innato e amore d’elezione, il primo sempre senza errore, mentre l’altro può errare (Purg. XVII, 94-96); l’amore che, se nei beni mondani (i ‘secondi beni’) “sé stesso misura” (tema della retta bilancia), non può essere causa di mal diletto ma che, “quando al mal si torce, o con più cura / o con men che non dee corre nel bene”, opera peccando contro il suo fattore (vv. 97-102). La tematica è ancora presente nel porre da parte di Dante il problema del rapporto tra amore e libero arbitrio: “ché, s’amore è di fuori a noi offerto / e l’anima non va con altro piede, / se dritta o torta va, non è suo merto” (Purg. XVIII, 43-45).
■ Un’altra variazione di questi temi nel Paradiso, tanto contigua da consentire un raffronto simmetrico con Purg. XVII, 91-102, è nella dottrina dell’Incarnazione spiegata da Beatrice nel cielo di Mercurio (Par. VII, 25ss.): per non aver sopportato di porre un freno alla sua volontà (il tema del freno appartiene alla quinta tromba: Ap 9, 1-2), Adamo dannò sé e tutta la sua discendenza, “onde l’umana specie inferma giacque / giù per secoli molti in grande errore”, fino al momento in cui al Verbo di Dio piacque discendere in terra. La natura umana (il terzo stato è appropriato all’uomo razionale: prologo, Notabile I), che si unì a Dio nella persona di Cristo, fu sincera e buona come venne creata, ma nondimeno era per sé stessa in colpa dopo la cacciata dell’uomo dal Paradiso, “però che si torse / da via di verità e da sua vita”: pertanto la pena della croce, se si misura (tema del peso) alla natura umana assunta, fu sommamente giusta e proporzionata alla colpa (ma fu ingiusta rispetto alla persona che soffrì, di qui la vendetta di Dio sui Giudei).
■ La trattazione del successivo cielo di Venere inizia con un riferimento all’“antico errore” delle “genti antiche”, le quali ritenevano che Venere, muovendosi nel terzo epiciclo del cielo, raggiasse il folle amore sugli uomini, e per questo onoravano con sacrifici e voti lei, sua madre Dione e il figlio Cupido, e dalla dea prendevano il nome dell’astro (Par. VIII, 1-12). Carlo Martello, quasi al termine del suo parlare, ammonisce il mondo a seguire l’inclinazione che la natura pone a ciascun uomo, poiché la natura, se trova discordante da sé la fortuna, cioè le condizioni esterne, “fa mala prova”, come un seme gettato fuori del terreno che gli è adatto. Conclude quindi utilizzando il tema del dritto e del torto, che nella prosa è proprio della Scrittura: “Ma voi torcete a la religïone / tal che fia nato a cignersi la spada, / e fate re di tal ch’è da sermone; / onde la traccia vostra è fuor di strada” (vv. 145-148). Il motivo è ripetuto poco dopo, in senso esclusivamente morale, allorché la vita del santo lume che cela l’angioino cessa di parlare: “Ahi anime ingannate e fatture empie, / che da sì fatto ben torcete i cuori, / drizzando in vanità le vostre tempie!” (Par. IX, 10-12; anche l’empietà rientra nel gruppo tematico). Più avanti, Cunizza, nella sua profezia del tradimento di Alessandro Novello, l’empio vescovo minorita di Feltre che nel luglio 1314 consegnò a Pino della Tosa i fuorusciti ferraresi che si erano presso di lui rifugiati, afferma che “troppo sarebbe larga la bigoncia / che ricevesse il sangue ferrarese, / e stanco chi ’l pesasse a oncia a oncia” (vv. 55-57), parole che contengono il tema della bilancia dall’esegesi dell’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5) e quello della stanchezza, che corrisponde al cavallo pallido del quarto sigillo (Ap 6, 8).
■ Un’ulteriore variazione è nell’invito del poeta al lettore a levare con lui lo sguardo a “l’alte rote” dei cieli, “dritto a quella parte / dove l’un moto e l’altro si percuote”, cioè agli equinozi (Dante intende quello primaverile), punti di incontro dei due opposti movimenti rotatori, quello diurno equatoriale di tutti i corpi celesti da est a ovest, e quello annuo zodiacale (o dell’eclittica) dei pianeti da ovest a est (Par. X, 7-9). L’arte del divino maestro, che ama la propria opera creata, provvede alla sua conservazione. Così lo zodiaco, in cui si muovono le orbite del sole e degli altri pianeti, è “oblico”, ossia inclinato, rispetto al piano (il “dritto”) dell’equatore celeste di circa 23 gradi e mezzo. Questa inclinazione dello zodiaco rispetto all’equatore viene incontro ai bisogni della vita sulla terra, essa è un giusto ‘torcersi’ dal “dritto”: se infatti la strada percorsa dalle orbite dei pianeti, cioè lo zodiaco, “non fosse torta, / molta virtù nel ciel sarebbe in vano, / e quasi ogne potenza qua giù morta”; e se poi “dal dritto più o men lontano / fosse ’l partire”, se cioè il divergere dello zodiaco dall’equatore fosse maggiore o minore di quello che è, ne conseguirebbero manchevolezze nell’ordine del mondo, in terra e in cielo, con grave alterazione dei climi (vv. 10-21). È da notare, in Par. X, 25-27, l’appropriazione dei motivi del torcere e della scrittura al poeta, che invita il lettore a cibarsi da solo della materia che gli ha messo innanzi, “ché a sé torce tutta la mia cura / quella materia ond’ io son fatto scriba” (il tema esegetico della Scrittura viene parodiato sia nella ‘scrittura’ del “poema sacro” come nelle parole di Carlo Martello, che lo appropria ad Aristotele a Par. VIII, 120).
■ In altro luogo del Paradiso, nel cielo di Giove, si registrano con una certa consistenza i temi del terzo stato. Nella terza vittoria, il “calculus lucidus” dato al vincitore è il “lapillus” piccolo e solido, calcato dai piedi, cioè Cristo uomo per noi umiliato e assottigliato ma perfuso della luce della grazia, della gloria e della divinità (Ap 2, 17). I temi della fantasia che muove dal senso e del conseguente errore, superato con la terza vittoria, sono già emersi con evidenza nel terzo girone del purgatorio. “Lucidi lapilli” sono definiti gli spiriti giusti che, formando l’aquila, ingemmano il sesto cielo (Par. XX, 16-17). L’esprimersi della benedetta immagine all’unisono, in prima persona singolare pur essendo contesta di molte luci, è fatto che non “fu per fantasia già mai compreso” (Par. XIX, 9), espressione che propone il vittorioso superamento dell’immaginativa che elabora le forme sensibili (cfr. la variazione dei temi a Par. X, 40-48).
L’aquila, che parla come un dottore sulle più profonde verità della fede, canta anche il tema della bilancia e del misurare dal terzo sigillo (Ap 6, 5), riferito a Dio, “quel bene / che non ha fine e sé con sé misura” (Par. XIX, 49-51), nonché il motivo dell’errore, appropriato al “mondo errante” il quale mai crederebbe che Rifeo Troiano fosse la quinta della sante luci che circondano la sua pupilla (Par. XX, 67-69).
Sono da notare anche le parole sulla “giustizia sempiterna”, che scindono il lume che “vien dal sereno / che non si turba mai” dai falsi lumi, “tenèbra / od ombra de la carne, o suo veleno” (Par. XIX, 64-66; l’oscurità è propria del cavallo nero all’apertura del terzo sigillo).
Queste parole dell’aquila portano al più alto livello il discorso di Virgilio, a Purg. III, sulla necessità di restare al quia. Discorso non a caso prefigurato dall’ombra recata dal corpo umano di Dante che rompe la luce del sole nel nuovo tempo (il Purgatorio è segnato dal tempo della Chiesa) e dall’ora del vespro a Napoli, “dov’ è sepolto / lo corpo dentro al quale io facea ombra”, che corrisponde al tempo antico, prima della venuta di Cristo.
Si possono dunque registrare, per la terza cantica, due zone dove si mostrano in prevalenza temi del terzo stato: la prima ha come centro il terzo cielo, di Venere, con propaggini nel cielo che precede e in quello che segue; la seconda è imperniata sul sesto cielo, di Giove. La topografia spirituale del Paradiso è tuttavia assai più complessa, come più fitto è l’intreccio dei motivi e più sottili le variazioni dei temi rispetto alle prime due cantiche.
Tab. XVIII.e
Purg. II, 4-6e la notte, che opposita a lui cerchia,
|
Purg. XI, 73-75, 103-108Ascoltando chinai in giù la faccia;
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 5 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal” (Ap 6, 5), scilicet quod habebat faciem hominis, “dicens: Veni”, scilicet per maiorem attentionem vel per imitationem fidei doctorum hic per hominem designatorum, “et vide. Et ecce equus niger”, id est hereticorum et precipue arrianorum exercitus astutia fallaci obscurus et erroribus luci Christi contrariis denigratus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet imperatores et episcopi arriani, “habebat stateram in manu sua”. Cum statera mensuratur quantitas ponderum, et ideo per stateram designatur hic mensuratio articulorum fidei, que quando fit per rectam et infallibilem regulam Christi et scripturarum suarum est recta statera, de qua Proverbiorum XVI° dicitur: “Pondus et statera iudicia Domini sunt” (Pro 16, 11), et Ecclesiastici XXI°: “Verba prudentium statera ponderabuntur” (Ecli 21, 28); quando vero fit per rationem erroneam et per falsam et intortam acceptionem scripture est statera dolosa, de qua Proverbiorum XI° dicitur: “Statera dolosa abhominatio est apud Deum” (Pro 11, 1), et in Psalmo: “Mendaces filii hominum in stateris” (Ps 61, 10), et Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram impiam et sac<c>elli pondera dolosa” (Mic 6, 11). |
|
Purg. XXII, 28-30, 34-39, 46-51, 61-63, 85-87, 130-132Veramente più volte appaion cose
|
Par. I, 133-135e sì come veder si può cadere
|
Tab. XVIII.f
Purg. XV, 9, 43-45, 52-53, 142-143che già dritti andavamo inver’ l’occasoe drizza’mi a lui sì dimandando:
|
Par. VII, 13-18, 25-45, 55-63Ma quella reverenza che s’indonna
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 5 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal” (Ap 6, 5), scilicet quod habebat faciem hominis, “dicens: Veni”, scilicet per maiorem attentionem vel per imitationem fidei doctorum hic per hominem designatorum, “et vide. Et ecce equus niger”, id est hereticorum et precipue arrianorum exercitus astutia fallaci obscurus et erroribus luci Christi contrariis denigratus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet imperatores et episcopi arriani, “habebat stateram in manu sua”. Cum statera mensuratur quantitas ponderum, et ideo per stateram designatur hic mensuratio articulorum fidei, que quando fit per rectam et infallibilem regulam Christi et scripturarum suarum est recta statera, de qua Proverbiorum XVI° dicitur: “Pondus et statera iudicia Domini sunt” (Pro 16, 11), et Ecclesiastici XXI°: “Verba prudentium statera ponderabuntur” (Ecli 21, 28); quando vero fit per rationem erroneam et per falsam et intortam acceptionem scripture est statera dolosa, de qua Proverbiorum XI° dicitur: “Statera dolosa abhominatio est apud Deum” (Pro 11, 1), et in Psalmo: “Mendaces filii hominum in stateris” (Ps 61, 10), et Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram impiam et sac<c>elli pondera dolosa” (Mic 6, 11).
|
|
Par. VIII, 1-12, 115-120, 145-148Solea creder lo mondo in suo periclo
|
Par. X, 7-27Leva dunque, lettore, a l’alte rote
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 17 (Ia visio, IIIa victoria] Tertia est victoriosus ascensus super phantasmata suorum sensuum, quorum sequela est causa errorum et heresum. Hic autem ascensus fit per prudentiam effugantem illorum nubila et errores ac impetus precipites et temerarios ac tempestuosos. Hoc autem competit doctoribus phantasticos hereticorum errores expugnantibus, quibus et competit premium singularis apprehensionis et degustationis archane sapientie Dei, de quo tertie ecclesie dicitur: “Vincenti dabo manna absconditum, et dabo ei calculum lucidum, et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo novit, nisi qui accipit” (Ap 2, 17). […] Calculus autem, id est lapillus parvulus et solidus, pedibus sepe calcatus, est homo Christus pro nobis humiliatus et exinanitus, luce gratie et glorie et deitatis <per>fusus, in quo est nomen novum. |
|
Nella terza età del mondo, dopo che i Sodomiti furono sommersi nel Mar Morto e gli Egiziani nel Mar Rosso, venne data al popolo di Dio la legge e l’ira divina fece sì che Core, Datan e Abiram e gli altri scismatici venissero inghiottiti (Numeri 16, 31-35); così nel terzo stato della Chiesa, sommersa la lussuria e l’idolatria delle genti per la morte e per il sangue di Cristo, venne data la legge costituita dai decreti ecclesiastici e dagli statuti regolari e l’ira divina ribollì sugli scismatici e sugli eretici per mezzo dei dottori, espositori della fede. Ancora (sempre nella terza età e nel terzo stato), come a causa della superba torre di Babele le lingue furono confuse e divise e la lingua prima e retta rimase nella casa di Eber e degli Ebrei, e poi, mentre le altre lingue precipitavano nell’idolatria diabolica, la fede e il culto di un solo vero Dio rimase nella casa di Abramo, così a causa della superbia di molti fedeli la lingua e la confessione della sola vera fede di Cristo venne divisa e confusa in più eresie, mentre la prima e vera lingua e confessione rimase nella casa di Pietro (prologo, Notabile XIII). Dei dottori del terzo stato sono proprie la discrezione e la prudenza, acquisite con l’esperienza che viene dalle tentazioni (preminenti nel secondo stato, dei martiri), con cui si pongono a confronto le situazioni in modo da escludere quanto è stolto o erroneo (si tratta del terzo esercizio della mente esposto ad Ap 2, 1). La lingua, secondo l’interpretazione propria di Gioacchino da Fiore del “calamus” dato a Giovanni di cui si dice in apertura del capitolo XI (terza visione, sesta tromba), è la “lingua erudita” che corregge con la sua austerità i cuori degli uomini. Il “calamo simile alla verga”, con cui si misurano correttamente gli edifici o i panni – corrisponde al “duro camo / che dovria l’uom (nel senso di uomo razionale) tener dentro a sua meta” di Purg. XIV, 143-144 [1] – designa il potere di reggere, dirigere, correggere e volgere in dritta parte le bestie indomite, con discrezione, virtù e giustizia.
Esiste pertanto equivalenza tra la legge data dai dottori, l’unica vera e indivisa lingua da essi predicata e la loro autorità che regge con esperienza e discernimento la Chiesa. Tutti motivi che emergono nel colloquio con Marco Lombardo (Purg. XVI), dove le variazioni sui temi del terzo stato sono al sommo: la necessità di porre freno con legge, di avere re che discerna “de la vera cittade almen la torre”, opposta a quella di Babele (vv. 94-96); l’esempio della Chiesa di Roma, la quale unendo in sé la spada e il pastorale ha confuso due soli e “due reggimenti”, generando una ‘babilonia’ inversa rispetto a quella provocata nelle lingue dall’“ovra inconsummabile” cui attese “la gente di Nembròt” (vv. 127-129). Nelle voci degli iracondi, che dicono “Agnus Dei”, “una parola in tutte era e un modo” (vv. 19-21), ma si verifica l’incomprensione linguistica tra i due interlocutori sul “buon Gherardo” (vv. 136-141: «“O tuo parlar m’inganna, o el mi tenta”, / rispuose a me; “ché, parlandomi tosco, / par che del buon Gherardo nulla senta”»).
Come già sopra esposto, il motivo della lingua vera, confessione dell’unica fede di Cristo di cui dovrebbe essere custode la casa di Pietro, sottolinea il duro rimprovero del poeta al simoniaco Niccolò III per “lo suon de le parole vere espresse” (Inf. XIX, 123). Alla stessa rosa tematica appartengono l’atteggiarsi di Dante, piegato col capo sul dannato confitto come palo nel foro della pietra, a frate confessore del “perfido assessin”; il suo restare scornato alle prime, incomprensibili parole di Niccolò che l’ha scambiato per Bonifacio VIII arrivato a prendere il suo posto prima del tempo (vv. 49-50, 58-60); il riferimento a Clemente V come “pastor sanza legge” (vv. 82-84).
In Inf. XXVIII Virgilio spiega a Maometto che Dante è ancora in vita, portato in giro per l’inferno “per dar lui esperïenza piena … e quest’ è ver così com’ io ti parlo” (vv. 46-51). Nel medesimo canto, tra i seminatori di scandalo e di scisma tagliati dalla spada di un diavolo (la spada è attributo dei dottori, che scindono l’eresia), il tema della lingua divisa prende forma di “contrapasso” in Curione, che con ardito parlare vinse l’esitazione di Cesare nel passare il Rubicone, dando l’avvio alla guerra civile, e che ora sta “sbigottito / con la lingua tagliata ne la strozza” (vv. 100-102).
Nella bolgia dei ladri, la lingua dell’uomo che si trasforma in serpente, “ch’avëa unita e presta / prima a parlar, si fende” (Inf. XXV, 133-134) [2].
Di leggi parla Catone: “Son le leggi d’abisso così rotte? … quella legge / che fatta fu quando me n’usci’ fora” (Purg. I, 46, 89-90), nel primo caso accostando loro il verbo ‘rompere’, tipico della terza chiesa (Ap 2, 12: “qui habet rumpheam”), e l’aggettivo “nera” alla “valle inferna” (allusione al cavallo nero in apertura del terzo sigillo, Ap 6, 5).
[1] “Camo” (freno, morso) in realtà deriva da “camus” e non da “calamus”, e come tale è nel Salmo 31, 9: “in camo et freno maxillas eorum constringe”, citato a Monarchia III, xv, 9. Ma il “calamus” di Ap 11, 1 è in realtà un “camus”, ed è accompagnato da motivi non contenuti nel Salmo 31, 9: la durezza, il discernere di colui che regge, l’uomo (razionale).
[2] La lingua di Virgilio è di un reggitore: il poeta latino è colui che possiede la scienza della discrezione, in virtù della quale conosce luoghi e tempi per ammettere ed escludere i malvagi dannati, che fa a lui venire, che “adizza” a parlare e ai quali dà licenza di andar via. La sua “parola ornata” o “parlare onesto” (così dice Beatrice in Inf. II, 67, 113), con cui nel mondo scrisse “li alti versi”, corrisponde alla “lingua erudita-calamo” data a Giovanni (Ap 11, 1): è la sola che possa piegare gli “schivi” Greci; essa frena la lingua del discepolo (Inf. XXVI, 70-75), congeda in lombardo la fiamma che fascia Ulisse, fa drizzare la voce del “latino” Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 19-21). Equivale agli sproni e al freno con cui l’Imperatore dovrebbe correggere l’Italia, “costei ch’è fatta indomita e selvaggia”, dopo che la Chiesa (la “gente” che dovrebbe “esser devota”) si è impadronita della cavalcatura (Purg. VI, 91-99).
Tab. XVIII.g
[LSA, prologus, Notabile XIII] (III) Sicut etiam in tertia (etate), submersis Sodomitis in mari mortuo et Egiptiis in mari rubro, data est lex populo Dei et Choree, Datan et Abiron cismaticos ceterosque de filiis Israel temptatores Dei absorbuit ira eius (Nm 16, 31-35), sic in tertio statu, luxuria et idolatria gentium per mortem et sanguinem Christi submersa, data est lex ecclesiasticorum decretorum et regularium statutorum populo Christi et contra cismaticos et hereticos efferbuit ira Dei.
|
|
[LSA, cap. XI, Ap 11, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] “Et datus est michi calamus” (Ap 11, 1). Hic ordini prefato datur potestas et discretio regendi ecclesiam illius temporis. Datio enim potestatis significatur <per> donationem calami, quo artifices domorum solent mensurare edificia sua. Discretio vero regendi sibi dari designatur, tum per regularem ipsius calami rectitudinem et mensuram, tum per hoc quod docetur quos debeat mensurare, id est regere, et quos relinquere. Dicit autem: “Et datus est michi”, supple a Deo, “calamus similis virge”, quasi dicat: non similis vacue et fragili canne seu arundini, sed potius recte et solide virge. Et certe tali communiter mensurantur panni et edificia. Per hanc autem designatur pontificalis vel magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei. Secundum Ioachim, calamus iste signat linguam eruditam, dicente Psalmo (Ps 44, 2): “Lingua mea calamus scribe”, qui est similis virge, quia sicut austeritate virge coarcentur iumenta indomita, ita lingue disciplina dura corda hominum corriguntur. [Expositio, pars III, f. 145rb] |
|
Inf. XIX, 49-50, 58-60, 82-84, 121-123Io stava come ’l frate che confessa
|
Purg. XVI, 19-21, 94-97, 127-141Pur ‘Agnus Dei’ eran le loro essordia;
|