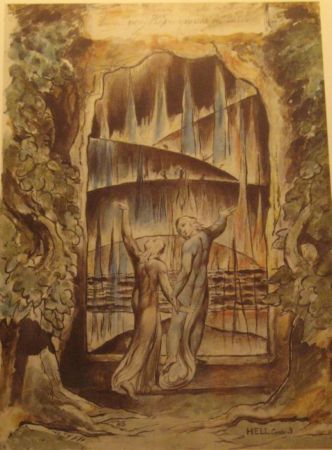La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuoriCanti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXXII, 124-XXXIII, 90
|
Introduzione. I. La porta dolorosa. II. La chiesa dei tiepidi. III. Un eletto decaduto: “l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto”. IV. Sulle rive d’Acheronte. Testi e commento.
INTRODUZIONE
Il terzo canto dell’Inferno si divide in tre parti principali. La prima riguarda la porta prima di varcarla (vv. 1-21). La seconda descrive l’ambiente infernale e i primi dannati incontrati, i pusillanimi (vv. 21-69). La terza narra quanto avviene sulla riva d’Acheronte (vv. 70-136).
■Come il primo verso del poema – “Nel mezzo del cammin di nostra vita” – contiene, incardinato nel senso letterale che allude al trentacinquesimo anno dell’autore, il riferimento a Cristo mediatore, la cui vita deve essere dalla nostra perfettamente imitata e partecipata, così la scritta sulla porta dell’inferno – l’“atri ianua Ditis” dell’Eneide (VI, 127) – inizia i primi tre versi ripetendo tre volte “Per me si va”, parodicamente rovesciando e adattando a un duro senso le parole di Cristo in Giovanni 10, 9: “Io sono la porta. Chi entrerà per me sarà salvato”. Solo la seconda terzina fa appello all’intera Trinità creatrice. Al sommo della porta sono scritte parole di colore oscuro e dal senso duro; al di là di essa è chiusa ogni illuminazione spirituale, come una pesante pietra chiudeva il sepolcro di Cristo prima della resurrezione. Una volta entrata, la “mente che non erra” dovrà ritrarre un luogo di antica lapidea durezza nell’Inferno, che potrebbe definirsi l’Antico Testamento del “poema sacro”.
“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”: ricorda Georges Güntert che Jacob Burckhardt “intitolò così il suo capitolo sulle città italiane del Medioevo, per indicare l’infausta politica da esse seguita” [1]. La “città dolente” non è semplicemente una generica Babilonia infernale in antitesi con la Gerusalemme celeste, è parodia di Babylon, la prostituta-città apocalittica storicamente operante al 1300, prossima a venire incenerita. I mercanti piangono la perdita del lucro acquistato nei commerci con la grande città, ora che è caduta. Il linguaggio mercantile – l’acquistare e il tristo perdere nel pianto, il perdere ogni speranza di guadagni, l’equivoco tra merce (il lucro) e mercede (il premio), il navigare per vie più o meno gravi verso porti più o meno lontani, la fine delle delizie di Babilonia, desideri per anime sensuali – segna molti luoghi dei primi canti del poema. Gli abitanti della “città dolente” del aldilà, antichi e moderni, sono pregni di passioni individuali; queste sono però fasciate da una veste sacra, ritagliata parodiando l’escatologia contenuta nella Lectura super Apocalipsim, e inserite in tal modo in un processo storico universale che manifesta i segni della volontà divina. Firenze è “città partita”, assalita da tanta discordia (Inf. VI, 61-63), dal giglio “per divisïon fatto vermiglio” (Par. XVI, 151-154). Le sue fazioni sono assimilate alle divisioni della religione evangelica che si verifica in apertura del sesto sigillo con il grande terremoto che divide in tre parti Babylon (Ap 6, 12; 16, 19-20; allo stesso terremoto alludono i versi finali di Inf. III), allorché i monti (cioè quanto di più stabile) vengono traslati e Babylon viene privata di ogni letizia nuziale (Ap 18, 22-23). Temi quasi cristallizzati nel nome di colui da cui tutto cominciò, Buondelmonte, contenente in sé letizia (bonum) e stabilità (montes), inopinatamente fuggiti (Par. XVI, 136-141).
Dante vive in un periodo, il sesto ‘stato’ della storia della Chiesa (la parodia applica liberamente questa su più soggetti), la cui la principale prerogativa è far parlare liberamente, per dettato interiore dello Spirito. È questo un tema che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo, anche nella vecchia roccia infernale. Appartiene alla sesta chiesa il parlare liberamente di Cristo – ad essa è dato l’“ostium apertum”, che è “ostium sermonis” – , la porta aperta alla favella, il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà. Appartiene alla sesta chiesa anche far venire quelli che si dicono Giudei senza esserlo, mutati nel cuore e disposti a farsi battezzare e governare. Questo far venire a parlare equivale all’invito dello Spirito di Cristo a convivare, a venire con desiderio e volontario consenso, in una pausa di pace nell’eterna dannazione. All’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono “dal voler portate” verso un momento di mutazione e quasi di conversione, sebbene limitata al successivo colloquio. Tutto l’Inferno è un contrappunto fra la durezza del giudizio – iscritta al sommo della porta -, e l’apertura al ricordo della vita per la parola dirompente, finché essa dura, la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi per poi ricadere, sollevarsi da atti bestiali per ritornare a essi dopo aver parlato, come nel conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per sé stesse mosse, sta un solo desiderio, il vivere ancora nel libro che è stato ad altri aperto.
■ Nella seconda parte del canto, l’ignavia dei peccatori senza nome è segnata parodiando per esteso l’esegesi oliviana dell’istruzione data alla tiepida settima chiesa d’Asia, Laodicea. Ad essa viene rimproverata (Ap 3, 17) la presunzione di considerarsi senza difetti, nella ritenuta abbondanza di ricchezze che paiono renderla sufficiente a sé stessa. Si considera beata, e invece è misera (la miseria si oppone alla beatitudine), miserabile (perché abbisogna di commiserazione), povera (perché manca non solo del sufficiente, ma pure del necessario), cieca (perché difetta della prudenza e della previdenza con cui i ricchi, che reggono le città e consigliano i potenti, raccolgono, conservano e dispensano i beni materiali; così i ricchi di beni spirituali sono prudenti e conoscono i consigli divini), nuda (a differenza dei ricchi, che indossano vesti preziose e ornate). Sono i difetti comuni a un mendicante cieco, nudo, bisognoso, pieno di miserie e miserabile all’altrui sguardo. Di essi sono vestiti gli ignavi. Il difetto maggiore del vescovo (o della chiesa) di Laodicea è la tepidezza, il non trovarsi né nel calore della carità che esulta in Dio né nel freddo dell’infedeltà triste per i propri peccati, per cui gli viene detto: “Magari tu fossi freddo o caldo!” (Ap 3, 15). Meglio (secondo Riccardo di San Vittore) sarebbe trovarsi freddi infedeli per ignoranza, ma con possibilità di convertirsi all’ardore della vera giustizia, piuttosto che tiepidi rinunciatari di una via di perfezione intrapresa e apostati da un alto stato. Olivi cita un passo delle Collationes di Cassiano a conferma di come sia più facile che un infedele o un secolare acquisti fervore spirituale che un monaco vi ritorni dopo averlo perduto. Verso questi “tiepidi”, detestati da Dio, anzi da lui vomitati, gli uomini spirituali e i dottori debbono tralasciare di diffondere moniti o insegnamenti salutari cosicché, spregiata una terra sterile occupata da sterpi nocivi, spargano altrove il seme della parola salutare, in una nuova terra tra i pagani e i secolari, piuttosto che seminare sulle spine, secondo il comando del profeta Geremia (Jr 4, 3). I temi del tepore, del dispregio e del vomito sono propri degli ignavi, “a Dio spiacenti e a’ nemici sui”, sdegnati dalla misericordia e dalla giustizia divina, dei quali il dottore Virgilio, che applica i precetti dell’abate Daniele nelle Collationes di Cassiano, parla brevemente: “non ragioniam di lor, ma guarda e passa” (Inf. III, 50-51, 63).
●La parodia dell’esegesi relativa a Laodicea in due casi opera su altri luoghi del “panno” apocalittico. Il primo riguarda il “cattivo coro” degli angeli neutrali (vv. 37-39), il secondo la “setta d’i cattivi” con “l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto” (vv. 58-60). I ‘cattivi’ sono i prigionieri fatti dai Saraceni, secondo l’esegesi dell’apertura del quarto sigillo (Ap 6, 8), in cui il cavallo pallido (la morte, già parodiato nella lupa) designa Maometto e la sua setta, secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore seguita da Olivi. Da quando i Saraceni hanno iniziato a devastare la Chiesa non si è mai letto o ascoltato di miracoli fatti dai fedeli uccisi o resi schiavi, né che fosse stato dato il verbo della predicazione per convertire a Cristo gli infedeli e vivificarli o per confermare nella vita della fede i fedeli, ché anzi la maggior parte dei finiti in cattività è convolata alla setta mortifera. Tra i Saraceni non accade – e ciò da più di seicento anni – quanto era avvenuto con i pagani e gli eretici, fra i quali si moltiplicavano i fedeli e molti venivano convertiti alla fede.
Ad Ap 12, 18, l’“arena” terrestre, polverosa, sterile, divisa in innumerevoli particelle indurite, instabile e disperdibile a ogni vento, penetrata e sbattuta dall’acqua del mare o putrefatta dal sole, viene interpretata, nel senso di Gioacchino da Fiore, come la moltitudine di coloro che non sono del tutto infedeli ma neppure aderenti alla pietà cristiana con l’integra purezza della fede. Si tratta delle genti (i cristiani di Alessandria e della Siria) rimaste in aliqua sui parte nelle terre orientali conquistate dai Saraceni vicine al mare dei pagani, come l’arena è vicino al mare. A questa esegesi rinvia il “cattivo coro”, mischiato agli ignavi, degli angeli che furono per sé, né ribelli né fedeli a Dio e per questo cacciati dai cieli e non ricevuti dal profondo inferno (Inf. III, 37-39). Il motivo dell’“arena” introduce a sua volta le terzine degli ignavi, nella descrizione del “tumulto, il qual s’aggira / … come la rena quando turbo spira” (vv. 28-30). Le anime degli ignavi sono “mischiate a quel cattivo coro” degli angeli neutrali; anche il ‘mischiare’ li contamina con la gente saracena, un tempo di puro ferro, secondo Gioacchino da Fiore, ma poi mescolatasi con altre genti.
● Con “l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto” l’esegesi di riferimento è quella del sesto stato, cioè dei tempi moderni. L’“insegna / che girando correa tanto ratta, / che d’ogne posa mi parea indegna” è la parodia della “dignitas signatorum”, di coloro che sono chiamati a guidare la milizia di Cristo, e per questo sono nominati, all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3-4). I magnanimi segnati, nei quali non c’è traccia di viltà, sono votati al martirio, non però quello corporale degli antichi cristiani, ma quello psicologico inferto dai seguaci dell’Anticristo, che insinua il dubbio sulle verità di fede, che inganna con false Scritture e con la falsa immagine dell’autorità papale (prologo, Notabile X). Quanti resistono a questo martirio non negano il nome di Cristo, ma lo confessano aprendosi (Ap 3, 8). L’innominato è dunque un eletto a un’alta carica, il quale vive nel sesto stato della Chiesa e che, trovandosi nell’angustia della persecuzione dove è chiamato a testimoniare la regola evangelica, si sente inadeguato, vile, e per questo rifiuta la “guerra”. Viene meno al precetto dato alla sesta chiesa – «“et non negasti nomen meum” scilicet in angustia persecutionis, aliter enim non est magnum non negare nomen Christi» -, per cui il suo è un “gran rifiuto” (negare equivale a rifiutare), fatto dal Vicarius Christi, colui che in terra ne porta il nome. Tutti gli indizi portano a Celestino V, come ben videro i contemporanei. Anfiarao, l’antico re di Argo, ha abbandonato la guerra tebana (Inf. XX, 21-36); il dubbio ha investito Dante se intraprendere “la guerra / sì del cammino e sì de la pietade”, ma poi il poeta si è aperto alle parole di Virgilio (Inf. II, 3-5; 127-132); Guido da Montefeltro non ha negato di fronte a Bonifacio VIII, confessando però la frode ingannato da una falsa immagine papale (Inf. XXVII, 100-111). Al contrario, “in tanta guerra”, il giovinetto Stefano “de li occhi facea sempre al ciel porte” (Purg. XV, 106-114) e Francesco, per quanto di vili origini come Pietro del Morrone, aprì a Innocenzo III la sua dura intenzione di vita (Par. XI, 88-93). Quanto Jacopone aveva realisticamente paventato, che la grande dignità alla quale l’eremita era stato assunto fosse pari alla tempesta che l’attendeva, viene da Dante certificato nel senso che il papa non seppe “portar ritto el gonfalone” apostatando da un alto stato.
■ La grande parodia fornisce, nel suo carattere polifonico, “e piedi e mano” alle perfezioni di Cristo sommo pastore, appropriandole liberamente ai dannati, come note dissonanti che suonano quanto è da Lui estraneo e diverso, ai purganti e ai beati; di esse si fregiano Virgilio, Caronte o Catone: manto (1, 13), capelli (1, 14), occhi (1, 14), piedi (1, 15).
“A la riva d’un gran fiume”, memore del grande fiume Eufrate che scorreva nell’antica Babilonia (Ap 16, 12; Inf. III, 71), Caronte è vestito con le prerogative della quarta perfezione di Cristo, che si mischiano con le immagini tratte dall’Eneide: «Charon, cui plurima mento / canities inculta iacet … iam senior – reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas per senilem et gloriosam canitiem capitis et crinium designata, unde subdit: “caput autem eius et capilli erant candidi tamquam lana alba et tamquam nix” – un vecchio, bianco per antico pelo» (Aen., VI, 299-300, 304; Ap 1, 14; Inf. III, 83). Di Cristo vengono citate le due vie, corrispondenti al calore della bianca lana e al freddo della neve, entrambe volte alla punizione: “i’ vegno per menarvi a l’altra riva / ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo … le lanose gote” (Inf. III, 86-87, 97). Gli “occhi di bragia” rinviano alla quinta perfezione (Ap 1, 14; 19, 12; v. 109), consistente nel fervido, splendente e perspicace zelo che osserva intorno ogni atto, intenzione o cenno delle chiese, per cui si dice: “e i suoi occhi fiammeggianti come fuoco”. La fiamma degli occhi ruota per acre zelo (Ap 9, 7.9; v. 99), a differenza del virgiliano “stant lumina flamma” (Aen. VI, 300). Si manifesta al modo di Cristo giudice: «”Ecce venit” … “veniam tibi”, id est contra te – Ed ecco verso noi venir … i’ vegno» (Ap 1, 7; 2, 12; vv. 82, 86). Batte col remo le anime pigre come Cristo usa la spada, cioè le vive parole, per condannare (Ap 2, 12; v. 111). Separando i buoni (Dante) dai malvagi, grida l’apocalittico “vae!” (“guai!”) contro quanti hanno reso la terra prava (Ap 11, 18; vv. 84, 88-89, 122).
Demonio peloso, come nella Babilonia descritta dai profeti (Ap 18, 2-3; vv. 83, 109), Caronte, non unico caso nel poema, è anche parodia fonosimbolica di Carlo Magno, il quale raccolse e radunò le reliquie della Chiesa, dopo le devastazioni saracene, a Roma, in occidente; fu allora istituita una vita “condescensiva”, cioè aperta alle moltitudini (che poi degenerò in rilassatezza e corruzione). Raccogliere i malvagi, membri della Chiesa carnale, è proprio di Caronte – “Caron dimonio, con occhi di bragia / loro accennando, tutte le raccoglie” -, il cui nome ha singolare consonanza con Karolus; il discendere e il radunarsi appartengono alle schiere dei dannati, sull’una e l’altra riva d’Acheronte (prologo, Notabile V; Inf. III, 109-110, 118-120; cfr. il sangue degli ignavi “che, mischiato di lagrime, a’ lor piedi / da fastidiosi vermi era ricolto”, vv. 67-69, parodia della piaga inferta ai piedi dai Manichei).
Come nell’Apocalisse i dieci re sono mossi con occulto ordine dalla giustizia divina, che fa coincidere la loro volontà con la propria e, spronati dal timore, consegnano “unus post alterum” la propria volontà alla bestia, devolvendo ad essa il potere regio che prima avevano libero, così le anime di quanti muoiono nell’ira di Dio sono pronte a passare al di là dell’Acheronte “l’una appresso de l’altra”, spronate dalla divina giustizia “sì che la tema si volve in disio” (Ap 17, 13.17; Inf. III, 70-75, 124-126).
La sintesi dell’Eneide con l’Apocalisse raggiunge l’apice con la celebre similitudine di Inf. III, 112-114: “Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie”, riferita al “mal seme d’Adamo” pronto a passare l’Acheronte, spronato dalla giustizia divina. La terzina, nel confronto tra Commedia e Lectura, va accostata a quella di Par. XXVIII, 115-117, riferita alla seconda terna della gerarchia angelica, “che così germoglia / in questa primavera sempiterna / che notturno Arïete non dispoglia”. L’Ariete è “notturno”, cioè visibile di notte, nell’autunno, mentre all’inizio della primavera sorge e tramonta con il sole. L’espressione traduce pertanto in poesia il concetto che nella città dei beati non vi sarà più notte (Ap 21, 25; “Nox enim non erit illic”). Su questo tema principale si innesta, come contrappunto, la tematica del ‘ladro’, trattata nei due passi simmetrici di Ap 3, 3 e 16, 15. Il ladro viene di notte (Ap 3, 3), come il giorno del giudizio: così scrive san Paolo ai Tessalonicesi invitandoli a vegliare e ad essere “figli della luce e del giorno” (1 Th 5, 2-7). E ad Ap 16, 15 si aggiunge: “Beato chi vigila e custodisce le sue vesti”, cioè le virtù e le buone opere, “affinché non vada nudo”, cioè spogliato delle virtù in modo che tutti vedano i suoi turpi peccati e la pena che verrà inflitta a sua confusione nel giorno del giudizio. Il verbo ‘spogliare’ è lo stesso proprio del notturno e autunnale Ariete.
È da notare, nella similitudine dei dannati con l’albero, l’accostamento del vedere, appropriato al ramo, con lo spogliarsi, motivi non presenti nella reminiscenza virgiliana – “Quam multa in silvis autumni frigore primo / Lapsa cadunt folia …” (Aen. VI, 309-310) – “fin che ’l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie” (Inf. III, 113-114) – «“ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus; “et videant”, scilicet omnes tam boni quam mali, “turpitudinem eius”» (Ap 16, 15) -, e che sono invece nell’esegesi di Ap 16, 15. È pertanto irricevibile, per motivi diversi da quelli addotti dal Petrocchi, la più facile variante rende: l’albero, vedendo a terra le sue foglie, partecipa della tristezza e miseria di “quelli che muoion ne l’ira di Dio”.
■Dal punto di vista della stesura, il terzo canto dell’Inferno registra un’ampia e accurata elaborazione dei temi della Lectura super Apocalipsim, in particolare nelle variazioni sui temi dell’istruzione data alla chiesa di Laodicea (i temi non sono tratti solo dall’Apocalisse in sé, ma da questa secondo l’esegesi di Olivi). Vi sono tuttavia alcuni versi che non sembrano rinviare a passi esegetici; il fenomeno, molto più ampio nei canti VI, VII, VIII e XI, sarà da valutare una volta esaminati compiutamente il primo gruppo di canti (a partire dal XII la rete semantica riferibile ciclicamente ai sette stati oliviani è più estesa, organizzata e compatta; alcune considerazioni preliminari sono state formulate in sede di esame di Inf. I). Una varietà di motivi pervade i versi relativi alla porta dell’inferno, come pure quelli che descrivono il passaggio dell’Acheronte. In questi ultimi, per la prima volta, il “poema sacro” si misura con l’Eneide, e lo fa concordandola con l’escatologia oliviana, cioè con la storia dei segni divini nel tempo umano, del quale Cristo è il centro.
[1] G. GÜNTERT, Canto III, in Lectura Dantis Turicensis, a cura di G. Güntert e M. Picone, Inferno, Firenze 2011, pp. 49-60: 51.
Inferno III |
Legenda [3] : numero dei versi; 18, 10 : collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo/i e versetto/i dell’Apocalisse [Ap]; Not. III : collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. Varianti rispetto al testo del Petrocchi.Qui di seguito viene esposto Inf. III con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim [html] [PDF] ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (PDF; introduzione in html). In quella sede è stato attribuito un diverso colore a ogni singolo status o gruppo di materia esegetica; in questo caso l’attribuzione dei colori segue il principio della maggiore evidenza. Ogni tabella sinottica, qui presentata o alla quale si rinvia in quanto già esaminata in altra sede, è preceduta o seguita da una parte esplicativa. |
‘Per me si va ne la città dolente, 21, 12; 18, 10
|
Abbreviazioni e avvertenze
Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.
LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.
Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).
Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.
Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.
In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.
Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.
Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994. Si tiene anche conto della recente edizione a cura di G. INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA.
I
LA PORTA DOLOROSA
■ L’imitazione di Cristo, tema fondamentale sul quale il “poema sacro”, fin dal primo verso, opera innumerevoli variazioni, tocca anche la scritta sulla porta dell’inferno. Essa ripete tre volte “Per me si va”. Rovesciate e adattate al loro duro senso, sono le parole di Cristo in Giovanni 10, 9: “Io sono la porta. Chi entrerà per me sarà salvato”, accompagnate da una triplice ripetizione del dolore: “ne la città dolente … ne l’etterno dolore … tu vedrai le genti dolorose”, per quanto la terza volta sia fuori della scritta, nelle parole di Virgilio (Inf. III, 1, 2, 17). Nell’esegesi, Cristo ad Ap 21, 12 è detto fondamento, porta e portinaio della Gerusalemme celeste. Ad Ap 4, 2 Olivi propone l’immagine della porta della tomba di Cristo, sulla quale era posta una pietra grande e pesante che fu rimossa al momento della resurrezione e dell’uscita dal sepolcro. Essa designa il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, che chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso all’intelligenza spirituale. Nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. Così al sommo della porta dell’inferno sono scritte parole di colore oscuro e dal senso duro, non solo minacciose, ma pure chiuse a ogni illuminazione spirituale (Inf. III, 10-12). I motivi del chiudere e della durezza segnano la descrizione del fondo dell’inferno, “nel loco onde parlare è duro”, che necessita di rime “aspre e chiocce”: in suo aiuto il poeta, memore di Stazio (Theb. X, 873-877) e dell’Ars poetica di Orazio (vv. 394-396), che fa concordare con l’esegesi apocalittica, invoca le Muse, le quali aiutarono Anfione “a chiuder Tebe” traendo con il suono della lira le pietre delle mura dal monte Citerone (Inf. XXXII, 10-14). È anche “cosa dura” dire della “selva selvaggia e aspra e forte” (Inf. I, 4-5). L’Inferno, che potrebbe definirsi l’Antico Testamento del “poema sacro”, è il luogo dell’antica lapidea durezza, dell’impetrarsi, del parlare duro di cose dure a dirsi, del duro giudizio, del senso duro della scritta al sommo della porta, dei duri lamenti, dei duri demoni, dei duri veli del gelo, della gravezza.
■ La “città dolente” è parodia di Babylon, la prostituta apocalittica, incenerita. Piangono i re della terra la caduta improvvisa e irreparabile della grande città, «“dicentes”, scilicet plangendo: “Ve, ve, ve”» (Ap 18, 10). È il modo di Francesca: “dirò come colui che piange e dice” (Inf. V, 126), ove si passa dalla prima alla terza persona. E Ugolino: “parlare e lagrimar vedrai insieme” (Inf. XXXIII, 9). Triplicano i re la dolorosa interiezione, parlano di Babilonia in terza persona e poi in seconda, al modo di coloro che prima piangono con sé stessi, poi si rivolgono alla persona compianta. Ai tre sodomiti che gli hanno chiesto (per bocca di Iacopo Rusticucci) se cortesia e valore dimorino “ne la nostra città sì come suole”, riferendosi ad essa in terza persona, Dante risponde direttamente in seconda persona: “La gente nuova e i sùbiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni” (Inf. XVI, 73-75). La dolorosa scritta sulla porta dell’inferno ripete per tre volte “Per me si va”; l’anafora distingue ancora il dire di Francesca, che ripete per tre volte “Amor”.
Anche i mercanti piangono la perdita del lucro acquistato nei commerci con Babilonia, ora che è caduta (Ap 18, 11-14, 17.19). Il linguaggio mercantile – l’acquistare e il tristo perdere nel pianto, il perdere ogni speranza di guadagni, l’equivoco tra merce (il lucro) e mercede (il premio), il navigare per vie più o meno gravi verso porti più o meno lontani, la fine delle delizie di Babilonia, desideri per anime sensuali – segna molti luoghi dei primi canti del poema: Dante che prima acquista e poi perde piangendo, a causa della lupa, la salita del “dilettoso monte”, “ch’io perdei la speranza de l’altezza” (Inf. I, 54-57); al quale Caronte dice che dovrà passare “per altra via, per altri porti”, portato da “più lieve legno” (Inf. III, 88-93); le parole scritte sulla porta: “per me si va tra la perduta gente … Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate” (vv. 3, 9); le anime del Limbo, delle quali dice Virgilio che non peccarono, ma se hanno meriti (“mercedi”) non basta, perché non furono battezzate, cui è pertanto applicato il tema della speranza perduta: “Per tai difetti, non per altro rio, / semo perduti, e sol di tanto offesi / che sanza speme vivemo in disio” (Inf. IV, 31-42). Quest’ultimo, più che al carnale appetito delle delizie perdute (Ap. 18, 14: “I pomi che la tua anima desidera … si sono allontanati da te”) è da ricondurre al desiderio dei santi padri dell’Antico Testamento, i quali nel Limbo piangono e sospirano con desiderio affinché il libro della vita venga loro aperto, secondo quanto si dice ad Ap 5, 4. Su tutti questi temi mercantili, di infernale economia del lucro, la variazione più distante è per l’ottavo cielo, dove discendono trionfalmente le schiere di Cristo e la Vergine: “Quivi si vive e gode del tesoro / che s’acquistò piangendo ne lo essilio / di Babillòn, ove si lasciò l’oro” (Par. XXIII, 133-135; cfr. le parole di san Pietro a Par. XXVII, 40-42).
Al contrario di quella che grava su Babylon, la maledizione dei pastori non ha fatto perdere a Manfredi la speranza: “Per lor maladizion sì non si perde, / che non possa tornar, l’etterno amore, / mentre che la speranza ha fior del verde” (Purg. III, 133-135). Perderanno, invece, i Senesi la speranza di mantenere il controllo di Talamone e ancor più “vi perderanno li ammiragli” (i “gubernatores” dell’esegesi), secondo Sapìa (Purg. XIII, 151-154).
■ La scritta sulla porta dell’inferno mostra, ancora, temi provenienti dall’esegesi del primo dei tre angeli di Ap 14, 6-12. La prima “ratio motiva”, che cioè muove, il primo angelo (Ap 14, 6-7), è il timore della “potestativa deitas”; la seconda è la vicinanza del giudizio; la terza il riconoscere a Dio la creazione di tutte le cose (su questo punto l’esegesi dell’angelo travasa in quanto si afferma, a Par. XIX, 40-42, di “Colui che volse il sesto / a lo stremo del mondo”); la predicazione di questo angelo è inoltre eterna e riguarda cose eterne. Sono motivi scritti sulla porta: “Giustizia mosse il mio alto fattore; / fecemi la divina podestate … Dinanzi a me non fuor cose create / se non etterne, e io etterno duro” (Inf. III, 4-5, 7-8). Si rileva lo sviluppo del tema della creazione nell’esegesi di Ap 3, 14 (settima chiesa), e la corrispondenza, in entrambi i casi segnata dalla presenza avverbiale, tra “e io etterno duro” (non dunque l’aggettivo “etterna”) e “sempiternaliter … perdurat” ad Ap 19, 3.
L’angelo che conduce Giovanni nel deserto della contemplazione spirituale gli spiega, nella sesta visione (Ap 17, 7-18), il mistero della prostituta e della bestia che la porta. Dice che “qui”, cioè in queste parole e in quelle che seguono, “c’è un senso che richiede sapienza” (Ap 17, 9), perché le cose che restano da dire sono oscure e necessitano di un’esposizione. Se si collaziona Ap 17, 9 con l’esegesi della porta del sepolcro di Cristo gravata dal lapideo duro senso letterale proprio dell’Antico Testamento (Ap 4, 1-2: ‘radice’ della seconda visione dei sette sigilli) si ritrovano ancora i fili con cui sono tessuti i versi che seguono quelli contenenti la “scritta morta” (Inf. III, 10-21): parole scritte di colore oscuro e dal senso duro, di fronte alle quali l’espressione di Virgilio, “Qui si convien lasciare ogne sospetto” (v. 14), pare ripetere quella dell’angelo, che “qui” si richiede sapienza. In altro luogo, ad Ap 13, 18, si dice che “qui”, cioè in questo luogo, si richiede il segreto di una grande sapienza per comprendere il numero del nome della bestia. Virgilio dice a Dante non solo che “qui” bisogna lasciare ogni sospetto e viltà, ma anche che sono venuti al luogo dove egli vedrà “le genti dolorose / ch’hanno perduto il ben de l’intelletto” (vv. 16-18; per l’espressione “noi siam venuti al loco” cfr. Ap 20, 8), che cioè non hanno più sapienza. Quindi, dopo averlo confortato prendendolo per mano (il tema proviene dalla dodicesima perfezione di Cristo sommo pastore, ad Ap 1, 17), mette Dante “dentro a le segrete cose” (vv. 19-21).
Tab. I.1
Tab. I.2
Inf. XVI, 67-69, 73-75cortesia e valor dì se dimora
|
Inf. V, 126, 139-140; XXXIII, 9dirò come colui che piange e dice ……Mentre che l’uno spirto questo disse,
|
|
[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 10-12.14.17.19 (VIa visio)] Et ideo convertentur ad luctum “dicentes”, scilicet plangendo : “Ve, ve, ve” (Ap 18, 10), id est summa et summe stupenda et lugenda maledictio et dampnatio est ista, scilicet “civitas illa magna Babilon, civitas illa fortis, quoniam una hora venit iudicium tuum”, id est tota dampnatio tua! Loquuntur autem primo de ea in tertia persona et postea in secunda secundum modum plangentium et stupentium, qui primo stupent secum et mox vertunt considerationem suam quasi ad personam quam plangunt. Triplicatio autem dolorose interiectionis, scilicet ipsius “ve”, significat vehementiam stuporis et planctus et casus quem plangunt et etiam consuetum modum graviter plangentium. Et potest legi: Ve, ve, ve, civitas illa magna, quomodo sic cecidit vel cecidisti! […]
|
||
Inf. I, 52-60questa mi porse tanto di gravezza
|
||
Inf. III, 1-3, 9, 16-18, 88-93‘Per me si va ne la città dolente,
|
Par. XXIII, 133-135; XXVII, 40-42
Quivi si vive e gode del tesoro
che s’acquistò piangendo ne lo essilio
di Babillòn, ove si lasciò l’oro.
Non fu la sposa di Cristo allevata
del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto,
per essere ad acquisto d’oro usata
Inf. IV, 31-45
Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi 7, 13
che spiriti son questi che tu vedi?
Or vo’ che sappi, innanzi che più andi,
ch’ei non peccaro; e s’elli hanno mercedi,
non basta, perché non ebber battesmo,
ch’è porta de la fede che tu credi;
e s’e’ furon dinanzi al cristianesmo,
non adorar debitamente a Dio:
e di questi cotai son io medesmo.
Per tai difetti, non per altro rio,
semo perduti, e sol di tanto offesi
che sanza speme vivemo in disio”.
Gran duol mi prese al cor quando lo ’ntesi,
però che gente di molto valore
conobbi che ’n quel limbo eran sospesi.
Par. XXVI, 118-120
Quindi onde mosse tua donna Virgilio,
quattromilia trecento e due volumi
di sol desiderai questo concilio
[LSA, cap. V, Ap 5, 4 (radix IIe visionis)] Item fletus hic quantus fuit in sanctis patribus ante Christum; cum etiam essent in limbo inferni, quanto desiderio suspirabant ut liber vite aperiretur eis et omnibus cultoribus Dei!
Purg. III, 133-135
Per lor maladizion sì non si perde,
che non possa tornar, l’etterno amore,
mentre che la speranza ha fior del verde.
Purg. XIII, 151-154
Tu li vedrai tra quella gente vana
che spera in Talamone, e perderagli
più di speranza ch’a trovar la Diana;
ma più vi perderanno li ammiragli.
Tab. I.3
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 6-7 (IVa visio, VIum prelium)] “Et vidi alterum angelum” (Ap 14, 6). Hic subditur trina predicatio trini ordinis doctorum, per tres angelos designatorum non solum propter misterium Trinitatis sed etiam propter tria ad mundum convertendum vel plenius elevandum in Deum valde utilia.
|
||
[LSA, cap. XIX, Ap 19, 3 (VIa visio)] Deinde redit ad explicandum effectum et signum prefati iudicii et vindicte dicens: “Et fumus eius”, id est tenebrosa amaritudo tormentorum eius, “ascendit in secula seculorum”, id est sempiternaliter in sua altitu-dine et vivacitate perdurat.Par. XV, 10-12Bene è che sanza termine si doglia
|
Purg. XIII, 28-30La prima voce che passò volando
|
|
II
LA CHIESA DEI TIEPIDI
■ A Laodicea, l’ultima delle sette chiese d’Asia, Cristo si presenta come l’“Amen”, cioè il vero “testimone fedele e verace, che è il principio”, cioè la prima causa, “della creazione di Dio”, che crea ogni cosa dal nulla e ricrea gli eletti infondendo la grazia (Ap 3, 14). I santi vengono chiamati “creature di Dio”, secondo quanto detto nella lettera di san Giacomo – “Di sua volontà egli ci ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo l’inizio delle sue creature” (Jc 1, 18) –, e nella lettera di san Paolo agli Efesini – “Siamo sua fattura, creati in Cristo Gesù per le opere buone” (Eph 2, 10). Al vescovo di Laodicea Cristo si propone in modo tale da fargli comprendere che quanto dirà contro di lui deriva da infallibile verità e fedeltà e in modo da ferire e spezzare la sua presunzione, per cui riteneva con arroganza di avere il bene quasi ne fosse lui stesso e non Cristo la prima causa. Egli insegna inoltre all’ultimo periodo della Chiesa, designato da questo vescovo, a ripensare il primo inizio della creazione di tutte le cose e il primo inizio della formazione della Chiesa stessa e la prima causa. Come ai primi viene rappresentato il giudizio finale, così agli ultimi il primo principio, per insegnarci a stare fissi in entrambi, ad umiliarci nella loro contemplazione, a infiammarci d’amore per la somma causa e a rendere grazie del nostro inizio e della finale consumazione.
Il tema della creazione è cantato da Beatrice, “fatta da Dio, sua mercé, tale”, da non essere toccata dalla miseria dei dannati né assalita dal fuoco dell’inferno, al quale non teme di scendere (Inf. II, 91-93): la miseria è uno dei difetti che Cristo rimprovera al vescovo di Laodicea (Ap 3, 15). Il tema si ritrova tra le “parole di colore oscuro” scritte sulla porta dell’inferno: “Giustizia mosse il mio alto fattore; / fecemi la divina podestate …” (Inf. III, 4-6), e con Ciacco: “tu fosti, prima ch’io disfatto, fatto” (Inf. VI, 42; l’esegesi è stata compiutamente esaminata altrove).
Nella tabella sono mostrate altre variazioni su questa parte di esegesi relativa a Laodicea. Segue infatti la riprovazione del difetto maggiore del vescovo o della chiesa (le istruzioni date alle sette chiese d’Asia sono dirette sia al singolo vescovo come all’intera comunità ecclesiale), che in questo caso è la tepidezza, il non trovarsi né nel calore della carità che esulta in Dio né nel freddo dell’infedeltà triste per i propri peccati: “Magari tu fossi freddo o caldo!” (Ap 3, 15). Il senso è che meglio sarebbe trovarsi freddi infedeli per ignoranza, ma con possibilità di convertirsi all’ardore della vera giustizia, piuttosto che tiepidi rinunciatari di una via di perfezione intrapresa e apostati da un alto stato. L’“utinam frigidus esses” risuona nell’apostrofe contro i traditori che stanno in Cocito, “mal creata plebe” (si è visto che il tema della creazione appartiene anch’esso alla settima chiesa), che meglio sarebbe stata in vita pecore o capre, ossia ignoranti e umili (Inf. XXXII, 13-15).
Al momento del primo sogno di Dante nel purgatorio, è l’ora in cui la rondinella “comincia i tristi lai” ricordando i “suo’ primi guai” (la trasformazione di Filomela in rondine) e in cui la mente, più peregrina dalla carne, è quasi divina nelle visioni (Purg. IX, 13-18). L’immagine traduce il ricordare la prima causa, che è anche vera, da parte dell’ultima chiesa (che corrisponde all’approssimarsi dell’alba), e l’essere contristato dei propri peccati e dunque ‘freddo’ (nei versi il ‘freddo’ dell’ora non è reso esplicito, ma richiamato dai “tristi lai”, perché ‘freddo’ e ‘triste’ sono nell’esegesi equivalenti).
Il rimprovero verso la tepidezza di Laodicea è soprattutto appropriato agli ignavi, e su vasta scala. Ma non solo. Non essere né freddi per la tristezza derivante dalla miseria dei propri peccati né caldi per l’esultare in Dio con fervida devozione è tema che passa nel “misero modo” che “tegnon l’anime triste di coloro / che visser sanza ’nfamia e sanza lodo” (Inf. III, 34-36), ma anche, con ben altro valore, nella sembianza “né trista né lieta” delle quattro grandi ombre di poeti incontrate nel Limbo (Inf. IV, 82-84). Costoro non peccarono, e quindi non possono essere tristi; però, per quante “mercedi” abbiano che li rendono onorati (a differenza degli ignavi), “non adorar debitamente a Dio”, e quindi non possono ora letiziare nella lode divina (vv. 33-42).
Tab. II.1
Inf. VI, 40-42“O tu che se’ per questo ’nferno tratto”,
|
Par. XXXIII, 2, 4-6umile e alta più che creaturatu se’ colei che l’umana natura
|
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 14-15 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Hiis autem, sicut et in ceteris ecclesiis, premittit preceptum de istis scribendis ac deinde proponitur Christus loquens, ibi (Ap 3, 14): “Hec dicit amen”, id est verus seu veritas; vel “amen”, id est vere; “testis fidelis et verus, qui est principium”, id est prima causa, “creature Dei”, et hoc tam creando omnia de nichilo quam recreando electos per infusionem gratie. Sancti enim <anthonomasice> dicuntur creature Dei, secundum illud epistule Iacobi capitulo I° (Jc 1, 18): “Voluntarie genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creature eius”. Et ad Ephesios II° dicit Apostolus (Eph 2, 10): “Ipsius sumus factura, creati in Christo Ihesu in operibus bonis”.
|
||
Inf. XXXII, 13-15Oh sovra tutte mal creata plebe
|
Purg. IX, 13-15Ne l’ora che comincia i tristi lai
|
|
■ Il difetto maggiore del vescovo (o della chiesa) di Laodicea è la tepidezza, il non trovarsi né nel calore della carità che esulta in Dio né nel freddo dell’infedeltà triste per i propri peccati, per cui gli viene detto: “Magari tu fossi freddo o caldo!” (Ap 3, 15). Meglio (secondo Riccardo di San Vittore) sarebbe trovarsi freddi infedeli per ignoranza, ma con possibilità di convertirsi all’ardore della vera giustizia, piuttosto che tiepidi rinunciatari di una via di perfezione intrapresa e apostati da un alto stato. Olivi cita un passo delle Collationes di Cassiano [1] (360 ca-435) a conferma di come sia più facile che un infedele o un secolare acquisti fervore spirituale che un monaco vi ritorni dopo averlo perduto. Verso questi “tiepidi”, detestati da Dio, gli uomini spirituali e i dottori debbono tralasciare di diffondere moniti o insegnamenti salutari cosicché, spregiata una terra sterile occupata da sterpi nocivi, spargano altrove il seme della parola salutare, in una nuova terra tra i pagani e i secolari, piuttosto che seminare sulle spine, secondo il comando del profeta Geremia (Jr 4, 3). L’ammonimento è rivolto a tutti coloro che hanno rinunciato a questo mondo e alla carnalità ma che poi, ritenendo di aver raggiunto il vertice della perfezione, sono lenti nel liberarsi dalle passioni e vengono così trovati in uno stato di tepidezza e rigettati dalla bocca di Dio. A differenza del freddo e del caldo, il tiepido provoca infatti nausea e vomito. I cibi freddi, recati alla bocca, si convertono in calore e diventano salutari e soavi, quelli viziati da tepidezza non solo non possono essere recati alle labbra, ma neppure guardati da lontano senza orrore. Così coloro che vengono ricevuti nelle viscere della carità, fattisi tiepidi, vengono vomitati poiché, pur potendo offrire un cibo salutare, sono diventati nauseabondi e detestabili. È più facile pertanto che un secolare o un pagano, acceso dall’ardore dello spirito, ascenda dal gelido stato di infedeltà alla fonte della vera purificazione, che vi riascenda un monaco nel quale sia scemato l’originario fervore e si ritenga ricco di beni spirituali e di nulla indigente, quando invece, fatto più deteriore del secolare o pagano, è misero, cieco, nudo e bisognoso di correzione.
I temi del tepore, del dispregio e del vomito sono propri degli ignavi, “a Dio spiacenti e a’ nemici sui”, sdegnati dalla misericordia e dalla giustizia divina, dei quali il dottore Virgilio, che applica i precetti dell’abate Daniele nelle Collationes di Cassiano, parla brevemente: “non ragioniam di lor, ma guarda e passa” (Inf. III, 50-51, 63; da considerare, al v. 31, la variante orror di error : ciò che è tiepido non può essere guardato senza orrore).
All’esegesi dell’istruzione data a Laodicea rinviano molti altri luoghi del poema. Il tema del tepore pernicioso ritorna ad esempio in un momento di grave pericolo, che insinua nell’animo il desiderio di rinunciare: il volo in groppa a Gerione verso Malebolge (Inf. XVII, 85-90). Allorché Virgilio lo invita a salire sul fiero animale, Dante prova tremando il senso di nausea e di vomito che il malato di “quartana” ha per i luoghi freddi (lo stesso sentimento proverà di fronte ai “gelati guazzi” di Cocito in Inf. XXXII, 70-72). La vergogna vince però la paura e il poeta non rinuncia ad andare avanti. Rispetto al commento scritturale, nei versi si conserva il tema della nausea mentre il freddo perde il suo valore positivo (di potersi trasformare in caldo) nei confronti del tiepido.
È Virgilio a invitare il gigante Anteo a non avere “schifo” di deporre lui e Dante al fondo dell’Inferno, “dove Cocito la freddura serra” (Inf. XXXI, 122-123). E in effetti il chinarsi di Anteo, senza “fare dimora” sul “fondo che divora / Lucifero con Giuda”, apparenta a suo modo il gigante a quei santi perfetti del quinto stato che condiscendono solo per la carità e l’utilità degli infermi senza per questo macchiarsi di impurità, nel caso senza contaminarsi coi traditori e gli apostati, dei quali colui che nella piana di Zama recò “già mille leon per preda” può ben avere “schifo”. Quei santi non verranno cancellati dal libro della vita, riceveranno anzi gloria e fama, secondo quanto esposto nell’esegesi della quinta vittoria, ed è la fama che brama Anteo (Ap 3, 5).
Pur nel prevalere dell’asceta Cassiano citato da Olivi, c’è spazio anche per la trasformazione dell’esegesi di Riccardo di San Vittore dell’“utinam frigidus esses”: risuona nell’apostrofe contro i traditori che stanno in Cocito, “mal creata plebe” (riflettere sulla propria creazione o principio appartiene anch’esso alla settima chiesa: Ap 3, 14), che meglio sarebbe stata in vita pecore o capre ignoranti e umili (Inf. XXXII, 13-15).
Lo stesso tema pervade la similitudine dei lussuriosi purganti nel settimo girone – “Poi, come grue ch’a le montagne Rife / volasser parte, e parte inver’ l’arene, / queste del gel, quelle del sole schife” (Purg. XXVI, 43-45) -, che cioè volino o al freddo o al caldo, quasi evitando comunque il tiepido (non esplicitato) come ingiunto al settimo vescovo. Le due schiere (lussuriosi secondo natura e contro), nel dipartirsi dopo essersi incontrate, “tornan, lagrimando, a’ primi canti” (vv. 46-48), cioè al principio, come deve fare la settima e ultima chiesa (Ap 3, 14); “lagrimando”, in quanto a questa è proposto il collirio pungente e lacrimativo, che fa riflettere sui propri difetti (Ap 3, 18). Dante, al quale è appropriato in senso negativo il tema della cecità: “Quinci sù vo per non esser più cieco” (v. 58), va “pensoso” di fronte a Guinizzelli (v. 100); Arnaut Daniel piange e va cantando, riflettendo afflitto sulla passata follia (vv. 142-143). Nel dubbio se accettare o meno il viaggio propostogli da Virgilio, Dante è come i fioretti chiusi dal gelo che si aprono al sole; passa dal freddo al caldo senza l’intermedio, pernicioso tepore (Inf. II, 127-129).
Alla chiesa di Laodicea e al suo vescovo viene rimproverata (Ap 3, 17) la presunzione di considerarsi senza difetti, nella ritenuta abbondanza di ricchezze che paiono renderla sufficiente a sé stessa. Essa si considera beata, e invece pecca di ignoranza dei propri difetti: è misera (la miseria si oppone alla beatitudine), miserabile (perché abbisogna di commiserazione), povera (perché manca non solo del sufficiente, ma pure del necessario), cieca (perché difetta della prudenza e della previdenza con cui i ricchi, che reggono le città e consigliano i potenti, raccolgono, conservano e dispensano i beni materiali; così i ricchi di beni spirituali sono prudenti e conoscono i consigli divini), nuda (a differenza dei ricchi, che indossano vesti preziose e ornate). Sono i difetti comuni a un mendicante cieco, nudo, bisognoso, pieno di miserie e miserabile all’altrui sguardo.
La cecità, inoltre, è duplice: c’è quella che proviene dall’ignoranza che riconosce tuttavia umilmente sé stessa come tale, e quella che nell’ignoranza presume il contrario. Come la perfezione della conoscenza sta nel sapere di sapere, così la somma ignoranza sta nell’ignorare di essere ignorante e stolto.
Da questa esegesi, in cui né Riccardo di San Vittore né Gioacchino da Fiore, le due “auctoritates” dell’Olivi, assumono particolare rilievo, il tema del mendico e dei suoi difetti si insinua ancora tra gli ignavi. Al vescovo di Laodicea viene detto “quia tu es miser” (Ap 3, 17), e Virgilio dice di essi: “… Questo misero modo / tegnon l’anime triste di coloro / che visser sanza ’nfamia e sanza lodo” (Inf. III, 34-36). Dell’uno si dice: «“et miserabilis” … quod vident te indigere Dei et ipsorum miseratione … “et cecus” … “et nudus”»; degli altri: “e la lor cieca vita è tanto bassa … misericordia e giustizia li sdegna … erano ignudi” (vv. 47, 50, 65). Contro la miseria, l’essere miserabile e povero, il vescovo di Laodicea viene invitato ad acquistare oro ignito e sottoposto a prova (Ap 3, 18), mentre gli ignavi sono “sciaurati” (vili, quasi fossero, per concordia nel suono delle parole, ‘senz’oro’: v. 64). Cristo stimola il vescovo della settima chiesa a imitare i santi esempi usando nel senso di ‘zelare per il bene’ un verbo – “emulari” – che ha però anche il significato di ‘invidiare’ (Ap 3, 19): così gli ignavi dalla cieca vita “ ’nvidïosi son d’ogne altra sorte” (v. 48).
Una variazione dei motivi compare all’inizio di Inf. XXIV (vv. 1-30). Il turbamento di Virgilio di fronte al guasto ponte della sesta bolgia è reso con la similitudine del villanello che abbisogna del foraggio per il bestiame, “in quella parte del giovanetto anno / che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra” (tra gennaio e febbraio), e che sconfortato non sa il da farsi di fronte a quella che crede neve e invece è brina che presto si scioglie ai raggi del sole facendogli riacquistare la speranza di pascere le sue pecorelle. Al villanello sono appropriati temi presenti nel rimprovero al vescovo di Laodicea: l’essere ignorante (“che non sa che si faccia”), misero e povero (“a cui la roba manca”, “come ’l tapin”). Virgilio, invece, se è rimasto turbato d’ira per essersi fatto ingannare dai Malebranche bugiardi, dimostra di aver riacquistato tutta la sua sicurezza e di essere dotato di tutte le virtù contrarie alla “cecità” rimproverata al vescovo, nonostante l’ira gli abbia per poco offuscato l’occhio della mente: prende “consiglio” su come affrontare la via, si mostra previdente su quello che dovrà fare dopo (“E come quei ch’adopera ed estima, / che sempre par che ’nnanzi si proveggia”), indicando a Dante le schegge di roccia cui aggrapparsi e avvisandolo di provarle prima se siano salde in modo da potervisi reggere (da notare la variazione del “regunt” in “ti reggia”), mostra insomma di essere uno di quei “divites in spiritualibus … prudentes et scientes consilia summi Dei”.
Nella similitudine del villanello entrano anche i temi della quarta perfezione di Cristo come sommo pastore trattata nel primo capitolo (Ap 1, 14), i cui capelli sono bianchi come la lana e come la neve. La lana lenisce col calore, è molle, temperata e soave nel candore; la neve è fredda, congelata, rigida e intensa nel candore non sostenibile alla vista. Così la sapienza di Cristo, umore che impingua e purga le colpe, è da una parte calda per la pietà e condescensiva in modo contemperato alle nostre facoltà; è dall’altra astratta, rigida e intensa. Non a caso la similitudine del villanello cade “in quella parte del giovanetto anno / che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra”: il passaggio dalla neve alla sua bianca sorella brina segna il passaggio dal rigido inverno, gelato e chiuso, al condiscendere temperato e pietoso verso la necessità di cibo delle pecorelle. I ‘crini’ di Cristo (cfr. infra) designano anche il maturo consiglio, per cui il temprare i crini da parte del sole è speculare alla formazione di un provvido consigliarsi da parte di Virgilio.
I motivi del reggere, della prudenza, dell’essere sufficienti sono appropriati a Salomone, elogiato da Tommaso d’Aquino come re “sufficïente” e senza pari (Par. XIII, 94-96, 104-105). L’Aquinate invita anche alla prudenza nel giudicare sulla futura sorte delle anime, nella presunzione di vedere dentro al consiglio divino come credono “donna Berta e ser Martino” (i due nomi sono usati con un’accezione di disprezzo che corrisponde ai difetti rimproverati alla settima chiesa, vv. 139-142). L’esser ciechi per pena e mendichi è proprio degli invidiosi del secondo girone del purgatorio (Purg. XIII, 61-62).
[1] Sull’uso di questo autore da parte di Olivi cfr. A. A. DAVENPORT, Private Apocalypse: Spiritual Gnosis in Saint John Cassian and Peter John Olivi, in Ende und Vollendung. Eschatologische Perspektiven im Mittelalter, herausgegeben von J. A. Aertsen und M. Pickavé, Berlin-New York 2002 (Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln, 29), pp. 641-656.
Tab. II.2
[LSA, cap. III, Ap 3, 15 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Increpans ergo eum, subdit (Ap 3, 15): “Scio opera tua”, id est scientia iudiciali et improbativa, “quia neque calidus es”, scilicet per caritatem, “neque frigidus”, per infidelitatem vel per omnimodam vite secularitatem, quasi dicat: solam fidem et quandam exterioris religionis speciem absque igne caritatis habes.
|
||
Purg. XXIX, 4-6E come ninfe che si givan sole
|
Inf. XVII, 85-87, 106-112, 115Qual è colui che sì presso ha ’l riprezzo
|
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 17-19 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Deinde hanc eius presumptionem improbat et falsificat per sex defectus intente sue presumptioni oppositos sueque presumptioni annexos.
|
||
Inf. III, 34-36, 46-51, 64-66Ed elli a me: “Questo misero modo
|
Inf. XXIV, 1-30In quella parte del giovanetto anno
|
|
|
|
|
■ Ad Ap 12, 18 (quarta visione, quinta guerra) si dice che il diavolo “stette fermo sull’arena del mare”, cioè sugli avanzi del vino purissimo dei quattro stati precedenti, corrottosi con l’eccezione di poche reliquie che nel quinto stato hanno conservato il seme della donna, osservando i comandamenti di Dio e dando testimonianza a Cristo (Ap 12, 18; cfr. anche l’esegesi del versetto precedente, 12, 17). L’“arena” terrestre, polverosa, sterile, divisa in innumerevoli particelle indurite, instabile e disperdibile a ogni vento, penetrata e sbattuta dall’acqua del mare o putrefatta dal sole, viene interpretata, nel senso di Gioacchino da Fiore, come la moltitudine di coloro che non sono del tutto infedeli ma neppure aderenti alla pietà cristiana con l’integra purezza della fede. Si tratta delle genti (i cristiani di Alessandria e della Siria) [2] rimaste in aliqua sui parte nelle terre orientali conquistate dai Saraceni vicine al mare dei pagani, come l’arena è vicino al mare. A questa esegesi rinvia il “cattivo coro”, mischiato agli ignavi, degli angeli che furono per sé, né ribelli né fedeli a Dio e per questo cacciati dai cieli e non ricevuti dal profondo inferno (Inf. III, 37-39). Il motivo dell’ “arena” introduce a sua volta le terzine degli ignavi, nella descrizione del “tumulto, il qual s’aggira / … come la rena quando turbo spira” (vv. 28-30). Sul significato di “cattivo” cfr. supra.
Pietro Alighieri, nella terza redazione del suo commento (ca. 1358) riconduce gli angeli neutrali a Ugo di San Vittore: “Et ex hoc dicit hic auctor in persona Virgilii quod anime dictorum captivorum unite sunt cum illis angelis qui non fuerunt boni nec mali tenendo cum Deo vel cum Lucifero, quos Ugo de Sancto Victore dicit puniri etiam extra Infernum in loco et aere caliginoso (…)” [3]. Ma il Vittorino, se ritiene possibile un diverso grado di punizione degli angeli caduti, non parla di una specie ignava [4]. Altre fonti accreditate sono gli Stromata di Clemente di Alessandria [5], la Visio Pauli (sec. V, dove sono puniti gli ignavi, non gli angeli) [6], la Navigatio sancti Brendani [7], il Parzival di Wolfram von Eschenbach (ca. 1210-1220) [8] (in queste due ultime ci sono gli angeli neutrali, ma non sono puniti all’inferno). Gli angeli neutrali hanno un’origine letteraria e teologica insieme [9]. Si tratta di opere precedenti la Commedia, ma da ciò non si può dedurre una conoscenza certa di questa o dell’altra da parte di Dante.
È certo invece che questi angeli danno “e piedi e mano” all’esegesi apocalittica di Gioacchino da Fiore che, spostata in avanti di un secolo quanto alla sua applicazione (Gioacchino termina la sua Expositio nel 1200) [10], li fascia con un criptico significato di storia contemporanea, dopo il luttuoso evento della caduta di San Giovanni d’Acri nel 1291, ultimo baluardo della cristianità in Terrasanta. Si ricordino le parole di Guido da Montefeltro sui cristiani compromessi con gli infedeli: “Lo principe d’i novi Farisei, / avendo guerra presso a Laterano, / e non con Saracin né con Giudei, / ché ciascun suo nimico era cristiano, / e nessun era stato a vincer Acri / né mercatante in terra di Soldano”, espressione, quest’ultima, che ben s’accorda con le parole di Gioacchino da Fiore su quanti “utrum sint christiani aut sarraceni dubitatur” (Inf. XXVII, 85-90).
Si noti che il tema dell’arena percorre tutti i canti dedicati all’“orribil sabbione” del terzo girone del settimo cerchio. Gli ultimi dannati sono gli usurai: “poco più oltre veggio in su la rena / gente seder propinqua al loco scemo”, cioè al burrone (Inf. XVII, 31-36). Sull’arena ma vicini a Malebolge, essi partecipano dell’instabilità degli ignavi; sono infatti violenti sui generis, contro la natura e l’arte (e quindi indirettamente contro Dio), ma pure quasi fraudolenti (Gerione, il simbolo della frode, nel salire dall’abisso arriva fin lì). Agli ignavi li accomuna il disprezzo che si esprime nel parlar poco: “Dicerolti molto breve … non ragioniam di lor, ma guarda e passa – Li tuoi ragionamenti sian là corti” (Inf. III, 45, 51; XVII, 40) [11].
[2] Si tratta, come Gioacchino precisa ad Ap 16, 19, di non pochi cristiani di Alessandria e di Siria e di altri luoghi,“qui tamen, si de moribus agitur, utrum sint christiani an sarraceni dubitatur” (Expositio, pars VI, distinctio I, f. 192va-b); cfr. G. L. POTESTÀ, Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Bari 2004, pp. 319-320.
[3] Cfr. il testo in I commenti danteschi dei secoli XIV, XV e XVI, a cura di P. PROCACCIOLI, Roma 1999 (Archivio Italiano).
[4] UGO DI SAN VITTORE, Summa Sententiarum, II, iv; PL 176, col. 84 B-C.
[5] CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromata, VII, 7; PG 9, coll. 466-467. È fonte sostenuta con decisione da B. NARDI, Dal “Convivio” alla “Commedia” (Sei saggi danteschi), Roma 1960 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi Storici, 35-39; ristampa anastatica, 1992), pp. 331-350: 338-339.
[6] TH. SILVERSTEIN – A. HILHORST, Apocalypse of Paul. A new critical edition of three long latin versions, Genève 1997 (Cahiers d’Orientalisme, XXI), 31, p. 136. È fonte sostenuta da G. INGLESE, in Dante Alighieri, Commedia. Revisione del testo e commento. Inferno, Roma 2007, p. 63, nt. a Inf. III, 39.
[7] NAVIGATIO SANCTI BRENDANI ABBATIS. From Early Latin Manuscripts, ed. C. Selmer, University of Notre Dame Press 1959, cap. 11, 16-48, pp. 22-25.
[8] WOLFRAM VON ESCHENBACH, Parzival, IX, 471, 15-25; XVI, 798, 11-22 (ed. a cura di L. Mancinelli. Traduzione e note di C. Gamba, Torino 1993).
[9] Per maggiori dettagli sulle fonti cfr. Dante e Gioacchino da Fiore, III.1; A. FORNI, Dante e Gioacchino da Fiore, in “Collectanea Franciscana”, 91 (2021), pp. 639-701: 663-667.
[10] Cfr. POTESTÀ, Il tempo dell’Apocalisse (nota 2), pp. 286-287.
[11] Da notare la rima “latino / vicino” a Inf. XXII, 65, 67, dove il motivo della Chiesa “latina” rimasta nel quinto stato come reliquia dopo le devastazioni saracene in Oriente, “vicina” e quasi mescolata alle impurità, è appropriato in modo sarcastico ai barattieri del quinta bolgia (il numero corrisponde allo stato della storia della Chiesa, al quale principalmente rinviano i versi relativi a quella zona). All’esegesi di Ap 12, 18 rinviano anche parole-chiave in Inf. XXIV, 85, 90 («“Et stetit”, scilicet dracho, “super arenam maris” – Più non si vanti Libia con sua rena … né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe») e Purg. V, 15, 18 (“et semper instabilis et ab omni vento dispergibilis – per soffiar di venti … perché la foga l’un de l’altro insolla”).
Tab. II.3
Inf. XXII, 64-67Lo duca dunque: “Or dì: de li altri rii
|
Inf. XXIV, 85, 88-90Più non si vanti Libia con sua rena ……né tante pestilenzie né sì ree
|
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 17.18 – 13, 1 (IVa visio, Vum prelium)] (Ap 12, 17) Utrique enim signanter vocantur reliqui seu reliquie, quia sicut bibita superiori et puriori et maiori parte vini vasis magni restant pauce reliquie cum fecibus quibus sunt propinque et quasi commixte, sic de plenitudine purissimi vini doctorum et anachoritarum tertii et quarti temporis remanserunt reliquie circa tempora Sarracenorum; ac deinde pluribus ecclesiis per Sarracenos vastatis et occupatis, Grecisque a romana ecclesia separatis, remansit in quinto tempore sola latina ecclesia tamquam reliquie prioris ecclesie per totum orbem diffuse. De utrisque ergo reliquiis simul agit, tum quia in utrisque remissio habundavit respectu perfectionis priorum, tum quia bestia sarracenica contra utrosque pugnavit quamvis primo contra primos. […]
|
[LSA, prologus, Notabile V; V status] Quia vero ecclesia Christi usque ad finem seculi non debet omnino extingui, ideo oportuit eam in quibusdam suis reliquiis tunc specialiter a Deo defendi et in unam partem terre recolligi, qua nulla congruentior sede Petri et sede romani imperii, que est principalis sedes Christi. Ideo in quinto tempore, quod cepit a Karolo, facta est defensio et recollectio ista […].
|
Inf. III, 25-30, 37-39Diverse lingue, orribili favelle,
|
Inf. XIII, 18-19; XIV, 13-15, 28, 38-39, 73-74, 79-81; XV, 116-117; XVI, 28-29, 40-41; XVII, 31-36
…………………….. e sarai mentre
che tu verrai ne l’orribil sabbione.
Lo spazzo era una rena arida e spessa,
non d’altra foggia fatta che colei
che fu da’ piè di Caton già soppressa. ……
Sovra tutto ’l sabbion, d’un cader lento ……
onde la rena s’accendea, com’ esca
sotto focile, a doppiar lo dolore. ……
Or mi vien dietro, e guarda che non metti,
ancor, li piedi ne la rena arsiccia ……
Quale del Bulicame esce ruscello
che parton poi tra lor le peccatrici,
tal per la rena giù sen giva quello.
…………………..….. però ch’i’ veggio
là surger nuovo fummo del sabbione.
E “Se miseria d’esto loco sollo
rende in dispetto noi e nostri prieghi” ……
L’altro, ch’appresso me la rena trita,
è Tegghiaio Aldobrandi …………..
Però scendemmo a la destra mammella,
e diece passi femmo in su lo stremo,
per ben cessar la rena e la fiammella.
E quando noi a lei venuti semo,
poco più oltre veggio in su la rena
gente seder propinqua al loco scemo.
■ Olivi pone la quaestio se il tepore non debba intendersi male minore rispetto al freddo, in quanto il freddo è più distante dal calore di quanto non lo sia il tepore, il quale partecipa, in qualche modo, del caldo. Secondo il teologo francescano, l’apostasia da un alto stato di religione allontana dal calore della carità molto più di quanto il freddo in sé si allontani dal caldo: in questo senso il tepore non è intermedio tra freddo e caldo, ma più distante da quest’ultimo del freddo. Meglio fare nuovamente il vino dall’umore della vite che dal vino putrefatto. Tuttavia, se essere tiepidi significa soltanto una diminuzione del primitivo fervore cui si aggiunge l’umile e gemente desiderio di ritornarvi, allora il tepore può assumere un valore effettivamente intermedio tra il freddo e il caldo. Inoltre, preferire il freddo al caldo non è preferire il male al bene, perché l’essere freddo può essere inteso non in modo assoluto ma come minore male rispetto alla tepidezza.
Argomenti che vengono appropriati a Piccarda e Costanza d’Altavilla, anime che appaiono nel cielo della Luna in minor grado di beatitudine perché manchevoli nei voti (Par. IV, 94-114). Costoro iniziarono una vita di perfezione ma poi furono costrette con la violenza a ritornare nel mondo. Beatrice spiega a Dante dubbioso che se la loro volontà fosse stata intera, esse si sarebbero ricondotte alla strada onde erano state sottratte. Essendo però troppo rara una tale volontà intesa assolutamente, nel caso di Costanza (che vale anche per Piccarda), la quale mantenne nel secolo l’affetto per il velo, prevalse il principio della scelta del male minore operato dalla volontà secundum quid. Così Costanza, costretta a rifiutare il velo, è ritornata nella frigidità del secolo, che si rivela male minore di una irrecuperabile tepidezza, come dimostra il desiderio di ritornare al calore dello stato di religione, a vegliare e dormire “con quello sposo ch’ogne voto accetta / che caritate a suo piacer conforma” (Par. III, 100-102, 115-117). La distinzione delle due volontà è comune nel pensiero scolastico; l’esegesi dell’istruzione a Laodicea la inserisce tuttavia nella remissione del calore della carità di un voto monastico, fatto per abbandonare il secolo, e ciò si addice pienamente alle anime che si mostrano nel cielo della Luna.
Tab. II.4
[LSA, cap. III, Ap 3, 15 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Sed videtur quod minus malum sit esse tepidum quam esse frigidum, quia frigidum plus distat a calido et plus contrariatur ei et difficilius calefit quam tepidum; tepidum etiam plus participat de calido quam frigidum.
|
|
(segue 3, 15) Concedo tamen quod illa tepiditas, que absque huiusmodi precipitiis vel precipitiorum periculis dicit solam quandam remissionem primi fervoris cum humili gemitu et cum desiderio reassurgendi ad illam, et etiam cum aliquo conatu licet imperfecto, minus opponitur prefato fervori et minus distat ab illo quam esse omnino frigidum.
|
Par. III, 115-117Ma poi che pur al mondo fu rivolta
|
■ Il vomito nei confronti di chi è tiepido non avviene in modo repentino, ma a poco a poco, perché è gradualmente che si discende dalla sommità al basso e poi si rovina precipitando. Per questo Cristo non dice al vescovo, per la sua apostasia da un alto stato o per avere grande disposizione ad essa, “ti vomiterò”, bensì “inizierò a vomitarti” (Ap 3, 16), nel senso che se finora lo ha tollerato, d’ora innanzi non potrà più farlo, come un cibo fatto abominevole e intollerabile. Il medesimo tema è proposto al vescovo della prima chiesa (Efeso) disceso dal primo grado di fervida carità (Ap 2, 5). Il tepore rimproverato al primo vescovo precede tuttavia l’ingresso dei sette spiriti malvagi, mentre quello rimproverato al settimo si verifica dopo che tale ingresso si è compiuto, di cui dice Cristo: “la nuova condizione di quell’uomo è peggiore della prima” (Matteo 12, 45). Il primo degli spiriti malvagi è lo spirito di presunzione, che è radice e sede della superbia. Per questo, a sottolineare l’arrogante e intollerabile presunzione del vescovo di Laodicea, si afferma: “Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla” (Ap 3, 17). Egli si ritiene infatti ricco, di ricchezze ereditate o acquisite con la sua virtù, per la scienza, per la predicazione delle scritture, per l’eloquenza, per l’amministrare i sacramenti, per la dignità pontificale, per il favore e la lode del volgo.
Il rovinare in basso a poco a poco è proprio di Dante, impedito dalla lupa, “bestia sanza pace”, nella salita al dilettoso monte e respinto verso la selva oscura, “là dove ’l sol tace” (Inf. I, 58-61; la pace e il tacere sono temi del settimo stato). L’essere disposto a trista e progressiva rovina è proprio di Firenze, come detto dal poeta a Forese Donati (Purg. XXIV, 79-81).
Tab. II.5
[LSA, cap. III, Ap 3, 16-17] Deinde comminatur ei horrendam reiectionem eius a Dei societate, quam per nomen vomitus designat, tum quia vomitus est horribilissima reiectio cibi prius transglutiti, tum quia tepida solent plus provocare vomitum quam frigida vel calida. Unde subdit (Ap 3, 16): “Sed, quia tepidus es, et nec frigidus nec calidus, incipiam te evomere ex ore meo”.
|
|
Inf. I, 58-61tal mi fece la bestia sanza pace, Not. III
|
Purg. XXIV, 79-81però che ’l loco u’ fui a viver posto,
|
■ Alla distinzione tra l’ignorante che umilmente conosce sé stesso come tale e quello che con presunzione non sa di essere ignorante (Ap 3, 17) è possibile ricondurre le parole di Cacciaguida “e cieco toro più avaccio cade / che cieco agnello” (Par. XVI, 70-71), riferite all’immigrazione a Firenze di gente del contado, che “principio fu del mal de la cittade”, lì dove, prima di questa commistione, la cittadinanza “pura vediesi ne l’ultimo artista” (vv. 49-51, 67-69). Come chiosa Benvenuto, “quanto maior populus, tanto minor intellectus”. Il “cieco toro” corrisponde alla “ceca et inflata nescientia” e il “cieco agnello” all’umile riconoscimento dei propri difetti da cui si può pervenire a una vista chiara: è da notare che nell’esegesi il difetto della cecità è connesso con l’arte di governare.
Vengono quindi consigliati a Laodicea dei rimedi per eliminare i difetti indicati (Ap 3, 18). Il primo (contro la miseria, l’essere miserabile e povero) consiste, come già detto, nell’acquistare oro ignito e sottoposto a prova, ossia la carità ardente, provata e purgata di ogni impurità dal fuoco di molte fornaci, resa in tal modo incorruttibile come l’oro. Questa virtù acquista chi, rinunciando a ogni cosa, offre tutto il suo cuore a Dio e con obbedienza si dedica al suo servigio (questo punto, collazionato con l’esegesi della settima vittoria [Ap 3, 20], è stato esaminato altrove).
Il vescovo di Laodicea viene poi persuaso ad eliminare il quinto difetto, cioè la nudità già apparente o ancora nascosta per l’ipocrisia, con l’indossare vesti bianche, che designano il candore della castità e della santità e il decoro della santa conversazione perfusa dalla luce divina.
Contro il quarto difetto – la cecità – gli viene consigliato di ungere gli occhi con un collirio. Questa unzione, che in principio punge amaramente gli occhi e provoca le lacrime ma in fine rende chiara la vista, designa l’amaro essere compunto delle proprie colpe. Si contrappone alla presunzione in quanto essa tiene il cuore riflesso su di sé e sui propri difetti, e pertanto include in sé, aumentandola, la prima illuminazione del cuore che consiste nel conoscere sé stessi e le proprie colpe, e anche la considerazione dei giudizi di Dio e della sua maestà reverenda e tremenda e al tempo stesso pia. Con il collirio viene designata anche la Sacra Scrittura: il precetto divino è lucido e illumina gli occhi.
È da notare che, nell’elencare ad Ap 3, 17 i difetti, la cecità viene premessa alla nudità, mentre qui, nel persuadere alla riparazione, le vesti precedono il collirio. Infatti, quando si perde la carità interiore, prima si perde la luce interiore e la vista, e poi si perde l’ornato esterno delle buone opere e della conversazione onesta. Nella riparazione dei difetti, invece, non si perviene a una piena compunzione e illuminazione della vista interiore fino a quando, lasciate le opere prave, non si assume l’ornato delle buone opere o dell’esteriore stato di penitenza, per quanto l’inizio della compunzione preceda questo ornato.
Il tema del collirio, che provoca all’inizio le lacrime, è presente al momento in cui Virgilio immette il discepolo nelle “segrete cose” infernali: “Quivi sospiri, pianti e alti guai / risonavan per l’aere sanza stelle, / per ch’io al cominciar ne lagrimai” (Inf. III, 22-24).
Tra i lussuriosi purganti nel settimo girone, Arnaut Daniel piange e va cantando, riflettendo afflitto sulla passata follia (Purg. XXVI, 142-143). Anche Dante è “pensoso” di fronte a Guinizzelli (v. 100), a lui è appropriato in senso negativo il tema della cecità: “Quinci sù vo per non esser più cieco” (v. 58). Ai lussuriosi spetta il motivo del lacrimare: le due schiere (secondo natura e contro), nel dipartirsi dopo essersi incontrate, “tornan, lagrimando, a’ primi canti”, cioè al principio, come deve fare la settima e ultima chiesa (vv. 43-48). I temi propri di Laodicea pervadono la stessa similitudine – “poi, come grue ch’a le montagne Rife / volasser parte, e parte inver’ l’arene, / queste del gel, quelle del sole schife” -, che cioè volino o al freddo o al caldo, quasi evitando comunque il tiepido (non esplicitato) come ingiunto al settimo vescovo [12].
Prima di varcare la porta dell’inferno, Virgilio afferma che quello è il luogo dove stanno “le genti dolorose / c’hanno perduto il ben de l’intelletto” (Inf. III, 16-18: la perdita dell’“interior lux et visus”). Dei pusillanimi viene citata prima la cecità (“e la lor cieca vita è tanto bassa”, v. 47) e poi la nudità (“Questi sciaurati, che mai non fur vivi, / erano ignudi …”, vv. 64-65), conformemente all’ordine proposto dall’esegesi come conseguenza della perdita della luce interiore.
Prima di iniziare la salita del purgatorio, Virgilio lava con la rugiada le guance lacrimose del discepolo, affinché il colore naturale del viso sia di nuovo visibile, dopo essere stato nascosto dalla caligine infernale, e lo cinge “d’un giunco schietto” (Purg. I, 94-99, 121-136). Questi riti, che corrispondono alla riassunzione dell’ornato delle buone opere e dell’esteriore stato di penitenza che, nella riparazione, precede il recupero completo della vista (che avviene progressivamente nella salita della montagna), sono operati su mandato di Catone, il quale impersona questo ornato, come dimostra la descrizione del volto, fregiato dal lume delle quattro sante stelle (vv. 37-39), e il riferimento di Virgilio a “la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara” (vv. 74-75). Una variante del tema è nelle parole di Virgilio nell’imminente presenza dell’angelo dell’umiltà, che invita a salire al secondo girone: “Di reverenza il viso e li atti addorna” (Purg. XII, 82; sarà da valutare la variante “li atti e ’l viso”, perché nella purgazione l’ornato delle opere precede la vista interiore).
Il motivo dell’ornato della buona azione onesta, combinato con quello dell’essere persuasi nell’acquistare da Cristo l’oro della carità (“suadeo tibi emere a me aurum ignitum”) entra nella descrizione del “popol giusto e sano” dell’Empireo: “Vedëa visi a carità süadi (che cioè persuadevano alla carità), / d’altrui lume fregiati e di suo riso, / e atti ornati di tutte onestadi (l’ornato esteriore, che si può accostare alla descrizione del volto di Catone, che in questo luogo segue e non precede la vista)” (Par. XXXI, 49-51).
Il tema del collirio inteso come Sacra Scrittura è nel lacrimare di Beatrice di fronte a Virgilio (Inf. II, 115-117).
[12] Le gru per natura evitano il gelo, non il sole: la similitudine irreale vuole comunque affermare, come detto nell’esegesi di Laodicea, che anche i freddi (i quali per Dante coincidono con i lussuriosi contro natura) possono riassurgere al calore di carità.
Tab. II.6
Par. XVI, 70-71e cieco toro più avaccio cade
|
||
[LSA, cap. III, Ap 3, 17-18 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Nota etiam quod notat eum de duplici cecitate. Prima est ceca ignorantia agendorum et vitandorum ac sperandorum seu amandorum et spernendorum, et hanc notat cum dicit quod “es cecus”.
|
||
Inf. II, 115-117Poscia che m’ebbe ragionato questo,
|
||
Inf. III, 16-18, 22-24, 64Noi siam venuti al loco ov’ i’ t’ho detto
|
Purg. XII, 82
Di reverenza il viso e li atti addorna
li atti e ’l viso
Purg. I, 127-129
porsi ver’ lui le guance lagrimose;
ivi mi fece tutto discoverto
quel color che l’inferno mi nascose.
Purg. XXVI, 43-48, 58, 100-102, 142-143
Poi, come grue ch’a le montagne Rife
volasser parte, e parte inver’ l’arene,
queste del gel, quelle del sole schife, 3, 15
l’una gente sen va, l’altra sen vene;
e tornan, lagrimando, a’ primi canti 3, 14
e al gridar che più lor si convene
Quinci sù vo per non esser più cieco
e sanza udire e dir pensoso andai
lunga fïata rimirando lui,
né, per lo foco, in là più m’appressai.
Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
consiros vei la passada folor
Par. XXXI, 49-51
Vedëa visi a carità süadi,
d’altrui lume fregiati e di suo riso,
e atti ornati di tutte onestadi.
III
UN ELETTO DECADUTO
“l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto”
■ Dopo che Virgilio, interrogato due volte dal discepolo, ha brevemente spiegato, parodiando l’esegesi della tiepida Laodicea, che gente sia quella incontrata (vv. 31-51), Dante guarda e vede un’insegna che gira correndo senza posa, con dietro una grande moltitudine; in essa riconosce qualcuno, poi identifica (“vidi e conobbi”) per un qualche segno “l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto” (vv. 52-60). Nelle tre terzine a essere parodiata non è l’esegesi della settima chiesa d’Asia, ma la “signatio” all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3-4).
L’angelo del sesto sigillo, ascendendo da oriente (Ap 7, 2), rimuove l’impedimento frapposto dai quattro angeli che stanno sopra i quattro angoli della terra: designano i demoni i quali cercano di impedire ai quattro venti di soffiare, cioè di impedire la predicazione della fede, la conversione delle genti e anche il conservarsi dei fedeli nella fede già accolta (Ap 7, 1: prestano panno a Caronte, Minosse, Cerbero, Pluto).
Rimosso l’impedimento, il segno è posto sulla fronte, non vergognosa ma liberamente magnanima, degli eletti amici di Dio, degni di essere nominati, difensori della fede fino al martirio da lui conosciuti per nome e ascritti alla più alta milizia dei baroni, dei decurioni, dei cavalieri che si distingue da quella volgare dei fanti (Ap 7, 3-4). Questa esegesi, nella quale il sesto stato corrisponde agli ultimi sei anni della costruzione del Tempio dopo la cattività in Babilonia (secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore), è una sacra sinfonia militare i cui temi trascorrono in più luoghi della Commedia: dalla “signatio” poetica di Dante, amico di Beatrice e “sesto tra cotanto senno” nella schiera dei sommi poeti del Limbo, alla “signatio” apostolica nelle virtù teologali di fronte a Pietro, Giacomo e Giovanni; dall’impossibile amicizia con Dio di Francesca e Paolo (anch’essi in una schiera) alle famiglie fiorentine, menzionate da Cacciaguida, che portano la “bella insegna” del marchese Ugo di Toscana, assunte a una milizia più alta rispetto a Giano della Bella, l’autore dei famosi Ordinamenti di giustizia (1293) anch’egli di essa insignito (la quale “fascia col fregio”), ma che oggi si raduna col popolo, corrispondente alla volgare e pedestre milizia che viene dopo i segnati. Questi eletti ‘sesti’ amati da Dio sono lo sviluppo sacro di coloro (De vulgari eloquentia, II, iv, 10-11) che Virgilio, nel sesto dell’Eneide, definisce “Dei dilectos”, i poeti tragici innalzati al cielo per ardente virtù (Aen., VI, 129-131: “Pauci, quos aequus amavit / Iuppiter”), designati dall’“astripeta aquila”.
Il tema della “signatio” sulla fronte degli eletti e amici di Dio, difensori pubblici della fede, si mostra già nel primo canto del poema, nella “vergognosa fronte” con cui Dante risponde a Virgilio (Inf. I, 81; cfr. III, 79). Anche l’espressione di Virgilio al v. 129 – “oh felice colui cu’ ivi elegge!” – fa parte del gruppo tematico.
Il tema dell’amicizia divina contrapposto alla volgare milizia è presente nelle accorate parole con cui Lucia invita Beatrice a soccorrere Dante, “ch’uscì per te de la volgare schiera” dei poeti (Inf. II, 103-105), che la stessa Beatrice, rivolgendosi a Virgilio, definisce “l’amico mio, e non de la ventura” (v. 61; da notare, nello stesso canto [vv. 44-45], il contrasto tra il “magnanimo” Virgilio e la “viltade” da cui è offesa l’anima di Dante). Virgilio, mosso da Beatrice, rimuove l’“impedimento” frapposto dalla lupa a Dante nel salire il “dilettoso monte”; svolge anch’egli in qualche modo la funzione dell’angelo del sesto sigillo.
In Inf. III i temi della “signatio” sono soggetti a una variazione dissonante: la “dignitas signatorum” si trasforma in “una ’nsegna … che d’ogne posa mi parea indegna”; ai segnati segue la “turba magna quam dinumerare nemo poterat” (Ap 7, 9) come dietro l’insegna “venìa sì lunga tratta / di gente, ch’i’ non averei creduto / che morte tanta n’avesse disfatta” (cfr. “le turbe, ch’eran molte e grandi” del Limbo, Inf. IV, 29-30). Nel testo sacro, e nella sua esegesi, la gente innumerevole viene condotta dai segnati, quasi pedestre milizia guidata da cavalieri, al trono dell’Agnello, che li guiderà alle fonti delle acque (Ap 7, 10-17). I pusillanimi corrono invece senza posa. I motivi del correre e del posarsi sono presenti ad Ap 21, 16, dove si tratta della misura della Gerusalemme celeste, che è di 12.000 stadi. Lo stadio è lo spazio al cui termine si sosta o si posa per respirare e lungo il quale si corre per conseguire il premio. Esso designa il percorso del merito che ottiene il premio in modo trionfale, secondo quanto scrive san Paolo ai Corinzi: “Non sapete che tutti corrono nello stadio, ma di costoro uno solo prende il premio?” (1 Cor 9, 24). Ciò concorda con il fatto che lo stadio è l’ottava parte del miglio, e in questo senso designa l’ottavo giorno di resurrezione. In tal modo agli ignavi, che corrono senza meta in cui posarsi, è applicato al contrario il motivo paolino perché della loro vita non è rimasta alcuna fama nel mondo non avendo in essa conseguito alcun premio; al tempo stesso sono la negazione delle genti innumerevoli vestite di bianco che seguono i segnati e che l’Agnello guida alle fonti delle acque (Ap 7, 17), cioè a un termine e a un obiettivo finale [1]. La stessa domanda di Dante a Virgilio – «dissi: “Maestro, che è quel ch’i’ odo? / e che gent’ è che par nel duol sì vinta?”» (vv. 32-33, domanda ripetuta più avanti, presso l’Acheronte, vv. 72-73) – è tragica parodia delle parole di Giovanni, il vecchio dell’Apocalisse che chiede chi siano e da dove vengano quelle genti biancovestite: «“Hii, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis, “et unde venerunt”, id est ex quibus meritis et per quam viam sanctitatis ad tantam gloriam pervenerunt?» (Ap 7, 13, passo dalle numerose variazioni).
L’“insegna” è quella della milizia di Cristo (cfr. Par. XII, 37-42), non viene detto se mostrava una rappresentazione; tuttavia, poiché i dannati “erano ignudi”, forse tramite essa il poeta ‘conobbe’, cioè identificò, l’ombra innominata.
I segnati del sesto stato, eletti che hanno dignità sugli altri, sono magnanimi, non vili: l’accostamento nei versi dell’insegna e della viltà del personaggio innominato indica che costui dovette ricoprire una carica di rilievo, alla quale rinunciò. Se i segnati sono nominati, nella loro dissonante parodia non lo sono: “Quel personaggio è necessariamente un innominato, e il suo principale significato sta nel suo anonimato. Se gl’ignavi non meritano l’Inferno dantesco, dove i peccatori mostrano pur di avere una loro terribile grandezza, quell’ombra non merita nemmeno di esser chiamata per nome” [2]. Fra i vari luoghi del poema nei quali si registrano variazioni dei temi della “signatio”, il sesto girone del purgatorio è il luogo dove “non si vieta / di nominar ciascun” (Purg. XXIV, 16-18) e con nomi significanti, se confrontati con un’esegesi teologica che annovera “equites … barones seu duces … centuriones … decuriones”, come Ubaldin da la Pila (il castello del Mugello, che concorda nel suono con “l’alto primipilo” di Par. XXIV, 59), “messer Marchese” (il forlivese gagliardo bevitore), Forese paragonato a “lo cavalier di schiera che cavalchi, / e va per farsi onor del primo intoppo”, gli stessi Virgilio e Stazio “gran marescalchi”.
I segnati sono, secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore, coloro che portano a compimento il numero dei martiri. Ma a quale martirio sono destinati? Il sesto stato – il periodo in cui vivono Olivi e Dante, iniziato con Francesco d’Assisi – concorre con il secondo, per antonomasia lo stato dei martiri, non per connessione temporale (questo inizia infatti con la persecuzione di Nerone o con la lapidazione di santo Stefano o con la passione di Cristo), ma a motivo della quantità dei testimoni della fede. Il tipo di martirio è tuttavia diverso. I martiri del sesto stato soffrono nel dubbio, il loro è un “certamen dubitationis” che i primi testimoni della fede non provarono per l’evidenza dell’errore in cui incorrevano gli idolatri pagani. Nel sesto stato il martire non prova soltanto il tormento del corpo, viene anche spinto (“propulsabuntur martires”) dalla sottigliezza degli argomenti filosofici, dalle distorte testimonianze scritturali, dall’ipocrita simulazione di santità, dalla falsa immagine dell’autorità divina o papale, in quanto falsi pontefici insorgono, come Anna e Caifa insorsero contro Cristo. Per rendere più intenso il martirio, i carnefici stessi operano miracoli. Tutto ciò appartiene alla tribolazione del tempo dell’Anticristo, alla tentazione che induce in errore persino gli eletti, come testimoniato da Cristo nella grande pagina escatologica di Matteo XXIV: “dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi (cfr. Mt 24, 24)”. Scrive Gregorio Magno, commentando Giobbe 40, 12 – “stringe (nel senso di tendere) la sua coda come un cedro” -: “ora i nostri fedeli fanno miracoli nel patire perversioni, allora i seguaci di Behemot faranno miracoli anche nell’infliggerle. Pensiamo perciò quale sarà la tentazione della mente umana allorché il pio martire sottoporrà il corpo ai tormenti mentre davanti ai suoi occhi il carnefice opererà miracoli” (prologo, Notabile X).
Filadelfia, la sesta chiesa interpretata come “amor fratris” e come “salvans hereditatem”, depositaria del seme evangelico, viene lodata perché non ha negato il nome di Cristo nell’angustia della persecuzione (Ap 3, 8). Non negare il nome di Cristo non è cosa grande se non in una forte persecuzione, nel momento in cui si è spinti e quasi costretti a negare. Non negare significa confessare, in quanto tacere in questo caso è come negare. I santi del sesto stato, che preservano il “verbum patientie” di Cristo – sostenendo con pazienza le persecuzioni e serbando la fede e i precetti -, saranno a loro volta preservati dalla futura tentazione, pochi eletti salvati, come Noè, nell’arca che conserverà l’eredità e il seme della fede da seminare nuovamente nel mondo (Ap 3, 10). Essi sentiranno la tentazione e la patiranno, ma non rovineranno dalla fermezza della fede e della carità, verranno anzi esercitati e condotti alla vittoria.
Grazie all’esegesi l’ombra comincia a illuminarsi. Si tratta di un eletto a un’alta carica, il quale vive nel sesto stato della Chiesa e che, trovandosi nell’angustia della persecuzione dove è chiamato a testimoniare la regola evangelica, si sente inadeguato, vile, e per questo rifiuta. Viene meno al precetto dato alla sesta chiesa – «“et non negasti nomen meum” scilicet in angustia persecutionis, aliter enim non est magnum non negare nomen Christi» -, per cui il suo è un “gran rifiuto” (negare equivale a rifiutare), fatto dal Vicarius Christi, colui che in terra ne porta il nome.
Una situazione di alta dignità in un luogo di tormenti quasi profeticamente (o piuttosto realisticamente, come intende il Padoan [3]) anticipata dalla domanda di Jacopone: “Que farai Pier da Morrone?”:
Quanno l’omo vertuoso posto è ’n loco tempestoso,
sempre el trovi vigoroso a portar ritto el gonfalone.
Grann’ è la tua degnetate, non è men la tempestate:
grann’ è la varietate che trovarai en tua mascione.
■ Nell’“oscura costa”, Dante tiene dietro a Virgilio: “io sol uno / m’apparecchiava a sostener la guerra / sì del cammino e sì de la pietate” (Inf. II, 3-5). La guerra è tentazione, la “pugna militaris” che contraddistingue lo stato dei martiri (antichi e moderni; prologo, Notabile I). Virgilio gli ha detto che “il dilettoso monte / ch’è principio e cagion di tutta gioia” non può essere raggiunto per “corto andar”. Altro viaggio deve essere da lui intrapreso, dal momento che la mortifera e invincibile lupa, venendo incontro al poeta che sale, lo ha fatto rovinare “in basso loco”. Nel sesto stato, la gioia dello spirito può essere raggiunta solo attraverso la prova da parte degli eletti che preservano il seme della fede. La ‘teologia del dolore’ dell’Olivi [4] permea il viaggio di Dante. Il poeta viene assalito dal dubbio di non avere virtù possente all’“alto passo” e muta il suo intendimento iniziale di seguire Virgilio. Questi, vedendo l’anima di Dante “da viltade offesa”, gli spiega i motivi della sua venuta e allora la stanca virtù si apre all’ardire: al sesto stato, il periodo nel quale vive il poeta, è data scarsa virtù per le grandi opere, compensata dalla ‘porta aperta’. Nella domanda di Dante a Virgilio – “Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede? / Io non Enëa, io non Paulo sono; / me degno a ciò né io né altri ’l crede” (Inf. II, 31-33) – sta lo stesso senso di inadeguatezza indotto dalla stanca virtù che dovette certamente provare l’eremita della Maiella di fronte all’elezione al soglio di Pietro: “Et quid sum ego ad tale tantumque onus accipiendum talemque potestatem? Ego non sum sufficiens ad me salvandum; quomodo totum mundum” [5].
Un antico esempio contrario, del lasciare la guerra, è l’indovino Anfiarao, il quale di fronte agli occhi dei Tebani rovinò a valle “fino a Minòs che ciascheduno afferra” (Inf. XX, 31-36). I versi della Tebaide (VIII, 84-85) di Stazio, pronunciati da Plutone all’arrivo nell’Ade del re di Argo, sono da Dante concordati con la visione storica dell’Olivi e ad essa ‘torti’: a nulla gli servì sapere prima la propria sorte non potendo sfuggire al giudizio divino; meglio avrebbe fatto a resistere nella guerra-tentazione per essere di coloro “qui sunt firmi in fide et fortes ad vincendum persecutionem” (Ap 3, 10).
Alla seconda chiesa d’Asia, propria dei martiri (Smirne), si dice: “Sii fedele fino alla morte”, cioè fino all’ultimo giorno della vita o fino al soffrire il martirio, che uccide il corpo, “e ti darò la corona della vita”, cioè la gloria eterna. Sono parole che si ritrovano a Purg. XVIII, 136-138, nella terzina del secondo esempio di accidia punita, relativa ai compagni di Enea che si fermarono in Sicilia (Aen. V, 604ss.), gente “che l’affanno non sofferse / fino a la fine”, offrendo sé stessa “a vita sanza gloria”. Ad Ap 20, 5 (settima visione) è detto: “E gli altri morti”, cioè i reprobi nella morte eterna, “non vissero” la vita della grazia e della gloria “fino al compimento dei mille anni”, ossia per tutto il tempo di questa vita, dopo la quale verranno puniti più duramente. Chi in questa vita non visse sono gli ignavi, “questi sciaurati, che mai non fur vivi” (Inf. III, 64). L’espressione “questi non hanno speranza di morte” (v. 46) va riferita all’esegesi della “seconda morte”, che è “dolor perpetuus peior morte et faciens continue appetere mortem” (Ap 2, 11; 20, 5-6; Inf. I, 115-117).
Una situazione simile a quella di Celestino si verifica con san Francesco. Pur essendo di umili origini, ‘vile’, in quanto figlio di un mercante, e umile perché “dispetto” per la povertà, non “li gravò viltà di cuor le ciglia” ma aprì regalmente la sua dura intenzione a Innocenzo III, dal quale ottenne la prima approvazione della sua religione (Par. XI, 88-93; si confronti l’atteggiamento di Francesco con quello di Dante nella selva: “quando chinavi, a rovinar, le ciglia”, come gli dice san Bernardo a Par. XXXII, 138). Si tratta di una variazione di temi in parte presenti anche nella descrizione del martirio di santo Stefano, tra le visioni estatiche di mansuetudine nel terzo girone della montagna (Purg. XV, 106-114). La morte aggrava il martire verso la terra, ma egli fa degli occhi porte al cielo; la viltà derivata dall’origine non grava le ciglia di Francesco, che apre il suo intento al papa [6].
L’aprirsi, proprio del sesto stato al quale è appunto data la ‘porta aperta’, si contrappone alla viltà. Ciò avviene in Francesco – “Né li gravò viltà di cuor le ciglia … ma regalmente sua dura intenzione / ad Innocenzio aperse” (Par. XI, 88-92) – come in Dante – “perché tanta viltà nel core allette … Quali fioretti dal notturno gelo / chinati e chiusi, poi che ’l sol li ’mbianca, / si drizzan tutti aperti in loro stelo” (Inf. II, 121-132).
■ Il nome dell’ombra innominata, taciuto quasi per “contrapasso” all’essere venuto meno al precetto dato alla sesta chiesa – “et non negasti nomen meum” (Ap 3, 8) -, viene illuminato altrove, nel discorso beffardo che Bonifacio VIII, vero carnefice dei nuovi martiri della Chiesa, fa a Guido da Montefeltro: “però son due le chiavi / che ’l mio antecessor non ebbe care” (Inf. XXVII, 104-105). Guido viene ‘spinto’ da “argomenti gravi” a dare a Bonifacio VIII il consiglio fraudolento su come prendere Palestrina: “Allor mi pinser li argomenti gravi / la ’ve ’l tacer mi fu avviso ’l peggio” (vv. 106-107). Ha dinanzi l’immagine dell’autorità pontificia, nel Notabile X del prologo della Lectura assimilata ad Anna e a Caifa, che lo assolve ancor prima di peccare. Nel suo cuore si insinua il dubbio su quale sia la vera via di salvezza: resistere in nome di “quel capestro / che solea fare i suoi cinti più macri” oppure cedere all’autorità papale? Come Francesca e Paolo nell’interpretare i “dubbiosi disiri” d’Amore, che essi intesero solo in senso carnale indotti da una falsa Scrittura, così anche il vecchio uomo d’arme viene meno nel momento della prova, nella quale avrebbe dovuto mantenere ferma la professione della regola evangelica, accettata col farsi “cordigliero”.
“Et non negasti nomen meum” (Ap 3, 8). Non negare il nome di Cristo non è cosa grande se non in una forte persecuzione, allorché si è spinti e quasi costretti a negare. Non negare significa confessare, in quanto tacere in questo caso è come negare. Così Guido, il quale ritiene peggior partito il tacere e non nega quanto gli viene chiesto, ma al “gran prete” confessa non il nome di Cristo e la regola evangelica, bensì la frode (vv. 106-111). Neppure Francesco potrà impedire che il diavolo “löico” ne porti l’anima dopo la morte a Minosse (vv. 112-129).
Il papa, domandando consiglio al francescano, lo inganna agendo in nome della potestà conferitagli da quelle chiavi che forse aveva consigliato lui stesso a Celestino di non avere care. Di fronte agli argomenti distorti del pontefice e alla falsa immagine della sua autorità – elementi che contrassegnano il martirio psicologico del sesto stato, e lo differenziano da quello subìto dagli antichi cristiani nel secondo -, il francescano Guido, dando il consiglio fraudolento, cede e apre al Caetani la porta di Palestrina, come il papa angelico, cedendo con il gran rifiuto, gli ha aperto la porta del pontificato. In entrambi i casi, i due potenziali eletti non hanno saputo vincere le tentazioni e salvare il seme della fede nella regola evangelica, aprendo la strada a colui che non temette “tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio” (Inf. XIX, 55-57).
■ È possibile che la viltà la quale indusse “il gran rifiuto” fosse determinata, nella mente di Dante, anche dalla viltà di origine, cioè dalla “matrice contadina” che “caratterizza tutta la vita di Pietro del Morrone” [7]. Il tema del rapporto tra la viltà e il suo contrario, la nobiltà, tra imperfezione e perfezione, è discusso nel IV Trattato del Convivio, scritto in tempi ravvicinatissimi, se non contemporanei, alla decisione di compiere il viaggio. Non è casuale che l’esegesi relativa a Laodicea, la settima chiesa d’Asia rimproverata per la sua tepidezza, sia appropriata oltre che agli ignavi, in un diverso e positivo contesto, all’ignaro villanello della similitudine in principio di Inf. XXIV, memore de “lo più vile villano di tutta la contrada” di cui si parla nel Convivio, che sul Falterona ritrovò per caso zappando un antico tesoro (IV, xi, 8). Ma nel Convivio (IV, xx, 3-6) vi è pure la distinzione tra nobiltà di schiatta e nobiltà d’elezione da parte di Dio, “appo cui non è scelta di persone, sì come le divine Scritture manifestano”, il quale rende dèi chi vuole eleggere, distinzione che ben s’incontra con la “signatio” all’alta milizia che avviene all’apertura del sesto sigillo, la cui esegesi distingue appunto la magnanimità dei segnati sulla fronte dalla volgare schiera (Ap 7, 3-4). La viltà d’origine può essere superata, come mostra l’esempio di Francesco e del fondatore di Roma, Quirino, il quale “vien … da sì vil padre, che si rende a Marte” (Par. VIII, 131-132). Pietro del Morrone, che nobile non era, ma fu eletto da Dio a un’alta missione, apostatò da questa – vero precetto divino da custodire – uscendo dal campo prima di aver sofferto fino in fondo, certificando a sé stesso, in tal modo, la propria celeste elezione.
■ Che lo stesso Dante ritenesse legittima, dal punto di vista canonico, l’elezione di Bonifacio VIII si ricava, come osservato da Arsenio Frugoni [8], dalla profezia che Ugo Capeto fa dell’episodio di Anagni, dove sarebbe stato Cristo a “esser catto” nel “vicario suo” (Purg. XX, 87), mentre le dure parole di san Pietro contro “quelli ch’usurpa in terra il luogo mio” (Par. XXVII, 22-24) esprimono una condanna morale.
Dante, quando iniziò la Commedia nel 1307-1309, era molto più vicino alle posizioni di Ubertino da Casale (dal quale ebbe probabilmente in mano la Lectura super Apocalipsim), che considerava la rinuncia celestiniana un’“horrenda novitas” [9], di quanto non lo sarebbe stato dopo il 1316, con Par. XII, 124-126, allorché per bocca di Bonaventura avrebbe condannato le due opposte fazioni, degli estremisti e dei rilassati: “ma non fia da Casal né d’Acquasparta, / là onde vegnon tali a la scrittura, / ch’uno la fugge e altro la coarta”. Tuttavia la vicinanza stava più nell’appropriare figure apocalittiche come l’Anticristo mistico a personaggi storici che nel considerare canonicamente illegittima la rinuncia di Celestino e la successiva elezione di Bonifacio VIII. La figura del Caetani, vero persecutore dei martiri della Chiesa degli ultimi tempi, non ha alcun aspetto positivo, ma il metro di giudizio è quello morale, non quello proveniente dal diritto canonico. L’inganno perpetrato ai danni di Guido da Montefeltro si riverbera su quello messo in atto contro Celestino; entrambi, l’uomo d’arme fattosi cordigliero e il papa angelico sono posti all’inferno per aver ceduto al dubbio, nella subdola tentazione del moderno martirio, non resistendo nell’angustia l’uno, consigliando l’altro la frode.
■ Quasi tutti i contemporanei, leggendo del “gran rifiuto”, pensarono a Celestino V [10]. Dante non conobbe di persona Pietro del Morrone, diversamente non avrebbe scritto: “Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto / vidi e conobbi …”. Ma certamente non rimase insensibile di fronte agli eventi di quel travagliato anno 1294. Quasi al termine della lunga vacanza del soglio papale per la morte di Niccolò IV (4 aprile 1292 – 5 luglio 1294), cadde, intorno all’11 marzo, la visita a Firenze di Carlo Martello, primogenito di Carlo II d’Angiò e re titolare d’Ungheria, che appunto si incontrava col padre (cfr. Giovanni Villani, Nuova Cronica, IX, 13). È probabile che Dante facesse parte del comitato d’onore per l’ingresso del sovrano, capeggiato da Giano di messer Vieri de’ Cerchi. Carlo Martello sarà poi presente a L’Aquila alla consacrazione di Celestino V (29 agosto) e, dopo la rinuncia (13 dicembre), provvederà alla sua cattura a Vieste [11]. Una delegazione di nobili fiorentini accompagnò il re a Napoli il 5 ottobre 1294, ma non c’è alcuna prova che Dante vi facesse parte [12].
Carlo Martello, unico angioino a essere considerato positivamente nel poema, è gioiosamente ricordato in Paradiso VIII per l’intenso “amor amicitiae”. Le parole del sovrano, vero e proprio “alter Christus”, critico della propria famiglia, sono pregne dell’escatologia oliviana: la breve vita, interrotta nel 1295, conforme con quella altrettanto breve di Cristo; il suo amore verso Dante pari a quello portato verso il prediletto Giovanni; l’accenno al Vespro che sovvertì la “bella Trinacria” è storica realizzazione dell’apocalittico muoversi delle isole all’apertura del sesto sigillo. I fratelli di Carlo Martello – Ludovico, Roberto e Raimondo Berengario – educati in Provenza, fatti prigionieri dagli Aragonesi, ricevettero una lettera di Olivi, pregna anch’essa di escatologismo, il 18 maggio 1295 [13]. Quando nel marzo 1294 Carlo Martello incontrò Dante, già conosceva bene l’eremita del Morrone, che aveva potuto vedere a Sulmona nel luglio 1293; ne parlò col padre proprio nel marzo 1294, perché padre e figlio videro Pietro ai primi di aprile [14]. Non è impossibile che ne abbia parlato anche con l’amico fiorentino di fronte al quale, da morto, intonerà la canzone Voi che ’ntendendo il terzo ciel movete.
La rinuncia celestiniana fu anche per Dante, come per Ubertino e diversamente dallo stesso Olivi, un’“horrenda novitas”, che segnò la delusione di “una tensione di rinnovamento, una ansia di salvezza […] di un accadere meraviglioso e nuovo” permeato, come scrisse Arsenio Frugoni a proposito del Giubileo del 1300, di escatologismo, il quale “oltre che ideologia di lotta e di riforma del gruppo spirituale, era anche un vero e proprio sentimento storico” [15]. Proprio l’accenno all’anno giubilare, tragicamente collocato dove la penitenza non trova più luogo (Inf. XVIII, 28-33), assumerà i motivi dell’apertura del sesto sigillo, della fuga ai monti e alle pietre delle genti le quali, atterrite dal grande terremoto, “vanno a Santo Pietro”; quell’“essercito molto” che Celestino V, sei anni prima, aveva rinunciato a guidare rendendo indegna e innominata la sua dignità di “segnato” dal nome noto a Dio.
■ Quando Dante scrisse Inf. III, Celestino V non era stato ancora canonizzato (1313). Il fatto non gli poté restare ignoto, e ciò costituisce un’argomentazione contro l’identificazione del pontefice dimissionario con l’innominato ignavo. Ma, come osserva Frugoni, non era necessario un ritocco del testo [16]. Anche concessa una revisione generale della prima cantica, l’ombra restò innominata. Un’altra osservazione, che la canonizzazione non fosse un dogma di fede [17], gira a vuoto nel registro dantesco, che è unicamente morale nel riportare il giudizio divino sugli uomini e non fa conto dei canoni. Lo dimostra la meravigliosa salvazione dello scomunicato Manfredi, e anche l’innominata (ancora una volta) e più fulgida quinta luce del cielo del Sole di cui dice Tommaso d’Aquino (solo tre canti dopo precisata in Salomone), maschera della sapienza teologica dell’Olivi nel momento, dopo il Concilio di Vienne, del grande dibattito in terra sulla sua ortodossia.
[1] Il passo paolino è citato (con concetti analoghi reperibili in Cicerone e in Boezio) in Convivio IV, xxii, 6 (ed. F. Brambilla Ageno, Firenze 1995) a proposito dell’appetito naturale, simile negli uomini e negli animali, che dapprima «se medesimo ama, e teme e fugge quelle cose che a lui sono contrarie, e quelle odia». Poi «comincia una dissimilitudine tra loro, nel procedere di questo appetito, ché l’uno tiene uno cammino e l’altro un altro. Sì come dice l’Apostolo: “Molti corrono al palio, ma uno è quelli che ’l prende”, così questi umani appetiti per diversi calli dal principio se ne vanno, e uno solo calle è quello che noi mena alla nostra pace». Da questo punto di vista, gli ignavi – fasciati dall’esegesi dell’istruzione data al tiepido vescovo di Laodicea – sono la massima espressione dell’«amor sui propter se» (gli angeli neutrali “per sé fuoro”: Inf. III, 39): corrono senza posa e senza una meta, o meglio verso tutte le mete, non distinguono fra le cose che «sono più amabili e meno, e più odibili [e meno]» e non pervengono di conseguenza ad amare la parte migliore di sé, cioè l’animo, né in quell’amore si dilettano come nella propria felicità e beatitudine. È questo un esempio di come nei primi canti dell’Inferno si ritrovino concetti e forme linguistiche proprie del Convivio, sui quali ha scritto Giorgio Petrocchi in Itinerari danteschi, Bari 1969 (Biblioteca di critica e letteratura, III), pp. 257-275.
[2] GÜNTERT, Canto III, pp. 56-57.
[3] G. PADOAN, «Colui che fece per viltade il gran rifiuto», in Il pio Enea, l’empio Ulisse. Tradizione classica e intendimento medievale in Dante, Ravenna 19872, pp. 64-102: 70 nt. 23.
[4] Cfr. R. MANSELLI, L’attesa dell’età nuova ed il gioachimismo, in L’attesa dell’età nuova nella spiritualità della fine del Medioevo (…), Todi 1962, ripubblicato in IDEM, Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo. Studi sul francescanesimo spirituale, sull’ecclesiologia e sull’escatologisno bassomedievali, introduzione e cura di P. Vian, Roma, 1997 (Nuovi studi storici, 36), pp. 50-51: “Tutta la storia umana è dolore: tutte le età sono miste di bene e di male; ma specialmente la fine della quinta età e l’inizio della sesta età, quella, per l’Olivi, ormai imminente degli ultimi tempi della Chiesa, vede uno straripare indicibile di male; dalle colpe morali agli errori filosofici e teologici, dal malcostume ecclesiastico alla decadenza insinuatasi persino nello stesso ordine francescano, che con san Francesco aveva riportato sulla terra la vita stessa del Cristo”.
[5] Cfr. S. Pierre Célestin et ses premiers biographes, Vie et miracles de S. Pierre Célestin par deux des ses disciples, II, 28, in “Analecta Bollandiana”, 16 (1897), p. 417.
[6] Stefano è “giovinetto”: lo stato dei primi martiri corrisponde alla “pueritia inexperta” propria del secondo stato della Chiesa, il cui sviluppo è concepito secondo le età dell’uomo (prologo, Notabile III): di essa partecipa anche il sole, “la spera / che sempre a guisa di fanciullo scherza” nella similitudine che apre Purg. XV. Stefano, la cui visione compare nel girone degli iracondi purganti, è esempio di martire che preserva il “verbum patientie”, proprio della sesta chiesa, nel chinarsi grave verso la terra e nel pregare per il perdono dei suoi persecutori. Subito dopo Virgilio spiega che le visioni di mansuetudine si sono manifestate “perché non scuse / d’aprir lo core a l’acque de la pace / che da l’etterno fonte son diffuse” (Purg. XV, 106-114; 130-132). L’aprire il cuore equivale all’apertura della porta nel sesto e settimo stato. Una volta aperta la porta – come spiegato nell’esegesi dell’angelo che al suono della sesta tromba ha la faccia come il sole e tiene il libro aperto e grida a gran voce come un leone che ruggisce (Ap 10, 3) – non c’è più alcun velo di scusa per quanti resistono a motivo della loro durezza.
[7] Cfr. P. GOLINELLI, Ancora di colui «che fece per viltade il gran rifiuto» (Inf. III, 60), in “Rivista di Storia e Letteratura Religiosa”, 31 (1995/3), pp. 443-460.
[8] A. FRUGONI, Celestino V, in Enciclopedia Dantesca, I, p. 906.
[9] UBERTINO DA CASALE, Arbor vitae crucifixae Iesu, Venetiis 1485, rist. anast. a cura di C. T. Davis, Torino 1961, lib.V, cap. viii, p. 460b: “et tunc illa horrenda novitas reiectionis Celestini pape et usurpationis successoris super ecclesiam est adducta”. Contro gli Spirituali estremisti Olivi sostenne in una quaestio la legittimità della rinuncia di Celestino V: cfr. A. FORNI, Pietro di Giovanni Olivi di fronte alla rinuncia di Celestino V, in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo”, 99, 1 (1993), pp. 117-157.
[10] Cfr. supra, nt. 3.
[11] Cfr. R. MANSELLI, Carlo Martello, re titolare di Ungheria, in Enciclopedia Dantesca (Istituto della Enciclopedia Italiana), 1970, I, pp. 841-843: 842.
[12] Cfr. G. PETROCCHI, Biografia, ibid., Appendice, pp. 17-18.
[13] Una traduzione italiana delle lettere ai figli di Carlo II d’Angiò (18 mag. 1295) e a Corrado di Offida (14 set. 1295) è in PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Scritti scelti, a cura di P. Vian, Roma 1989 (Fonti cristiane per il terzo millennio), pp. 210-225.
[14] Cfr. P. HERDE, Cölestin V. (1294) (Peter vom Morrone), der Engelpapst. Mit einem Urkundenanhang und Edition zweier Viten, Stuttgart 1981 (Päpste und Papstttum, 16), pp. 58-59.
[15] A. FRUGONI, La Roma di Dante, tra il tempo e l’eterno, in IDEM, Pellegrini a Roma nel 1300. Cronache del primo Giubileo, presentazione di C. Frugoni, a cura e con Introduzione di F. Accrocca, Casale Monferrato 1999, pp. 102-103.
[16] Cfr. supra, nt. 8.
[17] Cfr. G. PETROCCHI, Itinerari danteschi, Bari 1969, pp. 76-77, dove viene richiamata l’amichevole polemica con Bruno Nardi.
Tab. III.1
[LSA, cap. VII, Ap 7, 3-4 (IIa visio, apertio VIIi sigilli)] Clamat ergo (Ap 7, 3): “Nolite”, id est non audeatis; vel si ad bonos angelos loquitur, dicit “nolite” quia, ex quo ipse prohibuit, non debuerunt velle; “nocere”, scilicet per effrenatam temptationem vel per predicationis et gratie impeditionem, “terre et mari neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum”.
|
||
Inf. I, 81, 129rispuos’ io lui con vergognosa fronte.oh felice colui cu’ ivi elegge!Inf. II, 43-45, 61-63, 103-105, 121-125“S’i’ ho ben la parola tua intesa”,
|
Par. XVI, 127-132Ciascun che de la bella insegna porta
|
|
Tab. III.2
[LSA, prologus, Notabile X] Sextus (status) vero concurrit cum secundo non in eodem tempore sed in celebri multitudine martiriorum, prout in apertione quinti signaculi aperte docetur (cfr. Ap 6, 9), quamvis in modo martirii quoad aliqua differant. Nam martiria a paganis et idolatris facta nullum certamen dubitationis inferebant martiribus, aut probabilis rationis, propter nimiam evidentiam paganici erroris. Non sic autem fuit de martiriis per hereticos, unum Deum et unum Christum confitentes, inflictis. In sexto autem tempore non solum propulsabuntur martires per tormenta corporum, aut per subtilitatem rationum philosophicarum, aut per intorta testimonia scripturarum sanctarum, aut per simulationem sanctitatis ypocritarum, immo etiam per miracula a tortoribus facta. Nam, teste Christo, “dabunt signa et prodigia magna” (Mt 24, 24). Unde Gregorius, XXXII° Moralium super illud Iob: “stringit caudam suam quasi cedrum” (Jb 40, 12), dicit: « Nunc fideles nostri mira faciunt, cum perversa patiuntur ; tunc autem Behemot huius satellites, etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit humane mentis illa temptatio, quando pius martir corpus tormentis subicit, et tamen ante eius oculos miracula tortor facit »*. Propulsabit etiam eos per falsam imaginem divine et pontificalis auctoritatis. Sic enim tunc surgent pseudochristi et pseudochristus contra electos, sicut Annas et Caiphas pontifices insurrexerunt in Christum. Erunt ergo tunc tormenta intensive maiora, tempore autem paganorum fuerunt extensive pluriora: nam plusquam per ducentos annos duraverunt.* S. Gregorii Magni Moralia in Iob, libri XXIII-XXXV, cura et studio M. Adriaen, Turnholti 1975 (Corpus Christianorum. Series Latina, CXLIII B), lib. XXXII, cap. XV, 67-72 (n. 24), p. 1648 (= PL 76, col. 650 C). |
||
[LSA, cap. III, Ap 3, 8 (Ia visio, VIa ecclesia)] “Ecce dedi coram te hostium apertum quod nemo potest claudere”. […] “Et servasti”, id est et quia servasti, “verbum meum”, id est doctrinam mee fidei et mee legis. “Et non negasti nomen meum”, scilicet in angustia persecutionis, aliter enim non est magnum non negare nomen Christi, sed solum cum quis per fortes persecutiones impellitur et quasi cogitur ad negandum. Tunc etiam idem est non negare quod confiteri, quia tacere in tali casu est negare. Ex hoc ergo innuit istum magnam persecutionem fidei sustinuisse, unde et paulo post dicit Christus eum servasse verbum patientie sue (Ap 3, 10). Nota quomodo hoc preclare competit sexto statui, cuius proprie est profiteri et servare legem evangelicam seu regulam non solum preceptorum sed etiam consiliorum Christi, et cuius est Christi nomen constanter et perseveranter confiteri contra persecutiones gravissimas duplicis Antichristi, scilicet mistici et proprii, et cuius erit perfectissime convertere totum Israelem […].
|
Inf. XXVII, 100-111E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti;
|
|
Tab. III.3
[LSA, cap. III, Ap 3, 8.10-11 (Ia visio, VIa ecclesia)] “Dedi”, inquam sic tibi “apertum”, “quia modicam habes virtutem”, scilicet ad miracula vel ad corporalia fortis active opera, que sensuales homines plus admirantur et estimant quam intellectualia et interna, unde et plus moventur per illa quam per ista et facilius trahuntur ad imitandum seu ad desiderandum imitari <illa quam ista>, et ideo carentem istis et miraculis oportet habere modo supradicto hostium apertum, si multi sunt convertendi per ipsum. “Et servasti”, id est et quia servasti, “verbum meum”, id est doctrinam mee fidei et mee legis. […]
|
|
Par. XX, 49-51E quel che segue in la circunferenza
|
Inf. II, 3-5……………………. e io sol uno
|
IV
SULLE RIVE D’ACHERONTE
● La quarta perfezione di Cristo sommo pastore consiste nella reverenda e preclara maturità del consiglio, designata dalla senile e gloriosa canizie del capo e dei crini, per cui si dice: “il suo capo e i suoi capelli erano candidi come lana bianca e come neve” (Ap 1, 14). Il capo costituisce la cima della mente e della sapienza; i capelli indicano la moltitudine e l’ornato dei sottilissimi e spiritualissimi pensieri e affetti, oppure la pienezza dei doni dello Spirito Santo che adornano la cima della mente.
I capelli di Cristo sono bianchi come lana e come neve. La lana lenisce col calore, è molle, temperata e soave nel candore; la neve è fredda, congelata, rigida e intensa nel candore non sostenibile alla vista, ma è anche umore che purga e impingua la terra. Così la sapienza di Cristo è da una parte calda per la pietà e condescensiva in modo contemperato alle nostre facoltà; è dall’altra astratta, rigida e intensa, ma anche purgativa delle colpe e impinguativa della nostra eredità.
L’esegesi della quarta perfezione si distingue pertanto in due parti, la prima strettamente connessa con i capelli, la seconda mostra invece una duplice proprietà nella sapienza di Cristo.
La duplice prerogativa della sapienza di Cristo ha diversi significati portati da parole: nix, frigiditas, algor, rigor, rigida, abstracta, candor intensior nostroque visui intolerabilior, per indicare il lato che si potrebbe chiamare duro della sapienza divina; lana, calor, mollities, condescensiva, contemperativa, pietate calefactiva, candor contemperantior, per designarne invece il lato pietoso e temperato. Inoltre il lato duro, indicato dalla neve, non si mostra solo freddo e rigido, ma anche purgativo e impinguativo, per cui la sapienza divina è sordium purgativa nostreque hereditatis impinguativa.
Beatrice (Purg. XXX, 70-81), nel suo apparire a Dante nel Paradiso terrestre, si presenta dapprima come “proterva”, cioè altera e rigida. Come una madre al figlio rimproverato “par superba … perché d’amaro / sente il sapor de la pietade acerba”, così la donna riprende (vv. 73-75) le prime parole di rimprovero (vv. 55-57) – “continüò come colui che dice / e ’l più caldo parlar dietro reserva”. Beatrice mostra il lato astratto della sapienza di Cristo, ma nello stesso tempo di lei si anticipa il lato pietoso: il “più caldo parlar” può essere riferito sia alle seconde parole, più dure delle prime, ma anche a quelle, assai più temperate ed espresse con pietà non acerba, che pronuncerà in seguito, dopo il pentimento di Dante. Il contrasto tra il gelido rigore e il caldo pietoso e temperato percorre infatti i versi che seguono.
Beatrice tace, e gli angeli cantano “In te, Domine, speravi ”, cioè il salmo XXX, ma solo i primi nove versetti, perché dopo “pedes meos” David chiede misericordia a Dio nelle proprie tribolazioni, cosa che sarebbe fuor di luogo per Dante (vv. 82-84). Gli angeli sono “dolci tempre” (v. 94), “sustanze pie” (v. 101): ad essi è appropriato il lato pietoso della sapienza di Cristo.
Alle parole proterve e superbe della donna il cuore del poeta si congela come la neve tra gli alberi d’Appennino quando è “soffiata e stretta da li venti schiavi”, cioè del nord-est, e tale resta fino all’ascolto del canto pietoso degli angeli che paiono partecipare del suo dramma e dire a Beatrice: “Donna, perché sì lo stempre?”, cioè perché gli togli vigore con le tue parole non temperate? Poi, come la neve si liquefa allo spirare del caldo vento meridionale che proviene dall’Africa (“la terra che perde ombra”), così il gelo stretto attorno al cuore del poeta si scioglie in “lacrime e sospiri”, “spirito e acqua”, “e con angoscia / de la bocca e de li occhi uscì del petto” (vv. 85-99). Anche Dante dunque partecipa dei due lati, rigido e aperto, della sapienza di Cristo.
È da notare la compresenza di alcune parole nella ristretta parte di esegesi e nel ristretto numero di versi: la neve e il congelarsi, il caldo, la pietà, il contemperare. Il significato originario non cambia, anche se quanto nell’esposizione scritturale è concentrato solo su Cristo è in poesia diffuso su tre soggetti, Beatrice, gli angeli e Dante. Bisogna anche dire che se la neve e il gelo sono accostati già nel parlare comune, e nell’ambito di questo sono altresì contrapponibili al caldo e al temperato, non appartiene del tutto al comune sentire acquisito nel linguaggio accostare la pietà al caldo e al temperare in contrapposizione al gelo.
Sarebbe ancora da notare che i piedi e il liquefarsi (vv. 84, 88) sono parole che compaiono nella sesta prerogativa di Cristo come sommo pastore, che concerne la vita attiva e l’operare, per cui si dice: “e i suoi piedi simili all’oricalco, come nel crogiolo ardente” (Ap 1, 15). L’oricalco (l’ottone) è assai simile all’oro, nel crogiolo si liquefa, è nitido, fiammeggiante, scintillante: così in Cristo gli atti corporei, esterni e inferiori procedevano e procedono fiammeggianti per la carità verso Dio e verso di noi, scintillanti in modo esemplare, provati durante la vita terrena nel crogiolo delle tentazioni e assai simili all’oro della sua interna e suprema carità.
Sgorgare lacrime e sospiri appartiene invece alla settima prerogativa, per cui si dice: “e la sua voce come la voce di molte acque” (Ap 1, 15), cioè come la voce di piogge inondanti e come l’impeto di fiumi e il mugghiare del mare. Questa voce di molte acque viene interpretata (in un luogo parallelo, ad Ap 14, 2) come suono di un’acqua che irriga, impingua, rinfresca con le lacrime e con sospiri ruggenti. La sapienza di Cristo, designata dalla neve, è rigida ed astratta, ma anche “sordium purgativa”.
● Il duplice aspetto della sapienza di Cristo non si ritrova solo nei versi sopra citati. “Freddi e molli” sono i canali de “li ruscelletti che d’i verdi colli / del Casentin discendon giuso in Arno”, che “la rigida giustizia” divina fa sì che siano sempre dinanzi agli occhi di maestro Adamo, il falsario di Romena, per accrescergli l’arsura della sete dell’idropico datagli per pena (Inf. XXX, 64-72). Il bucolico paesaggio virgiliano – “hic gelidi fontes, hic mollia prata” (Buc. X, 42) – è qui armato dai motivi propri della sapienza divina, che si presenta, anche nella pena, insieme neve e lana, fredda e ‘condiscendente’ (il tema è nei ruscelletti che “discendono”; da notare l’aggettivo “rigida”, presente nei versi e nell’esegesi).
●La prima parte dell’esegesi di Ap 1, 14 è relativa ai capelli, o crini, che nella loro senilità designano la “reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas”. Un accostamento (non consueto), quello dei crini e del consiglio, che è ben conosciuto dal diavolo preparato in logica che argomenta con successo, di fronte a san Francesco, il suo diritto a prendersi l’anima di Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 115-117). Guido, arrivato alla vecchiaia, si era pentito delle proprie opere volpine e si era cinto del cordone, ma poi, dando a Bonifacio VIII il consiglio fraudolento su come conquistare Palestrina, si era rimesso nelle prime colpe, e da quel momento i suoi crini non sono stati più segno di maturità e di gloria celeste, per cui il diavolo dice: “dal quale in qua stato li sono a’ crini”. Crini e consiglio sono accostati nei versi in senso negativo, all’opposto di quanto viene detto di Cristo.
● I motivi sacerdotali delle perfezioni di Cristo come sommo pastore rivestono Catone, il Gentile degno di significare Dio più di qualsiasi altro uomo terreno (Convivio, IV, xxviii, 15). La santità (terza perfezione: Ap 1, 13) è propria delle quattro stelle (le virtù cardinali, le “quattro luci sante”), “non viste mai fuor ch’a la prima gente”, che adornano la sua faccia di luce come se avesse davanti il sole (Purg. I, 23-24, 37-39; il tema della “facies eius sicut sol” costituisce la decima perfezione ad Ap 1, 16). È “veglio onesto” (Purg. II, 119; terza perfezione) e muove le “oneste piume”, cioè la barba (Purg. I, 42). Questa (vv. 34-36) è mista di pelo bianco (quarta perfezione, i capelli candidi come la neve: Ap 1, 14), somigliante (seconda perfezione, somiglianza con il Figlio dell’uomo: Ap 1, 13) ai capelli (quarta perfezione) che cadono sul petto in doppia lista (il precinto delle mammelle, cioè dell’intelletto e della volontà). La senile maturità del consiglio designata dai capelli (quarta perfezione) è reverenda, per cui è “veglio … degno di tanta reverenza in vista”, di fronte al quale Virgilio rende reverenti le gambe e il capo di Dante (vv. 31-32, 49-51). Il suo “santo petto” (v. 80; la santità è nella terza perfezione) designa, come si desume da Ap 2, 4, il retto consiglio, che corrisponde alla domanda del veglio se per Virgilio e Dante sia mutato il consiglio divino che impedisce ai dannati di fuggire la prigione eterna (vv. 47-48). La castità (terza perfezione) è negli occhi della moglie Marzia (vv. 78-79). Invia i due poeti verso il “molle limo” sull’orlo più basso della montagna del purgatorio: ivi crescono giunchi che non induriscono al percuotere delle onde, simbolo dell’umiltà che è principio di purgazione (vv. 100-105; cfr. i “piè molli” a Purg. XXI, 36). Ivi Dante deve essere lavato nel viso d’ “ogne sucidume” e cinto (terza perfezione; Purg. I, 94-96, 133). È da notare che la sapienza di Cristo è molle e condescensiva (come i giunchi), e anche “sordium purgativa” (quarta perfezione).
Tab. IV.1
[LSA, cap. I, Ap 1, 13-14.16 (radix Ie visionis)] Secunda (perfectio summo pastori condecens) est nature humane conformitas seu condescensiva ad subditos humilitas et humanitas, propter quod dicit: “similem Filio hominis” (Ap 1, 13). Ex hoc autem quod non dicit “Filium hominis”, sed “similem Filio hominis”, arguit Ricardus quod angelum vidit, qui in persona et similitudine Christi demonstrabat sibi omnia, qui eo amplius habuit auctoritatis quod apparuit in ipsa similitudine salvatoris. […]Tertia (perfectio summo pastori condecens) est sacerdotalis et pontificalis ordinis et integre castitatis et honestatis sanctitudo, unde subdit: “vestitum podere”. Poderis enim erat vestis sacerdotalis et linea pertingens usque ad pedes, propter quod dicta est poderis, id est pedalis: pos enim grece, id est pes latine. Poderis enim, secundum aliquos, erat tunica iacinctina pertingens usque ad pedes, in cuius fimbriis erant tintinabula aurea, et de hac videtur dici illud Sapientie XVI<II>° (Sap 18, 24): “In veste poderis, quam habebat, totus erat orbis terrarum, et parentum magnalia in quattuor ordinibus lapidum erant sculpta”. Dicuntur etiam fuisse in veste poderis quia erant in rationali et superhumerali ipsi poderi immediate superposita. Per utramque autem designatur habitus celestis castitatis et sanctitatis sacerdotes et pontifices condecens, pro cuius ardua plenitudine subdit: “et precinctum ad mamillas zona aurea”. […]Quarta (perfectio summo pastori condecens) est reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas per senilem et gloriosam canitiem capitis et crinium designata, unde subdit: “caput autem eius et capilli erant candidi tamquam lana alba et tamquam nix” (Ap 1, 14). Per caput vertex mentis et sapientie, per capillos autem multitudo et ornatus subtilissimorum et spiritualissimorum cogitatuum et affectuum seu plenitudo donorum Spiritus Sancti verticem mentis adornantium designatur.
|
||
Inf. XXVII, 115-117Venir se ne dee giù tra ’ miei meschini
|
Inf. X, 34-36Io avea già il mio viso nel suo fitto;
|
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 14 (radix Ie visionis)] Quarta (perfectio summo pastori condecens) est reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas per senilem et gloriosam canitiem capitis et crinium designata, unde subdit: “caput autem eius et capilli erant candidi tamquam lana alba et tamquam nix” (Ap 1, 14). Per caput vertex mentis et sapientie, per capillos autem multitudo et ornatus subtilissimorum et spiritualissimorum cogitatuum et affectuum seu plenitudo donorum Spiritus Sancti verticem mentis adornantium designatur.
|
Purg. XXX, 70-75, 79-102regalmente ne l’atto ancor proterva
|
|
[Ap 1, 15] Septima (perfectio summo pastori condecens) est sue doctrine celebris resonantia et irrigatio fecunda, unde subdit: “et vox illius tamquam vox aquarum multarum”, id est sicut vox pluviarum inundantium et impetus fluminum et marinorum fluctuum et rugituum, sic enim ab ipso et ab eius scripturis et doctoribus manat vox predicationis irrigantis et comminantis.
|
||
● Catone, per la senilità e il biancore (Purg. I, 31, 34), è accostabile a Caronte (Inf. III, 83, 97): “un veglio solo … Lunga la barba e di pel bianco mista” – “un vecchio, bianco per antico pelo … Quinci fuor quete le lanose gote” (unico riferimento alla lana nel poema, assente in Virgilio; cfr. Aen. VI, 299-300: “cui plurima mento / canities inculta iacet”). Anche per il traghettatore d’Acheronte i temi corrispondono in parte alla quarta prerogativa di Cristo sommo pastore, di cui vengono citate le due vie, corrispondenti al calore della lana e al freddo della neve, entrambe volte alla punizione: “i’ vegno per menarvi a l’altra riva / ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo” (Inf. III, 86-87). L’aggettivo “antico” appartiene, nell’esegesi della sesta coppa versata dall’angelo sul grande fiume Eufrate (Ap 16, 12), all’antica Babilonia per la quale quel fiume scorreva contribuendo non poco alla sua difesa. Secondo Gioacchino da Fiore, esso designa Roma o la milizia mondana dell’impero cristiano, per cui ad Ap 17, 15 viene detto che “le acque sopra le quali siede la meretrice sono i popoli e le genti”. Di qui il verso “vidi genti a la riva d’un gran fiume” (Inf. III, 71). Di Babilonia si dice ad Ap 18, 2: “Ed è fatta nido di demoni e covo di ogni spirito immondo e di ogni uccello sozzo e odioso”. I demoni sono detti “spiriti” per la natura sottile; “uccelli” per agilità, velocità e superbia; “immondi” per le macchie dei vizi; “odiosi” per la grande malizia, empietà ed arroganza. Babilonia sarà la loro abitazione e il loro covo, poiché come nella colpa terrena, nel consentire ad essi e nell’imitarli, fu ad essi soggetta e associata e fu quasi la loro casa, così sarà nella pena eterna. Giovanni in questo caso mantiene l’immagine di Isaia: “Babilonia, gloriosa città tra i regni, sarà come Sodoma sconvolta da Dio; le sue case si riempiranno di serpenti, vi faranno dimora gli struzzi e esseri pelosi vi danzeranno” (Is 13, 19.21). Di qui il “pelo” di Caronte.
La quinta perfezione di Cristo come sommo pastore è il fervido, splendente e perspicace zelo della contemplazione che osserva intorno ogni atto, intenzione o cenno delle chiese, per cui si dice: “e i suoi occhi fiammeggianti come fuoco” (Ap 1, 14). Un passo simmetrico è ad Ap 19, 12. Se si collazionano i passi relativi alla quinta perfezione con quanto ad Ap 9, 9 si dice, nell’esegesi della quinta tromba, sullo zelo acre delle locuste le cui ali suonano come ruote ed eserciti tumultuosi che corrono in guerra contro ogni sentenza contraria (cfr. infra), si ritrovano altri fili con cui è tessuta la figura di Caronte, “che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote” (lo zelo è il motivo-chiave che unisce i tre passi). Dante ha presente il virgiliano “stant lumina flamma” (Aen. VI, 300), ma modifica l’immobilità dello sguardo con il movimento circolare degli occhi, reso dalle “rote” fiammeggianti, che raccoglie tutte le anime con cenni. Un altro passo che può aver recato motivi a Inf. III, 99 è ad Ap 14, 11, dove la fiamma infernale è detta ardente e sempre in vivacissimo moto (cfr., a Inf. IV, 123, “Cesare armato con li occhi grifagni”). La “bragia” degli occhi si trova ad Ap 4, 8, nel fuoco della carità proprio dei cherubini, lampade ardenti secondo Ezechiele (Ez 1, 13), riferito alle sei ali piene di occhi circospetti di ciascuno dei quattro esseri viventi che vanno intorno alla sede divina difendendola dalle insidie come un leone (cfr. l’atteggiamento di Sordello a Purg. VI, 61-66).
L’avvento di Caronte è segnato, come quello di Virgilio, da temi che nell’esegesi sono propri di Cristo. La sua apparizione riprende il tema, da Ap 1, 7 e 2, 12, dell’avvento di Cristo giudice, che viene proposto al lettore in modo sensibile e terribile: «Ecce venit cum nubibus … “veniam tibi”, id est contra te, “cito” – Ed ecco verso noi venir per nave … i’ vegno per menarvi a l’altra riva» (Inf. III, 82, 86; cfr., a Inf. IV, 86-87, l’arrivo di Omero con la “spada”, che come il “remo” di Caronte corrisponde al “gladium” di Ap 2, 12, cioè alla parola viva dello spirito di Cristo, che determina, giudica e condanna).
Alcuni motivi suggeriti ad Ap 11, 18 (settima tromba) sono presenti nei versi che descrivono la “trista riviera d’Acheronte”. La divisione dei buoni dai malvagi è nell’invito di Caronte a Dante: “pàrtiti da cotesti che son morti” (Inf. III, 89; per il verso precedente, “e tu che se’ costì, anima viva”, cfr. Ap 16, 3). L’ira sta nell’espressione di Virgilio: “quelli che muoion ne l’ira di Dio …” (v. 122). L’essere pravo e il “guai!” (“vae!”) nelle parole crude del nocchiero: “Guai a voi, anime prave!” (v. 84; cfr. l’espressione “terra prava” a Inf. XVI, 9 e Par. IX, 25).
Nel quietare “le lanose gote” di Caronte, Virgilio svolge la funzione dell’angelo del sesto sigillo (Ap 7, 1-2).
Tab. IV.2
[LSA, cap. I, Ap 1, 14 (radix Ie visionis)] Quarta (perfectio summo pastori condecens) est reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas per senilem et gloriosam canitiem capitis et crinium designata, unde subdit: “caput autem eius et capilli erant candidi tamquam lana alba et tamquam nix” (Ap 1, 14). Per caput vertex mentis et sapientie, per capillos autem multitudo et ornatus subtilissimorum et spiritualissimorum cogitatuum et affectuum seu plenitudo donorum Spiritus Sancti verticem mentis adornantium designatur.
|
||
[LSA, cap. I, Ap 1, 7 (prohemium, septem primatus Christi secundum quod homo)] Septimo ascribit ei primatum iudiciarie retributionis omnium bonorum et malorum, et ut hoc sensibilius et magnificentius ac terribilius nobis ingerat, introducit eius de celis maiestativum adventum quasi iam presentem seu in procinctu imminentem, dicens: “Ecce venit cum nubibus” (Ap 1, 7). Non solum autem propter causam predictam dicit “venit” de presenti, sed etiam quia sicut rex venturus Romam ad iudicia danda dicitur venire ex quo inchoat iter suum, et domificator dicitur hedificare domum ex quo incipit iacere fundamenta, sic Deus dicitur venire ad iudicium quia quicquid ab initio ecclesie facit est iter ad illud. Preterea nunc continue dat multa occulte iudicia, et pro tanto semper venit et per effectus iudiciorum. |
[LSA, cap. II, Ap 2, 12 (Ia visio, IIIa ecclesia)] “Si quo minus”, id est si in aliquo minus quam monui penitueris, id est si aliter quam dixi egeris, “veniam tibi”, id est contra te, “cito”. “Cito” dicit, ut ex propinquitate sui adventus magis timeat et citius ac fortius peniteat.
|
|
|
Inf. IV, 85-90Lo buon maestro cominciò a dire:
|
|
[LSA, cap. XI, Ap 11, 18 (IIIa visio, VIIa tuba)] “Et irate sunt gentes” (Ap 11, 18), id est et gratias tibi agimus de hoc, quod ita gloriose regnasti in tuis sanctis et super tuos hostes quod inde irati et perturbati sunt hostes. “Et advenit ira tua”, id est effectus tue iudiciarie ire seu tue iuste vindicte in reprobos.
|
||
Tab. IV.3
[LSA, cap. IX, Ap 9, 3.7.9 (IIIa visio, Va tuba)] “De fumo” autem predicti casus et apertionis “putei exierunt locuste” (Ap 9, 3), id est religiosi illorum sequaces ac leves et volatiles et cupidi et carnales et ypocritales et detractores, qui et contra omnes eis non faventes animosissime concitantur quasi equi currentes in bellum (Ap 9, 7), et etiam contra omnia multum spiritalia contra que zelum acrem assumunt. “Vox” autem “alarum” (Ap 9, 9), id est suarum sententiarum quas altissimas et prevolantes esse presumunt, est sicut vox rotarum et tumultuosi exercitus currentis in bellum contra omnem sententiam contrariam quantumcumque veram. |
[LSA, cap. I, Ap 1, 14 (radix Ie visionis)] Quinta (perfectio summo pastori condecens) est contemplationis speculative et practice zelativus et perspicax fervor et splendor, omnes actus et intentiones et nutus ecclesiarum circumspiciens, unde subdit: “et oculi eius velut flamma ignis”.[LSA, cap. XIX, Ap 19, 12 (VIa visio)] “Oculi autem eius sicut flamma ignis” (Ap 19, 12), scilicet propter ardorem zeli ad faciendum iudicium et iustitiam de impiis et ad liberandum suos ab eis et ad inflammandum et illuminandum eos igne caritatis et amative sapientie. |
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 8 (radix IIe visionis)] Item moraliter per sex alas animalium designantur sex virtutes. […] Due vero quibus volant sunt fides et spes. Caritas enim est ignis seraphicus quo sancta animalia sunt plena; sunt enim ignita quasi carbones et lampades ardentes, prout dicitur Ezechielis I° (Ez 1, 13). […] Sequitur: “Et in circuitu et intus plena sunt oculis” (Ap 4, 8), id est perspicaciter et circumspecte vident sua interiora et exteriora, et etiam interiora et exteriora Dei et ecclesie et scripture sacre. Precavent etiam hostes impios in circuitu ambulantes et insidias diaboli, qui tamquam leo circuit querens quem devoret. Discutiunt etiam sua interiora, ut corrigant defectus et ordinent bona. Nota quod plenitudo oculorum appropriatur ordini cherubin secundum Dionysium; trinus autem ordo alarum seu valde esse alatum appropriatur seraphin secundum ipsum, sicut et expansio et volatus amoris.[LSA, cap. XIV, Ap 14, 11 (IVa visio, VIum prelium)] Deinde de eternitate et de irremissibilitate pene eorum subdit (Ap 14, 11): “Et fumus tormentorum eorum in secula seculorum ascendet”, id est in sua quasi infinita altitudine stabunt semper eis tormenta, ac si semper ascenderet ignis eorum et fumus. Ad litteram etiam innuit quod ignis infernalis, quo torquebuntur, erit fumosus et tenebrosus et semper in vivacissimo motu tamquam semper ardentissimus. Per hunc fumum etiam, secundum Ioachim, designatur dampnatorum murmur et blasphemia contra Deum semper ascendens*.* Expositio, pars IV, distinctio VI, f. 174va. |
||
|
Aen. VI, 298-301Portitor has horrendus aquas et flumina servat
|
|
●I dieci re, designati con le dieci corna, e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno delle acque, cioè dei popoli, su cui si riposava consolandosi, la denuderanno degli ornamenti e ricchezze, ne mangeranno le carni e la bruceranno riducendola in cenere, in modo che non rimanga alcuna memoria o segno della sua antica gloria (Ap 17, 16). Nel far ciò i dieci re, oltre a perseguire il proprio intento, serviranno il volere di Cristo e saranno mossi da un suo occulto ordine: “Dio ha infatti messo loro in cuore di fare ciò che a lui piace, in modo che consegnino il proprio regno alla bestia”, soggiacendo al re della bestia, “finché siano consumate”, cioè realizzate, “le parole di Dio” sulla distruzione della meretrice e sulla liberazione degli eletti dalle sue mani (Ap 17, 17). Dio muove i cuori degli empi a empie azioni, ma senza che in Lui influisca alcuna colpa o vizio; anzi, in tutto ciò c’è somma giustizia e convenienza.
Il tema della città incenerita è reso dall’immagine di “Troia in cenere e in caverne”, scolpita con segno “basso e vile” fra gli esempi di superbia punita sul duro pavimento del primo girone del purgatorio (Purg. XII, 61-63; il motivo della cenere è fra quelli che chiudono il quarto sigillo [Ap 5, 1] ed è presente nel pianto dei mercanti sulla caduta di Babilonia [Ap 18, 19]).
Come i dieci re sono mossi con occulto ordine dalla giustizia divina, che fa coincidere la loro volontà con la propria, così le anime di quanti muoiono nell’ira di Dio sono pronte a passare al di là dell’Acheronte spronate dalla divina giustizia, “sì che la tema si volve in disio” (Inf. III, 70-75, 124-126). Si può confrontare l’esegesi di Ap 17, 17 con quella di Ap 17, 13, dove i dieci re, spronati dal timore, consegnano la propria volontà alla bestia, devolvendo ad essa il potere regio che prima avevano libero. Il volgersi del timore nel desiderio contiene in sé, in versione tragica, il tema del venire con desiderio e volontario consenso sviluppato nell’esegesi di Ap 22, 17, il luogo dove Cristo invita chi ha sete a venire, e chi vuole ad attingere gratuitamente l’acqua della vita (è da notare che “gratis” compare anche ad Ap 17, 13, riferito alla devoluzione alla bestia della volontà da parte dei dieci re). Si tratta delle acque della vita che cancellano ogni desiderio che reca pena, alle quali, ad Ap 7, 17 (nel finale dell’apertura del sesto sigillo), si dice che l’Agnello guiderà i beati che sono passati attraverso la grande tribolazione. Per occulto giudizio divino, afferma Beatrice, la nostra redenzione è avvenuta muovendo i Giudei: “Però d’un atto uscir cose diverse: / ch’a Dio e a’ Giudei piacque una morte; / per lei tremò la terra e ’l ciel s’aperse” (Par. VII, 46-48).
Da notare che il convenire insieme dei dieci re, i quali uno dopo l’altro consegnano gratis o per forza o per timore la propria libera volontà alla bestia (Ap 17, 12-13), permea tanto le anime dannate nel passaggio dell’Acheronte quanto le parole di Marco Lombardo contro il forzato andare insieme di spada e pastorale, impero e papato, i “due soli” del mondo che dovrebbero invece concorrere liberi e non soggetti l’uno all’altro (Purg. XVI, 109-112; non a caso Marco, ai vv. 79-81, ha parlato della libertà umana che soggiace non agli astri, ma alla “maggior forza” di Dio).
Tab. IV.4
Purg. XII, 16-18, 61-63Come, perché di lor memoria sia,
|
Par. VII, 46-48, 55-57Però d’un atto uscir cose diverse:
|
|
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 16-17 (VIa visio)] “Et decem cornua, que vidisti, et bestia” (Ap 17, 16), et etiam bestia seu rex bestie seu, secundum Ricardum, “et bestia”, id est diabolus; “hii”, scilicet decem reges per cornua designati, “odient fornicariam et desolatam facient illam”, scilicet suis aquis seu populis in quibus consolatorie quiescebat, “et nudam”, scilicet suis ornamentis et divitiis, “et carnes eius manducabunt”, <id est crudeliter dilacerabunt et occident, “et ipsam igni concremabunt”,> id est eius urbes et terras cremabunt et incinerabunt, ut quasi non sit memoria vel signum prioris status vel glorie eius.
|
||
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 13 (VIa visio)] Unde et mox subditur quod “virtutem et potestatem suam bestie tradent”, id est erunt obedientes et famulatorie cooperantes principali regi bestie, videturque ver-bum tradendi sonare quod potestatem regiam, quam prius habebant liberam et insubiectam, sub-icient illi regi gratis vel vi vel timore illius compulsi. |
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 17 (VIIa visio)] Deinde ipse Christus per se liberaliter invitat et offert, dicens: “Et qui sitit veniat, et qui vult accipiat aquam vite gratis”. Quia nullus cogitur nec potest venire nisi per desiderium et voluntarium consensum, ideo dicit “qui sitit et qui vult”. Idem autem est venire quod accipere “aquam vite”, id est gratiam vite refectivam et vivificam et perducentem in vitam eternam. Dicit autem “gratis”, tum quia absque omni pretio venali et exteriori datur et accipitur, tum quia prima gratia datur absque omni previo merito et tamquam principium et caus<a> meriti, ac per consequens totum premium et augmentum gratie quod per primam gratiam acquiritur gratia reputatur. Dicit etiam “gratis”, quia tota a summa caritate Christi et summe gratuita et liberali predestinatur et offertur et datur. |
|
Tab. IV.5
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 12-13 (VIa visio)] Sequitur (Ap 17, 12): “Et decem cornua, que vidisti, decem reges sunt, qui regnum nondum acceperunt; sed potestatem tamquam reges una hora accipient post bestiam”. Aut per decem reges designantur hic ad litteram decem, aut indeterminata multitudo regum, ut more scripture sumatur numerus determinatus pro indeterminato. Dicuntur autem accipere regnum “post bestiam” quia suberunt bestie, id est principali regi ipsius bestie qui et ipse dicitur bestia, et secundum hoc le “post” non dicit hic posteritatem temporis sed solum subiectionis et sequele. Unde et mox subditur (Ap 17, 13) quod “virtutem et potestatem suam bestie tradent”, id est erunt obedientes et famulatorie cooperantes principali regi bestie, videturque verbum tradendi sonare quod potestatem regiam, quam prius habebant liberam et insubiectam, subicient illi regi gratis vel vi vel timore illius compulsi. […] Quia vero cum dicitur quod “una hora accipient” potestatem regnandi (Ap 17, 12), posset credi quod “una hora” sumatur hic large, sicut a Iohanne sumitur “hora novissima” pro tota sexta etate (cfr. 1 Jo 2, 18), ita quod omnes, qui in ea successive unus post alterum regnaverunt, possunt hoc modo dici “una hora” regnasse, ideo hunc sensum excludit per hoc quod subdit: “Hii unum consilium habent” (Ap 17, 13), id est concordi et unanimi consilio et consensu convenient insimul contra Christum et electos eius, et etiam contra meretricem, id est contra ecclesiam a Christo meretricatam. Ex quo patet quod non successive unus post alium, immo insimul regnabunt et concordabunt. Concordatque hoc cum eo quod Ieremias, capitulo L° loquens contra Babilonem, dicit: “Ecce ego adducam in Babilonem congregationem gentium magnarum” (Jr 50, 9). Et post subdit (Jr 50, 41-43): “Ecce populus veniet ab aquilone, et gens magna et reges multi a finibus terre, crudeles et immisericordes contra te fili<a> Babilonis. Audivit rex Babilonis famam eorum, et dissolute sunt manus eius”. Et tamen constat quod isti reges venerunt cum Ciro rege et Dario. |
||
|
Purg. XVI, 79-81, 109-112A maggior forza e a miglior natura
|
|
Tab. IV.6 [Nota]
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 18 (IVa visio, Vum prelium)] Arena enim est terrea seu pulverosa et sterilis et in multitudine<m> partium minimarum et in lapillulorum athomos induratorum innumerabilem divisa et semper instabilis et ab omni vento dispergibilis. |
|
[LSA, cap. IX, Ap 9, 9.12 (IIIa visio, Va tuba)]
|
||
Inf. IX, 64-75, 82-84, 100-103E già venìa su per le torbide onde
|
Inf. XV, 94-96, XVI, 1-6, 19-30, 40-42, 76-78, 86-87
|
|
Nota alla Tab. IV.vi |
||
La settima proprietà delle locuste è il rombo delle ali pari al rombo dei carri da guerra che corrono tirati da molti cavalli. Si tratta del suono di un volo tumultuoso e impetuoso, come di quadrighe. Le ali stridono e rugghiano quando vengono al conflitto (nella seconda fase, intermedia, del quinto stato, segnata da Manichei e Valdesi), e designano il disseminare parole per superare con esse tutto quello che non si può vincere con la ragione. Le loro sentenze, che presumono altissime e volanti sopra le altre, formano come il suono di ruote e di eserciti tumultuosi che corrono in guerra contro ogni sentenza contraria, per quanto vera (Ap 9, 9).
|
||
Tab. IV.7 [Nota]
[LSA, cap. IX, Ap 9, 5-6 (IIIa visio, Va tuba)] Pedes vero transfigunt per duo, scilicet per litteralem corticem scripture quam pro se inducunt dicentes plus standum esse littere quam expositioni nostre, et iterum per ration<em> experientiam sequentem et apparentiam sensus, propter quod derident fidem nostram dicentem corpus Christi esse in parva hostia et in qualibet parte eius, aut quod Deus bonus nostra membra turpia et verenda et vermes et pulices et bufones et consimilia nobis nociva et tediosa creavit. |
|
Inf. III, 64-69Questi sciaurati, che mai non fur vivi,
|
Inf. XVII, 49-51non altrimenti fan di state i cani
|
IV stato[LSA, cap. XII, Ap 12, 14 (IVa visio, III-IVum prelium)] “Ubi alitur per tempus et tempora et dimidium temporis a facie serpentis” […] Alitur autem ibi non solum spiritali doctrina et contemplatione et copia gratiarum, sed etiam incorporatione gentium, quas per fidem et gratiam eis datam incorporat sibi. Quia enim non potuit comedere et incorporare Iudeos, ideo in terris gentium, prius a Deo desertis, datus est sibi locus ut incorporet eas sibi, ne per penuriam fidelium tota a diabolo consumatur. |
V stato[LSA, prologus, Notabile V] Quia vero ecclesia Christi usque ad finem seculi non debet omnino extingui, ideo oportuit eam in quibusdam suis reliquiis tunc specialiter a Deo defendi et in unam partem terre recolligi, qua nulla congruentior sede Petri et sede romani imperii, que est principalis sedes Christi. Ideo in quinto tempore, quod cepit a Karolo, facta est defensio et recollectio ista, tuncque congrue instituta est vita condescensiva, ut nequeuntibus in arduis perdurare daretur locus gratie in mediocri statu. |
VI stato[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (Ia visio, VIa ecclesia)] Unde et congrue vocatur Philadelphia, id est salvans hereditatem, quia in regula evangelica, quasi in archa Noe, salvabitur semen fidei et electorum a diluvio Antichristi tam mistici quam aperti.[LSA, cap. IX, Ap 9, 15 (IIIa visio, VIa tuba)] Nota quod ipsi ex se parati sunt occidere omnes bonos et malos sibi resistentes, non tamen sunt soluti seu permissi duas partes electorum, scilicet maiores et minores, occidere morte ad interitum eternum ducente. Mors enim sanctorum pretiosa est et ad vitam eternam perducens, et ideo debet potius dici vita seu vivificatio; mors autem peccatorum pessima. Dicit enim “tertiam partem” ad innuendum quod non permittentur totam ecclesiam simpliciter extinguere, immo semper remanebit semen pro parte duplici electorum, et in eis ecclesia et cultus Christi semper vivet et continuabitur. |
|
Nota alla Tab. IV.7 |
|
La Chiesa, fino alla fine del mondo, non deve estinguersi. Carlo Magno la difese, dopo le devastazioni saracene, raccogliendone le reliquie a Roma, in occidente (prologo, Notabile V); Filadelfia, la chiesa del sesto stato (corrisponde, per Olivi e Dante, ai tempi moderni), salva, come Noè nell’arca, il seme della fede dal diluvio dell’Anticristo (Ap 2, 1); il seme degli eletti sempre rimarrà (Ap 9, 15). Il principio, per Dante, vale anche per le genti che popolano “l’aiuola che ci fa tanto feroci”. Così fu per le genti antiche apparentemente tutte cadute per la pestilenza inviata da Giunone, alle quali non mancò tuttavia il pasto refettivo, come alla donna nel deserto della Gentilità: “e poi le genti antiche, / secondo che i poeti hanno per fermo, / si ristorar di seme di formiche” (Inf. XXIX, 62-64). I Mirmidoni, con cui Giove ripopolò Egina trasformando le formiche in uomini, salvarono allora il seme umano. Viene in mente José Saramago: “basterà che sopravviva qualche animaletto, qualche insetto, e i mondi ci saranno, quello della formica, quello della cicala, non sposteranno certo tende, non si guarderanno in uno specchio, ma questo che c’entra, in fondo l’unica grande verità è che il mondo non può essere morto” [La zattera di pietra, trad. di R. Desti, Torino 1997, p. 9]. Il pasto eucaristico della donna (la Vergine, ma anche la Chiesa o il corpo mistico di Cristo) è tema del quarto stato (Ap 12, 14), il seme che rimane del quinto (Ap 12, 17).
|
|