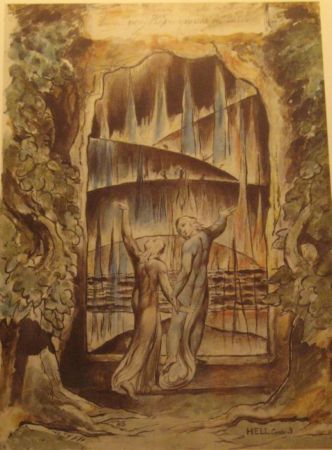La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuoriCanti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXXII, 124-XXXIII, 90
|
Inferno VIII |
Legenda [3]: numero dei versi; 7, 13: collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]; Not. II: collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. Varianti rispetto al testo del Petrocchi.
|
Io dico, seguitando, ch’assai prima
|
Inferno IX, 1-105 |
Quel color che viltà di fuor mi pinse
|
INDICE
1. “Io dico, seguitando, ch’assai prima” (Inf. VIII, 1). 2. La palude del quinto stato. 2a. L’impazienza che non può aspettare: l’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9.11). 2b. Il seme che rimane (Ap 12, 17). 3. L’orgoglio fiorentino. 4. Dite, ovvero l’infuocata Gerusalemme saracena. 5. Due porte aperte. 6. Due appelli al lettore (Inf. IX, 61-63; Purg. VIII, 19-21). Appendice: 1. Variazioni sul tema del vagus. 2. Variazioni su Apocalisse 6, 7-8.
■ Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, Olivi suggerisce, nel prologo della Lectura, un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato sui sette stati (status), cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, prefigurate nell’Antico Testamento.
|
Abbreviazioni e avvertenze
Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.
LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.
Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).
Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.
Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.
In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.
Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.
Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994. Si tiene anche conto della recente edizione a cura di G. INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA.
1. Io dico, seguitando, ch’assai prima
“Io dico, seguitando, ch’assai prima” (Inf. VIII, 1). Contro la narrazione di Boccaccio, secondo la quale Dante avrebbe composto a Firenze i primi sette canti dell’Inferno che poi, casualmente ritrovati in un “quadernuccio” e fattigli pervenire in Lunigiana presso i Malaspina al tempo dell’esilio, avrebbe continuati seguitando con l’ottavo [1], sta il rapporto di parodia che la Commedia ha instaurato con la Lectura super Apocalipsim fin dal primo verso. Questo rapporto non poté stabilirsi a Firenze prima dell’esilio (1302), perché Olivi completò il commento apocalittico poco innanzi la morte a Narbonne nel 1298 e la Lectura arrivò in Italia nei primi anni del Trecento (la prima data certa è il 1305, quando Ubertino da Casale l’aveva con sé scrivendo a La Verna l’Arbor vitae). Dunque Inferno VIII, come i canti precedenti e quelli successivi dell’ipertesto Commedia, è stato scritto elaborando, secondo le norme più volte registrate in questa ricerca, l’ipotesto Lectura. L’esame dei testi mostra tuttavia come, nel corso della stesura del poema, questo rapporto parodico non sia stato sempre omogeneo. Alcune considerazioni sono già state formulate; allo stato attuale della ricerca esse possono così riassumersi:
● La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che semanticamente corrispondono ai sette stati della storia della Chiesa come esposti nella Lectura super Apocalipsim di Olivi.
● L’Inferno registra cinque cicli settenari. Il primo inizia con Inf. IV e si conclude con l’apertura della porta della città di Dite a Inf. IX. A partire dal secondo ciclo, in particolare da Inf. XII (dove prevalgono i temi del secondo stato, ma il ciclo si avvia subito dopo l’apertura della porta), la rete semantica riferibile ciclicamente ai sette stati oliviani è più estesa, organizzata e compatta. Lo è meno nel primo ciclo, dove accanto a blocchi più strutturati, come Inf. V, si registrano versi che non contengono parole-chiave che rinviano alla Lectura (sono riportati in una tabella). Questo fenomeno, non presente nelle cantiche successive, comporta o un’incertezza nel rapporto fra Commedia e Lectura nella prima fase, oppure, più probabilmente, è indice di una prima, parziale stesura estranea a tale rapporto, di una Ur-Commedia della quale restano tracce.
● In Inf. I – II la semantica che rinvia alla Lectura è molto più estesa e sviluppata rispetto, ad esempio, ai canti VI, VII, VIII, XI, per cui è ragionevole pensare che proemio e prologo siano stati scritti quando il rapporto parodico aveva raggiunto la piena maturità. Inf. III e IV, per quanto elaborino tematiche diverse, sono canti speculari, trattando il primo dei pusillanimi (fasciati con l’esegesi di Laodicea, la settima chiesa d’Asia), il secondo dei magnanimi (i quali, nel “nobile castello” figura in terra della Gerusalemme celeste, sono assimilati alla sede divina prima che Cristo apra i sette sigilli). Inf. V, con le sue variazioni su temi del secondo stato (i martiri), si mostra organicamente connesso con il testo parodiato. Non è così per Inf. VI e VII, canti nei quali se ai golosi (VI), agli avari e prodighi (VII, 1-99) e agli iracondi e accidiosi (VII, 100-126) sono appropriati rispettivamente temi del terzo stato (i dottori), del quarto (gli anacoreti o contemplativi, in Inf. VII in concorrenza con il terzo) e del quinto (la rilassatezza della Chiesa), per un numero consistente di versi (in almeno sei terzine per ciascun canto) non sembrano sussistere legami semanticamente strutturati con l’esegesi apocalittica oliviana. Lo stesso si può dire per i due canti successivi, Inf. VIII-IX. Nel primo risuonano ancora estesamente i temi del quinto stato (palude Stigia, con un intermezzo di motivi del quarto stato per gli orgogliosi, figurati da Filippo Argenti); a partire dal v. 68 vengono parodiati, nella descrizione della città di Dite, i temi propri della Gerusalemme celeste oggetto della settima visione apocalittica, motivi che si sono già insinuati nei versi relativi al “nobile castello” del Limbo (Inf. IV, 106-111). In Inf. IX vengono riproposti temi del quinto stato e della settima visione; crescono i motivi del sesto stato, che toccano l’acme con l’apertura della porta di Dite da parte del messo celeste (vv. 61-90). Sia nell’ottavo come nel nono canto, al modo dei due precedenti, si registra un certo numero di versi che sembrano non connessi semanticamente alla Lectura.
Con l’ingresso, attraverso la porta aperta, nel sesto cerchio degli eretici inizia il secondo ciclo settenario dell’Inferno (che perviene fino alla salita di Gerione dall’abisso comprendendo gli usurai; con il volo in groppa alla “fiera con la coda aguzza” inizia il terzo ciclo a Inf. XVII, 82). L’avvio del secondo ciclo si estende per tutto Inferno X, canto ermetico per eccellenza che, a differenza dei quattro canti che precedono, elabora con grande maturità la tematica offerta dalla Lectura, come si registra in Inf. I e II. Con Inf. XI si registrano nuovamente lacune nel rapporto tra poema ed esegesi; nel canto Virgilio ordina l’inferno non secondo i sette peccati capitali (come avviene per la montagna del purgatorio), ma secondo l’immagine del “libro scritto dentro e fuori, segnato con sette sigilli” (Ap 5, 1), distinguendo appunto quattro specie di dannati posti fuori della città di Dite (lussuriosi, golosi, avari e prodighi, gli immersi nella palude Stigia) e tre “cerchietti” dentro (violenti, fraudolenti contro chi non si fida e contro chi si fida). Un ordine che lascia fuori gli ignavi, il Limbo e gli eretici.
● Il “quadernuccio” fiorentino del quale parla Boccaccio non conteneva i primi sette canti dell’Inferno nella forma in cui ci sono pervenuti. Infatti, “forma e contenuto dei primi sette canti, cioè il loro aspetto stilistico e narrativo strettamente omogeneo ai seguenti e del tutto nuovo, e soprattutto l’idea centrale etica, politica e religiosa che li guida e che già contiene tutto il poema, non possono in alcun modo immaginarsi prima dell’esilio e prima del Convivio” [2]. D’altronde lo stesso Boccaccio, nelle Esposizioni, nota dubbioso l’impossibilità che il sesto canto, con la profezia di Ciacco, sia stato scritto prima delle condanne dei Bianchi del gennaio-ottobre 1302 con il conseguente esilio (episodio che, d’altronde, risponde semanticamente alla Lectura). La narrazione non è però del tutto inventata. Si può infatti supporre che il “quadernuccio” contenesse abbozzi stesi a Firenze prima dell’esilio, quando Dante non poteva conoscere la Lectura oliviana e che, una volta scelta questa come canovaccio del poema, furono inseriti nelle sue maglie semantiche, lasciando però nei primi undici canti alcuni versi per i quali la “gonna” non venne cucita sul “panno” esegetico (cfr. Par. XXXII, 139-141). La scoperta della Lectura oliviana diede a Dante “l’idea centrale etica, politica e religiosa … che già contiene tutto il poema” e ai primi sette canti “il loro aspetto stilistico e narrativo strettamente omogeneo ai seguenti e del tutto nuovo” [3], non però del tutto omogeneo per organica rispondenza al testo parodiato. Se mai una prima stesura esistette in questa forma, essa fu redatta in volgare; non è in alcun modo verificabile la notizia, data dall’epistola di Ilaro, che Dante avesse concepito inizialmente il suo poema in latino, né è pensabile che le parti dei primi undici canti non connesse semanticamente con la Lectura siano il risultato di una traduzione dal latino. Boccaccio afferma che il “quadernuccio” venne recapitato a Dante presso i Malaspina; ciò poté avvenire negli anni 1307-1308, quando il poeta si trovava presso Moroello, allorché, per il probabile tramite di Ubertino da Casale, ricevette anche la Lectura super Apocalipsim di Olivi.
● La narrazione di Boccaccio, per essere in parte vera, presuppone una riscrittura. Certamente, senza riscontri precisi, “ogni verso può appartenere alla ‘riscrittura’”, togliendo alla notizia “qualsiasi ricaduta critica” [4]. Ma il confronto dell’ipertesto Commedia con l’ipotesto Lectura mostra come la ‘scrittura’, operata semanticamente sull’esegesi oliviana, abbia lasciato parti non scritte in tal modo. I versi conclusivi di Inf. VII (vv. 127-130) e quelli iniziali di Inf. VIII (vv. 1-6) non sembrano rispondere a parti dell’esegesi apocalittica. I primi sono preceduti, nel passaggio dal quarto cerchio degli avari e prodighi al quinto della palude Stigia, da versi dove sono incardinate numerose parole-chiave riferibili al quinto stato, temi che vengono ripresi a partire da Inf. VIII, 10. La terzina precedente, nei versi 8-9: “Questo che dice? e che risponde / quell’ altro foco? e chi son quei che ’l fenno?”, rinvia ad Ap 7, 13, i cui motivi, veri e propri Leitmotive nella polifonia di un’opera polisemica, sono stati già inseriti nei canti precedenti (Inf. II, 18; III, 32-33.71-73; IV, 31-32.46.74; V, 50-51.112; VII, 37-38). Nell’intensa elaborazione della Lectura, qualcosa è stato lasciato fuori, e non può trattarsi che di una stesura o abbozzo precedente. Così è avvenuto per i versi conclusivi di Inf. VII e quelli iniziali di Inf. VIII, incastonati, con la narrazione che in quest’ultimo canto torna indietro rispetto alla conclusione del precedente, fra terzine che estesamente rinviano all’esegesi oliviana. Naturalmente non sappiamo se anche i versi collegati alla Lectura abbiano avuto una precedente stesura, tuttavia non si puo negare un’evidente differenza stilistica tra i versi finali di Inf. VII (127-130) e, ad esempio, la similitudine di Inf. V, 82-87 che registra quel collegamento.
●Accertata l’esistenza a partire da Inf. III e fino a Inf. XI, con l’eccezione del quinto e del decimo canto, di versi non connessi semanticamente alla Lectura, con la conseguenza che questi furono scritti prima dell’inizio della sistematica parodia dell’opera di Olivi, che non li riguardò, ci si può chiedere perché in principio di Inf. VIII la narrazione torni indietro – “Io dico, seguitando, ch’assai prima” -, punto rilevato da Boccaccio per giustificare la giunzione con i primi sette canti recapitati a Dante nel “quadernuccio”. La giunzione presuppone una cesura, per cui una spiegazione potrebbe essere che Dante avesse già fatto circolare Inf. VII (insieme al canto VI, che gli è strettamente omogeneo); al momento di proseguire, non potendo più modificare il verso finale [5] – “Venimmo al piè d’una torre al da sezzo” (si tratta già delle mura della città di Dite?) – e volendo inserire, prima di descrivere l’effettivo arrivo a Dite e alle sue torri (le “mischite”), il percorso lungo la “morta gora” sulla barca di Flegiàs, con l’episodio di Filippo Argenti (“persona orgogliosa”, esempio di superbia punita, peccato al quale non è dedicata una precisa zona nell’inferno), il poeta tornando indietro con la narrazione abbia creato lo spazio per tali inserimenti.
[1] G. BOCCACCIO, Trattatello in laude di Dante, ed. M. Fiorilla, Roma 2017, I red. §§ 179-182; II red. §§ 117-120.
[2] A. M. CHIAVACCI LEONARDI, Inferno. Commento, Milano 2007, p. 265.
[3] Ibid.
[4] Così G. INGLESE, Vita di Dante. Una biografia possibile, Roma 2015, p. 97.
[5] Così sostiene G. PADOAN, Il lungo cammino del “poema sacro”. Studi danteschi, Firenze 1993 (Biblioteca dell’“Archivum Romanicum”, Ser. I, vol. 250), pp. 39-44.
2. La palude del quinto stato
■ Dopo aver individuato mentalmente, nei primi due canti dell’Inferno, sinfonia dell’intera opera, numerosi temi che davano “e piedi e mano” all’esegesi escatologica della Lectura, il lettore spirituale non avrebbe mancato di ritrovare, percorrendo la selva dei motivi intrecciati, nel terzo canto quelli propri della tiepida Laodicea, la settima chiesa d’Asia, applicati ai pusillanimi e di scorgere in Caronte la parodia, tragica e dissonante, delle prerogative di Cristo sommo pastore premesse alla prima visione apocalittica. Entrato poi nel primo cerchio dell’abisso, leggendo nei versi le parole-chiave che con ars memorandi lo conducevano al testo dottrinale in latino da lui ben conosciuto, avrebbe scorto nel “nobile castello” del Limbo la versione terrestre della Gerusalemme superna e negli “spiriti magni” gli assistenti di Colui che siede sul trono, il sapientissimo con in mano il libro ancora chiuso, prima che Cristo apra i sette sigilli. Quel lettore si sarebbe reso conto che il viaggio di Dante aveva un andamento per settenari, per zone (non del tutto coincidenti con le divisioni materiali) corrispondenti ai sette stati o periodi della storia della Chiesa come esposti e organizzati nella Lectura oliviana. Con una differenza sostanziale, perché nei versi la parodia aggiornava l’esegesi tanto da attribuire ai classici, in primo luogo a Virgilio e ad Aristotele, una sacralità che nel commento apocalittico appartiene solo della Chiesa e all’Ordine dei Minori. Nel secondo cerchio, dei lussuriosi, dopo il primo, apostolico stato di fondazione della Chiesa, avrebbe trovato temi del secondo stato (i martiri), leggendo della gentilità fluttuante come il mare in tempesta, del moderno martirio psicologico che inganna con false scritture, del volto di Cristo interpretato in modo carnale; avrebbe anche riconosciuto l’invito dello Spirito a convivare, a venire e parlare con desiderio e volontario consenso, in una pausa di pace nell’eterna dannazione. Al terzo cerchio, dei golosi, gli sarebbero risuonati i temi del terzo stato, dei dottori che combattono le eresie nella Chiesa con la spada della ragione, perché eresie erano le divisioni di Firenze, la “città partita” e da “tanta discordia assalita” della quale parla Ciacco. Gli avari e prodighi del cerchio successivo, il quarto, sarebbero apparsi fasciati dai temi, applicati in registro dissonante, del quarto stato proprio degli anacoreti o contemplativi, concorrenti con il terzo come intelletto e affetto, ragione e vita, spada e pasto eucaristico; anche nella Fortuna “general ministra”, così come la descrive Virgilio, si potevano ritrovare le prerogative del vescovo di Tiatira, la quarta chiesa d’Asia.
■ Il passaggio alla palude Stigia (Inf. VII, 97) introduce i temi del quinto stato della Chiesa. Storicamente iniziato a partire dall’aiuto recato da Carlo Magno o da suo padre Pipino alla Chiesa romana, questo periodo dura almeno fino alla conversione di san Francesco (1206) che apre il sesto stato, ma questo, quasi cent’anni dopo quando Olivi scriveva la Lectura (completata al più tardi nel 1298), concorreva ancora con il quinto. Di una bellezza stellare nei suoi princìpi, fiorente di regole monastiche e canoniali, aperto alla vita associata delle moltitudini dopo l’austera e a lungo insostenibile solitudine degli anacoreti del precedente periodo, il quinto stato è poi caduto in rovina per rilassatezza, tanto che la Chiesa si è trasformata quasi in una nuova Babilonia: “a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta” (prologo, Notabile VII: il tema sarà applicato al simoniaco Niccolò III).
Dei temi del quinto stato, del quale è propria la “condescensio”, fanno segno gli iracondi e gli accidiosi. Discendono i due poeti (Inf. VII, 97), discende in Stige il “tristo ruscel” (vv. 106-108). Virgilio e Dante vanno giù “in compagnia de l’onde bige” (vv. 104-105); ripetono il tema della quinta vittoria (Ap 3, 5), per cui si discende agli infermi senza assumere macchie o imperfezioni, vivendo tra i carnali, i rilassati e gli immondi in modo puro, immacolato e santo come se ci si trovasse in solitudine o in mezzo a gente austera e perfetta. Il tema viene cantato da Virgilio prima di discendere nella barca di Flegiàs: “più non ci avrai che sol passando il loto” (Inf. VIII, 19-21, 25). Tutto il viaggio all’inferno è uno stare mescolati coi reprobi, ovvero un correre con essi, come avviene in questa vita: “corpus reproborum continue in hac vita currit quasi commixtum et confligens cum corpore seu collegio electorum” (prologo, Notabile II). Di qui il verso: “Mentre noi corravam la morta gora” (Inf. VIII, 31; è da escludere la variante passavam di Urb). Oppure l’andata in “fiera compagnia” dei dieci demoni dalla non buona sembianza che scortano Dante e Virgilio verso un passaggio alla sesta bolgia che non esiste (Inf. XXII, 13-15). Nella sesta bolgia, dov’è il “collegio” degli ipocriti, i due poeti ‘corrono’ “per l’aura fosca”, ma poi procedono secondo il passo lento dei dannati gravati dalle cappe (Inf. XXIII, 80-81).
La triste accidia rende chiuso il quinto sigillo (Ap 5, 1), alla cui apertura i santi stanno protetti sotto l’altare di Dio (Ap 6, 9.11); al suono della quinta tromba dal pozzo dell’abisso esce fumo che annerisce l’aria e il sole (Ap 9, 1-2): gli accidiosi, che vissero “portando dentro accidïoso fummo”, stanno “sotto l’acqua” (Inf. VII, 118, 121-124; le variazioni sui temi del quinto sigillo – “subtus altare Dei” – raggiungeranno l’acme con i barattieri). Dal fumo salgono le pungenti locuste, irate per offese, con denti corrosivi della fama altrui (Ap 9, 3.5.8): gli iracondi stanno “con sembiante offeso … troncandosi co’ denti a brano a brano” (vv. 111, 114; con i motivi delle locuste saranno fregiati i Capetingi). Al versamento della quinta coppa, sulla tenebrosa sede della bestia, i carnali si mangiano le lingue per il dolore, “quia intra se pre livore invidie tabescunt et se ipsos ac sui gaudii quietum saporem omnino destruunt et corrodunt” (Ap 16, 10-11): i tristi fitti nel limo dello Stige “si gorgoglian ne la strozza, / ché dir nol posson con parola integra” (Inf. VII, 125-126; il riferimento all’esegesi mostra come la tristitia comprenda sia l’accidia come l’invidia). Il nocchiero della palude Stigia, Flegiàs, esprime anch’egli, “ne l’ira accolta”, il tema della corrosione interiore (Inf. VIII, 22-24). Filippo Argenti, l’orgoglioso fiorentino, “in sé medesmo si volvea co’ denti” (v. 63).
■ Uno dei temi principali del quinto stato è l’attendere (quinto sigillo, Ap 6, 9-11): insofferenti dei mali che pervadono la Chiesa, i santi chiedono a Dio con alte grida immediata vendetta, ma ad essi viene detto di aspettare ancora per poco, in vista del grande terremoto con il quale, all’apertura del sesto sigillo, verrà distrutta la Chiesa carnale. Nel “fummo del pantan” (quinta tromba, Ap 9, 2) “s’aspetta” la barca di Flegiàs (vv. 11-12); Virgilio dice a Dante di aspettare mentre va a parlare coi diavoli (“ma qui m’attendi”, v. 106), ed è attesa breve (v. 113: “ma ei non stette là con essi guari”).
Il tema del santo desiderio di vendetta che chiama contro i malvagi e che non soffre altra attesa risuona più volte nel poema. Il grande desiderio di Dante di vedere Filippo Argenti attuffato nella broda dello Stige viene soddisfatto mentre tutti gridano “A Filippo Argenti!” (Inf. VIII, 52-63). In principio del canto successivo, a Virgilio tarda l’arrivo del messo celeste che faccia vendetta dei diavoli che hanno chiuso le porte della città di Dite (Inf. IX, 9). La sentenza di maledizione, cioè la durezza dei precetti e dei giudizi della vecchia legge, comminata contro quanti non ne hanno rispettato la lettera in tutte le sue parole, è motivo della chiusura del quinto sigillo (ad Ap 5, 1); risuona in Filippo Argenti, “spirito maladetto” (Inf. VIII, 38) e nelle “parole maladette” dette dai diavoli contro Dante (v. 95). All’opposto sono le parole di Virgilio verso il discepolo, unico seme rimasto della Chiesa: “benedetta colei che ’n te s’incinse!” (v. 45).
Il tema dell’attendere è congiunto con quello del rimanere, dall’esegesi della quinta guerra, che il diavolo conduce contro il seme della donna, sola reliquia rimasta di una Chiesa limitata all’Occidente per le devastazioni saracene (Ap 12, 17; il verbo è variamente appropriato: rimango, ti rimani, rimarrai, rimase, Inf. VIII, 34, 38, 92, 116; Virgilio e Dante, uniche reliquie della Chiesa, rimangono ‘soli’ di fronte ai diavoli: vv. 89, 91).
L’attesa, sia pur per breve tempo, è angosciosa, per quanto confortata da Virgilio con i temi propri di Smirne, la chiesa dei martiri, seconda delle sette d’Asia (Ap 2, 8.10; Inf. VIII, 103-108). Al suono della quinta tromba, tolto il freno che lo teneva chiuso, dal fumoso pozzo dell’abisso (Ap 9, 1-2) escono le locuste a guisa di scorpioni: “brachiis ad amplexandum expansis, sed cauda retro pungit” (Ap 9, 3; Filippo Argenti “distese al legno ambo le mani”, Inf. VIII, 40). Il grave dolore e il cruccio provocato dalla loro puntura insinua dubbi nella fede, che inducono il timore di errare in qualsivoglia parte, vera o falsa, e che suscitano mestizia e costernazione nel vedere tanti mali, fino al tedio della vita e al desiderio di morire (Ap 9, 5-6). Ma il loro nuocere durerà per breve tempo, “cinque mesi”, al termine dei quali, come dice l’Apostolo a Timoteo, la loro insipienza sarà manifesta (2 Tm 3, 9).
Il dubbio assale Dante, lasciato solo da Virgilio recatosi a parlare con i diavoli custodi della città di Dite (“… e io rimagno in forse, / che sì e no nel capo mi tenciona”, Inf. VIII, 110-111), dubbi che persistono al ritorno di Virgilio sconfitto, confermati dalla “parola tronca” della guida – “Pur a noi converrà vincer la punga / … se non …” -, quasi a vacillare sia lo stesso Virgilio (Inf. IX, 7-9). Il “se non” – “sin autem” nell’esegesi scritturale – traduce uno stato d’animo di costernazione, corrispondendo la situazione dei due poeti a quella degli Israeliti nella tribolazione di Oloferne, quando essi decisero che se entro cinque giorni (i cinque mesi dell’Apocalisse) non fosse arrivato l’aiuto divino, si sarebbero consegnati ad Oloferne. L’arrivo di Giuditta (Jdt 7, 23-25) corrisponde alla discesa del messo celeste che apre la porta della città di Dite. Si tratta dunque del dubbio da cui vengono assaliti nella fase estrema del quinto stato quanti provano la puntura delle locuste. L’angosciosa attesa da parte delle reliquie della Chiesa che rimangono nel quinto stato – “Oh quanto tarda a me ch’altri qui giunga!”, afferma Virgilio a Inf. IX, 9 – è per l’arrivo del messo celeste che aprirà la porta di Dite: corrisponde al sesto stato, al quale è data la porta aperta.
Tab. I
2a. L’impazienza che non può aspettare: l’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9.11).
Il chiamare dei santi martiri affinché la giustizia divina vendichi il loro sangue viene considerato in più punti da collazionare (Ap 5, 1 si riferisce al difetto che rende chiuso il quinto sigillo; Ap 6, 9-11 ai mali presenti nella Chiesa all’inizio e alla fine del quinto stato). Da tutti questi passi si deduce che all’apertura del quinto sigillo i santi, rattristati fino alla disperazione per i mali che invadono la Chiesa, chiedono a gran voce che venga fatta sùbita vendetta contro i carnali del quinto tempo che dispregiano Cristo e i suoi. Con grande desiderio gridano a Dio: “Fino a quando, Signore, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?”. Nel “fino a quando” sta la loro insofferenza ad attendere ancora una vendetta rinviata e che la giustizia divina non può ulteriormente procrastinare. Poiché santo, Dio non può non odiare l’iniquità, e in quanto vero non può non mettere in pratica i mali minacciati e i beni promessi. Tuttavia ai santi del quinto stato viene detto di quietarsi e di aspettare le cose grandi che avverranno all’apertura del sesto sigillo, quando saranno rivelati segreti fino allora chiusi e si rinnoveranno i gloriosi martìri in modo che il numero degli eletti venga completato.
■ Il tema del santo desiderio di vendetta che chiama contro i malvagi e che non soffre altra attesa risuona più volte nel poema. Il grande desiderio di Dante di vedere Filippo Argenti attuffato nella broda dello Stige viene soddisfatto mentre tutti gridano “A Filippo Argenti!” (Inf. VIII, 52-63). In principio del canto successivo, a Virgilio tarda l’arrivo del messo celeste che faccia vendetta dei diavoli che hanno chiuso le porte della città di Dite (Inf. IX, 9).
■I Malebranche non sono estranei a tale sentimento. Chinano i loro uncini sul poeta per accoccargli un colpo sul groppone, ma vengono trattenuti da Malacoda (Inf. XXI, 100-105). I “maladetti” invitano Rubicante a scuoiare lo sciagurato Ciampolo, ma vengono fermati da Barbariccia affinché Virgilio possa domandare per conto di Dante. Poco dopo, però, Libicocco, ritenendo di aver atteso troppo – “troppo avem sofferto” – gli porta via con l’uncino un brandello di braccio (Inf. XXII, 40-42, 70-72; il maledire appartiene alla tematica del quinto sigillo, ad Ap 5, 1: la sentenza di maledizione nei confronti di chi non rispetta la vecchia legge rende chiuso il sigillo, che viene invece aperto dalla “pietas indulgens” di Cristo come di una madre verso il figlio). Il conte Ugolino chiama due volte i figli morti e il desiderio del poeta che Pisa venga punita si sfoga nell’invettiva che succede all’episodio (Inf. XXXIII, 74, 79-84; in questo caso, il chiamare e l’esigere vendetta coincidono con i motivi analoghi contenuti nell’esegesi della sesta tromba, ad Ap 9, 13).
■ Il tema compare ben tre volte fra gli avari e i prodighi del purgatorio, in una zona (il quinto girone) che principalmente si riferisce al quinto stato. La prima volta è il poeta a maledire l’antica lupa e a interrogare il cielo circa il momento dell’arrivo del Veltro (Purg. XX, 10-15). La seconda volta è Ugo Capeto a chiedere sùbita vendetta a colui che tutto giudica a nome di Douai, Lille, Gand, Bruges vessate da Filippo il Bello (vv. 46-48), come i santi del quinto stato dai quali “expetitur instanter et alte iusta vindicta”. Ancora Ugo Capeto si rivolge a Dio chiedendogli quando potrà godere la gioia di vedere attuata la vendetta per ora nascosta nel suo segreto, chiusa cioè fino a quando, nel sesto stato, verrà il giudizio di Babylon (vv. 94-96). Terminato l’episodio di Ugo Capeto, un terremoto scuote la montagna: si tratta di un’allusione al terremoto con cui si apre il sesto sigillo (vv. 127-141). Allo stesso gruppo tematico appartiene l’accenno di Stazio alla vendetta della passione di Cristo compiuta dal “buon Tito” con la distruzione di Gerusalemme (Purg. XXI, 82-84): il senso letterale è un dato autobiografico di Stazio, quello spirituale un’allusione alla caduta della nuova Babilonia preceduta dal ricordato terremoto, prefigurato dalla fine della vecchia Sinagoga (cfr. prologo, Notabile XI).
■ Il tema viene usato ancora nell’apostrofe alla “serva Italia” di Purg. VI, con il rivolgersi al “sommo Giove” crocifisso in terra per chiedergli se rivolga altrove i suoi giusti occhi (vv. 118-123). Un ulteriore passo che può essere accostato agli altri è ad Ap 2, 23 (prima visione, quarta chiesa), dove si fa riferimento al fatto che Dio, i cui occhi di fuoco vedono e penetrano tutto, talvolta non punisce i peccatori secondo quanto giustizia esige, e allora sembra ignorare i mali.
■ L’episodio di Traiano e della vedovella, scolpito nel marmo del primo girone del purgatorio (Purg. X, 73-93), raffigura la misera madre che chiede vendetta per la morte del proprio figlio, e che avvenga presto, “come persona in cui dolor s’affretta”. La vedovella chiama l’imperatore “Segnor mio”, come Ugo Capeto che si rivolge a Dio perché punisca il suo sangue (Purg. XX, 94). La vedovella “li era al freno”, che è tema della quinta tromba (Purg. X, 77; Ap 9, 1-2), dove designa la rigida e severa disciplina verso i sudditi applicata dai prelati del principio ‘bello’ del quinto tempo. Traiano le risponde di aspettare il suo ritorno, che è quanto viene detto ai santi del quinto stato desiderosi di vendetta. Alla fine Traiano decide di compiere il proprio dovere prima di partire, perché “giustizia vuole e pietà mi ritene”, dove l’esigenza di giustizia fa parte dei temi proposti ad Ap 6, 9-11 (“cum iustitia tua exigat”) e la pietà è tema proprio del quinto stato (Ap 5, 1). Anche l’espressione “Or ti conforta” (v. 91) appartiene al gruppo, essendo riferita nel quinto sigillo alla Chiesa romana, “confortata” da Dio nel suo vigore presso i latini del quinto stato (Ap 6, 11). Traiano, che pietoso rende giustizia alla vedovella, è il modello di quello che dovrebbe fare e non fa Alberto tedesco, il quale (Purg. VI, 97ss.) non viene a vedere la sua Roma “che piagne vedova e sola” come la madre privata del figlio dinanzi al suo glorioso predecessore nel “roman principato”. La diffusissima leggenda, che Dante aveva certo presente, mostra dunque una armatura spirituale ed escatologica.
■ Chi non ha aspettato, è stato Cesare indotto dallo scismatico Curione, il quale sta nella nona bolgia “con la lingua tagliata ne la strozza”. Vorrebbe non aver mai visto la terra di Rimini dove, scacciato da Roma, spense il dubbio di Cesare se passare o no il Rubicone, affermando che il differire sempre nuoce a chi è pronto (Inf. XXVIII, 97-102). L’episodio deriva da Lucano – “tolle moras; semper nocuit differre paratis … affermando che ’l fornito / sempre con danno l’attender sofferse” -, ma la Pharsalia (I, 269, 280-281) concorda con la Lectura super Apocalipsim. L’attendere, tema che si oppone al “fornito”, deriva appunto dall’esegesi del quinto sigillo (Ap 6, 9.11), alla cui apertura viene espresso il desiderio dei santi di vedere vendicati i mali della Chiesa: perché differire la vendetta divina? Ai santi viene risposto che l’esecuzione della giustizia divina deve attendere fino al momento in cui sia raggiunto il numero di eletti prestabilito. I tre motivi addotti per attendere gli altri eletti – essere tutti conservi dello stesso Signore, la mutua fraternità dallo stesso Padre, la conformità nel martirio – bene si adattano a un caso di guerra civile.
L’attendere, al quale ha rinunciato Traiano, è speculare a quello di Cesare, con effetti però diversi quanto alle cause della rimozione. Nel primo caso è la vedovella che chiede giustizia, nel secondo Curione che spinge Cesare alla guerra civile, cioè allo scisma ereticale, e come tale è punito. Ciò anche se le parole dello scismatico sono servite agli occulti giudizi divini, che ha voluto le folgoranti imprese sotto il vittorioso e reverendo segno dell’aquila, quando “Cesare per voler di Roma il tolle” (Par. VI, 57).
■ “Quella sinistra riva … per suo segnore a tempo m’aspettava … E la bella Trinacria … attesi avrebbe li suoi regi ancora …” (Par. VIII, 58-71). Nelle parole di Carlo Martello, l’attendere dei “popoli suggetti”, infranto dal terremoto in apertura del sesto sigillo, è tema dall’ampio sviluppo, proprio dell’apertura del sigillo precedente, il quinto, ove si dice a quanti desiderano ardentemente la vendetta di Dio sui reprobi di aspettare il completarsi del numero degli eletti e le grandi cose che si compiranno nella sesta apertura. Il Vespro siciliano è stato anch’esso un non attendere, determinato dalla “mala segnoria” angioina, con l’effetto dell’irreparabile scisma della Sicilia dal resto d’Italia. Di questa scissione è antica prefigurazione “l’alpestro monte ond’ è tronco Peloro”, di cui dice Guido del Duca a Purg. XIV, 32. “Troncare” non è verbo casuale. Appartiene ai suicidi incarcerati nella mesta selva, che hanno diviso l’anima dal corpo, come ai seminatori di scandalo e scisma. È tema tipico del terzo stato della Chiesa, allorché i dottori con la spada della ragione spezzano le eresie che dividono la Chiesa. Una tematica che topograficamente nell’Inferno si ritrova con Ciacco e Pier della Vigna, Niccolò III, Curione e i suoi compagni di pena, Lucifero che maciulla i sommi traditori, Giuda, Bruto e Cassio: da Firenze, “città partita”, alla divisione di sé stessi, allo strazio della Chiesa, agli scismi fino ai traditori di Cristo e del “voler di Roma”. L’espressione “se mala segnoria, che sempre accora / li popoli suggetti” richiama “ond’io m’accoro” detto dalla vedova a Traiano, esempio di ‘buona signoria’ nel rinunciare ad attendere per far vendetta, mentre l’ingiusto dominio angioino ha reso vano l’attendere della discendenza del giusto Carlo Martello vissuto, come Cristo, per poco tempo (Par. VIII, 49-51).
■ È da notare che il tema del confortare, unito con quello dell’attendere, compare in luoghi percorsi da altri motivi del quinto stato. Virgilio dice a Dante di attenderlo mentre parla con gli ostinati diavoli custodi della città di Dite e di confortare di buona speranza “lo spirito lasso” (il quinto stato è per antonomasia rilassato nel suo declinare), che qui significa affranto per la paura insinuata dalle “parole maladette” che l’avevano sconfortato (Inf. VIII, 106-108). Si tratta di un’attesa breve, come quella proposta ai santi all’apertura del quinto sigillo – “non multo tempore, sed modico, volo vos expectare … Ma qui m’attendi … ma ei non stette là con essi guari” (Inf. VIII, 106, 113). Poco è il tempo che si deve aspettare per vedere esaudito il desiderio che Firenze sia punita (Inf. XXVI, 7-12). Ugo Capeto parla di sé non per il conforto che attende da quanti sono ancora in vita (di preghiere o di fama), ma perché vede rilucere tanta grazia in Dante (Purg. XX, 40-42).
■ Un esempio di clamore perché si attui la vendetta contro la corruzione della Chiesa è nel “grido di sì alto suono” emesso dalle fiammelle che nel cielo di Saturno discendono la scala d’oro per confermare l’invettiva di Pier Damiani contro i moderni pastori. In quel grido, non inteso da Dante, è contenuta una preghiera di vendetta la quale – così gli dice Beatrice “come madre che soccorre / sùbito al figlio palido e anelo / con la sua voce, che ’l suol ben disporre” – il poeta vedrà prima di morire (Par. XXI, 136-142; XXII, 1-18; cfr. Ap 5, 1). E san Pietro è l’ultimo nel poema ad invocare su Caorsini e Guasconi una punizione di Dio che non sembra arrivare. Nei versi (Par. XXVII, 57-60) sono cuciti due temi: il primo è la richiesta a Dio perché giudichi i malvagi, il secondo è quello del buon principio caduto a vile fine (cfr. prologo, Notabile V), secondo l’interpretazione (“principium pulchritudinis”) data al nome della quinta chiesa, Sardi.
■ È da notare infine come la sublimazione dell’attendere sia la speranza, di cui tanto bene parla Dante di fronte a san Giacomo, suo apostolo eponimo, a Par. XXV, 67ss. – «“Spene”, diss’ io, “è uno attender certo / de la gloria futura» – in un contesto pregno di signacula che rinviano la memoria del lettore spirituale all’esegesi oliviana dell’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9-11).
Tab. II
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (IIa visio, Vum sigillum)] In quinta autem (apertione), contra torporem accidie et otii quinti temporis, quod est sentina luxurie et omnis iniquitatis, clamant sancti martires eorum sanguinem, id est penales labores et dolores usque ad mortem, vindicari in illos. […]
|
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 9-11 (IIa visio, apertio Vi sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum quintum, vidi” et cetera. Ea que hic dicuntur possunt referri ad initium quinti status vel ad eius medium vel ad eius extremum. In initio enim eius visa est ecclesia quasi tota deficere, ac si novissimum iudicium huius seculi advenisset. Propter etiam scelera hereticorum et ypocritarum et scismaticorum et apostatantium ad sarracenicam sectam et ceterorum infidelium, videbatur martirium et labor primorum sanctorum vehementer exigere et expetere extremum iudicium dampnationis dari contra reprobos, post tanta sanctorum certamina et testimonia et exempla nolentes Christum et ipsos sequi. […]
|
[Ap 6, 9-11] Referendo vero predicta ad finem quinti status, designatur quod tunc tot et tanta scelera in carnali ecclesia inundabunt, et iam diu est inundare ceperunt, quod tam sancti preteriti quam presentes, ex tanta malorum inundantia fere usque ad desperationem contristati, cum grandi clamore expetunt et adhuc amplius expetent iudicium fieri pro ipsis et contra reprobos. Designatur etiam quod tunc a multis erat putan-dum finem mundi adesse, propter tantam inundantiam malorum et tan-tam paucitatem bonorum.
|
[Ap 5, 1; IIa visio, Vum sigillum] Tertia ratio septem sigillorum quoad librum Veteris Testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. […] Quintum est severitas preceptorum et iudiciorum, quia precipit “non concupisces” et “diliges Deum ex toto corde” (Dt 5, 21; 6, 5), et multa alia infirmitati humani generis ex se impossibilia, et tamen dat sententiam maledictionis omnibus qui non permanserint in omnibus verbis legis. Hanc autem temperat et exponit condescensiva Christi pietas indulgens multa infirmitatibus nostris, sicut mater infantulo suo. Et hoc notatur in quinta apertione, cum expetentibus iustitiam respondetur “ut requiescerent adhuc” per “tempus modicum, donec compleantur conservi eorum et fratres” (Ap 6, 11), id est ut propter pietatem fraterne salutis patienter differant et prolongent iudicia ultionis. |
|
Purg. VI, 112-114, 118-123Vieni a veder la tua Roma che piagne
|
Inf. XXI, 100-102; XXII, 31-33, 40-42, 70-72Ei chinavan li raffi e “Vuo’ che ’l tocchi”,
|
Tab. II bis
[LSA, cap. VI, Ap 6, 9 (IIa visio, apertio Vi sigilli)] Quia vero sufficiens numerus electorum, secundum eternam Dei predestinationem et secundum Christi redemptoris condignam honorificentiam et secundum congruentiam consumationis civitatis celestis et secundum promissionem factam patribus de plena reductione Israelis ad Christum, nondum erat completus, sufficiebatque interim sanctis animabus gloria ipsarum ante resumptionem et glorificationem suorum corporum eis dat<a>, ideo primo premittitur primus ordo iustitie, cum dicitur: “vidi subtus altare Dei” et cetera (Ap 6, 9). Secundo responditur executionem predicte iustitie debere differri propter complendum numerum electorum et quia interim sufficit sanctis glorificatio animarum suarum, ibi: “Et date sunt illis” et cetera (Ap 6, 11). |
||
Par. XXV, 67-69, 91-96, 124-129“Spene”, diss’ io, “è uno attender certo
|
||
Inf. VIII, 106-108, 112-114“Ma qui m’attendi, e lo spirito lasso
|
[Ap 6, 10] “Et clamabant voce magna” (Ap 6, 10), id est eorum martiria evidentissime et vehementissime, secundum ordinem iustitie, apud Deum exigebant dampnationem malo-rum nolentium eos sequi; vel, secundum ab-solutum ordinem divine iustitie, magno voto et desiderio hoc expetebant; “dicentes: Usquequo, Domine, sanctus et verus non iudicas et vindicas sanguinem nostrum de hiis qui habitant in terra?”, scilicet non solum per corporalem mansionem, sed etiam per terre-num amorem.
[Ap 6, 11] Deinde subduntur duo propter que iudicium hoc debet convenienter differri ad tempus.
Primum est sufficiens glorificatio animarum sanctarum, unde subdit (Ap 6, 11): “Et date sunt illis singule stole albe”. Duas quidem stolas albas, id est glorias et quasi vestes gloriosas, sunt habiture, quarum prima et principalissima est in anima, secunda vero erit in earum corpore. De prima ergo loquitur hic.
Secundum est numerus sanctorum martirum et electorum adhuc complendus et nondum completus. Unde subdit: “Et dictum est illis ut requiescerent”, scilicet in gloria preaccepta, “tempus adhuc modicum”, quasi dicat: non multo tempore, sed modico, volo vos expectare hoc iudicium, nec cum aliquo labore vestri, sed cum pura requie et pace quam dedi vobis, “donec impleantur”, id est ad plenum compleantur, “conservi eorum et fratres <eorum>, qui interficiendi sunt sicut et illi”.
Preter rationem sumptam ex completione numeri, tangit tria propter que gratanter debent hoc spectare.
Primum est honorificentia summi Domini ut habe<at> plures servos, et etiam coequalitas horum et illorum in servitute Dei, unde dicit quod sunt “conservi eorum”, id est simul cum eis servi eiusdem Domini.
Secundum est mutua confraternitas respectu eiusdem patris, unde dicit: “et fratres eorum”.
Tertium est martirii conformitas; “sunt” enim “interficiendi sicut et illi” qui precesserunt.
Inf. XVI, 13-15, 121-123
A le lor grida il mio dottor s’attese;
volse ’l viso ver’ me, e “Or aspetta”,
disse, “a costor si vuole esser cortese”.
El disse a me: “Tosto verrà di sovra
ciò ch’ io attendo e che il tuo pensier sogna;
tosto convien ch’al tuo viso si scovra”.
Inf. XXVI, 7-12
Ma se presso al mattin del ver si sogna,
tu sentirai, di qua da picciol tempo,
di quel che Prato, non ch’altri, t’agogna.
E se già fosse, non saria per tempo.
Così foss’ ei, da che pur esser dee!
ché più mi graverà, com’ più m’attempo.
[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 1 (VIa visio)] “Et post hec vidi alium angelum” (Ap 18, 1), id est alium doctorem vel alium ordinem doctorum. Nam per precedentem intelliguntur illi qui spiritalibus disciplinis exponunt malitiam meretricis et futurum casum eius, per istum vero illi qui casum eius iam factum predicaturi sunt magnifice et clare et letabunde. Vel per primum designantur hii qui docent absolute contemplari futura, per istum vero hii qui futurorum et factorum notitiam docent et iubent vel monent applicari ad fugam malorum et ad actionem bonorum. Unde subdit: “descendentem de celo”, id est de altitudine celestis contemplationis ad activam predicationis.
Inf. XXVIII, 97-99
Questi, scacciato, il dubitar sommerse
in Cesare, affermando che ’l fornito
sempre con danno l’attender sofferse.
Pharsalia I, 280-281
Dum trepidant nullo firmatae robore partes,
tolle moras; semper nocuit differre paratis.
[Ap 6, 9.11] Secundo responditur executionem predicte iustitie debere differri propter complendum numerum electorum et quia interim sufficit sanctis glorificatio animarum suarum, ibi: “Et date sunt illis” et cetera […].
Deinde subduntur duo propter que iudicium hoc debet convenienter differri ad tempus. […]
Preter rationem sumptam ex completione numeri, tangit tria propter que gratanter debent hoc spectare.
Primum est honorificentia summi Domini ut habe<at> plures servos, et etiam coequalitas horum et illorum in servitute Dei, unde dicit quod sunt “conservi eorum”, id est simul cum eis servi eiusdem Domini.
Secundum est mutua confraternitas respectu eiusdem patris, unde dicit: “et fratres eorum”.
Tertium est martirii conformitas; “sunt” enim “interficiendi sicut et illi” qui precesserunt. […]
Designatur etiam sanctos illius temporis admirari quare quintum tempus tantum durat, aut quare in tanta pace affluitate temporali faciente carnales amplius insanire, et quare Deus tanto tempore differt vindicare tot et tanta mala.
2b. Il seme che rimane (Ap 12, 17)
La quinta guerra (quarta visione) viene condotta dal drago contro le rimanenze (le reliquie) del seme della donna, rappresentate da coloro che custodiscono i precetti divini e danno testimonianza di Cristo (Ap 12, 17). Secondo Gioacchino da Fiore, il seme della donna è Cristo rapito in cielo con i suoi martiri, e questo è seme che precede; quello che rimane viene designato con l’evangelista Giovanni, cioè con i contemplativi propri del quarto stato. Olivi, che sviluppa l’esegesi autonomamente a partire dalla citazione di Gioacchino, ritiene tuttavia che il testo sacro, nella quarta visione, dopo aver trattato le guerre sostenute in primo luogo da Cristo (Ap 12, 4-6), in secondo luogo dai martiri (Ap 12, 7-12) e in terzo e quarto luogo dalla Chiesa, prima dispersa e poi riunita da Costantino e dotata delle ali dei dottori e degli anacoreti (le ali di una grande aquila) per volare nel deserto dei Gentili e in quello della vita contemplativa (Ap 12, 13-16), si riferisca ora in parte ad eventi successivi allo stato degli anacoreti (il quarto), e precisamente a quanti di essi rimasero sopravvivendo alle distruzioni operate dai Saraceni e, comunque, alle reliquie lasciate al quinto stato. In entrambi i casi si parla di “reliquie” poiché, come in un vaso di vino purissimo rimangono, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e più pura, solo poche reliquie vicine alle impurità e quasi con esse mescolate, così della pienezza e purezza del vino dei dottori e degli anacoreti del terzo e del quarto stato prima rimasero solo le reliquie, al momento della devastazione saracena, poi, nel quinto stato, occupate molte chiese dai Saraceni e separatisi i Greci dalla fede romana, rimase solo la Chiesa latina come reliquia della Chiesa che prima era diffusa in tutto l’orbe.
La rosa tematica offerta dall’esegesi oliviana di Ap 12, 17 – dove la citazione di Gioacchino da Fiore, fondata sul tema del seme che rimane, subisce un ampio e in parte diverso sviluppo – si presta a molteplici variazioni nel poema sacro, la cui ricchezza è paragonabile ai molti altri luoghi della Lectura che si mostrano essere stati fornitori di “panno” per l’intera stesura della “gonna”.
■ In Inf. VIII, nell’incontro con Filippo Argenti immerso nella palude Stigia, il tema del rimanere (Ap 12, 17) è dal poeta appropriato prima a sé stesso (v. 34: «E io a lui: “S’i’ vegno, non rimango”»), poi all’orgoglioso fiorentino (vv. 37-38: «E io a lui: “Con piangere e con lutto, / spirito maladetto, ti rimani”»). Nel secondo caso è congiunto con altri due temi propri del quinto stato.
Il primo è il ‘dare lutto’, presente nella quinta parte della sesta visione, che riguarda la caduta della superba gloria di Babylon, verso la quale si dice: “Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum” (Ap 18, 7; Filippo Argenti “fu al mondo persona orgogliosa” [v. 46]).
Il secondo tema è quello della maledizione, cioè la durezza dei precetti e dei giudizi della vecchia legge, che commina sentenza di maledizione contro quanti non ne hanno rispettato la lettera in tutte le sue parole, motivo di chiusura del quinto sigillo (ad Ap 5, 1). E certo la durezza lapidea dell’Antico Testamento si addice all’Inferno. Questa durezza viene temperata, all’apertura del quinto sigillo, dalla condescensiva “pietas” del quinto stato, che indulge a molte infermità umane, come la madre al suo bimbo. Non è pertanto casuale che le parole di Dante avverso Filippo Argenti siano seguite da quelle di Virgilio che riprendono il tema della donna (Ap 12, 17) e della madre (ad Ap 5, 1): «e disse: “Alma sdegnosa, / benedetta colei che ’n te s’incinse!”» (vv. 43-45), espressione ricalcata su Luca, 11, 27: “Beatus venter qui te portavit” (da notare come “benedetta colei” si contrapponga a “spirito maladetto”).
Cacciaguida riprenderà a sua volta tale tema, citando esplicitamente il motivo del seme e tacendo quello della donna e madre: «la prima cosa che per me s’intese, / “Benedetto sia tu”, fu, “trino e uno, / che nel mio seme se’ tanto cortese!”» (Par. XV, 46-48). Sono queste, dopo un primo incomprensibile parlare del suo avo, le prime cose intese dal poeta, allorché “’l parlar discese / inver’ lo segno del nostro intelletto” (vv. 43-45), discesa in cui è insito il tema, precipuo del quinto stato, della “condescensio” da un’alta situazione contemplativa. Appartiene a Cacciaguida anche il tema della “pietas” propria del quinto stato, nel discendere verso Dante dai bracci della croce: “Sì pïa l’ombra d’Anchise si porse … quando in Eliso del figlio s’accorse” (vv. 25-27). Nel ricordare la sua nascita, Cacciaguida richiama comunque il tema della donna e quello della madre al v. 133 (“Maria mi diè, chiamata in alte grida”), come a Par. XVI, 34-36, computando secondo l’uso fiorentino gli anni ab incarnatione («dissemi: “Da quel dì che fu detto ‘Ave’ ”») fino al giorno del parto.
I temi che fasciano l’episodio di Filippo Argenti sono ripresi, in Inf. VIII, al momento in cui Virgilio va da solo a parlare con i diavoli piovuti sulle porte della città di Dite. Il tema del rimanere è appropriato prima a Virgilio (“ché tu qui rimarrai, / che li ha’ iscorta sì buia contrada”), con “parole maladette” (vv. 92-96); poi a Dante che, lasciato solo dalla sua guida, resta nel dubbio: “e io rimagno in forse, / che sì e no nel capo mi tenciona” (vv. 109-111), dove si combina col tema del dubbio insinuato dalle locuste, proprio della quinta tromba (Ap 9, 5-6); poi ancora a Virgilio, “che fuor rimase” allorché i diavoli chiusero le porte (vv. 115-116). Da notare che il motivo dello stare da solo è attribuito sia a Virgilio (“Vien tu solo”, v. 89) come a Dante (“Sol si ritorni”, v. 91), motivo che nell’esegesi della quinta guerra appartiene alla chiesa di Roma, che ‘sola rimase’ dopo le devastazioni operate dai Saraceni nel quarto e nel quinto stato. Brunetto Latini definirà Dante la sola pianta rimasta a Firenze della “sementa santa” dei Romani (che colonizzarono Fiesole; Inf. XV, 73-78).
■ Il solenne tema del rimanere del seme subisce una grottesca variazione nella bolgia dei barattieri, appropriato a Ciampolo: “I’ vidi … / uno aspettar così, com’ elli ’ncontra / ch’una rana rimane e l’altra spiccia” (Inf. XXII, 31-33), prima che Graffiacane gli ‘arruncigli’ “le ’mpegolate chiome / e trassel sù, che mi parve una lontra”. Nei versi sono intrecciati numerosi temi del quinto stato. Le similitudini tratte prevalentemente dalla vita di uccelli e pesci, che sono diffuse per tutto il canto, corrispondono al quinto giorno della creazione, nel quale Dio disse agli uccelli (i monaci, più spirituali) e ai pesci (i chierici, commisti alle genti) “crescete e moltiplicatevi” (Genesi 1, 22), figura del quinto stato della Chiesa (prologo, Notabile XIII), nel quale i monasteri e le chiese si sono propagati nella Chiesa occidentale dopo l’ardua e solitaria vita degli anacoreti del quarto stato. Del quinto stato è proprio l’attendere, perché il numero degli eletti non è ancora completo (tema dell’apertura del quinto sigillo, Ap 6, 11); nell’attesa le anime stanno “sotto” l’altare di Dio (Ap 6, 9), quasi sepolte, riverenti verso la passione di Cristo che le sta sopra proteggendole e nascondendole sotto la custodia delle ali della sua gloria. I barattieri stanno “sotto i bollori” della pece (Inf. XXII, 30); Ciampolo ‘aspetta’, ma fuori della pece (cosa di cui si pente: “Così foss’ io ancor con lui coperto, / ch’i’ non temerei unghia né uncino!”, vv. 68-69). È rana che “rimane”, come nel quinto stato rimangono le reliquie della Chiesa latina (v. 33; il verbo rimanere è nell’11a terzina anche a Inf. XXX, 31); per questo Virgilio gli chiede, prima che venga disfatto dai Malebranche: “Or dì: de li altri rii / conosci tu alcun che sia latino / sotto la pece?” (vv. 64-66). È da notare come il motivo del seme (nell’esegesi congiunto con il “rimanere”) sia taciuto, mentre emergono altri motivi della rosa tematica. È presente, come in Inf. VIII, 38, 95, il tema della maledizione, che rende chiuso il quinto sigillo (ad Ap 5, 1): lo sciagurato Navarrese è capitato in mano ai “maladetti” (Inf. XXII, 42). In generale è da dire che nella quinta bolgia dei barattieri (come nella palude Stigia, fra i sodomiti sotto la pioggia di fuoco, nella valletta dei principi e nel quinto girone della montagna) si assiste a una delle più vaste metamorfosi di temi del quinto stato della storia della Chiesa.
Tab. III
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (V sigillum)] Tertia ratio septem sigillorum quoad librum Veteris Testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. […] Quintum est severitas preceptorum et iudiciorum, quia precipit “non concupisces” et “diliges Deum ex toto corde” (Dt 5, 21; 6, 5), et multa alia infirmitati humani generis ex se impossibilia, et tamen dat sententiam maledictionis omnibus qui non permanserint in omnibus verbis legis. Hanc autem temperat et exponit condescensiva Christi pietas indulgens multa infirmitatibus nostris, sicut mater infantulo suo. Et hoc notatur in quinta apertione, cum expetentibus iustitiam respondetur “ut requiescerent adhuc” per “tempus modicum, donec compleantur conservi eorum et fratres” (Ap 6, 11), id est ut propter pietatem fraterne salutis patienter differant et prolongent iudicia ultionis. |
||
[LSA, cap. XII, Ap 12, 17 (IVa visio, Vum prelium)] Dicit ergo: “Et iratus est dracho in mulierem” (Ap 12, 17). Nota quod quanto plus et pluries videt se vinci ab ecclesia et prole eius, tanto maiori ira exardescit ad illam fortius temptandam et deiciendam.
|
||
|
Inf. XXII, 31-33, 40-42I’ vidi, e anco il cor me n’accapriccia,
|
|
■ Il tema del rimanere si presenta all’inizio di Purg. VI, nel “si riman dolente” di chi ha perduto ai dadi (vv. 1-3). Il contesto è negativo, nel senso del rimanere con lutto rinfacciato a Filippo Argenti (Inf. VIII, 37-38); nei versi sono intrecciati temi propri della caduta di Babylon, con la conseguente perdita dei lucrosi commerci da parte dei mercanti (Ap 18, 10-11).
Da confrontare il “si riman dolente” di chi ha perduto al “gioco de la zara” con il “rimase turbato” proprio di Virgilio, che riconosce l’infruttuoso desiderio della conoscenza umana di arrivare alle ultime cause con le sole forze della ragione, un desiderio inappagato “ch’etternalmente è dato … per lutto”, come pena eterna nel Limbo, ad Aristotele, Platone e a molti altri (Purg. III, 34-45). Il tema del dare lutto proviene dalla quinta parte della sesta visione, che concerne la caduta di Babylon, verso la quale si dice: “Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum” (Ap 18, 7); il poeta pagano applica altrove a sé il tema della perdita dei lucrosi commerci intrattenuti dai mercanti con Babylon (Inf. IV, 40-42).
■ A Inf. XXVIII, 112 è Dante che ‘rimane’ a riguardare lo stuolo dei seminatori di scandalo e di scisma nella nona bolgia.
Nei versi che precedono (v. 110-111) si registra un altro motivo da Ap 18, 5 (quinta parte della sesta visione). In questo caso, il motivo congiunto al rimanere è quello del ‘cumulo’, cioè il pervenire i peccati di Babilonia “ad tantum et ad tam famosum cumulum” da non poter più essere tollerati. Questo motivo è appropriato al Mosca: “per ch’elli, accumulando duol con duolo, / sen gio come persona trista e matta”.
Nei versi che seguono (vv. 115-117) si insinuano motivi dell’apertura del quinto sigillo. Il tema della coscienza pura che consente di tollerare la compagnia dei pravi (così vengono interpretate le “bianche stole” di Ap 6, 11) precede la descrizione della pena di Bertran de Born, tanto incredibile da non poter essere riferita senza la protezione di una coscienza che sente di dire il vero ed è buona compagnia nell’ispirare coraggio.
Precedentemente, anche i versi di Inf. XXIII, 7-18 sono stati segnati dalla conversione, in rime aspre, dei temi da Ap 18, 5-6 (ad cumulum, duplicate – s’accoppia, doppia, s’aggueffa), contaminati con i motivi della quinta tromba (Ap 9, 5-6.8), riferiti alle locuste-diavoli che sopravvengono.
■ Nella bolgia degli indovini, il riferimento che Virgilio fa alla guerra di Troia – “quando Grecia fu di maschi vòta, / sì ch’a pena rimaser per le cune” (Inf. XX, 108-109) – è da confrontare, vera prefigurazione antica della storia della Chiesa, con le Chiese orientali “vastate” dai Saraceni nel quarto stato e con lo scisma greco, per cui della Chiesa un tempo ovunque diffusa rimasero solo poche reliquie nel quinto.
Nella descrizione di Lucifero, il tema del rimanere è prima appropriato a Dante (“Io non mori’ e non rimasi vivo”, Inf. XXXIV, 25; subentra anche il motivo del lutto: cfr. vv. 32, 36), ed è da confrontare con il rimanere in forse di Inf. VIII, 109-111; poi a Giuda, la schiena del quale, graffiata da Dite, “rimanea de la pelle tutta brulla” (Inf. XXXIV, 58-60), e il confronto è con i precedenti di Ciampolo (Inf. XXII, 31-33) e di Griffolino (Inf. XXX, 31-33).
■ A Inf. XXXII, 99, il rimanere è congiunto con il tema dei capelli di Cristo, nel fiero atteggiamento di Dante nei confronti di Bocca degli Abati, il malvagio traditore di Montaperti che non vuole rivelare il proprio nome: «Allor lo presi per la cuticagna / e dissi: “El converrà che tu ti nomi, / o che capel qui sù non ti rimagna”». I capelli, oggetto della quarta perfezione di Cristo come sommo pastore trattata nella prima visione (Ap 1, 14), sostituiscono il tema del vaso di vino purissimo, di cui restano poche reliquie, presente ad Ap 12, 17: accomunano infatti i due passi, quasi parole-chiave, i motivi della “plenitudo” e dell’“ornatus”. I capelli designano la moltitudine e l’ornato dei sottilissimi e spiritualissimi pensieri e affetti, oppure la pienezza dei doni dello Spirito Santo che adornano la cima della mente. Così la Chiesa, prima del quinto stato, era adornata dalle due ali date alla donna (Ap 12, 14: i dottori del terzo stato e gli anacoreti o contemplativi del quarto) e il vaso di vino purissimo era nella sua pienezza. Il non rimanere alcun capello sul capo significa pertanto l’annullamento dell’ornato, di ciò che è spirituale.
Tab. III bis
[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 5-7 (VIa visio)] Deinde reddit rationem quare sit ab ea exeundum, ne participent in eius delictis et penis, subdens (Ap 18, 5): “Quoniam pervenerunt peccata eius usque ad celum”, id est usque ad summum, seu ad tantum et tam famosum cumulum quod Deus amodo non potest ipsam amplius tolerare. Unde subdit: “et recordatus est Dominus iniquitatum eius”, scilicet ad statim puniendum illas. Per longam enim dissimulationem punitionis videbatur non recordari earum. Quia vero sancti sunt iudicaturi malos tam in extremo iudicio quam in hac vita, predicando et comminando iustam dampnationem ipsorum, ideo pro utroque istorum modorum subdit Deus (Ap 18, 6): “Reddite illi”, scilicet condignas penas, “sicut et ipsa reddidit vobis”, id est sicut per eam estis dure et impie afflicti, sic vos dure et severe seu iuste iudicate eam. “Et duplicate duplicia secundum opera eius”, id est multo maiora supplicia sibi inferte quam ipsa intulerit vobis, quia sic merentur prava opera eius. […] Quia vero non solum punietur pro malis que fecit in sanctos vel in proximos, sed etiam pro hiis quibus se ipsam vanificavit et fedavit, ideo pro hiis subditur (Ap 18, 7): “Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum”. Le “tantum” non significat hic absolutam equalitatem quantitatis, sed equalitatem proportionis et iustitie. Signanter autem notat eius culpam de duobus, scilicet de superba gloria et de carnali voluptate, quia hec duo sunt radices omnium aliorum. Nullus enim, secundum Ieronimum, querit divitias nisi pro hiis duobus. In hiis autem <tribus>, secundum Iohannem, consistit radicaliter tota malitia mundi (cfr. 1 Jo 2, 16). Quidam habent: “Quantum glorificavit se in deliciis suis”, et satis redit in idem. |
||
[LSA, cap. XII, Ap 12, 17 (IVa visio, Vum prelium)] Dicit ergo: “Et iratus est dracho in mulierem” (Ap 12, 17). Nota quod quanto plus et pluries videt se vinci ab ecclesia et prole eius, tanto maiori ira exardescit ad illam fortius temptandam et deiciendam.
|
||
Inf. XIV, 37-39
|
Inf. XX, 106-111Allor mi disse: “Quel che da la gota
|
|
3. L’orgoglio fiorentino
Il primo difetto che rende chiuso il quarto sigillo (ad Ap 5, 1) è il superbo essere indomito della nostra libertà: nella quarta apertura la morte che siede sul cavallo pallido (Ap 6, 8), cioè sulla carne già morta e impallidita (i Saraceni), domò e infranse la superba libertà delle chiese orientali che non vollero sottoporsi alla sede e alla fede di Pietro. E certo, afferma Olivi, nulla è più adatto ad infrangere la superbia del nostro potere quanto l’assidua considerazione ed esperienza della fragilità umana e della morte. Per spuntare la superbia umana è infatti detto nell’Ecclesiastico: “A che insuperbisci, terra e cenere?” (Ecli 10, 9) e: “In tutte le tue opere ricordati della tua fine, e non cadrai mai nel peccato” (Ecli 7, 40).
I temi della superbia domata e della considerazione della morte sono appropriati, nella descrizione dell’ultima bolgia, ai Troiani – la cui “altezza … che tutto ardiva” (motivo dell’ardua e alta vita degli anacoreti del quarto stato, distrutta in oriente dai Saraceni) fu volta in basso dalla fortuna, – e a Ecuba, che “forsennata latrò sì come cane”, dopo che si fu accorta dei propri figli morti (Inf. XXX, 13-21). Variazioni dei motivi (la superbia domata, l’esperienza della morte) si registrano in Capaneo (Inf. XIV, 63-64; da notare, al v. 90, “ammorta”, appropriato al Flegetonte, i cui vapori estinguono le falde della pioggia infuocata, salvando i “duri margini” sui quali passano i due poeti), in Fialte (Inf. XXXI, 91-93), in Omberto Aldobrandesco (Purg. XI, 52-54; “doma” è hapax), nelle parole di Beatrice e Pier Damiani nel cielo di Saturno (Par. XXI, 6, 11, 61).
Ecuba è “trista, misera e cattiva”, una troiana furia paragonata ai rabbiosi falsatori di persona (Inf. XXX, 16). I ‘cattivi’ sono i prigionieri fatti dai Saraceni, secondo l’esegesi dell’apertura del quarto sigillo (Ap 6, 8), in cui il cavallo pallido (la morte) designa Maometto e la sua setta, secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore seguita da Olivi. Da quando i Saraceni hanno iniziato a devastare la Chiesa non si è mai letto o ascoltato di miracoli fatti dai fedeli uccisi o resi schiavi, né che fosse stato dato il verbo della predicazione per convertire a Cristo gli infedeli e vivificarli o per confermare nella vita della fede i fedeli, ché anzi la maggior parte dei finiti in cattività è convolata alla setta mortifera. Tra i Saraceni non accade – e ciò da più di seicento anni – quanto era avvenuto con i pagani e gli eretici, fra i quali si moltiplicavano i fedeli e molti venivano convertiti alla fede (cfr. le espressioni come “cattivo coro”, “setta d’i cattivi” a Inf. III, 37, 62, riferite rispettivamente agli angeli neutrali e ai pusillanimi).
La superbia distrutta è nel ricordo di Montaperti, espresso da Oderisi da Gubbio a proposito di Provenzan Salvani, che era signore di Siena “quando fu distrutta / la rabbia fiorentina, che superba / fu a quel tempo sì com’ ora è putta” (Purg. XI, 112-114). L’orgoglio è veramente fiorentino. Con Filippo Argenti: “Quei fu al mondo persona orgogliosa … ’l fiorentino spirito bizzarro” (Inf. VIII, 46-48, 61-63). Nella risposta di Dante ai tre concittadini sodomiti: “La gente nuova e i sùbiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni”, Inf. XVI, 73-75). Costituisce un vizio proprio del quarto tempo, allorché – come si afferma nel Notabile XII del prologo con citazione di Gioacchino da Fiore – gli anacoreti contemplativi “fiorirono”, ma poi passarono dalla perfezione al gloriarsi e di qui all’esaltazione e infine alla rovina. Così l’aggettivo ‘fiorentino’ si insinua tra le maglie dell’armatura teologica, scavato nel “visus est floruisse ad horam” a proposito del quarto ordine nella citazione del quinto libro della Concordia.
|
Tab. IV
[LSA, prologus, Notabile XII] De quarto autem statu, scilicet anachoritarum, dicit Ioachim, libro V° Concordie, quod «proficiendo decrevit, quia et herba tunc magis proficit cum appropinquat ad messem. Nam tempus eius non tam illud esse dicitur in quo incipit quam illud in quo, peracta messione, grana per trituram separantur a paleis. Ordines enim iustorum propria tempora acceperunt non in quibus inceperunt sed in quibus ad consumationem et perfectionem venerunt. Quod autem diximus ordi-nem quartum, qui est heremitarum et virginum, proficiendo defecisse, timendum est potius quam dicendum. Aperta enim perfectio gloriationem parit, gloriatio exaltationem, exaltationem vero comitatur ruin<a>, quia scriptum est: “ante ruinam exaltatur cor” (Pro 16, 18; 18, 12). Igitur ordo iste quarto tempore claruit, sed mox defecit in illa claritate et in locis illis in quibus visus est floruisse ad horam, et hoc propter malitiam habitantium in eis»*. Preterea fragilitas humane carnis non patitur tantum statum diu in multitudine perdurare.* Concordia, V 1, c. 12; Patschovsky 3, p. 551, 3-20.[LSA, cap. VIII, Ap 8, 12 (IIIa visio, quarta tuba)] Per “stellas” vero, quidam singulares et alti et solitarii anachorite.[LSA, prologus, Notabile V] […] tuncque (in quinto statu) congrue instituta est vita condescensiva, ut nequeuntibus in arduis perdurare daretur locus gratie in mediocri statu. |
Inf. VIII, 46-48, 61-63Quei fu al mondo persona orgogliosa;
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1] Quartus (defectus in nobis claudens intelligentiam huius libri) est nostre libertatis superba indomabilitas. […] In quarta (apertione) vero mors sedens in equo pallido, id est in carne quasi iam emortua pallescente, domuit et infregit superbam libertatem orientalium eccle-siarum nolentium subici sedi et fidei Petri. Et certe nichil validius ad infringendam superbiam imperii nostri quam consideratio assidua et experientia humane fragilitatis et mortis, unde Ecclesiastici X° ad retundendam hominis superbiam dicitur: “Quid superbis terra et cinis?” (Ecli 10, 9), et capitulo VII° dicitur: “In omnibus operibus tuis memorare novissima tua et in eternum non peccabis” (Ecli 7, 40).Inf. XIV, 63-64, 88-90O Capaneo, in ciò che non s’ammorza
|
Purg. XI, 52-54, 112-114E s’io non fossi impedito dal sasso
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 8 (IIa visio, apertio quarti sigilli)] Equus autem sarracenicus dicitur “pallidus”, pallore scilicet tali qualis proprie competit mortuis. Mors etiam dicitur sedere super eum triplici ex causa. […] Tertia est quia, quando a principio tot ecclesias Christi vastavit, non legimus nec audivimus facta tunc fuisse miracula per fideles tunc occisos vel captivatos, nec data vive predicationis verba per que infideles converterentur ad Christum et vivificarentur aut per que fideles in vita fidei confirmarentur, quin potius maior pars captivatorum videtur ad eorum sectam mortiferam convolasse. Non enim, sicut inter paganos et hereticos multiplicabantur fideles et plures convertebantur ad fidem, sic contingit inter Sarracenos, immo contrarium iam per sescentos annos et amplius. |
|
Tab. IV bis
L’esegesi della quinta tromba (Ap 9, 1-12), con le locuste che escono dal fumoso pozzo dell’abisso, una volta tolto il freno che lo chiude (Ap 9, 3), costituisce un’abbondante riserva tematica. Maliziose con le braccia e ancor più con la coda, dalla puntura che induce dolore, cruccio e rimorso, rissose e accese in ira, animose e pronte nonché forti, variamente pervadono (senza mai essere esplicitamente nominate) con le loro malvage proprietà, la quinta bolgia. Traggono al male, le ali non consentono di volare in alto e a lungo, per vana gloria aderiscono a terra. Il passaggio dalla quinta bolgia (barattieri) alla sesta (ipocriti), con la drammatica fuga dei due poeti dai temibili Malebranche descritta in apertura di Inf. XXIII, introduce i motivi dell’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12-17).
|
||
[LSA, cap. IX, Ap 9, 3 (IIIa visio, Va tuba)] Tertio tangitur quedam spiritalis plaga quorundam pestiferorum de predicto fumo exeuntium, cum subdit: “et de fumo putei exierunt locuste in terram” (Ap 9, 3). Quamvis per has locustas possint designari omnes mali christiani quorum malitia est multa et publica et multorum lesiva et cruciativa, magis tamen proprie, quoad hunc primum sensum, designat pravam multitudinem clericorum et monachorum et iudicum et ceterorum curialium plurimos spiritaliter et temporaliter pungentium et cruciantium, qui omnes de fumo putei exeunt quia de pravo exemplo effrenationis prefate occasionem et inductivam causam sui mali traxerunt, et etiam quia quasi de puteo inferni cum predicto fumo exempli pessimi videntur exisse. Vocantur autem “locuste”, tum quia ad modum locuste alte saliunt per elationem, et hoc postremis cruribus quia vanam gloriam in omnibus finaliter intendunt, et ad terram recidunt per cupiditatem; tum quia instar locustarum postremis cruribus saliunt, proponendo scilicet in fine penitentiam agere et sic sperant ad gloriam eternam salire, pedibus vero anterioribus et toto ore terre adherent virentia cuncta rodentes; tum quia locusta est animal parvum et secundum legem mundum, habetque alas non ad altum et diuturnum volatum sed ad infimum et modicum. Et ideo partim designat ypocritas humilitatis et munditie et contemplativi volatus simulatores aliorum vitam detractionibus corrodentes et aliorum bona temporalia devorantes, sive per auctoritatem ecclesiasticam, sive per oblationem quasi sanctis factam, sive per questum quasi sub specie pietatis exactum, sive per symoniacam fraudem, sive per falsa et iniqua iudicia vel per alias impias exactiones; partim etiam designat leves et volatiles clericos et monachos carnalia sectantes et per <ea> multis nocentes.
|
||
Inf. XV, 25-27E io, quando ’l suo braccio a me distese,
|
Purg. II, 76-79Io vidi una di lor trarresi avante
|
|
Tab. V
Il verso “che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio” (Inf. VIII, 60) rinvia ai temi della settima tromba (la lode celeste per l’instaurazione del regno della grazia e della gloria dopo la sconfitta dell’Anticristo: Ap 11, 15.17-18), motivi variamente utilizzati altrove, nel passaggio dell’Acheronte o nel cielo del Sole. Si noti la semantica presente nel cielo di Giove (Par. XVIII-XIX), intrecciata con quella che conduce ad Ap 15, 3-4 (parte proemiale della quinta visione). Per le lettere D, I, L (iniziali, oltre che del primo versetto della Sapienza, di dilatationes, cioè della conversione universale a Cristo), formate dai lumi degli spiriti giusti (Par. XVIII, 78), il riferimento è anche ad Ap 20, 3. |
||
|
|
|
[LSA, cap. XI, Ap 11, 15.17-18 (IIIa visio, VIIa tuba)] “Et septimus angelus tuba cecinit” (Ap 11, 15), id est septimus et ultimus status ecclesie manifestari cepit. “Et facte sunt voces magne in celo dicentes: Factum est regnum huius mundi Domini nostri et Christi eius”, id est, secundum Ricardum, exhibende sunt Deo laudes “in celo”, id est in celesti ecclesia, de iustorum salvatione et impiorum dampnatione*, et de regni Christi et Patris eius super totum orbem d i l atatione et manifestatione. Licet enim semper realiter regnet super omnes bonos et malos, non tamen hoc semper omnibus innotescit, nec in bonis consumabitur regnum gratie et glorie usque ad septimum statum. Qui, ut sepe tactum est, est uno modo idem quod consumatio orbis et specialiter electorum in extremo iudicio introducenda; alio vero modo est idem quod quedam mira et finalis sabatizatio electorum in vita ista, exterminatis de medio omnibus heresibus et scismatibus et hostilibus impugnationibus populi Dei, prout tamen competit huic vite. Et secundum hoc omnia hic scripta referuntur uno modo ad istud, et alio consumationis modo ad primum.
|
||
Par. XVIII, 76-78, 115-129sì dentro ai lumi sante creature
|
Par. XIX, 13-15, 34-39, 103-105E cominciò: “Per esser giusto e pio
|
|
[LSA, cap. XV, Ap 15, 2-4 (Va visio, radix)] Unde subditur: “(Ap 15, 2) Habentes citharas Dei (Ap 15, 3) et cantantes canticum Moysi servi Dei et canticum Agni”. Canticum utriusque in hoc convenit, quod uterque cantavit de pia liberatione electorum et de terribili submersione seu perditione hostium. Differunt autem in hoc, quod canticum Moysi fuit sicut servi, cuius est timere Dominum terribilem in iudiciis; canticum vero Agni fuit vere filii mitissimi, cuius est filialiter amare patrem et consequi eius hereditatem. Ergo isti cantant simul canticum timoris ut servi et amoris ut filii, et hoc ipsum patet ex materia cantici eorum, unde subditur: “dicentes: Magna”, scilicet in se, “et mirabilia”, scilicet contemplantibus, “sunt opera tua, Domine Deus omnipotens”. Pro operibus autem seu iudiciis iustitie, subdunt: “Iuste et vere vie tue”, id est opera tua, “rex seculorum. (Ap 15, 4) Quis non timebit te, Domine, et magnificabit nomen tuum?”. Pro operibus vero misericordie, subdunt: “Quia solus pius es”, scilicet per se et substantialiter et summe; “quoniam omnes gentes venient”, scilicet ad te tamquam a te misericorditer vocate et tracte, “et adorabunt in conspectu tuo, quoniam iudicia tua manifesta sunt”, scilicet per evidentes effectus perditionis Antichristi et suorum et salvationis electorum. |
||
4. Dite, ovvero l’infuocata Gerusalemme saracena
■ Parodia della struttura formale della Gerusalemme celeste oggetto della settima visione apocalittica (Ap 21, 12), la città di Dite si presenta al poeta nella sequenza ternaria del suo modello: prima “l’alte fosse”, poi “le mura”, quindi “l’intrata”, ovvero le “porte” alle quali la barchetta di Flegiàs perviene “non sanza prima far grande aggirata”, cioè dopo aver costeggiato il circuito grande delle mura (Inf. VIII, 76-83; da notare l’espressione “venimmo in parte”, simile nell’esegesi al ‘venire alle parti’ di cui è formata la città). I diavoli chiudono a Virgilio le porte e gli negano “le dolenti case” (vv. 115-123; nella città superna le porte sono sempre aperte: Ap 21, 25). Il maestro è adirato, ma rassicura il discepolo che vincerà la prova nonostante dentro le mura ci si dia da fare per difendersi. L’espressione “qual ch’a la difension dentro s’aggiri” fa intervenire il passo sulla difesa, simmetrico a quello relativo al grande e alto muro della città da Ap 21, 12, tratto da Ap 4, 4 e appropriato ai seniori che circondano, difensori e famuli, il trono di Dio.
I motivi proseguono nel canto seguente. Virgilio assicura di essere già entrato “dentr’ a quel muro” in virtù degli scongiuri di “Eritón cruda” (Inf. IX, 22-27). La palude Stigia “cinge dintorno la città dolente” (vv. 31-32): il cingere la città rientra nell’esegesi di Ap 20, 8, allorché Gog e Magog, l’ultima delle tribolazioni, cingono d’assedio l’accampamento dei santi e la città diletta, la quale, secondo Agostino (De civitate Dei, XX, 11), non si trova in un solo luogo ma è diffusa in tutto il mondo e fra tutte le genti.
Infine, entrati nella città di Dite grazie all’arrivo del messo celeste, i due poeti passano (il ‘passare’, come ad Inf. IV, 109, contiene in sé il motivo del patire) tra le alte mura (“li alti spaldi”) e i “martìri” degli eresiarchi (Inf. IX, 133; X, 1-2). Nel testo di esegesi scritturale le alte mura sono i màrtiri e i dottori che difendono la città e la fede; nei versi ci sono gli “alti spaldi” e i “martìri”, cioè i tormenti degli eretici seppelliti nelle arche roventi. Ma il tema del difendere rimane in Farinata, che difese la sua città “a viso aperto” (Inf. X, 93).
■ La città di Dio, che da questi è illuminata e assume l’immagine come il ferro s’accalora al fuoco e ne prende la specie, che è come pietra di diaspro (Ap 21, 11), diventa, nella sua proiezione infernale, “la città del foco” dalle mura che “mi parean che ferro fosse”, “luogo … / tutto di pietra di color ferrigno” in Malebolge (Inf. VIII, 78; X, 22; XVIII, 1-3). Impetrarsi e rosseggiare sono propri della sede divina descritta in principio della seconda visione apocalittica (Ap 4, 2-3), quando Giovanni vede Dio seduto su un trono, con in mano il libro segnato dai sette sigilli, ancora chiuso prima della loro apertura da parte di Cristo. Colui che siede, immobile per giustizia nel suo stare, è simile nel sembiante al verde diaspro (per gli eletti) e alla rossa cornalina (per i reprobi).
La città di Dite dalle ferrigne mura ha torri definite “meschite”, cioè moschee, rosse per l’arroventare del fuoco eterno (Inf. VIII, 70-74, 78). Il termine presta “e piedi e mano” all’esegesi di Ap 13, 1-2, dove Olivi cita l’interpretazione data da Gioacchino da Fiore della statua vista da Nabucodonosor nel sogno spiegato da Daniele, secondo la quale con la quarta parte della statua, fatta di ferro mescolato con fango (Dn 2, 33; è da ricordare che il Veglio di Creta ha il piede destro in terracotta), viene indicato il regno dei Saraceni indomabili come il ferro e correnti alla guerra. Ma si tratta di ferro misto, cioè di seme non più puro, indebolito perché mescolato ad altre genti. Meschite (meglio la forma mischite), dunque, concorda nel suono con mixtum, ed è segnale mnemonico che rinvia ai significati dell’esegesi esposta nella Lectura. Che poi le “meschite” siano “là entro certe ne la valle” (Inf. VIII, 71), sta ad indicare la certa e giusta misura del giudizio divino, che propina (mesce) il vino dell’ira, «“quod mixtum”, id est propinatum, “est mero”, id est purissimo supplicio» (Ap 14, 10).
I diavoli ostinati, che non vogliono fare entrare Virgilio e Dante nella città, corrono a gara entro le mura, che sembrano ferro, e si preparano alla guerra proprio come i Saraceni. L’arrivo del messo celeste dimostrerà poi, all’apertura della porta con una verghetta, la scarsa solidità di quelle mura, difese da una tracotanza usata già “a men segreta porta, / la qual sanza serrame ancor si trova”, cioè per difendere inutilmente la porta dell’inferno di fronte a Cristo (Inf. VIII, 124-126). La tematica della gente ‘mista’, che nell’esegesi è relativa ai Saraceni, è ben conosciuta da Cacciaguida (per altro morto come crociato), allorché lamenta l’attuale mistura della cittadinanza di Firenze con gente del contado, “di Campi, di Certaldo e di Fegghine” (Par. XVI, 49-51).
5. Due porte aperte
■ Di ritorno dai diavoli che, chiuse le porte, gli hanno negato “le dolenti case” di Dite, Virgilio assicura Dante che “questa lor tracotanza non è nova; / ché già l’usaro a men segreta porta, / la qual sanza serrame ancor si trova. / Sovr’ essa vedestù la scritta morta” (Inf. VIII, 124-127). Si tratta della porta dell’inferno spezzata da Cristo disceso agli Inferi, e da allora rimasta tale. Le parole di Virgilio rinviano all’esegesi di Filadelfia, la sesta chiesa d’Asia, alla quale Cristo promette di dare la “porta aperta”: “Sexta (ecclesia) autem dicitur habere hostium scripturarum <ac> predicationis et cordium convertendorum apertum” (Ap 2, 1). Si tratta di un’esegesi, più volte richiamata nel poema, fondata sull’interiorità: Cristo, interno dettatore, muove nei predicatori la volontà al parlare, suggerendo le parole che aprano alla conversione i cuori degli ascoltatori. Un’esegesi singolarmente coincidente con la poetica delle “nove rime” di Dante, dettate “dentro” da Amore e significate con la lingua “quasi come per sé stessa mossa” (cfr. Purg. XXIV, 52-54; Vita Nova, 10.13 [XIX 2]).
“Già di qua” da quella porta, asserisce Virgilio, “discende l’erta … tal che per lui ne fia la terra aperta” (Inf. VIII, 128-130), cioè il messo celeste che aprirà l’altra porta, quella di Dite. “Già”, come nell’esegesi, è avverbio che indica l’imminenza del giudizio, quasi in effetto; discendere è tema proprio del quinto stato; la “terra aperta” rinvia ad Ap 19, 20 (la bestia e lo pseudoprofeta messi vivi nell’inferno).
■ L’apertura della porta dell’inferno avvenne, con la discesa di Cristo al Limbo, subito dopo la sua morte, seguita da un terremoto che sconvolse tutto l’inferno, come ricorda Virgilio a Inf. XII, 37-45, seguendo Matteo 27, 51. Ma un nuovo terremoto sta per verificarsi. Se con l’avvento di Cristo nella carne è iniziata la sesta età del mondo (dopo le prime cinque percorse nel Vecchio Testamento), il secondo avvento di Cristo, nello Spirito dei suoi discepoli e imitatori, si svolge nel sesto periodo (status) della sesta età, “punto”, secondo Olivi, cioè causa finale, di tutta la storia. Il sesto sigillo si apre con un grande terremoto (Ap 6, 12; 8, 5, 16, 18), naturale, politico e interiore per il risvegliarsi delle coscienze a una vita nova. La discesa del messo che apre la porta di Dite è segnata dai temi del terremoto che fa fuggire per il terrore: “un fracasso d’un suon, pien di spavento, / per cui tremavano amendue le sponde … e fa fuggir le fiere e li pastori … fuggir così dinanzi ad un ch’al passo / passava Stige con le piante asciutte” (Inf. IX, 65-66, 72, 80-81). Non vi è nulla che possa trattenere il passaggio del messo celeste (“sanz’ alcun rattento”), il quale “passava Stige con le piante asciutte”; all’apertura, la porta “non v’ebbe alcun ritegno” (vv. 69, 81, 90), parodia dell’esegesi della sesta coppa, versata dall’angelo sul grande fiume Eufrate per prosciugarne le acque e togliere ogni impedimento agli eserciti che distruggeranno Babylon (Ap 9, 14). L’impeto e il disdegno verso quanti gli resistono è proprio anche dell’angelo dal volto solare, al suono della sesta tromba (Ap 10, 2-3; vv. 68, 88). La “verghetta” con la quale apre la porta è il “calamus” dato a Giovanni con il quale si piegano gli indomiti (Ap 11, 1 [sesta tromba]; v. 89); i diavoli sono “gente dispetta” (Ap 11, 8-9 [sesta tromba], v. 91).
■ Non ai soli temi del sesto stato della storia della Chiesa rinvia la discesa del messo celeste, che pure con essi conclude il primo ciclo settenario dell’Inferno. Viene utilizzata anche una parte del materiale tematico riferibile al periodo precedente, da Ap 9, 9 (quinta tromba: la settima proprietà delle locuste è il rombo delle ali pari al rombo dei carri da guerra che corrono tirati da molti cavalli), nell’arrivo accompagnato da “un fracasso d’un suon” paragonato a un “vento / impetüoso per li avversi ardori” (Inf. IX, 65, 67-68). Il vento “polveroso” (v. 71) conduce al tema dell’“arena” (quinta guerra: Ap 12, 18), che tra le caratteristiche ha la durezza, la quale ben si addice all’ostinazione dei diavoli arroganti e recalcitranti (al v. 75 è presente anche il tema del fumo, sempre dalla quinta tromba, ad Ap 9, 2). Un altro motivo inserito nell’episodio deriva dalle argomentazioni per cui l’eresia manichea (i Valdesi e i Catari), tipica del quinto periodo, non costituisce l’elemento principale della futura tentazione dell’Anticristo mistico, che Olivi ritiene invece essere la filosofia aristotelica e araba. L’eresia manichea è stata infatti già sufficientemente confutata da Agostino e pertanto non è necessario sudarci ancora sopra, salvo eliminarne i vili residui, non essendo consueto che quanto è stato vinto venga riproposto come oggetto principale della guerra da sostenere (Ap 9, 5-6). Il messo celeste giunto nel sesto stato, aperta la porta e rimproverati i diavoli per la loro arroganza punita più volte, come dimostra l’esempio di Cerbero che per aver tentato di impedire a Ercole l’entrata nell’Ade “ne porta ancor pelato il mento e ’l gozzo”, ritorna indietro come colui che è morso da altra sollecitudine che non quella che gli è davanti (vv. 100-103). È da notare il motivo del ‘mordere’, più volte presente nell’esegesi della quinta tromba, e la resa dell’“insudare”, fastidioso perché la dura arroganza è stata più volte repressa, nel frequente rimuovere con la mano sinistra il grasso vapore dal volto (il fumo che esce dal pozzo al suono della quinta tromba; vv. 82-84).
■ Virgilio, che attende il messo con ansiosa certezza (“Attento si fermò com’ uom ch’ascolta”, Inf. IX, 4), cuce Ap 3, 3 (quinta chiesa: «“In mente ergo habe”, id est attente recogita … si digne recogitaveris gratiam tibi prius impensam …»; il passo è parodiato anche nelle parole del messo rivolte ai diavoli: “Cerbero vostro, se ben vi ricorda”, v. 98) con Ap, 1, 3 (“beatus … qui audit”, causa finale del libro dell’Apocalisse).
Il sesto stato, al quale è data la porta aperta, è il periodo della storia atto per eccellenza al passivo ricevere piuttosto che al fare o al dare (Ap 3, 7). Per cui Virgilio rassicura il discepolo: “Non temer; ché ’l nostro passo / non ci può tòrre alcun: da tal n’è dato” (Inf. VIII, 104-105). È anche il tempo nel quale lo zelo divino non può più tollerare senz’ira l’adulterio della sua sposa, la Chiesa (Ap 5, 1). Ne è consapevole Virgilio, quando dice de “la città dolente, / u’ non potemo intrare omai sanz’ ira” (Inf. IX, 32-33).
Il poeta pagano fa inchinare il discepolo di fronte al messo (Inf. IX, 87): l’angelo tollerava il riverire nell’Antico Testamento; lo proibisce a Giovanni nel Nuovo (Ap 19, 10; cfr. Purg. XIX, 127-135).
■ Anche le Erinni, personaggi della mitologia classica, partecipano dei temi tratti dall’esegesi apocalittica. Le “tre furïe infernal” formano una pessima Trinità come i “tre spiriti immondi al modo delle rane” che Giovanni vede al versamento della sesta coppa (Inf. IX, 38; Ap 16, 13-14); si drizzano “in un punto”, quasi facendo segno del sesto stato, punto sul quale convergono gli altri periodi (v. 37; prologo, Notabile VIII); sono “di sangue tinte” perché antica prefigurazione dell’abominevole prostituta che siede sopra la bestia (Ap 17, 3-4); “con idre verdissime eran cinte; / serpentelli e ceraste avien per crine” (vv. 40-41): cingersi e crini appartengono rispettivamente alla terza e quarta prerogativa di Cristo come sommo pastore (Ap 1, 13-14), ma le ceraste (serpentelli cornuti) rinviano ancora alla prostituta dalle sette teste e dieci corna (Ap 17, 3). Vogliono vendicare “in Tesëo l’assalto” (v. 54), come il diavolo, sconfitto da Michele nella seconda guerra e calcato in terra, vuole vendicarsi rabbioso di tanta abiezione (Ap 12, 12). E “’l Gorgón”, al quale Dante deve chiudere gli occhi per non essere impietrito (fatto “di smalto”, tema della sede divina da Ap 4, 3; vv. 52-57), è la falsa immagine della Veronica, cioè del sudario di Cristo (Ap 22, 10).
■ Si è detto che le due porte aperte, quella dell’inferno e quella di Dite, fanno segno di due momenti della storia della salvezza: il primo avvento di Cristo nella carne, nel periodo di fondazione della Chiesa (primo stato della sesta età del mondo) e il secondo avvento nei suoi discepoli spirituali, al momento della renovatio universale (sesto stato), quando avviene il viaggio di Dante.
A proposito del numero del nome della bestia (DCLXVI: Ap 13, 18), Olivi cita l’interpretazione data da Gioacchino da Fiore (nell’Expositio in Apocalypsim) del numero sei e dei suoi derivati, in quanto numeri che colgono le cose temporali fatte nei sei giorni della creazione e amate dai figli di questo mondo: il tempo secolare da Adamo alla fine del mondo (DCLXVI); le sei età di questo mondo in cui la bestia regna (DC); i sei tempi della sesta età nei quali la bestia perseguita più atrocemente la Chiesa (LX); il sesto tempo della sesta età, cioè il tempo del regno dell’Anticristo in cui arde il furore della bestia (VI). Questi temi sono punti di riferimento nella quinta bolgia dei barattieri. Virgilio, per parlare con i diavoli, perviene sull’argine fra la quinta e la sesta bolgia, “e com’ el giunse in su la ripa sesta, / mestier li fu d’aver sicura fronte”, gli è cioè appropriato il motivo del portare sulla fronte il marchio della bestia o il suo nome o il numero del nome (Ap 13, 17), non però per confessare e magnificare in modo manifesto la potestà di questa, ma il “voler divino e fato destro” che lo rende sicuro da raffi e da runcigli (Inf. XXI, 64-66, 79-84; il tema della “fronte” è proprio, ad Ap 7, 3-4, dei segnati del sesto stato). I Malebranche escono da sotto il ponticello “con quel furore e con quella tempesta / ch’escono i cani a dosso al poverello” (Inf. XXI, 67-72), cioè con il furore con cui la bestia nel sesto stato della sesta età infuria contro l’ordine evangelico fondato da Francesco, “poverel di Dio”.
Malacoda asserisce che “giace / tutto spezzato al fondo l’arco sesto”, e spiega che la via infernale fu interrotta a causa del terremoto verificatosi nel momento della morte di Cristo, dalla quale sono passati 1266 anni e un giorno meno cinque ore, come dice scandendo i numeri “sessanta” (sesta età) e “sei” (sesto tempo della sesta età): “Ier, più oltre cinqu’ ore che quest’ otta, / mille dugento con sessanta sei / anni compié che qui la via fu rotta” (Inf. XXI, 106-114; le cinque ore che mancano alludono agli ultimi cinque mesi di tribolazione di cui ad Ap 9, 5).
Malacoda, bugiardo nell’affermare che “presso è un altro scoglio che via face”, che cioè passa sopra la sesta bolgia, dice il vero scandendo gli anni intercorsi tra la morte di Cristo (nell’anno 34 dall’Incarnazione, all’ora sesta o meridiana come detto in Convivio IV, xxiii, 10-11) e l’ora attuale (26 marzo 1300, alle sette antimeridiane). Tuttavia Virgilio, affermando alla fine del precedente canto che “già iernotte fu la luna tonda”, la quale non nocque ma giovò al discepolo “per la selva fonda” (Inf. XX, 127-129), ha indicato un’altra data, coincidente con il plenilunio fissato dai calendari, cioè l’8 aprile (il plenilunio reale cadde il 4/5 aprile) [1]. Malacoda, che tra l’altro farcisce il suo parlare anche col numero degli anni della permanenza della donna nel deserto (1260; Ap 12, 6.14), usa il computo tradizionale dei Padri della Chiesa, per cui Gesù è morto il 25 marzo dell’anno 34. Virgilio accenna invece all’anniversario della morte, celebrato l’8 aprile, il Venerdì Santo del 1300. La differenza fondamentale, nell’economia del poema e per la cronologia del viaggio, sta nella luna piena la quale, non avendo affatto un mero valore simbolico, si deve intendere illuminò Dante nel “passo / che non lasciò già mai persona viva”, per poi condurlo fuori del “pelago” verso il colle illuminato già dai raggi del sole (Inf. I, 13-27). La parte iniziale del poema è fortemente segnata dai temi dell’angelo del sesto sigillo, che rimuove impedimenti e ingiunge di non nuocere (Ap 7, 1-2). L’angelo, che porta il sigillo del Dio vivente, cioè le stimmate, designa il secondo avvento di Cristo, non nella carne, ma nel suo Spirito. Si rinnovano la vita, la legge e le sofferenze di Cristo. Per cui Malacoda, nel suo scandire separatamente le cifre marchiandole in parte con i segni del numero del nome della bestia, calcola il tempo secondo la data storica della morte di Cristo nel suo primo avvento (che è poi l’unica che conosce per diretta esperienza del terremoto). Virgilio parla invece del nuovo Venerdì Santo che coincide con la commemorazione dell’antico e insieme con l’inizio della nuova passione di Cristo nello Spirito. Si potrebbe dire che il diavolo usa il senso letterale, il poeta pagano quello spirituale (che poi, per Dante, ha valore storico quanto la lettera). Discendendo verso il Flegetonte, giù per la “ruina” causata dal terremoto in morte di Cristo, spesso le pietre si muovono sotto i piedi del poeta, “per lo novo carco”, cioè sotto il peso di un corpo vivo (Inf. XII, 28-30), ma il ‘nuovo’ è anche indice del sesto stato, del secolo che si rinnova, del nuovo avvento di Cristo nei suoi discepoli spirituali, che ripercorre il primo avvento del Salvatore, causa per cui, come afferma Virgilio, “in quel punto questa vecchia roccia, / qui e altrove, tal fece riverso” (vv. 44-45).
Il Limbo corrisponde alla sede divina prima dell’apertura da parte di Cristo del libro segnato da sette sigilli. Come questa apertura era desiderata e sospirata dagli antichi Padri, così lo è ora, nel secondo avvento; come all’apertura del sesto sigillo i segnati per milizia e privilegio precedono la turba innumerevole, così la schiera dei sommi cinque poeti coopta Dante, “sesto tra cotanto senno”; come nel sesto stato le genti saranno convertite “in spiritu magno et alto”, così nel nobile castello albergano gli “spiriti magni”, cioè le genti giuste, antiche (prima del Cristianesimo) e ‘moderne’ (i maomettani Avicenna, Averroè e il Saladino) in un processo della Redenzione ancora aperto che guarda a una nuova età di palingenesi e di conversione universale, che nel caso di Dante si realizza tramite la poesia.
[1] Sulla questione cfr. E. MOORE, Gli accenni al tempo nella Divina Commedia e loro relazione con la presunta data e durata della visione, vers. it. di C. Chiarini, Firenze 1900 (Biblioteca Critica della Letteratura Italiana diretta da F. Torraca; rist. anast., Roma 2007); G. INGLESE, in Dante Alighieri, Commedia. Revisione del testo e commento. Inferno, Roma 2007, pp. 51 (nt. a Inf. II, 1), 235 (nt. a Inf. XX, 129), 243-244 (nt. a Inf. XXI, 112-114). Le due indicazioni temporali, all’apparenza irrimediabilmente contrastanti, non lo sono se riferite la prima alla lettera recitata da Malacoda, la seconda al senso spirituale (anch’esso storico, non simbolico) del viaggio di Dante.
Tab. VI
Al termine della trattazione, nella quarta visione, della seconda guerra sostenuta dalla Chiesa (nel secondo stato, proprio dei martiri: Ap 12, 7-12), i cieli si allietano (modo di dire per cui trasferiamo i nostri affetti sulle cose inanimate) per la vittoria sul diavolo. Aumenta però l’ira di questi rivolta a tentare terra e mare, cioè quanti, tempestosi per vizi, aderiscono alle cose terrene; il diavolo discende su costoro in quanto è consapevole che, nell’imminenza del giudizio finale, gli resta poco tempo per tentare (Ap 12, 12).
|
||
[LSA, cap. XII, Ap 12, 12 (IVa visio, IIum prelium)] “Propterea” (Ap 12, 12), id est propter proiectionem demonum et propter tam triumphalem virtutem sanctorum martirum, “letamini, celi et qui habitatis in eis”. Celos vult letari, tum illo modo affectus quo res inanimatas alloquimur et nobiscum quasi coexaltare vel condolere appetimus; tum ut celi sumantur pro sanctis habitantibus in eis unde, secundum Ricardum, quod premittit: “celi” exponit cum subdit: “et qui habitatis in eis”*; tum quia per celos possunt intelligi superiores sancti sub quorum ali<s> inferiores habitant, vel sumuntur pro toto collegio in quo unusquisque stat sicut pars in suo toto.* In Ap IV, ii (PL 196, col. 802 A-B). |
||
Inf. XXVII, 7-12Come ’l bue cicilian che mugghiò prima
|
Purg. I, 22-27I’ mi volsi a man destra, e puosi mente
|
|
[segue 12, 12] Deinde explicat augmentum mali quod ex prefata diaboli deiectione subsequuntur terrestres et tempestuosi, unde subdit: “Ve terre”, id est terrenis et terrena amantibus, “et mari”, id est infidelibus vel quibuscumque tempestuosis per varia vitia fluctuantibus et per sevitiam amaris, “quia descendit diabolus ad vos”, scilicet per ampliorem potestatem vos temptandi sibi iuste permissam, quia scilicet tempore tante salutis et victorie per Christum et eius martires obtente, et manifesto exemplo et documento orbi toti ostense, aut nullatenus aut non sufficienter estis eos secuti. |
Inf. V, 28-30, 97-99Io venni in loco d’ogne luce muto,
|
|
[segue 12, 12] “Descendit” etiam “ad vos diabolus” plusquam ante, propter maiorem voluntatem et conatum vos gravius temptandi. Unde subditur: “habens iram magnam”, scilicet se ulciscendi de sua tanta deiectione facta a Christo et a sanctis, et quia non potest se ulcisci in eis vult saltem se ulcisci in nos. Habet etiam “iram magnam” ad hoc ut omne malum implendum, tamquam “sciens quod modicum tempus habet”, scilicet ad temptandum, id est quia scit tempus extremi iudicii cito venturum, et etiam quia scit magnam potestatem temptandi sibi interim super electos esse ablatam usque prope seculi finem, quo est iterum solvendus. |
||
Inf. XII, 14-15, 22-25
|
Purg. XIII, 118-123, 130-135Rotti fuor quivi e vòlti ne li amari
|
|
Tab. VII
[LSA, cap. I, Ap 1, 4-5 (Salutatio)] Deinde subdit a quo optat eam dari, insinuans trinam habitudinem esse dantis. Prima est Deus, ut in se ipso absolute et eternaliter existens. Secunda est eius spiritualis virtus, prout est ad varios influxus donorum spiritualium indistantissime ordinata et in ipsis participata et quasi multiplicata. Tertia est Christus in quantum homo, predicta dona nobis promerens et impetrans et dispensans.
|
|
Inf. VIII, 128; IX, 64; Purg. XXIII, 108; XXXIII, 41e già di qua da lei discende l’ertaE già venìa su per le torbide ondegià per urlare avrian le bocche apertea darne tempo già stelle propinque |
Inf. XXX, 112-114; Par. XVII, 16-18, 52-54E l’idropico: “Tu di’ ver di questo:
|
6. Due appelli al lettore (Inf. IX, 61-63; Purg. VIII, 19-21)
Ad Ap 10, 7 l’angelo dal volto solare (sesta tromba) giura che si compirà il “mistero”, cioè gli occulti giudizi di Dio, profeticamente preannunciati sotto veli mistici. L’esegesi del “mistero” conduce a una terzina famosa, l’appello al lettore che precede l’arrivo del messo celeste che apre la porta della città di Dite, chiusa a Virgilio dai diavoli che non vogliono farvi entrare Dante, anzi intendono rimandarlo indietro da solo per la buia strada (Inf. IX, 61-63). Le parole di questa terzina – “O voi ch’avete li ’ntelletti sani, / mirate la dottrina che s’asconde / sotto ’l velame de li versi strani” – risultano quasi tutte da una collazione di tre passi: l’esegesi del tema introduttivo della Lectura, da Isaia 30, 26; Ap 10, 7; Ap 13, 9. Il primo passo si riferisce alla dottrina settiforme di Cristo, nascosta nell’Antico Testamento sotto i veli profetici, che verranno tolti nel giorno in cui la luce della luna sarà come quella del sole. Il secondo è relativo ai giudizi divini, cioè ai ‘misteri’ preannunciati sotto il medesimo velame. Il terzo fa appello a coloro che hanno orecchio – «“Si quis habet aurem”, id est sanam intelligentiam dictorum et dicendorum, “audiat”» -, i quali, sulla base di quanto il testo sacro ha detto o dirà, debbono mantenersi nella tribolazione pazienti e confidenti nell’aiuto divino, perché verranno salvati contro quanti vogliono condurli in prigionia. Così l’arrivo del messo celeste salva i due poeti, ed è descritto con versi “strani”, cioè oscuri (Ap 5, 1), perché non è ancora tempo di aprire la dottrina di Cristo ai malvagi e agli indisposti nemici. La terzina è preceduta da altre due che espongono il tema del chiudere proposto ad Ap 10, 4: al minacciato sopravvenire del “Gorgón” che impietrisce, invocato dalle tre Furie, Virgilio fa volgere indietro il poeta e gli chiude il viso con le sue stesse mani, sciogliendo gli occhi del discepolo solo all’arrivo del messo celeste (Inf. IX, 55-60, 73).
Simmetrica all’episodio del discendere del messo celeste è, in Purg. VIII, la discesa dei due angeli che mettono in fuga il serpente nella valletta dei principi. Qui il tema del giurare levando in alto le mani (assente nell’episodio infernale) – come l’angelo dal volto solare – è fatto proprio da una delle anime che giunge e leva le mani intonando l’inno Te lucis ante (vv. 10-18). Subito dopo, il nuovo appello di Dante al lettore perché aguzzi gli occhi al vero, in quanto il velo è ora tanto sottile che il trapassarvi dentro risulta lieve (vv. 19-21). Il velo, ancora una volta, allude al “mistero” e, come afferma Gioacchino da Fiore (citato nell’esegesi di Ap 12, 6), i misteri del terzo stato generale del mondo (che corrisponde al sesto e settimo stato della Chiesa secondo Olivi) sono più sottili di quelli del primo e del secondo stato e pertanto meno necessitano di versi oscuri che ne nascondano la dottrina.
L’Inferno corrisponde al primo stato, quello del Padre (che comprende le prime cinque età del mondo, prima della venuta di Cristo); il Purgatorio al secondo stato, del Figlio (la sesta età, che inizia con l’avvento di Cristo) e al terzo, dello Spirito (il sesto e il settimo stato della sesta età), che si apre con l’apertura della porta di san Pietro (la porta del purgatorio). La valletta dei principi si inserisce nella zona in cui prevalgono ancora i temi del quinto stato della Chiesa, uno dei quali è l’attesa della nuova età. L’appello, che allude alla prossima apertura dei misteri del terzo stato, precede, come nel nono canto dell’Inferno, l’arrivo di qualcuno, in questo caso dei due angeli che vengono dal grembo di Maria (Purg. VIII, 25-42). La loro faccia che fa smarrire l’occhio è variante del tema dell’angelo che ha la faccia come il sole oppure del risplendere del volto Cristo nelle perfezioni trattate ad Ap 1, 16-17. È da notare che la levità del velo si contrappone agli “avversi ardori” del vento impetuoso cui è paragonato il messo celeste che apre la porta della città di Dite, e ciò corrisponde a quanto, con citazione di Gioacchino da Fiore, si dice ad Ap 15, 1 di Cristo, che venne prima per redimere “in spiritu levitatis” e che verrà per giudicare “in spiritu ardoris”.
Quelle che paiono due allegorie per eccellenza – “la dottrina che s’asconde / sotto ’l velame de li versi strani”, a Inf. IX, 61-63, e “’l velo … ora ben tanto sottile, / certo che ’l trapassar dentro è leggero”, a Purg. VIII, 19-21 – mostrano in realtà la differenza tra l’allegoria dei poeti e quella dei teologi di cui Dante parla nel Convivio (II, i, 2-15: 4). Si tratta di due velami del vero (o della dottrina) dei quali il primo nasconde, e il secondo nasconde assai meno non perché esprimano entrambi, a diversi livelli, “una veritade ascosa sotto bella menzogna”, cioè sotto la lettera-finzione della poesia, ma perché si riferiscono a due momenti storici differenti del viaggio, il primo (il tempo antico) in cui l’illuminazione è chiusa; il secondo (il tempo moderno, ovvero la soglia del sesto stato dell’Olivi, che equivale alla terza età di Gioacchino da Fiore, appropriata allo Spirito Santo) in cui è molto più sottile e aperta. Ciò corrisponde al teologico vedere le vicende di Cristo e della Chiesa come prefigurate nei fatti e nei detti dei profeti dell’Antico Testamento. Per i teologi, infatti, ha valore storico non solo la lettera, che non può essere quindi una finzione, lo ha anche l’allegoria con riferimento alla storia antica, “figura” della nuova.
Tacere gli eventi futuri, che sono anche giudizi divini, viene ingiunto a Dante da Cacciaguida nel momento in cui dice di Cangrande “cose / incredibili a quei che fier presente”, che corrispondono a ciò che l’angelo che giura chiama “mistero”, cioè “segreto”, occulto e incredibile ai mondani ma non agli eletti (Par. XVII, 91-93).
APPENDICE
1. Variazioni sul tema del vagus
Una delle cause che rendono chiuso il sesto sigillo – elemento centrale nella teologia della storia dell’Olivi – è lo straniarsi remoto e difforme da tutto ciò che è spirituale e deiforme, l’esser vago, l’alienarsi (ad Ap 5, 1). Per questo Cristo parla del giovane vago che se ne andò a perdersi in una regione lontana (Luca 15, 13), e degli erranti figli di Israele dice il profeta Isaia che “si sono volti indietro” (Is 1, 4), e nel Salmo è scritto: “Sui fiumi di Babilonia sedevamo piangendo, e ai salici sospendemmo le nostre cetre dicendo: come canteremo il cantico del Signore in una terra straniera?”, cioè in Babilonia (Ps 136, 1-4); e il profeta Baruc: “Perché, Israele, ti trovi nella terra dei nemici e sei invecchiata in una terra straniera?” (Bar 3, 10-11).
All’aprirsi del sigillo, Babilonia, la sposa adultera che si era alienata da Cristo, viene scossa da un grande terremoto e dall’ira dell’Agnello (Ap 6, 12-17), cui fa seguito la “signatio” della nuova milizia di Cristo (Ap 7, 3-8).
Nelle tre tabelle che seguono sono stati raccolti alcuni esempi di variazione sul tema del “vagus”.
I
■ La “femmina balba”, apparsa in sogno al poeta nel quarto girone della montagna, si trasforma in “dolce serena” che col piacere del suo canto distoglie i naviganti dal loro cammino: “Io volsi Ulisse del suo cammin vago / al canto mio” (Purg. XIX, 22-23; il tema è anticipato al momento dell’addormentarsi: “che li occhi per vaghezza ricopersi, / e ’l pensamento in sogno trasmutai” (Purg. XVIII, 144-145). L’aggettivo “vago” può essere variamente concordato (con Ulisse, nel senso di ‘desideroso di seguire il suo cammino’; con il cammino, nel senso di ‘errante’, o legato al canto che ‘invaghisce’); ha comunque un carattere che deriva dall’esegesi del sesto sigillo proposta in apertura del capitolo quinto: la difformità e il lontanissimo estraniarsi da ciò che è spirituale rendono chiuso il sigillo, onde Cristo parla del giovane vago che se ne andò in una terra lontana (Lc 15, 13) e Isaia dei figli vaghi che si sono volti indietro (Is 1, 4). Dei temi da Ap 5, 1 sono presenti nei versi l’essere vago e il canto, per cui è più probabile che Ulisse sia stato volto dal suo cammino perché invaghito del canto della sirena. Ad Ulisse e ai suoi compagni, lontani da casa e “vecchi e tardi” (Inf. XXVI, 106), ben si addice anche l’apostrofe di Baruc 3, 11 rivolta a Israele che invecchia in terra straniera.
Nei versi sono presenti anche temi dall’esegesi morale della terza tromba (in fine del cap. XI). Dopo la sollecitudine per la propria vita (contro cui si appunta la seconda tromba), interviene la sollecitudine del sapere, che si vanifica nella curiosità e nell’errore: contro di essa risuona la terza tromba, sopra l’acqua della sapienza cui l’intelligenza si ribella divenendo come una stella cadente nell’errore, designato dalla terza parte delle acque. Buona e dolce è l’acqua della scienza che concerne ciò che è vero e ciò che è utile: la scienza speculativa delle cose divine e la prudenza che regge le azioni costituiscono le due parti buone delle acque. Ma l’eccesso di sollecitudine verso sé stessi provoca la caduta di persone sante, che pure apparivano lucenti come stelle e ardenti come fiaccole, nelle acque del piacere carnale, messo da parte il piacere delle cose divine e il piacere che deriva dalle virtù e dalle sante opere.
Il riferimento del capitolo XI alla “cura sciendi”, cioè alla sollecitudine che deriva dal desiderio di sapere, ma che poi diventa colpevole curiosità errante, potrebbe suggerire l’interpretazione per cui Ulisse, nel suo cammino “a divenir del mondo esperto / e de li vizi umani e del valore”, sia stato portato lontano e reso “vago” dal canto della sirena, che non è quella del racconto omerico e nemmeno Circe, ma l’ansia di sapere fine a sé stessa che spinge a varcare i limiti imposti da Dio alla conoscenza umana, la quale per quei tempi era aperta all’esperienza dei costumi umani, dei vizi e delle virtù, della quale Orazio rende modello il greco, e che avrebbe dovuto essergli sufficiente, mantenendolo nel campo dell’intelligenza morale, di “color che ragionando andaro al fondo” e lasciarono “moralità” al mondo (Purg. XVIII, 67-69) [1].
Non diversamente la spada di Beatrice si appunta su Dante colpevole di aver ascoltato, errando, le sirene, mentre avrebbe dovuto muoversi “in contraria parte” (Purg. XXXI, 43-48). Uno “straniarsi” dalla sua donna che il poeta non ricorda più avendo bevuto l’acqua del Lete (Purg. XXXIII, 91-93).
Da notare i motivi dell’acqua e del piacere, nell’esegesi (capitolo XI) riferiti alla “cura sciendi, que cum evanescit fit curiosa et erronea” contro la quale suona la terza tromba, che Beatrice appropria ai pensieri del poeta, incrostati come l’acqua dell’Elsa, macchiati (cioè oscurati) come il gelso dal sangue di Piramo nel loro vano dilettare (Purg. XXXIII, 67-69). Sono i pensieri che gli hanno impedito di riconoscere moralmente, nel grande albero dell’Eden, la giustizia di Dio (vv. 70-72).
È probabile che in entrambi i casi, dell’eroe greco e del poeta, ad essere condannata, per quanto avvolta con reticenza in un comune riferimento ai beni terreni (nella semantica del piacere e del vaneggiare), sia la ragione che travalica i propri limiti, cioè la filosofia. Se lo straniarsi appartiene alla Babilonia storica, non bisogna dimenticare che ciascuno di noi ha una propria Babilonia interiore la quale, come afferma Olivi, deve essere bruciata e uccisa per poter cantare alleluia ed entrare alle nozze dell’Agnello (Ap 19, 10).
Gli stessi temi che tengono chiuso il sesto sigillo (l’esser vago, diverso, remoto) sono appropriati all’allontanarsi dei Domenicani dai precetti del fondatore quali pecore remote e vagabonde (Par. XI, 124-129: da notare in particolare l’espressione “che per diversi salti non si spanda”, dove “salto” equivale a “selva”; vagheggiare in senso positivo e vaneggiare sono anche nel canto precedente, vv. 92, 96). L’estraniarsi di Dante da Beatrice è assimilabile, almeno in parte, a quello dei membri di un ordine religioso dal proprio fondatore.
■Nel quarto girone della montagna, il tema dell’esser vago è anticipato al momento dell’addormentarsi: “che li occhi per vaghezza ricopersi, / e ’l pensamento in sogno trasmutai” (Purg. XVIII, 144-145). Interviene qui il tema del torpore e del sonno, proprio della quinta chiesa d’Asia. Al vescovo di Sardi, così ozioso e intorpidito da non avere più in mente il suo primo stato di grazia, viene minacciato il repentino giudizio divino che verrà su di lui come un ladro, che arriva di nascosto all’improvviso, senza che si sappia l’ora della venuta (Ap 3, 3). Il torpore di cui è accusato il vescovo di Sardi è lo stesso di Dante, ignaro del suo essersi ritrovato nella selva oscura, descritto in apertura del poema: “Io non so ben ridir com’ i’ v’intrai, / tant’ era pien di sonno a quel punto / che la verace via abbandonai” (Inf. I, 10-12).
“Vago” è il poeta di percorrere la divina foresta dell’Eden (Purg. XXVIII, 1-2). Ma non si tratta di un cammino come quello da cui fu volto Ulisse, per cui “per lui, perduto, a morir gissi” (Inf. XXVI, 84), né di uno smarrirsi nella selva (nonostante la simmetria tra “tanto, ch’io / non potea rivedere ond’ io mi ’ntrassi” [Purg. XXVIII, 23-24] e “Io non so ben ridir com’ i’ v’intrai, / tant’ era pien di sonno …” [Inf. I, 10-11]), perché, dopo aver visto “il temporal foco e l’etterno”, il suo arbitrio è “libero, dritto e sano” e può prendere per guida il proprio piacere, che non è più la “dulcis voluptas” delle cose mondane di cui era piena la “dolce serena” apparsagli nel secondo sogno fatto sulla montagna (Purg. XXVII, 127-142).
■ Il drago che nelle vicissitudini del carro-Chiesa se ne va “vago vago” (Purg. XXXII, 130-135) mostra anch’esso il tema dello straniarsi remoto e difforme da tutto ciò che è spirituale e deiforme, l’esser vago, l’alienarsi. Dopo le due discese dell’aquila (la prima delle quali corrisponde al secondo stato, dei martiri), intervallate dall’avvento di una volpe messa in fuga da Beatrice (terzo stato, dei dottori che confutano le eresie), apertasi la terra tra le due ruote del carro, il drago ne esce figgendo la coda su di esso e, ritraendola “come vespa che ritragge l’ago”, ne strappa e porta con sé una parte del fondo. Come già interpretarono i contemporanei di Dante, si tratta dei Saraceni, che a partire dal quarto stato occuparono molti territori dove prima fioriva la fede cristiana e in particolare la santa vita degli anacoreti. La bestia saracena, come si sostiene ad Ap 6, 3, è “diversa” dalle altre; così l’esser vago vago del drago allude alla legge di Maometto, contraria a Cristo più di quanto lo fossero state la legge dei Giudei e quella dei Gentili, che poi sparirono e contro le quali si poteva argomentare con la Scrittura. La “difformitas et semotissima extraneitas … ad omnia spiritualiora et deiformiora opposita” di Ap 5, 1 si congiunge con l’essere dissimile della quarta bestia, che corrisponde al cavallo pallido che si mostra all’apertura del quarto sigillo (Ap 6, 8), designante Maometto e la sua mortifera legge. Allora anche i pensieri “diversi”, tra i quali vaneggia la mente del poeta tanto “che li occhi per vaghezza ricopersi, / e ’l pensamento in sogno trasmutai” (Purg. XVIII, 141-145), alludono alla quarta bestia dissimile, tanto che la “femmina balba” che viene in sogno è tessuta con i fili di Iezabele, la profetessa falsa e carnale come la legge di Maometto, descritta nell’istruzione a Tiàtira, la quarta delle chiese d’Asia (Ap 2, 18 sgg.). I temi della bestia saracena, “dissimilis” perché “nostras scripturas non recipit” (Ap 6, 3) sono parodiati con la “sì diversa cennamella”, tanto diversa da “cose nostrali”, usata da Barbariccia per dare un cenno di partenza alla schiera dei Malebranche (Inf. XXII, 9-10; nello stesso canto l’essere “invaghito” è appropriato a Calcabrina, v. 134; da notare al v. 136 la forma disparito, dove ad Ap 6, 3 dissimilis si accompagna a disperierunt: i passi in 5, 1 e 6, 3 sono analogicamente congiunti dal tema della difformità).
Tra le vicende allegoriche del carro, la meretrice che siede sopra di esso appare al poeta “con le ciglia intorno pronte”, e gli rivolge “l’occhio cupido e vagante” suscitando il sospetto e l’ira del gigante che vigila su di essa (la casa di Francia che vigila sul papato, Purg. XXXII, 154-156).
[1] Ci si domanda chi sia la sirena, o meglio a che punto del viaggio di Ulisse sia intervenuta: se sia da identificare con Circe (secondo gli antichi commentatori, ma Circe non stava “in mezzo mar”, bensì “là presso a Gaeta, / prima che sì Enëa la nomasse”, Inf. XXVI, 90-93), oppure se sia intervenuta prima della sosta presso Circe (il che introdurrebbe un non giustificato elemento di novità nella vicenda narrata da Ulisse in prima persona), o dopo. Il confronto testuale con l’esegesi dell’esser vago, che rende chiuso il sesto sigillo e conduce in lontana parte ad invecchiare in un luogo dove non si può cantare il canto del Signore, induce a pensare che la sirena sia intervenuta dopo la sosta presso Circe, e designi l’ardore del desiderio che il libro della conoscenza venga aperto tutto prima del tempo. Perché è proprio al sesto stato, al futuro, che Ulisse vuole andare, anche se non sa di tutti i successivi sviluppi della storia umana. Sulla soglia della sesta età del mondo, in vista della montagna, si perde e il suo allegrarsi torna in pianto.
“Serena” concorda con l’essere “serenus” dell’esegesi, cioè con l’“inspectio serena” che precede l’“inebriatio extatica” (ad Ap 7, 8 identificate rispettivamente con la tribù di Giuseppe e con quella di Beniamino), e con l’“aer serenus” del sesto e del settimo stato, quando il libro è compiutamente aperto al vedere, e la faccia di Cristo splende come il sole, per cui si entra “ad serenam pacem archane contemplationis Dei” (Ap 15, 8; 16, 17). L’accenno a Ulisse da parte della femmina balba-sirena si colloca in una zona riferibile al quarto stato, il periodo dell’alta contemplazione e del volo anagogico, dopo una zona (a partire da Purg. XVIII, 76) nella quale prevalgono i temi del terzo stato, l’età dell’uomo razionale frenato dalla legge. Ci si può chiedere ancora se la fonte classica di Dante non sia stata il De finibus di Cicerone (V, xviii, 49), dove le sirene promettono scienza agli uomini che ne sono cupidi.
All’inciso – “ideo tertium tubicinium fit super aquas sapientie, cui intelligentia rebellans est quasi stella cadens in varios errores” (cap. XI, interpretazione morale delle sette trombe) -, riferito al tubicinare del terzo stato del quale è proprio dare la legge, conducono le parole di Virgilio, cioè di colui che per antonomasia designa la ragione: “ché quello imperador che là sù regna, / perch’ i’ fu’ ribellante a la sua legge, / non vuol che ’n sua città per me si vegna” (Inf. I, 124-126). Come lo stesso Virgilio afferma in Purg. VII, 25-27, il suo difetto è stato “non per far, ma per non fare”. Virgilio intende dire che il senso morale, proprio dell’uomo razionale (e di cui sono la più alta espressione gli antichi ‘dottori’, prefigurazione di quelli della Chiesa) avrebbe dovuto essergli sufficiente “per far”, cioè “per adorar debitamente a Dio”? L’“innata libertate”, della quale si accorsero “color che ragionando andaro al fondo … però moralità lasciaro al mondo” (Purg. XVIII, 67-69) avrebbe dovuto fargli conoscere la giustizia di Dio “moralmente”, come dice Beatrice a Dante stesso a proposito dell’albero dell’Eden (Purg. XXXIII, 70-72)? È il problema della salvezza delle genti giuste, “quello / dubbio che m’è digiun cotanto vecchio” che l’Aquila ben conosce (Par. XIX, 32-33) e che risolve in una non conoscenza, cioè nell’affermazione della radice ignota, ai mortali e agli stessi beati, della predestinazione, e nell’esempio di Rifeo Troiano al quale fu aperta la vista verso la storia futura, per cui accettò la fede in Cristo: “Dio li aperse / l’occhio a la nostra redenzion futura; / ond’ ei credette in quella” (Par. XX, 122-124; 130-138).
Tab. App. I
Par. X, 91-96; XI, 124-129Tu vuo’ saper di quai piante s’infiora
|
Inf. XXVI, 83-84, 106-108non vi movete; ma l’un di voi dica
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (VIum sigillum)] Prima (causa) est quia septem sunt defectus in nobis claudentes nobis intelligentiam huius libri. […] Sextus est ad omnia spiritualiora et deiformiora opposita difformitas et semotissima extraneitas, propter quod adolescens vagus dicitur a Christo abisse in regionem longinquam (Lc 15, 13), et de filiis vagis dicitur Isaie I° quod “<ab>alienati sunt retrorsum” (Is 1, 4), et in Psalmo dicitur: “Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?” (Ps 136, 4), scilicet in Babilone, que confusio interpretatur; et Baruch III° dicitur: “Quid est, Israel, quod in terra inimicorum es; inveterasti in terra aliena?” (Bar 3, 10-11).
|
|
Purg. XXXI, 43-48; XXXIII, 67-72, 91-93
|
Purg. XVIII, 139-145; XIX, 19-24Poi quando fuor da noi tanto divise
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 3 (IIa visio, in apertione IIi sigilli)] Sicut etiam per equum pallidum, cuius sessor est mors, designatur Sarracenorum populus et eius propheta mortiferus, scilicet Mahomet, sic et per quartam bestiam dissimilem ceteris. Hec enim est dissimilis ceteris in tribus. Primo scilicet quia Iudeorum regnum et paganorum et hereticorum confluxerunt ad tempus cum fidelibus Christi et tandem disperierunt, sed bestia sarracenica surgens in quarto tempore confligit et perdurat in toto quinto et pertinget usque ad sectam Antichristi, propter quod hic dicitur quod “infernus”, id est infernalis secta Antichristi, “sequebatur eum”, scilicet equum pallidum et sessorem eius (Ap 6, 8). Secundo est eis dissimilis quia prima tria regna non habuerunt novam legem contrariam Christo. Nam lex Iudeorum, scilicet lex vetus, non fuit realiter contraria Christo, immo potius eius, nec lex nova quam heretici fingunt se sequi. Pagani autem legem non habuerunt quasi a Deo datam, sed solum legem naturalem in civilibus civiliter explicatam. Sarraceni autem habent legem carnalem et falsam a Mahomet, quasi a Dei propheta, datam. Tertio est dissimilis quia contra istam non possunt fideles arguere per scripturas sacras sicut possunt contra Iudeos et contra hereticos, quia ista nostras scripturas non recipit, nec per rationem naturalem potest sic faciliter et evidenter convinci sicut poterat idolatria paganorum, quia isti non idola nec plures deos sed solum unum deum colunt. Et insuper sapientes eorum ab antiquo philosophicis vacant et specialiter philosophie Aristotelis, unde et christiani latini acceperunt ab eis comenta super libros Aristotelis et plura alia de scientia medicinali, et etiam de quadrivio et specialiter de astronomia, ita ut iam multa scripta theologorum latinorum sunt Sarracenorum auctoritatibus farcita et fedata, in quo satis est signum quod infernus sequatur sectam illam. Preterea bestia hec non sustinet fidem Christi inter eos predicari aut aliquid contra eorum legem dici, immo statim morte punitur. Non sic autem fuit in tribus primis. |
|
II
■ Il vagheggiare è connesso all’adolescenza, perché Cristo parla del giovane vago che andò a perdersi in una regione lontana (Luca 15, 13; ad Ap 5, 1). L’adolescenza è congiunta con l’errore: nel Notabile III del prologo si dice che lo zelo si appunta, nel terzo stato, “contra adolescentiam levem et in omnem ventum erroris agitatam”, dopo che nel primo ha contrastato la “fatua infantia” e nel secondo la “pueritia inexperta”. Ad Ap 6, 5 (apertura del terzo sigillo), colui che siede sopra il cavallo nero – designa gli imperatori o i vescovi ariani – ha in mano una bilancia. La stadera misura la quantità dei pesi, e sta ad indicare la misurazione degli articoli di fede. Quando la misurazione avviene secondo la retta e infallibile regola di Cristo, allora il peso è giusto; quando invece la misurazione si fonda sull’errore e sul falso e torto accoglimento della Scrittura, allora la stadera è dolosa. Sono temi presenti nelle parole di Marco Lombardo, allorché dice dell’anima che esce dalle mani del Creatore, “che la vagheggia / prima che sia, a guisa di fanciulla / che piangendo e ridendo pargoleggia”, la quale, “semplicetta che sa nulla”, s’inganna correndo dietro questo o quel bene materiale, se la legge non le pone un freno (Purg. XVI, 85-96; da notare al v. 93 l’uso del verbo torcere in senso positivo, all’opposto di Ap 6, 5). Sul vagheggiare da parte del Creatore è da considerare anche quanto dice Beatrice di Adamo a Par. XXVI, 82-84, dove intervengono temi dall’istruzione a Laodicea, la settima delle chiese d’Asia (Ap 3, 14).
Il terzo stato (i dottori) percorre sulla montagna con i suoi motivi l’intero terzo girone degli iracondi. I temi – che rappresentano il massimo sviluppo loro dato nella Commedia – occupano una vasta zona: affiorano già in Purg. XV, commisti nel passaggio dal secondo al terzo girone con quelli del secondo stato, e proseguono fino a Purg. XVIII, quando nel quarto girone il riferimento astronomico ai versi 76-81 segna il pieno passaggio al quarto stato degli anacoreti (con temi provenienti dalla quarta tromba e dalla quarta chiesa).
I temi della fantasia e dell’errore, precipui della terza vittoria (che consiste nella vittoriosa ascesa al di sopra della fantasia che muove dal senso, causa di errore e di eresia; Ap 2, 17), emergono con evidenza. Cessate le visioni estatiche di mansuetudine, che precedono l’episodio di Marco Lombardo, il poeta, tornato con l’anima “a le cose che son fuor di lei vere”, riconosce che le cose da lui viste erano “non falsi errori”, errori in quanto non esistenti nella realtà, non falsi come esperienza di visione soggettiva (Purg. XV, 115-117).
Andando a ritroso nei versi, si registra un anticipo dell’anima vagheggiata dal Creatore “a guisa di fanciulla, / che piangendo e ridendo pargoleggia” (Purg. XVI, 85-87) nello scherzare del sole a guisa di fanciullo nelle prime tre ore del giorno, che è sviluppo della leggera e agitata adolescenza assegnata nel Notabile III del prologo al terzo stato (Purg. XV, 1-6). Oltre che riferimento astronomico alle oscillazioni del moto solare apparente fra i due tropici, sarà pertanto da intendere nel senso di un’allusione alla luminosità non ancora matura, “quae semper tremulat et est in motu, sicut puer ludendo” come lo intendeva Pietro di Dante, oppure che cresce via via fino al meriggio (che corrisponde alla maturità). Si può anche fare riferimento al tema, sempre nel Notabile III del prologo, della “pueritia inexperta” (secondo stato, proprio dei martiri), che congiunto con quello del combattimento si registra nella visione estatica del martirio di santo Stefano, “un giovinetto … in tanta guerra”, che compare nel terzo girone del purgatorio tra gli esempi di mansuetudine (Purg. XV, 106-114).
■ Vagheggiare ed errore sono compresenti in principio di Par. VIII: Venere è “la stella / che ’l sol vagheggia or da coppa or da ciglio”, la quale “le genti antiche ne l’antico errore” onoravano insieme alla madre (Dione) e al figlio (Cupido, nel quale si annida il tema dell’adolescenza). Il sole che vagheggia la stella “or da coppa or da ciglio” (in simmetria con Dio che vagheggia l’anima “che piangendo e ridendo pargoleggia” a Purg. XVI, 85-87; cfr. Elice che vagheggia il figlio Arcade a Par. XXXI, 33) può essere ricondotto a quanto, ad Ap 5, 1, si dice sulla terza causa della chiusura dei sigilli, determinata dal libro dell’Antico Testamento, che sul suo involucro mostra sette apparenze. La settima sta nella fluttuante volubilità del Vecchio Testamento (il tempo de “le genti antiche ne l’antico errore”), involuto nelle ombre oscure delle figure che lo coprono, come un mare procelloso e vertiginoso la cui voragine non abbia fondo, o come una nube densa e tetra che ora si tinga di rosso ora appaia pallida o verde o bianca, ora in un luogo ora in un altro (la coppa o il ciglio di Venere). Questa oscurità viene aperta dal nudo intelletto e dalla semplicità della fede e della sapienza di Cristo, cosicché taccia ogni contraddizione o litigio tra Vecchio e Nuovo Testamento. È da notare che a Venere sono appropriati temi della quinta delle chiese d’Asia, Sardi, bella nel suo principio, quando possedeva tutte le perfezioni stellari, poi corrottasi (Ap 3, 3).
■ Altra variazione sui temi del vagheggiare e dell’errare è in Par. X. Il poeta invita il lettore a levare con lui lo sguardo “a l’alte rote” dei cieli, “dritto a quella parte / dove l’un moto e l’altro si percuote”, cioè agli equinozi, punti di incontro dei due opposti movimenti rotatori, quello diurno equatoriale di tutti i corpi celesti da est a ovest, e quello annuo zodiacale (o dell’eclittica) dei pianeti da ovest a est (vv. 7-9). L’arte del divino maestro, che ama la propria opera creata e che il lettore deve cominciare a “vagheggiar”, provvede alla sua conservazione. Così lo zodiaco, in cui si muovono le orbite del sole e degli altri pianeti, è “oblico”, ossia inclinato, rispetto al piano (il “dritto”) dell’equatore celeste di circa 23° e mezzo. Questa inclinazione dello zodiaco rispetto all’equatore viene incontro ai bisogni della vita sulla terra, essa è un giusto ‘torcersi’ dal “dritto”, secondo quanto esposto ad Ap 6, 5 sulla bilancia che misura la retta o intorta interpretazione della Scrittura. Se infatti la strada percorsa dalle orbite dei pianeti, cioè lo zodiaco, “non fosse torta, / molta virtù nel ciel sarebbe in vano, / e quasi ogne potenza qua giù morta”; e se poi “dal dritto più o men lontano (cfr., ad Ap 5, 1, “dicitur … abisse in regionem longinquam”) / fosse ’l partire”, se cioè il divergere dello zodiaco dall’equatore fosse maggiore o minore di quello che è, ne conseguirebbero manchevolezze nell’ordine del mondo, in terra e in cielo, con grave alterazione dei climi (vv. 10-21). Questo torcersi obliquamente dei pianeti, che si allontanano dal “dritto” in modo equilibrato (tema della bilancia, da Ap 6, 5), avviene per “sodisfare al mondo che li chiama”, e corrisponde al “declinare” della vita della grazia che condiscende verso le moltitudini dopo l’ardua e a lungo insostenibile vita solitaria degli anacoreti, che è tema proprio del quinto stato. Da notare, in Par. X, 26-27, l’appropriazione dei motivi, ancora da Ap 6, 5, del ‘torcere’ e della ‘scrittura’ al poeta, che invita il lettore a cibarsi da solo della materia che gli ha messo innanzi, “ché a sé torce tutta la mia cura / quella materia ond’ io son fatto scriba”.
■ Al suonare dell’alto corno di Nembrot, il poeta crede di vedere “molte alte torri”, ma Virgilio gli spiega, “acciò che ’l fatto men ti paia strano” che, poiché “’l senso s’inganna di lontano”, egli male discerne (“nel maginare abborri”) scambiando per torri quelli che sono giganti. Man mano che s’avvicina e vede meglio come per nebbia che si dissipa, in Dante fugge l’errore (il mettere in fuga la nebbia e l’errore è tema della terza vittoria: Ap 2, 17) e cresce la paura (Inf. XXXI, 19-39). “Lontano” rima con “strano” (vv. 26.30): entrambi i termini si trovano nell’esegesi ad Ap 5, 1, il cui tema principale, ora taciuto, è il vagheggiare. La stessa domanda di Dante – “Maestro, dì, che terra è questa?” (v. 21) – ricorda quella di Baruc 3, 10: “Quid est, Israel, quod in terra inimicorum es?”.
■ C’è anche un esser vago che non erra, ché anzi si giustifica per la verità. Bonagiunta da Lucca, che purga la gola nel sesto girone della montagna, è “anima … che par sì vaga / di parlar”, e se le parole su Gentucca, la donna che farà piacere Lucca al poeta fiorentino, insinuano “errore”, cioè il dubbio, questo verrà sciolto dai veri fatti (Purg. XXIV, 40-48). Piccarda è “l’ombra che parea più vaga / di ragionar”, e Beatrice invita l’amico a parlare, “ché la verace luce che le appaga / da sé non lascia lor torcer li piedi”, cioè non consente che errino (Par. III, 31-36).
Tab. App. II
Purg. XV, 1-6, 115-117; XVI, 85-93; Par. XXVI, 82-84Quanto tra l’ultimar de l’ora terza
|
[LSA, prologus, Notabile III] Item (zelus) est septiformis prout fertur contra quorundam ecclesie primitive fatuam infantiam (I), ac deinde contra pueritiam inexpertam (II), et tertio contra adolescentiam levem et in omnem ventum erroris agitatam (III), et quarto contra pertinaciam quasi in loco virilis et stabilis etatis se firmantem (IV), quinto contra senectutem remissam (V), sexto contra senium decrepitum ac frigidum <et> defluxum (VI), septimo contra mortis exitum desperatum et sui oblitum (VII).
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (clausura VIIi sigilli)] Tertia ratio septem sigillorum quoad librum Veteris Testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. […] Septimum est sensuum veteris scripture fluctuans volubilitas et involucrorum seu tegumentorum figuralium umbrositas et obscura multiformitas, unde e<s>t sicut mare procellosum et vertiginosum et voraginosum et quasi non habens fundamentum seu fundum. Est etiam sicut nubes densa et tetra, nuncque rubescens nunc vero pallescens, nunc virens nunc albens, et nunc in uno loco et nunc in alio. Hanc autem aperit intellectualis nuditas et simplicitas fidei et sapientie Christi, prout Apostolus IIa ad Corinthios III° docet. Hanc autem plenius aperiet Christus, cum implebitur illud quod sub sexto angelo tuba canente iurat et clamat angelus tenens librum apertum, scilicet quod “in diebus septimi angeli, cum ceperit tuba canere, consumabitur”, id est ad plenum implebitur et explicabitur, “misterium Dei sicut evangelizavit per servos suos prophetas” (Ap 10, 6-7). Tunc enim omnis litigatio et contradictio inter vetus et novum omnino silebit, prout notat apertio septima (cfr. Ap 8, 1). |
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (VIum sigillum)] Prima (causa) est quia septem sunt defectus in nobis claudentes nobis intelligentiam huius libri. […] Sextus est ad omnia spiritualiora et deiformiora opposita difformitas et semotissima extraneitas, propter quod adolescens vagus dicitur a Christo abisse in regionem longinquam (Lc 15, 13), et de filiis vagis dicitur Isaie I° quod “<ab>alienati sunt retrorsum” (Is 1, 4), et in Psalmo dicitur: “Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?” (Ps 136, 4), scilicet in Babilone, que confusio interpretatur; et Baruch III° dicitur: “Quid est, Israel, quod in terra inimicorum es; inveterasti in terra aliena?” (Bar 3, 10-11).
|
|
Inf. XXXI, 19-33, 37-39Poco portäi in là volta la testa,
|
Par. X, 7-27Leva dunque, lettore, a l’alte rote
|
III
■ Il riferimento del Salmo 136, 4 al pianto dei figli di Israele, vaghi nell’esilio (la citazione ad Ap 5, 1 è completata da quella ad Ap 14, 8; a quest’ultimo passo rinvia l’effetto del rimprovero di Beatrice a Purg. XXXI, 7-9) è nell’essere gli occhi del poeta vaghi di piangere di fronte alla “molta gente” e alle “diverse piaghe” della nona bolgia (Inf. XXIX, 1-3). “Diverse” è da intendere nel senso di “strane” (Ap 5, 1) o “dissimili” (Ap 6, 3), al modo della “sì diversa cennamella” usata da Barbariccia per dare un cenno di partenza alla schiera dei Malebranche (Inf. XXII, 9). E veramente le piaghe inferte ai seminatori di scandalo e di scisma, rotti e tagliati nelle membra, li rendono lontanissimi dalla compiuta figura umana, che si realizza nel sesto stato, quando si rinnova la vita evangelica e l’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio nel sesto giorno della creazione, assomiglia in modo più perfetto al suo esemplare. Nello stesso canto, “vaghezza” è attribuita ad Albero da Siena, che mandò al rogo il suo familiare Griffolino d’Arezzo solo perché questi non gli insegnò come volare dopo essersi vantato di saperlo fare. Anche questa “vaghezza e senno poco” indica la lontananza da ciò che è deiforme, perché l’uomo creato nel sesto giorno è uomo razionale (il “senno poco” di Inf. XXIX, 114 corrisponde alla “mente torta” di Ecuba ad Inf. XXX, 21).
■ Il tema della difformità e dello straniarsi, unito a quello del pianto e del lamento (presente anche nella sesta coppa, ad Ap 16, 16, dove le lamentazioni di Geremia per la morte del re Giosia sono assimilate al pianto sulla morte di Cristo), risuona nei “lamenti in su li alberi strani” fatti dalle Arpie nella selva dei suicidi (Inf. XIII, 15). I “lamenti … strani” sottolineano anche qui la difformità rispetto a quanto è deiforme, perché l’anima feroce dei peccatori puniti in quella selva si è divisa essa stessa dal proprio corpo. L’uomo razionale, creato nel sesto giorno assimilato al sesto stato, è stato offeso: “Uomini fummo, e or siam fatti sterpi”, dice Pier della Vigna (v. 37), mentre le “brutte Arpie” designano gli uccelli immondi creati nel quinto giorno assimilato al quinto stato, prima dell’uomo. Questi “lamenti … strani” si accomunano alle “diverse piaghe” della nona bolgia, ed è contiguità non solo apparente, perché il confronto dei testi consente di affermare che suicidi e seminatori di scandalo e di scisma sono tessuti sulla stessa parte di panno, quella che riunisce i temi del terzo stato, proprio dei dottori che confutarono le eresie che divisero la Chiesa. Così, al termine della quarta zona dell’Inferno in cui i temi del terzo stato sono prevalenti (che comprende la nona bolgia, dove sono puniti i seminatori di scandalo e di scisma), il motivo dello straniarsi risuona ancora sulla soglia della successiva e ultima bolgia, dove sono puniti i falsari: “lamenti saettaron me diversi, / che di pietà ferrati avean li strali” (Inf. XXIX, 43-44), prima che la descrizione delle pene dia luogo ai temi del quarto stato.
■ Se i “lamenti … strani” sono all’opposto dell’umano e del razionale e rendono chiuso il sesto sigillo, la cui apertura è segnata dalla più chiara intelligenza della Scrittura e dalle maggiori illuminazioni spirituali, i “versi strani” di Inf. IX, 61-63 sono i più lontani da quell’intelligenza e da quelle illuminazioni, e per questo il poeta fa appello a coloro che hanno “li ’ntelletti sani” affinché mirino la dottrina di Cristo che si nasconde sotto il loro velame, che non è ancora tempo di aprire di fronte ai malvagi e agli indisposti. Ai “lamenti … diversi” di Inf. XXIX, 43 consegue una chiusura (“ond’ io li orecchi con le man copersi”), come i “versi strani” di Inf. IX, 63, i quali chiusi nascondono la dottrina di Cristo che solo quanti hanno “li ’ntelletti sani” possono scorgere, sono preceduti dalla chiusura degli occhi di Dante alla venuta della Gorgone (vv. 59-60: “e non si tenne a le mie mani, / che con le sue ancor non mi chiudessi”), corrispondente alla chiusura imposta al profeta Daniele nell’Antico Testamento (Ap 10, 4).
■ Essere vago e piangere sono congiunti (Ap 5, 1; 14, 8); il pianto è anche desiderio di apertura del libro, cosa che solo Cristo può fare. Così ad Ap 5, 4 Giovanni piange a nome di tutti i santi padri, che sospirano con desiderio, poiché non si trova alcuno degno di aprire il libro. Sono congiunti nell’esegesi anche l’essere vago e il sospendere. Nel cielo ottavo Beatrice attende l’arrivo delle schiere del trionfo di Cristo, rivolta verso il meridiano come l’uccello innanzi l’alba “previene il tempo in su aperta frasca, / e con ardente affetto il sole aspetta”. L’attendere è tema proprio del quinto sigillo (Ap 6, 11), l’aprirsi e l’alba sono motivi del sesto stato. La donna “stava eretta e attenta” (sesta vittoria: Ap 3, 12), “sospesa e vaga” (motivi che segnano la contemplazione e la momentanea chiusura del sesto sigillo), mentre il poeta si fa desideroso: “fecimi qual è quei che disïando / altro vorria, e sperando s’appaga” (Par. XXIII, 1-15; cfr. la similitudine con la ninfa Eco, “quella vaga”, a Par. XII, 13-15). Da notare il valore ambiguo dell’essere “sospesi”, che da una parte indica il desiderio di qualcosa che non si ha, dall’altra lo stare assorti nella contemplazione, un’ambiguità di cui sono pregni “color che son sospesi” nel Limbo (cfr. Purg. X, 104; XV, 84; XXVII, 106).
■ Desiderio ed esser vago sono appropriati a Dante, bramoso di vedere attuffato nella palude Filippo Argenti (Inf. VIII, 52-57), anche se nel caso il tema del desiderio è da ricondurre al desiderio di vendetta dei santi all’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 10) piuttosto che al desiderio di Giovanni ad Ap 5, 4.
Tab. App. III
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (VIum sigillum)] Prima (causa) est quia septem sunt defectus in nobis claudentes nobis intelligentiam huius libri. […] Sextus est ad omnia spiritualiora et deiformiora opposita diffor-mitas et semotissima extraneitas, propter quod adolescens vagus dicitur a Christo abisse in regionem longinquam (Lc 15, 13), et de filiis vagis dicitur Isaie I° quod “<ab>alienati sunt retrorsum” (Is 1, 4), et in Psalmo dicitur: “Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?” (Ps 136, 4), scilicet in Babilone, que confusio interpretatur; et Baruch III° dicitur: “Quid est, Israel, quod in terra inimicorum es; inveterasti in terra aliena?” (Bar 3, 10-11).
|
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 16 (Va visio, VIa phiala)] Vel forte scriptura sacra voluit hoc bellum assimilare illi bello in quo rex Iosias est in Magedon occisus, prout dicitur IIII° Regum XXIII° (4 Rg 23, 29) et II° Paralipomenon XXXV° (2 Par 35, 20-25), ubi et dicitur quod Ieremias cum tota Iudea et Iherusalem vehementissime planxit eum et fecit lamenta-tiones super eum, cui quidem planctui assimilatur planctus mortis Christi a tribubus Israel convertendis fiendus, prout dicitur Zacharie XII° (Zac 12, 11-14). Et secundum hoc, <huic> nom<ini> Magedon, quod interpretatur temptatio, adiungitur ar, quod interpretatur suscitatio vel vigilie; vel her, quod interpretatur vigilans vel consurgens vel effusio, ut sic scriptura insinuet quod in magno prelio Antichristi et regum suorum re<nov>abitur magnus planctus crucis Christi et martirum eius, et consurget magna effusio temptationis in qua diabolus Anti-christus cum suis attente pervigilabit. |
Inf. IX, 58-63Così disse ’l maestro; ed elli stessi
|
Inf. XIII, 15fanno lamenti in su li alberi straniInf. XXIX, 1-3, 43-45, 112-114La molta gente e le diverse piaghe 6, 3
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 8 (IVa visio, VIum prelium)] Secundus autem angelus seu doctor predicat amotionem precipui impedimenti ad agendum predicta seu expeditionem intrinseci et domestici obstaculi. Predicat enim casum Babilonis, id est ecclesie carnalis, dicens: “Cecidit, cecidit Babilon illa magna” (Ap 14, 8).
|
|
Purg. XXXI, 7-9Era la mia virtù tanto confusa,
|
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 4 (radix IIe visionis)] Quartum est vehemens desiderium Iohannis de libri apertione grandi fletu ipsius ostensum, ibi: “Et ego flebam multum” (Ap 5, 4). […] Deinde subditur gemitus Iohannis procedens ex desiderio apertionis et ex visa impossibilitate et indignitate omnium ad ipsam complendam. Ait enim: “Et ego flebam multum, quoniam nemo dignus inventus est aperire librum nec videre illum”. Iohannes tenet hic typum omnium sanctorum patrum salvatorem et divine gratie et glorie promeritorem et impetratorem et largitorem desiderantium et pro eius dilatione et inaccessibilitate gementium. Hic autem gemitus pro tanto est in sanctis post Christi adventum pro quanto ad ipsum pro consumatione totius ecclesie et pro gratia et gloria per ipsum impetranda et largienda toto corde suspirant, et pro quanto cum humili gemitu recognoscunt nullum ad hoc fuisse potentem et dignum nisi solum Christum; potissime tamen designat cetum et statum contemplativorum, qui pre ceteris altius et viscerosius ad istud suspirant. […] Item fletus hic quantus fuit in sanctis patribus ante Christum; cum etiam essent in limbo inferni, quanto desiderio suspirabant ut liber vite aperiretur eis et omnibus cultoribus Dei! |
|
Par. XXIII, 7-15
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (VIum sigillum)] Prima (causa) est quia septem sunt defectus in nobis claudentes nobis intelligentiam huius libri. […] Sextus est ad omnia spiritualiora et deiformiora opposita diffor-mitas et semotissima extraneitas, propter quod adolescens vagus dicitur a Christo abisse in regionem longinquam (Lc 15, 13), et de filiis vagis dicitur Isaie I° quod “<ab>alienati sunt retrorsum” (Is 1, 4), et in Psalmo dicitur: “Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?” (Ps 136, 4), scilicet in Babilone, que confusio interpretatur; et Baruch III° dicitur: “Quid est, Israel, quod in terra inimicorum es; inveterasti in terra aliena?” (Bar 3, 10-11). [Ap 14, 8] […] ita et ut David prophetice dicat: “Super flumina Babilonis illic sedimus et flevimus”, et “in salicibus eius suspendimus organa nostra”, dicentes: “Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?” (Ps 136, 1-2, 4). |
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (VIum sigillum)] Prima (causa) est quia septem sunt defectus in nobis claudentes nobis intelligentiam huius libri. […] Sextus est ad omnia spiritualiora et deiformiora opposita difformitas et semotissima extraneitas, propter quod adolescens vagus dicitur a Christo abisse in regionem longinquam (Lc 15, 13), et de filiis vagis dicitur Isaie I° quod “<ab>alienati sunt retrorsum” (Is 1, 4), et in Psalmo dicitur: “Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?” (Ps 136, 4), scilicet in Babilone, que confusio interpretatur; et Baruch III° dicitur: “Quid est, Israel, quod in terra inimicorum es; inveterasti in terra aliena?” (Bar 3, 10-11). |
||
canto
|
gissi, gissen
|
volsi
|
vecchi
|
vaghezza
|
terra
|
diversi, diverse
|
strano, strani
|
lontano, di lontano, da la lungi
|
2. Variazioni su Apocalisse 6, 7-8
Il confronto con l’esegesi di Ap 6, 8 (seconda visione, quarto sigillo), che molto elabora la corrispondente dell’Expositio di Gioacchino da Fiore, mostra i diversi registri di variazione che risuonano nella parodia dantesca. Nell’esegesi viene spiegato il significato del versetto scritturale per cui al cavallo pallido apparso all’apertura del sigillo, che ha nome Morte, “fa seguito l’inferno”. Olivi si interroga circa il significato di questa espressione, che appare tautologica, in quanto pare ovvio che alla morte dei peccatori segua l’inferno: “quia nulli est dubium quin mortem culpe et gentem semper ab ipsa possessam sequatur dampnatio infernalis”. Di qui la prima variazione in due punti distinti, che riguardano appunto i dannati: «dicean: “Chi è costui che sanza morte / va per lo regno de la morta gente?”. … E io: “Maestro, assai chiara procede / la tua ragione, e assai ben distingue / questo baràtro e ’l popol ch’e’ possiede”» (Inf. VIII, 84-85; XI, 67-69).
Olivi interpreta il cavallo pallido come i Saraceni e l’inferno che segue come l’Anticristo, nel senso che i primi preparano la via al secondo. Ciò si vede bene, afferma il frate, nel fatto che molti elementi della filosofia saracena (Olivi allude ad Aristotele e ad Averroè) si sono introdotti nella filosofia cristiana diventata in tal modo vana, cosicché è già operante il mistero dell’iniquità, del quale parla san Paolo (II Tessalonicesi 2, 7), che a suo tempo verrà in luce. La parodia dantesca, che ha già assimilato la figura di Aristotele a quella di colui che siede sul trono celeste circondato dai seniori (fra i queli è Averroè: Ap 4, 3-4), appropria i vani filosofanti cristiani, insieme con la reminiscenza paolina, all’esser vano, cioè vuoto, Fonte Avellana, l’eremo di Pier Damiani: “si tamen christianos, vane philosophantes iam disseminati. Quod non est huius temporis aperire; iam enim misterium operatur iniquitatis (cfr. 2 Th 2, 7), quod suo tempore de medio exibit in lucem … Render solea quel chiostro a questi cieli / fertilemente; e ora è fatto vano, / sì che tosto convien che si riveli” (Par. XXI, 118-120).
Una terza variazione è altrettanto distante dal tema originale. Olivi afferma che il testo sacro, dove parla dell’inferno che segue la morte, forse intende dire altro e tale intenzione non è da deridere. Dante trasferisce i termini nelle parole di Beatrice, a proposito della teoria di Platone sul ritorno dell’anima alle stelle: “videtur tamen ultra hoc aliud intendisse […] et tamen ridiculosum est dicere quod corporalis locus inferni mittatur in stagnum ignis tamquam ibi puniendus … e forse sua sentenza è d’altra guisa / che la voce non suona, ed esser puote / con intenzion da non esser derisa” (Par. IV, 55-57).
La semantica, nelle tre variazioni, mantiene nella prima segno (o segni, trattandosi di parole-chiave) e significato; nella seconda e terza il significato è diverso (si passa dalla filosofia araba alla decadenza degli eremi, dal testo scritturale alla sentenza di Platone) e del significato originario i segni mantengono solo un’involucro esteriore.
Il rapporto tra Commedia e Lectura instaura un’ars memorativa, per la quale le parole-chiave incardinate nel senso letterale del poema sollecitano la memoria del lettore spirituale verso la dottrina dell’altra opera, che già conosce, per la quale i versi prestano “e piedi e mano”. Inoltre il fatto che gruppi di terzine numericamente corrispondenti, a diversi stadi della Commedia, contengano parole-chiave che conducono alla medesima pagina esegetica indica che queste parole, se dovevano essere per il lettore spirituale signacula mnemonici di un altro testo, erano per il poeta anche segni del numero dei versi, ‘luogo’ dove collocare i medesimi signacula in forma e contesto diversi (esempi: per Ap 6, 7-8; altri: 5, 8; 7, 3-4; 7, 13-14). Che il poema sia stato pubblicato per gruppi di canti, non più modificabili, oppure per cantiche riviste, sempre stava innanzi all’autore la medesima esegesi teologica, “panno” che prestava innumerevoli possibilità di variazioni tematiche e di sviluppi nel lungo fare la “gonna”.
Nella prima delle tre variazioni sui temi da Ap 6, 8 era ben riconoscibile il significato del testo dottrinale da parte di un lettore che ne fosse già consapevole; nella seconda e nella terza no, perché dovevano servire alla memoria dell’autore. Nella polifonia del poema, si tratta di note che, come scrisse Wagner della sonata per lo Hammerklavier di Beethoven, non sono state scritte per il pubblico, ma solo per il pianoforte.
[LSA, cap. VI, Ap 6, 8 (IIa visio, apertio IVi sigilli)] Dicendo ergo quod infernus sequitur predictum equum et sessorem eius significat duo.
|
|
Inf. VIII, 84-85; XI, 67-69dicean: “Chi è costui che sanza morte
|
Par. XXI, 118-121Render solea quel chiostro a questi cieli
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 7-8 (IIa visio, apertio IVi sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum quartum, audivi vocem quarti animalis”, scilicet aquile, “dicentis: Veni”, scilicet per imitationem mei et per attentionem ad tibi monstranda, “et vide” (Ap 6, 7).
|
||
Inf. XXXIII, 1-3 (1)La bocca sollevò dal fiero pasto
|
Par. IV, 1-3Intra due cibi, distanti e moventi
|
|
Inf. IV, 13-18 (5-6)“Or discendiam qua giù nel cieco mondo”,
|
Inf. VII, 13-15 (5)Quali dal vento le gonfiate vele
|
Purg. XIX, 13-15 (5)la lingua, e poscia tutta la drizzava
|
Inf. XXXIII, 22-24 (8)Breve pertugio dentro da la Muda,
|
Purg. VIII, 22-24Io vidi quello essercito gentile
|
Purg. XXIII, 22-24Ne li occhi era ciascuna oscura e cava,
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 7-8 (IIa visio, apertio IVi sigilli)] “Et ecce equus pallidus” (Ap 6, 8), id est, secundum Ricardum, ypocritarum cetus per nimiam carnis macerationem pallidus et moribundus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet diabolus, qui per pravam intentionem ypocritarum sedet in eis et per eos malitiam suam exercet, “nomen illi mors”. Hoc enim nomen bene diabolo convenit, quia per eum mors incepit et alios ad mortem trahere non cessat. “Et infernus”, id est omnes in inferno dampnandi, “sequeb<atur> eum”, quia omnes tales eum imitantur.
|
||
Inf. I, 49-54 (17-18)Ed una lupa, che di tutte brame
|
Inf. VI, 52-54 (18)Voi cittadini mi chiamaste Ciacco:
|
Inf. XIV, 52-57 (18-19)Se Giove stanchi ’l suo fabbro da cui
|
Inf. I, 88-90 (30)Vedi la bestia per cu’ io mi volsi;
|
Inf. XXII, 88-90Usa con esso donno Michel Zanche
|
|
Inf. I, 94-99 (32-33)ché questa bestia, per la qual tu gride,
|
Inf. XIV, 94-96 (32)“In mezzo mar siede un paese guasto”,
|
[Ap 6, 3] Preterea bestia hec (equus pallidus) non sustinet fidem Christi inter eos predicari aut aliquid contra eorum legem dici, immo statim morte punitur. |
[LSA, cap. VI, Ap 6, 7-8 (IIa visio, apertio IVi sigilli)] “Et ecce equus pallidus” (Ap 6, 8), id est, secundum Ricardum, ypocritarum cetus per nimiam carnis macerationem pallidus et moribundus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet diabolus, qui per pravam intentionem ypocritarum sedet in eis et per eos malitiam suam exercet, “nomen illi mors”. Hoc enim nomen bene diabolo convenit, quia per eum mors incepit et alios ad mortem trahere non cessat. “Et infernus”, id est omnes in inferno dampnandi, “sequeb<atur> eum”, quia omnes tales eum imitantur.
|
||
Inf. I, 88-90 (30)Vedi la bestia per cu’ io mi volsi;
|
Inf. XXIX, 88-93 (30-31)“dinne s’alcun Latino è tra costoro
|
|
Par. XI, 118-121 (40-41)Pensa oramai qual fu colui che degno
|
Par. XXI, 118-121Render solea quel chiostro a questi cieli
|
|