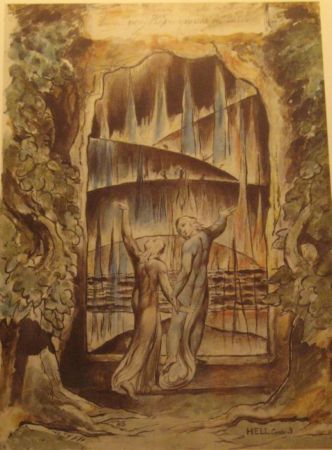La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuori [EN]Canti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX; XXXI; XXXII, 124-XXXIII, 90Purgatorio: III; XXVIII
|
Quale lettore viene suggerito o interrotto? Risolvere il “nodo” intuito, che ritenne entrambi al di qua di ogni conclusione, da De Sanctis e da Gramsci: questo il punto di qualsiasi ermeneutica su Inferno X. Qual è il confine fra poesia e storia, individuale questa o collettiva? Quale dramma si è perduto o è stato seppellito? È un problema da affrontare “non sanza tema”, non adatto però a chi, per usare le parole di Michele Barbi, preferisca “tapparsi nello studiolo di don Ferrante, e invecchiare sulle posizioni raggiunte”. Con l’ausilio della “chiave” (la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi, il testo sul quale ha operato la parodia dantesca), può essere infatti penetrato per nuovi sentieri e aperto alla discussione. Quelle idee di ieri che sembravano morte, però presenti alla mente di Dante nello scrivere di Farinata e dei Cavalcanti, tornano oggi alla luce disseppellite dallo Spirito della storia nello scavo topografico-spirituale della Commedia, di una “Pompei dei segni” costruita sul confine fra Medioevo e Umanesimo, al tramonto dell’antica storia della salvezza collettiva e di fronte alle moderne esigenze del “viver bene” dell’“omo in terra”.
Legenda [3]: numero dei versi; 6, 1: collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]; Not. XIII: collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. Varianti rispetto al testo del Petrocchi.
|
|
Inferno IX, 106-133 |
|
Dentro li ’ntrammo sanz’ alcuna guerra; 6, 1
|
|
Inferno X |
|
Ora sen va per un secreto calle,
|
INDICEIntroduzione. Topografia spirituale della Commedia: la posizione di Inferno X. 1. Dentro “la città del foco” (Inf. IX, 106-X, 21). 2. Farinata: l’agnizione (X, 22-39). 3. Farinata: la statua (X, 39-51). 4. Cavalcante (X, 52-72). 4.1. La nuova era s’avvicina, ma quando inizia? 4.2. “forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”: morte corporale o sostituzione nel primato della “gloria de la lingua”? 4.3. Divieto di andare senza guida. 4.4. Il cammino verso la beatitudine. 5. Farinata: l’uomo (X, 73-93). 6. Federico II (X, 119). Appendice: “E poi ch’a la man destra si fu vòlto” (Inf. IX, 132). Esame delle varianti. |
■ Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, Olivi suggerisce, nel prologo della Lectura, un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato sui sette stati (status), cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, prefigurate nell’Antico Testamento.
|
Abbreviazioni e avvertenze
Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.
LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.
Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).
Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.
Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.
In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.
Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di WARREN LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in ALBERTO FORNI – PAOLO VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.
Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di GIORGIO PETROCCHI, Firenze 1994. Si tiene anche conto della recente edizione a cura di GIORGIO INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA.
Si fa riferimento ai seguenti commenti:
Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno. Commento di ANNA MARIA CHIAVACCI LEONARDI, Milano 2007 (19911).
Dante Alighieri, Commedia. Inferno. revisione del testo e commento di GIORGIO INGLESE, Roma 2007.
INTRODUZIONE
Si propone la lettura interiore di Inf. X, quale avrebbe potuto farla uno Spirituale toscano alla fine del primo decennio del Trecento o agli inizi del secondo, prima che le persecuzioni condannassero all’oblio il libro-vessillo della riforma della Chiesa, l’ultima grande visione storico-collettiva del Medioevo. Ben diversa era stata la situazione subito dopo il 1305, allorché il destino degli Spirituali non era già segnato. Il “poema sacro” fu scritto anche per quanti, leggendone il volgare, avrebbero potuto risalire, attraverso una metamorfosi semantica che s’imprime nella memoria, alla dottrina esegetica della Lectura super Apocalipsim. A quella dottrina, aggiornata secondo le esigenze, classicistiche, aristoteliche e imperiali, dell’autore della Commedia, erano stati dati “e piedi e mano” rivestendone fatti personali e locali. Innumerevoli exempla avrebbero potuto essere predicati dai pergami fiorentini, se il “poema sacro” avesse vinto la crudeltà, che fuori “del bello ovile” il suo autore serrava [1].
Percorrendo ‘topograficamente’ la Commedia secondo i temi dei singoli sette stati oliviani è possibile rilevare come i motivi del terzo stato, dei dottori che combattono l’eresia (e anche quelli del quinto relativi allo stesso tema), pur presenti in quantità cospicua e con intere zone ad essi dedicate in cui prevalgono sui temi degli altri stati, siano meno rilevanti proprio dove ci si aspetterebbe di trovarli, cioè fra gli eresiarchi del sesto cerchio infernale. Nel canto più ermetico del poema, il tema centrale non è l’eresia [2], bensì la translatio del primato politico e della gloria della lingua: non sono i temi del terzo stato ad essere trasformati, ma soprattutto quelli del primo e del sesto. In altri termini, il senso letterale o esteriore è nella Commedia fortemente asimmetrico rispetto a quello spirituale o interiore. Il confine fra eresia e scisma, fra eresia ed errore, formalmente ben chiaro al poeta, si apre in effetti a ogni aspetto dello stato umano in ogni periodo della storia.
Ma quale era la concezione che Dante aveva dell’accadere storico? Come scrisse Auerbach, “egli non lo vede solamente come evoluzione terrena, come sistema d’avvenimenti sulla terra, bensì in continua correlazione con un piano divino, che è la mèta a cui continuamente volge l’accadere umano” [3]. Sulla storia provvidenziale racchiusa nell’Apocalisse, così come esplicata dall’Olivi che ad essa applica categorie storiche, Dante esercita il suo genio linguistico, attribuendo a sé e all’universo umano quanto ivi concentrato sull’Ordine francescano. Un processo figurale non simbolico o allegorico, semmai di allegoria dei teologi, la quale considera ciò che è antico prefigurazione del nuovo venuto con Cristo (e, per l’Olivi, del rinnovamento operato nel sesto stato della Chiesa) che si compirà nella patria celeste. L’antico e il nuovo ineriscono a personaggi e fatti storici pregni di verità, non a finzioni che la nascondono (cfr. Convivio, II, i, 4). Di qui il realismo dantesco, portato nell’aldilà. L’incontro desiderato con Farinata, e quello inopinato con Cavalcante, fu sentito dal poeta come un passaggio storico, fra computo generazionale e gloriose traslazioni, dall’antico (quanto venuto prima delle “nove rime”) alla nuova e seconda venuta di Cristo nello Spirito dei suoi discepoli.
Le vicende assumono un valore esemplare. Tutti i tre più gravi peccati capitali, secondo Ciacco, cooperano alle divisioni di Firenze, e ne sono concausa (Inf. VI, 74-75). Un particolare fatto cittadino viene elevato a modello di male universale, e questo espandersi verso l’universale al di là del proprio particolare, per poi ritornarvi, è secondo Olivi una caratteristica del modo tenuto dai grandi profeti, Isaia o Ezechiele e da Cristo stesso (cfr. Ap 13, 1). Così ancora il poeta dirà della fama di Firenze che “si spande” per tutto l’inferno (Inf. XXVI, 1-3), o farà dire che la sua città “è pianta” di Lucifero (Par. IX, 127-128).
Dante desidera ardentemente vedere Farinata degli Uberti, insieme ad altri cittadini di Firenze che ritiene “sì degni”, e che invece, come gli riferisce Ciacco, “son tra l’anime più nere” (Inf. VI, 79-87). Rispetto ai fatti profetizzati da Ciacco, vengono coinvolte le generazioni precedenti, e di entrambi gli schieramenti, dal ghibellino Farinata ai guelfi Guido Guerra, Tegghiaio Aldobrandi e Iacopo Rusticucci che stanno sotto la pioggia di fuoco coi sodomiti, fino ad altro ghibellino, Mosca dei Lamberti, che dicendo “Capo ha cosa fatta” decretò l’assassinio di Buondelmonte (1216) e l’inizio della divisione tra Guelfi e Ghibellini, come da lui stesso dichiarato nella bolgia che punisce i seminatori di scandalo e di scisma. Sui dissidi della propria generazione Dante fa così ricadere tutto il male precedente, in modo non dissimile da Cristo, che attribuisce tutti i mali provenienti da ogni generazione di reprobi alla particolare malvagia generazione dei reprobi Giudei del suo tempo, sulla quale ricade tutto il sangue versato dal tempo di Abele il giusto (Matteo 23, 35-36: “ut veniat super vos omnis sanguis iustus”; Inf. VI, 64-65: “Dopo lunga tencione / verranno al sangue”). Come sentenzierà Giustiniano, condannando sia Guelfi come Ghibellini, “Molte fïate già pianser li figli / per la colpa del padre” (Par. VI, 109-110). Allo stesso modo Olivi, trattando della prostituta apocalittica che siede sopra molte acque (Ap 17, 6), afferma che come un fiume che dura per molto tempo viene sempre considerato uno, per quanto l’acqua dei suoi primi anni sia diversa dall’acqua di questo anno che corre, così il continuo succedere del popolo romano viene considerato una gente e un popolo, in modo che si possa dire che questo popolo fu prima pagano e poi cristiano tanto da attribuire, quasi per sineddoche, quel che è di una parte all’altra parte o al tutto. Così la colpa della prima parte ridonda nella successiva, in quanto recidiva e fatta ingrata della grazia di Cristo che con misericordia l’ha lavata e santificata.
Far parlare liberamente, per dettato interiore, quasi invitando a un convivio spirituale e rompendo il vecchio duro senso, è forse il maggior tema del sesto stato, al quale è data la porta aperta a dire liberamente di Cristo. Corrisponde alla poetica di Dante, come manifestata a Bonagiunta da Lucca e da questi riconosciuta nel sesto girone del purgatorio, nascente per interno dettato e ispirazione d’Amore, dietro al quale il poeta si tiene stretto come alla sua regola (Purg. XXIV, 52-54). È un tema che risuona ovunque nel poema, anche nella vecchia roccia infernale dove i dannati vengono con desiderio e volontario consenso, con “disio” e con “velle”, varcando per un attimo questa ideale porta aperta al parlare.
La teologia della storia dell’Olivi – la più travagliata del tempo nella sua novità, destinata al di fuori del mondo universitario e, con le sue volgarizzazioni, dello stesso Ordine francescano – servì a Dante per dare ad Aristotele e agli Antichi la cittadinanza “di quella Roma onde Cristo è romano”, compimento di tutta la storia terrena e figurale. Non fu la poesia “ancilla theologiae”, bensì fu il “saeculum humanum” ad appropriarsi delle sacre prerogative in favore del “viver bene” dell’“omo in terra”.
Se “l’aldilà diventa teatro dell’uomo e delle sue passioni” [4], è perché questi assumono una veste sacra. Ma tanto forte fu il loro risuonare nei luoghi eterni, che di essa subito si spogliarono diventando indipendenti: la figura superò il compimento [5]. La condanna, nel 1326, della Lectura super Apocalipsim, con il conseguente oblio dei lineamenti della storia della salvezza collettiva segnati dal frate di Sérignan, tolse subito ogni possibilità di ritrovare i sensi mistici della Commedia, rimanendo solo la lettera e la selva delle interpretazioni. L’“autunno del Medioevo” era al sommo.
■ La Commedia, nelle intenzioni del suo autore, è un poema polisemico, cioè con più significati (Ep. XIII, 7: “istius operis non est simplex sensus, ymo dici potest polysemos, hoc est plurium sensuum”). Questi significati plurimi sono contenuti e portati al lettore attraverso segni, che sono le parole incardinate nel senso letterale. Non tutti i significati dovevano essere a tutti comprensibili. Un poema polisemico presuppone un pubblico diversificato. Una parte di questo pubblico si sarebbe fermata al senso letterale; un’altra avrebbe percepito quella che si suole chiamare allegoria (ma Dante parlava di “sensi mistici”: allegorico, morale, anagogico), ovvero l’altro nascosto nella lettera dei versi. Prima di iniziare la Commedia, nel Convivio (I, ix, 5) Dante aveva avuto presente un pubblico laico in lingua volgare. Si trattava di “[…] principi, baroni, cavalieri e molt’altra nobile gente, non solamente maschi ma femmine, che sono molti e molte in questa lingua, volgari, e non litterati”. Ma ora il nuovo volgare fondato sull’umile latino dell’esegesi biblica – come mostra la sistematica parodia della Lectura super Apocalipsim di Olivi (“ad modum loquendi, remissus est modus et humilis”, Ep. XIII, 10) – si proponeva come lingua adatta alla conversione universale, che è il vero scopo del “poema sacro” (“finis totius et partis est removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum felicitatis”). Questo poteva essere letto e compreso a diversi livelli, dalla donnetta (“quia locutio vulgaris in qua et muliercule comunicant”) al chierico più dotto. La prima non avrebbe forse percepito il verso iniziale di Inf. XXXIV – Vexilla regis prodeunt inferni – come una riscrittura sull’incipit del celebre inno di Venanzio Fortunato, lo avrebbero però ben compreso i letterati e i chierici. Ma i segni seminati nello spartito della nuova Apocalisse, mnemoniche pietre miliari sulle quali erano scritti concetti teologici tratti dall’esegesi oliviana, avrebbe potuto leggerli soltanto chi conosceva l’opera parodiata. Questo particolare pubblico non si formò, perché gli Spirituali (non un gruppo organizzato, ma di sensibilità comune), i quali dovevano conoscere la Lectura e che nel primo decennio del Trecento, quando la riforma della Chiesa era ancora possibile, non erano stati sconfitti, furono poi perseguitati e il loro libro-vessillo, censurato nel 1318-1319 e condannato nel 1326, fu votato alla clandestinità e quasi alla sparizione. Così si perdette anche il linguaggio che esprime i sensi interiori del “poema sacro”.
■ Come mostra la Topografia spirituale della “Commedia”, il viaggio di Dante ripercorre la storia dell’umanità attraverso gli stati, cioè i periodi storici della Chiesa sulla base dei quali, secondo Olivi, può essere organizzata ed esposta l’Apocalisse. Prima l’Antico Testamento (nel quale gli status del Nuovo sono prefigurati), quando i sette sigilli restano chiusi in un mondo cieco e di lapidea durezza, non però del tutto chiuso alle illuminazioni spirituali; così nell’Inferno i dannati parlano come per dettato interiore (proprio del sesto stato) e nel quietarsi della pena (proprio del settimo). Poi, con il Purgatorio, viene percorso il Nuovo Testamento con il primo avvento di Cristo nella carne e la storia della Chiesa con i suoi sette stati; nel sesto di essi è il nuovo avvento di Cristo nello Spirito, cioè nei suoi discepoli spirituali. Infine il settimo stato, che si svolge parte in questa vita e parte nella futura, ha come scena in terra l’ultimo girone della montagna e l’Eden alla sua sommità; poi, con il Paradiso, descrive lo stato delle anime beate dopo la morte in attesa della resurrezione.
Dunque l’Inferno se, letteralmente, è il luogo dove è punito chi ha demeritato, è anche il vecchio regno che bisogna lasciarsi alle spalle, l’“Antico Testamento” del nuovo libro evangelico. Non a caso l’ordinamento che Virgilio dà dell’inferno, nel canto XI, appare segnato dall’immagine dell’Apocalisse come “libro scritto dentro e fuori, segnato da sette sigilli” (Ap 5, 1; 6, 1; cfr. infra). L’inferno è formato da nove cerchi ma, a ben vedere, nel discorso di Virgilio e nelle domande di Dante ne vengono enumerati solo sette. Tre sono dentro le mura della città di Dite: il cerchio dei violenti (a sua volta diviso in tre gironi), il cerchio dei fraudolenti veri e propri (Malebolge, dove sono i fraudolenti verso chi non si fida) e il cerchio minore dei traditori (Cocito: i fraudolenti verso chi si fida). Quattro sono fuori le mura, meno martellati dalla giustizia divina in quanto meno offesero: gli iracondi e gli accidiosi dello Stige (“quei de la palude pingue”), i lussuriosi (“che mena il vento”), i golosi (“che batte la pioggia”), gli avari e i prodighi (“che s’incontran con sì aspre lingue”). L’ingresso nella città di Dite è dunque nella parte interna e più profonda del libro.
■ Dite, la città infernale, è l’immagine rovesciata della Gerusalemme celeste, questa da Dio illuminata, quella rossa come ferro bollente che esce dal fuoco. La santa città, che ha torri simili a moschee, pare conquistata dai Saraceni; è guardata da diavoli che corrono alla difesa, ma che nulla possono contro il messo divino che apre la porta. Entrato, Dante vede “grande campagna”: è il campo nel quale Cristo vinse il mondo, ora ridonda di tormenti e di amaro dolore per i dannati. Qui sono sparsi, in modo disuguale, i “sepolcri” avvolti da fiamme che li accendono, da essi escono “sì duri lamenti”. Questa terra di durezza e di fiamme, parodia della durezza giudaica infiammata contro Cristo sulla quale risuona, per punirla, la prima tromba apocalittica, è paragonata ai sepolcreti di Arles e di Pola, collocati in luoghi dai significati malvagi – lo stagnante Rodano, il Carnaro – che cingono, quasi assediandola, l’“Italia bella”. I sepolcri, più o meno caldi per il diverso livello di pena inflitto agli eretici che vi sono rinchiusi più numerosi di quanto si pensi, hanno i coperchi “levati”. Sono l’immagine rovesciata del sepolcro di Cristo: la pietra grande e pesante che lo chiudeva (il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, che chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura) fu rimossa al momento della resurrezione, dando adito all’intelligenza spirituale e alle illuminazioni divine. Le arche degli eretici, “monimenti”, dai “coperchi … sospesi” e “levati” fino al momento in cui verranno chiusi il giorno del giudizio, consentono ai dannati ancora una “mala luce”, per cui contemplano le cose che sono lontane nel tempo, senza sapere nulla degli eventi vicini o presenti; l’illuminazione divina, che “cotanto ancor ne splende”, permette a Farinata di profetizzare l’esilio di Dante.
■All’inizio dell’incontro con Farinata risuonano due temi contrastanti, cupo il primo nell’apostrofe del ghibellino – “O Tosco”, che allude all’appartenenza a gente avvelenata -, solare il secondo nel riconoscimento che quel toscano va “parlando onesto”, cioè con la “lingua erudita”, freno agli indomiti e veicolo della conversione universale, di cui aveva scritto Gioacchino da Fiore. Dicendogli “la tua loquela ti fa manifesto”, Farinata non fa solo la parodia di Matteo 26, 73 – “loquela tua manifestum te facit” –, dove il riferimento alla negazione di san Pietro è forse occulta allusione dell’aver rinnegato la lingua fiorentina con il De vulgari eloquentia. Il calco evangelico è incastonato nelle maglie del commento apocalittico oliviano, lì dove Cristo parla manifestando – “loquitur ut … manifestator” – la propria regale autorità e la sua “claritas” magistrale ed esemplare e dice: “Io sono la radice e la stirpe di David”, di colui che nacque nello stesso tempo in cui nacque Roma. Non a caso, nel prosieguo del viaggio, Brunetto Latini definirà Dante “sementa santa” dei Romani (Inf. XV, 76-78), cioè unico depositario di una lingua gloriosa come l’antico latino, che supplisce l’assenza apparente di una Curia imperiale. Una lingua parlata nella “nobil patria”, Firenze, definita da Farinata con i termini propri della città superna, la Gerusalemme celeste.
Udito il suono della voce che esce improvvisa e spaventevole dall’arca, su comando di Virgilio Dante si volge indietro a guardare Farinata: così Giovanni, l’autore dell’Apocalisse, si volge indietro al suono della gran voce che lo richiama verso cose superiori; così Maria Maddalena, voltatasi, vide Cristo. Il ghibellino “s’è ritto”, anch’egli in qualche modo risorto dal sepolcro. Sdegnoso dell’inferno, verso il quale mostra “gran dispitto”, esprime una magnanimità negativa iscritta sulla “fronte”, audace come quella della bestia che sale dal mare superba nel parlare contro Cristo.
Farinata incarna la vecchia Sinagoga e i suoi capi, sdegnosa perché forte di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’ e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo. Ben si addice al ghibellino che domanda “quasi sdegnoso” chi furono “li maggior” (cioè gli avi) del proprio interlocutore, e che alla risposta alza in alto le ciglia, dichiarando di averli per due volte cacciati in quanto a lui avversi, l’immagine dei pontefici della vecchia legge i quali, superbi per l’altezza del magistero e della fama conseguita in tutto il popolo e con il favore di questo, non si sottomettono alla correzione di Cristo, che anzi sdegnano e disprezzano per l’abiezione. Ancor più, le sue parole – “Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte” – sono la parodia dell’operato del falso papa che, imposto dall’Anticristo mistico nato dal seme redivivo di Federico II, caccerà coloro “qui semini Frederici et specialiter illi imperatori et sibi et suo statui fuerant adversati”.
Di fronte allo sdegnoso ghibellino, sta l’umile Dante, imitatore di Cristo, del quale recita i temi. Nel suo desiderio di ubbidire a Farinata, per cui gli si apre rivelando quali fossero stati i suoi ‘maggiori’, il poeta ripete quanto Cristo dice sull’aurea carità alla settima chiesa d’Asia, Laodicea, di aprirglisi con desiderio. Alle parole “sì che per due fïate li dispersi”, parodia della divisione intestina della grande città, cioè della religione evangelica all’apertura del sesto sigillo, Dante risponde insinuando il tema dell’arte di tornare dall’esilio, arte che i suoi avi hanno appresa, a differenza di quelli di Manente; dove il termine “arte” evoca le opere divine, nell’esegesi paragonate al suono di un maestro citarista che sa concordare “iustitia” e “lenitas”, rigore e dolcezza. Giustizia e pietà, le due vie di Dio, valgono anche per l’esule.
■Dallo stesso sepolcro nel quale s’è dritto Farinata si leva, ma in ginocchio, l’ombra di Cavalcante; si guarda intorno con dubbioso “sospecciar”, nella speranza di vedere il figlio Guido insieme a Dante. Cavalcante, come gli altri dannati, vede le cose che sono lontane, non quando s’avvicinano o sono presenti. Spera dunque che, per la passata amicizia, i due poeti siano ancora insieme. Il suo “sospecciar” ripete il dubbio di Gioacchino da Fiore, l’abate calabrese che nella Concordia, ampiamente citata da Olivi, dichiara, circa l’apertura del sesto sigillo, che il tempo è vicino ma che il giorno e l’ora sono conosciuti solo da Dio: “i tempi e i momenti mi sono ad ogni modo sospetti”. Con l’apertura del sesto sigillo inizia la terza età, quella dello Spirito, età che è anche quella delle “nove rime” dantesche. Il dubbio di Cavalcante è dunque il seguente: del “nuovo secolo” della poesia partecipa anche mio figlio? conseguirà anch’egli, come “il primo” dei suoi amici, la “gloria de la lingua”?
Cavalcante non vede il figlio, piangendo domanda a Dante perché non sia con lui. Lo apostrofa – “Se per questo cieco / carcere vai per altezza d’ingegno” – pensando che abbia intrapreso il viaggio con il solo sostegno della filosofia mondana (l’esegesi parodiata si riferisce ad Aristotele e ad Averroè).
La risposta di Dante fa in primo luogo risuonare il tema della necessità di una guida – “Da me stesso non vegno” –, parodia della voce che ingiunge a Giovanni di ricevere il libro aperto, la cui sapienza non è possibile apprendere senza guida, dalla mano dell’angelo della sesta tromba che sta sul mare e sulla terra (Ap 10, 8).
Dante aggiunge che “colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”. La parodia questa volta si esercita su un passo del profeta Daniele (12, 11-12) commentato nell’esegesi oliviana: “Dal tempo in cui sarà tolto il sacrificio perpetuo e sarà eretto l’abominio della desolazione ci saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e perviene a 1335 giorni”, cioè alla beatitudine (“videtur perducere ad iubileum pacis et gratie septimi status”). Il “disdegno” di Guido Cavalcanti è stato verso una guida (“cui”) che conduce alla beatitudine, nel poema rispettivamente impersonate da Virgilio e Beatrice. Le due figure, immagini l’una del Cristo uomo che insegna esteriormente, l’altra del suo Spirito che detta interiormente, sono inconcepibili separate, la prima è necessaria per arrivare alla seconda. Disdegnando una guida, Guido ha disdegnato entrambe. Virgilio, causa prossima, parla di Beatrice come causa finale, per cui dirà al discepolo nel momento di riprendere la strada: “quando sarai dinanzi al dolce raggio / di quella il cui bell’ occhio tutto vede, / da lei saprai di tua vita il vïaggio”.
“Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”. Mio figlio è dunque morto? – si chiede Cavalcante. “Ebbe” è tratto da un contesto (l’istruzione data a Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia, ad Ap 2, 5) in cui non si fa riferimento a una morte corporale, come equivoca disperandosi il padre di Guido, ma a una traslazione del primato (nel caso, del primato poetico di mettere fuori le “nove rime”, corrispondenti all’età dello Spirito che si apre con il sesto stato, apertura prossima che a Cavalcante non è concesso di vedere, come a Zaccaria, il padre di Giovanni, di dire di Cristo). Questa traslazione a Dante, taciuta in Inf. X, è palesemente confermata da Oderisi da Gubbio in Purg. XI, 97-99: “Così ha tolto l’uno a l’altro Guido / la gloria de la lingua; e forse è nato / chi l’uno e l’altro caccerà del nido”. Alla stessa esegesi di Ap 2, 5 appartiene il “disdegno” di Guido, assimilato alla superba presunzione della Sinagoga o della Chiesa “ex circumcisione” di Gerusalemme, e quindi di Efeso stessa, minacciata di traslazione del suo primato metropolitano. Non morte corporale dunque, ma sostituzione mentre è ancora in vita nella “gloria de la lingua”: tale il destino di Guido Cavalcanti.
Insieme a Farinata e a Cavalcante, nel sepolcro giace anche anche Federico II, colui che nel De vulgari eloquentia (I, xii, 4), insieme con il figlio Manfredi, era stato insignito della nobiltà d’animo propria degli “illustres heroes”. Perché dunque ora è dannato? Solo perché epicureo e il giudice non si sente di assolverlo? Non aveva forse disposto contro gli eretici nelle Costituzioni melfitane? E perché ancora, nel prosieguo del viaggio, si verificherà l’inopinata salvazione di Manfredi e poi il parlare di Piccarda appunto su Federico, “’l terzo e l’ultima possanza” (Par. III, 118-120)?
Nel silenzio che lo fascia, qualcosa accomuna l’imperatore a Farinata e a Guido. Con l’Uberti, e con l’Omberto Aldobrandesco purgante nella cornice dei superbi, condivide la concezione della nobiltà per “antico sangue” e “opere leggiadre”. Così viene citato, e contestato nonostante il rilievo provvidenziale dato all’autorità imperiale, in Convivio IV, iii, 6: “domandato che fosse gentilezza, rispuose ch’era antica ricchezza e belli costumi”. È l’ultima menzione di Federico II prima che Farinata ne riveli l’eterna dannazione come epicureo. Nel mezzo sta la vocazione di Dante al viaggio, il suo sentirsi eletto, segnato con gli amici di Dio per un’alta missione, “sesto tra cotanto senno” non per nobiltà acquisita dai propri “maggior” ma per quella nobiltà di spirito che discende direttamente dalla grazia donata. È Dio, “appo cui non è scelta di persone” in base alla presunzione dell’antico, che rende i singoli “quasi dèi” (Convivio, IV, xx, 3-6).
Se Federico II ha in comune con Farinata la concezione della nobiltà fondata su uno stare antico, è congiunto con Guido Cavalcanti nel trovarsi al di qua delle “nove rime”. Anche se, grazie a lui e al suo degno figlio Manfredi, nella regale sede di Sicilia vide la luce “quicquid nostri predecessores vulgariter protulerunt”, ora una nuova lingua supplisce alla vacanza imperiale, di un istituto comunque indefettibile. Nei “monimenti” del sesto cerchio, come nel sepolcro di Cristo chiuso dalla vecchia pietra prima della resurrezione, non sono sepolti solo “con Epicuro tutti suoi seguaci, / che l’anima col corpo morta fanno”; vi giace anche una poesia antica che non è riuscita a trasmigrare, ben guidata, nella nuova.
■ Minimamente toccato dall’interruzione, Farinata continua il precedente discorso restando immutabile: nel profetizzare l’esilio di Dante veste i panni di Dio padre, fermo e stabile nella sua giustizia; il suo “parlar che mi parea nimico” fa segno dell’inimicizia del Padre verso il Figlio, che ha voluto tanto patisse per l’umana redenzione, inimicizia solo apparente, per il Redentore e per il suo imitatore che, per vedere Beatrice, sta muovendo e muoverà “passi tanti” (cfr. Purg. XXXI, 133-135).
Ma quando Dante gli spiega che la causa dell’esilio perpetuo degli Uberti è la memoria del sangue sparso a Montaperti, Farinata, fino allora immutabile nell’aspetto e immobile nella figura, sospirando muove il capo. Subisce quasi un terremoto interiore, come nel crollarsi de “lo maggior corno de la fiamma antica” che invola lo schivo Ulisse, segno che la novità del sesto stato, al quale è dato di parlare liberamente per adesione della volontà a Cristo interno dettatore, rompe la durezza della vecchia roccia infernale. È il momento nuovo, tanto caro a De Sanctis, che spezza la lapidea durezza del vecchio, in cui la passione terrena trasforma la statua in uomo e gli apre il libro della memoria ricordandogli il suo muovere contro Firenze lui capopolo con gli altri, non senza ragione quasi ministro della giustizia divina, e poi la sua solitaria difesa a Empoli “a viso aperto” della città contro tutti, che per un attimo lo fa assurgere ai segnati di Cristo ai quali nel sesto stato, all’apertura del sesto sigillo, è data la costante e magnanima libertà di difendere pubblicamente la fede, un’audacia assai diversa da quella con cui pareva “avesse l’inferno a gran dispitto”. Firenze, anche se “nido di malizia tanta”, era pur sempre il luogo dove cinque anni dopo Montaperti sarebbe nato Dante – anch’egli fra i segnati -, pianta in cui rivive “la sementa santa” dei Romani, come dice Brunetto Latini. Salvando Firenze, Farinata ha salvato il seme della fede.
L’auspicio per la discendenza del magnanimo ghibellino – “Deh, se riposi mai vostra semenza” – ripete il tema con cui ad Ap 14, 13 inizia la settima parte della quarta visione, riferito a quanti muoiono nella fede e nella carità di Dio: “Da ora in poi, dice lo Spirito, riposino dalle loro fatiche”, cioè dalla passata tribolazione, per cui gli Uberti sono esclusi, come il poeta stesso, da Firenze. Dopo il momento sesto cristiforme, del difensore “a viso aperto” di Firenze, subentra la pace in terra del settimo stato, impossibile per Manente, ma non per i suoi ancor vivi.
[1] Cfr. ERICH AUERBACH, Mimesis, Il realismo nella letteratura occidentale, trad. it., Torino 19735, I, p. 215: “I molti drammi compiuti si riuniscono tutti in un unico grande dramma in cui si tratta di lui stesso e dell’umanità, e tutti sono soltanto ‘exempla’ per l’acquisto o la perdita della beatitudine eterna”.
[2] Cfr. ALBERTO ASOR ROSA, Identità e storia nel canto X dell’ Inferno, in Studi di filologia e letteratura italiana in onore di Gianvito Resta, a cura di V. Masiello, I, Roma, 2000, pp. 116-117: “[…] le anime dannate, che ne sono protagoniste, hanno poco a che fare, in qualità di personaggi, con il peccato che viene punito nel sesto cerchio, ossia l’epicureismo e l’eresia: non una sola parola, fra quante ne pronunziano, né di ricordo né di recriminazione né di rammarico, riguarda il peccato commesso (se non, forse, nell’accentuazione di certi caratteri psicologici e affettivi dei due protagonisti, Farinata degli Uberti e Cavalcante de’ Cavalcanti)”. Apparentemente limitata agli epicuri (Inf. X) a ai monofisiti (Inf. XI, 1-9), l’eresia si ritrova altrove nel poema nelle sue più varie manifestazioni. È proprio del terzo stato della Chiesa il tema del tagliare, dividere, rompere o scindere: esso si rinviene in diverse zone, quasi fosse un motivo dall’andamento interno, sotterraneo e insieme ciclico. Cerbero (Inf. VI), nel graffiare, scuoiare e squartare i peccatori, è figura che anticipa il colloquio tra Dante e Ciacco sulle divisioni politiche fiorentine. Nella prima cantica, la tematica torna in evidenza nella selva dei suicidi, la cui anima feroce si è divisa dal corpo (Inf. XIII); nella terza bolgia dei simoniaci, che hanno straziato la “bella donna”, cioè la Chiesa (Inf. XIX); nella nona dei seminatori di scandalo e di scisma, dove sta anche il Mosca che fu causa delle discordie fiorentine (Inf. XXVIII); in Lucifero che con ognuna delle sue tre bocche “dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla” e, per maggior pena, graffia Giuda che pende dalla bocca anteriore scorticandogli il dorso, mentre gli altri due traditori sono gli assassini di Cesare, Bruto e Cassio (Inf. XXXIV, 55-67). Questo dividere in sostanza l’uomo, nei suoi vari aspetti, da Dio e dalla sua giustizia è assimilabile alle eresie, che divisero l’umanità di Dio dalla sua divinità, degradando la prima o confondendola con la seconda, come quelle di Ario e di Sabellio, i quali, secondo quanto dice Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole, “furon come spade a le Scritture / in render torti li diritti volti” (Par. XIII, 127-129). Così, a Purg. XVI, 106-114 (i “due soli” di Roma), aver spento e congiunto a sé il potere temporale (la “spada”) da parte del potere spirituale (il “pasturale”) significa aver confuso due stati distinti nel tempo (gli ‘stati’, però, oltre che epoche, sono anche modi di essere degli individui in qualsivoglia periodo storico), cioè il terzo (i dottori, che razionalmente confutano le eresie con la spada e danno le leggi: il tema dello scindere e del dividere percorre tutto il canto) con il quarto (i contemplativi anacoreti, dalla santa e divina vita fondata sull’affetto), due stati di sapienza solare che devono invece separatamente concorrere per due diverse strade ad infiammare il meriggio dell’universo. Una confusione assimilabile all’eresia di Ario, che divise il Figlio dal Padre ritenendolo non consustanziale, a livello di creatura o, ancor meglio, a quella di Sabellio, che unificò il Padre e il Figlio nella stessa persona. Ancora, la tematica dell’eresia manichea, che condanna il matrimonio (alla quale, nell’esegesi della quinta tromba, sono assimilati Catari, Valdesi e Patarini), incide profondamente sulla zona dei sodomiti (Inf. XV-XVI) e, intrecciata con i motivi propri delle locuste, su quella dei barattieri (Inf. XXI-XXII). Tutto ciò è dimostrabile percorrendo ‘topograficamente’ il poema secondo i temi dei singoli sette stati oliviani che vengono semanticamente variati nel senso letterale del poema.
[3] AUERBACH, Mimesis, I, p. 211.
[4] Ibid., I, p. 219.
[5] Ibid., p. 218.
Topografia spirituale della Commedia: la posizione di Inferno X
Dentro li ’ntrammo sanz’ alcuna guerra (Inf. IX, 106). Il libro dell’Apocalisse, definito ad Ap 5, 1 “volumen”, scritto dentro e fuori, che sarebbe incongruo affermare distinto per quaderni e carte, ha una forma immaginaria a guisa di rotolo, con sette pieghe, ciascuna delle quali chiusa da un sigillo. A ciascuna apertura si presentavano a Giovanni le immagini da lui descritte dei cavalli e dei cavalieri, come se uscissero vive da dentro le pieghe (Ap 6, 1). Sui motivi propri del libro è tessuta la visione finale dell’unità e semplicità di Dio, volume che nel profondo della sua essenza lega con amore tutto ciò che “si squaderna” in modo diffuso per l’universo (Par. XXXIII, 85-87). Ma è soprattutto in Inf. XI, il canto in cui Virgilio spiega l’ordinamento e la distribuzione dei dannati, che questi temi vengono sviluppati. L’inferno è formato da nove cerchi ma, a ben vedere, nel discorso di Virgilio e nelle domande di Dante ne vengono enumerati solo sette. Tre sono dentro le mura della Città di Dite: il cerchio dei violenti (a sua volta diviso in tre gironi), il cerchio dei fraudolenti veri e propri (Malebolge, dove sono i fraudolenti verso chi non si fida) e il cerchio minore dei traditori (Cocito: i fraudolenti verso chi si fida). Quattro sono fuori le mura, meno martellati dalla giustizia divina in quanto meno offesero: gli iracondi e gli accidiosi dello Stige (“quei de la palude pingue”), i lussuriosi (“che mena il vento”), i golosi (“che batte la pioggia”), gli avari e i prodighi (“che s’incontran con sì aspre lingue”). Se mancano all’appello il primo cerchio (il Limbo) e il sesto (gli eretici), ciò è perché il “nobile castello” del Limbo è la parodia della sede divina prima dell’apertura dei sigilli e perché la spiegazione dell’ordinamento infernale avviene accanto all’arca dell’eretico papa Anastasio II, cioè nel sesto cerchio. Oppure essa è memore di quanto sostenuto da Tommaso d’Aquino circa l’eresia la quale, in modo analogo alla bestialità rispetto alla malizia umana, era da collocare “extra numerum peccatorum” (In IV Sent., ds 13, qu 2, ar 2; cfr. supra). In ogni caso, esempio di concordia fra la dottrina aristotelica e l’esegesi apocalittica, l’enunciazione dei sette cerchi corrisponde al tema del libro scritto “dentro e fuori” e segnato sulle sette pieghe. Anche il riferimento alle “carte” della Fisica di Aristotele, utilizzata da Virgilio per precisare la posizione degli usurai, concorda con siffatta tematica. A Inf. IX, 107-108, il desiderio di guardare “dentro” la città di Dite, una volta varcata la porta, è il desiderio di guardare l’interno del libro. Tale fu anche il desiderio dei santi Padri, prima dello scioglimento da parte di Cristo dei sette sigilli (Ap 5, 2-4).
L’apertura della porta della città di Dite da parte del messo celeste (Inf. IX, 89-90) sviluppa il tema della porta aperta data a Filadelfia, sesta chiesa (Ap 3, 8). È un “passo”, – afferma Virgilio, equivocando tra il ‘passare’ e il ‘patire’ – che “non ci può tòrre alcun: da tal n’è dato” (Inf. VIII, 104-105); così al sesto stato, “predilectus a Christo” come Giovanni, spetta il “pati seu recipere” piuttosto che l’“agere vel dare” proprio del “prediligens Christum” come Pietro (Ap 3, 7). Dice Virgilio della città di Dite, “u’ non potemo intrare omai sanz’ ira” (Inf. IX, 32-33): la vendetta nei confronti dell’adultera Babylon, si afferma della Chiesa carnale nell’esegesi dell’apertura del sesto sigillo, non può avvenire “absque summa ira”.
L’apertura della porta, fasciata dai temi del sesto stato, si pone al culmine del primo ciclo settenario dell’Inferno: questo inizia nel Limbo con uno ‘snodo’ (Inf. IV: temi dalle ‘radici’ delle visioni e dal primo stato, di fondazione della Chiesa) e prosegue con il successivo prevalere dei temi degli stati intermedi tra il primo e il sesto: lussuriosi (Inf. V: temi dal secondo stato, dei martiri, concorrendo ancora quelli del primo); golosi (Inf. VI: temi dal terzo stato); avari e prodighi (Inf. VII: temi dal quarto stato, che concorre con il terzo, come i contemplativi anacoreti concorrono per antonomasia con i dottori); iracondi, accidiosi, superbi, tutti immersi nella palude Stigia (Inf. VII – VIII: temi del quinto stato, che persistono per tutto Inf. IX fino all’apertura della porta di Dite). Aperta la porta, un nuovo ‘snodo’ (Inf. X) avvia il secondo ciclo settenario. Per questo l’esame di Inf. X inizia ‘topograficamente’ a Inf. IX, 106, al momento dell’ingresso.
La novità che il sesto stato, per eccellenza stato di rinnovamento del mondo, arreca nell’Inferno è una novità fittizia o prefigurante la vera, quale poteva essere prima della venuta di Cristo. L’apertura della porta di Dite non è vera novità, perché essa è stata chiusa dall’ostinazione dei diavoli, recidivi dopo l’apertura della porta dell’inferno da parte di Cristo prefigurata dalla venuta di Ercole all’Ade, per cui dice loro il messo celeste: “Cerbero vostro, se ben vi ricorda, / ne porta ancor pelato il mento e ’l gozzo” (Inf. IX, 98-99) [1]. Il tema del chiudere risuona insistente, appropriato al disdegno dei diavoli (Inf. VIII, 88), alle porte (v. 115), al vedere di Dante (Inf. IX, 55), alle mani di Virgilio (v. 60), ed anche, passata la porta, all’Italia chiusa dal Carnaro (v. 114). Una volta aperta la porta, il messo celeste torna indietro con “sembiante / d’omo cui altra cura stringa e morda / che quella di colui che li è davante” (vv. 101-103). Sembra convinto che quella contro i diavoli non sia la guerra più importante, memore forse di quanto nell’esegesi della quinta tromba si afferma dell’eresia manichea, la seconda delle tre tribolazioni (dopo la rilassatezza del clero, dei monaci e dei laici e prima dell’impugnazione dello spirito di Cristo fatta dai religiosi ipocriti e fraudolenti). L’eresia catara e valdese (o manichea) non costituisce l’elemento principale della futura tentazione dell’Anticristo mistico, che Olivi ritiene invece essere la filosofia aristotelica e araba. L’eresia manichea è stata infatti già sufficientemente confutata da Agostino e pertanto non è necessario sudarci ancora sopra, salvo eliminarne i vili residui del quinto stato, non essendo consueto che quanto è stato vinto venga riproposto come oggetto principale della guerra da sostenere (Ap 9, 5-6). I diavoli ostinati si sono così volti al passato; il duro rimprovero del messo celeste troverà più alta corrispondenza di fronte ad altra porta, allorché il libro sarà aperto e i velami risulteranno non strani ma sottili (Inf. IX, 61-63; Purg. VIII, 19-21), nell’ammonimento dell’angelo portiere del purgatorio a non volgersi indietro perché ciò non potrebbe mai essere scusato (Purg. IX, 131-132; X, 5-6).
[1] Come nel primo ciclo settenario l’apertura della porta della città di Dite non è vera novità, perché ripetizione di quanto già fatto da Cristo con la porta dell’inferno, così nel secondo ciclo l’episodio di Gerione, fasciato anch’esso dai temi del ‘nuovo’ sesto stato, di questo rappresenta solo l’aspetto falso. La fiera viene su ad un “novo cenno” di Virgilio, è paragonata a colui che “torna” dallo sciogliere l’ancora nel fondo del mare, e il tornare è proprio della sesta vittoria (Ap 3, 12). È però figura della frode dalla velenosa coda aculeata. Soprattutto, ha “la faccia … d’uom giusto”, ma in realtà è “sozza imagine di froda”. La figura di Gerione che viene in su nuotando per l’aere grosso e scuro è “maravigliosa ad ogne cor sicuro” (Inf. XVI, 132), cioè tale da sgomentare anche un animo saldo, e corrisponde all’operare meraviglie da parte del carnefice di fronte al martire tormentato negli ultimi tempi (cfr. LSA, prologo, notabile X). Il portare Dante salvo in groppa al fiero animale da parte di Virgilio, fatto che il maestro ricorderà al discepolo titubante ad entrare nel fuoco (Purg. XXVII, 22-24), corrisponde al significato del nome della sesta chiesa, Filadelfia, interpretata come colei che “salva l’eredità”, cioè il seme evangelico, nella grande tentazione. Non è vera “novità”, nel terzo ciclo, il “mutare e trasmutare” della “settima zavorra” (Inf. XXV, 142-144), cioè dei ladri incapaci di mantenere la forma di uomo, quella più conforme a Cristo, regredendo allo stato bestiale, alla natura e alla forma del serpente creato prima dell’uomo. Il vero e santo sesto stato corrisponde al sesto giorno della creazione, in cui vennero creati prima i rettili e le bestie irrazionali, poi l’uomo che, come l’ordine evangelico, è fatto a immagine e somiglianza di Dio e domina tutti gli animali. Meglio si presenta Anteo, nel quarto ciclo, prefigurazione di Scipione a Zama, a sua volta antica figura della grande guerra del sesto stato (Inf. XXXI, 115ss.); ma è pur sempre un gigante che, sciolto, incute terrore. Sola vera ‘novità’, a conclusione della prima cantica, è il passaggio del centro della terra, con la conversione di Virgilio sull’anca di Lucifero (Inf. XXXIV, 79, 110-111): segna il passaggio, dopo le cinque età del mondo percorse nell’Antico Testamento, alla sesta età, quella della Chiesa, descritta nel Purgatorio.
1. Dentro “la città del foco” (IX, 106-X, 21)
Gerusalemme d’inferno
Le immagini della ‘città della nobiltà’ – la Gerusalemme celeste descritta nella settima visione (Ap XXI-XXII) – si ritrovano appropriati in molti luoghi del poema. Fosse e fondo forati e arti, mura; l’altezza dei primi o delle seconde, il loro esser uniti a chiudere cittadini; porte, entrare, case; cerchia, cerchiare e cinger castelli o la città; far grande aggirata, aggirarsi a difesa o a guardia; venire alle parti o al luogo: tutti motivi che pervadono il “nobile castello” del Limbo (Inf. IV) come la città di Dite (Inf. VIII, IX, X), poi Malebolge (Inf. XVIII, XIX), Cocito (Inf. XXXII), fino all’Empireo (Par. XXXII); non sono estranei al lamento sulla “serva Italia” (Purg. VI), e hanno perfino risvolti di esperienza interiore dell’individuo Dante messo nella fossa, separato da Beatrice con il muro di fuoco (Purg. XXVII).
Si può certamente ricordare, a proposito di tanto diverse variazioni dei medesimi motivi dell’esegesi apocalittica, il principio di teologia negativa affermato dallo Pseudo-Dionigi (Gerarchia celeste, II, 3; XV) – autore più volte richiamato da Olivi nelle sue opere -, per cui le cose invisibili sono meglio descritte e spiegate per mezzo di cose dissimili, da esse lontane, oscure, turpi. In altri termini, un passo dell’Apocalisse relativo alla Gerusalemme celeste può offrire ‘simboli’, cioè similitudini, sia a luoghi del poema che gli sono naturalmente vicini (nel Paradiso) sia lì dove si è più lontani da Dio (nell’Inferno). Questo spiega perché punti indubbiamente negativi come la bestia di Ap 13, 3, della quale una delle sette teste fu uccisa e poi rivive, possa essere applicata all’impero e alla sua prossima auspicata resurrezione. Oppure perché la stessa esegesi di Ap 16, 13-14 (i tre spiriti immondi al modo delle rane) possa essere parodiata nei ladri della settima bolgia, sempre instabili nel passare dallo stato umano a quello bestiale, oppure nei falsari di Romena, e al contempo nell’elogio che Tommaso d’Aquino fa di Francesco e dei suoi soci, esempi per eccellenza dell’uomo razionale ed evangelico creato nel sesto stato per presiedere, dominandole, alle bestie.
D’altronde, afferma Olivi, la Scrittura, allargata o stretta come una mano o una veste, può essere adattata a tempi diversi da quelli ai quali si riferisce (prologo, Notabile XI); così fece Giovanni elaborando le bestie della visione di Daniele nella quarta visione apocalittica. La bestia che “fu e non è” di Ap 17, 8 designa la Chiesa corrotta, ma quando Beatrice recita parte di questo versetto, a Purg. XXXIII, 35, pensa certamente anche all’impero.
A questo principio di teologia negativa si aggiunge quello, tipicamente oliviano, della costruzione progressiva della città: prima si trova il luogo e si scavano i fossati, poi si gettano le fondamenta e si edificano le mura, infine si innalzano le porte e si costruiscono le case. Queste tre fasi corrispondono alle tre età del mondo di Gioacchino da Fiore. In primo luogo venne infatti eletto il popolo di Israele per preparare in esso questa nobile città. Con l’avvento di Cristo, fondamento, porta e portinaio, muro e baluardo, furono eletti gli apostoli quali fondamenta e dopo di essi i Gentili perché passassero nella fede il muro. Gli apostoli furono pure porte, per le quali i fedeli entrarono nella fede e nella Chiesa di Cristo. Al momento della conversione finale di Israele e di tutto il mondo verranno nuovamente innalzate dodici porte, assimilabili ai dodici apostoli, per le quali entri l’universo popolo dei fedeli. Tuttavia in qualsivoglia stato della storia umana le parti della città possono essere adattate misticamente, né è da sorprendersi, perché come cose diverse possono essere designate in modo unitario, così quel che è uno può essere significato in modo molteplice (Ap 21, 12). Ulisse, punito per i suoi consigli fraudolenti, non però per l’ultimo suo viaggio, è solo una lucciola nel fossato della città di Dio ancora da costruire per lunga storia, che ben altri tempi, viaggi e guide avrebbe richiesto per essere vista e visitata.
La stessa fede, come la Chiesa, ha un suo sviluppo secondo gli stati, cioè i periodi storici. Ciascun dono dello Spirito può essere distinto in sette parti. Il terzo dono, la “tuba magistralis”, espone la fede in tal senso (prologo, Notabile III). La prima parte, volta a seminare la fede, corrisponde al sacramento del battesimo. Se il valore battesimale di ingresso nella fede (come ‘porta’) è ben presente a Par. XXV, 10-11, altro è il senso delle parole di Virgilio a Inf. IV, 36 sul battesimo “ch’è parte de la fede che tu credi” (dove tutti i codici, salvo il Cortonese, su revisione di parte, nell’edizione dell’antica vulgata del Petrocchi, recano “parte” e non “porta”, lezione però prescelta dall’editore). “Parte” è da intendere come ‘prerogativa’, ‘qualità’, propria dei singoli sette doni dello Spirito increato, uno semplicissimo ma partito nella storia della Chiesa, che procede secondo sette stati.
Ancora, la costruzione progressiva della città guarda sempre ai momenti di rinnovamento segnati dai tre avventi di Cristo: nella carne, nello spirito, nel giudizio (prologo, Notabile VIII). Il viaggio di Dante procede topograficamente per sette stati ciclicamente ripetuti ma a livello sempre più alto e di più ampia e ardua visione, per cui i precedenti momenti chiusi si aprono a nuova intelligenza. Da questo punto di vista, l’inferno non è solo, letteralmente, il luogo delle pene comminate dalla giustizia divina, ma rappresenta pure spiritualmente il vecchio in terra, ciò che non si è mai rinnovato; ivi, parafrasando un’espressione manzoniana, è percosso il “volgo disperso” che in vita non fu “percosso da novo crescente romor”. Nella vecchia roccia, luogo per antonomasia della durezza, è la poesia del “sesto” poeta a recare il nuovo, aprendo i cuori induriti alla parola.
La città di Dio, che da questi è illuminata e assume l’immagine come il ferro s’accalora al fuoco (Ap 21, 11), diventa, nella sua proiezione infernale, “la città del foco” dalle mura ferrigne. Il ferro è attributo dei Saraceni, invincibili ma non tanto, perché (come affermato nella citazione di Gioacchino da Fiore ad Ap 13, 1) la loro gente, forse un tempo ferrea, si è mischiata con altre perdendo solidità, come la statua del sogno di Nabucodonosor spiegato dal profeta Daniele aveva un piede di ferro e l’altro di terracotta. La città di Dite ha mura che paiono ferro e torri (definite “mischite”, cioè moschee) rosse per l’arroventare del fuoco eterno (Inf. VIII, 70-74, 78). Le “mischite”, che Dante distingue “certe” nella valle, oltre al significato letterale di ‘moschee’, recano in sé i significati offerti dall’esegesi del “mixtum”, con cui pure concordano nel suonare della parola. Il loro essere visibili in modo certo allude alla certezza della misura del giudizio divino contro i reprobi (Ap 14, 10). Inoltre, se applicato ai Saraceni, il “mixtum” significa che la solidità del ferro viene meno. I diavoli ostinati, che non vogliono fare entrare i due poeti nella città, corrono a gara entro le mura, che sembrano ferro, e si preparano alla guerra proprio come i Saraceni. L’arrivo del messo celeste dimostrerà poi, all’apertura della porta con una verghetta, la scarsa solidità di quelle mura, difese da una tracotanza usata già “a men segreta porta, / la qual sanza serrame ancor si trova”, cioè per difendere la porta dell’inferno (Inf. VIII, 124-126).
La formale descrizione delle parti della Gerusalemme celeste, contenuta nella settima visione, si è già rispecchiata nel “nobile castello” del Limbo e nelle mura della città di Dite, ferrigna e fattasi saracena, viste dalla palude Stigia. Continua una volta che Virgilio e Dante sono entrati nel gran campo delle arche roventi: “Et habebat murum magnum et altum (Ap 21, 12)”. Nel testo di esegesi scritturale l’alto muro designa i màrtiri e i dottori che difendono la città e la fede contro i nemici esterni; nei versi (Inf. IX, 133; X, 2) ci sono invece gli “alti spaldi” e i “martìri”, cioè i tormenti degli eretici, fra i quali ‘passano’ i due poeti. Ma il tema del difendere rimane in Farinata, che difese la sua città “a viso aperto” (Inf. X, 93). Firenze è “nobil patrïa”, come la città celeste è definita “nobilis civitas” (v. 26; Ap 21, 9.12). Martìri e porta, martìri e murarsi sono elementi diversamente ricollocati in altri luoghi del poema.
Il valore di passammo (Inf. IX, 133) non è estraneo al ‘patire’ e alla prova. Lo si è già trovato, ad esempio, nel “bel fiumicello” posto a difesa del “nobile castello” del Limbo, che racchiude in embrione tutte le parti della città celeste, non allegoria ma antica storica figura in terra dell’Empireo, questa vista all’inizio del viaggio, quello al termine: “Questo passammo come terra dura” (Inf. IV, 109). Passare per una prova è senso che si ritrova nell’“alto passo” nel quale Dante non deve diffidare, perché Virgilio, sua guida, gli dà conforto e sicurezza come Cristo rassicura Smirne, la chiesa d’Asia propria dei màrtiri (Inf. II, 12; Ap 2, 8.10). Il “folle volo” di Ulisse e dei suoi compagni è come un ingresso in una murale clausura, forzata prima del tempo – “poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo” (Inf. XXVI, 132) -, dove il muro della superna città non è citato ma lo si può immaginare da tutti gli altri elementi (l’ingresso, l’altezza, il patire) offerti dall’esegesi di Ap 21, 12.
e veggio ad ogne man grande campagna (IX, 110). All’apertura del primo sigillo appare Cristo resuscitato, seduto su un cavallo bianco (Ap 6, 2). Si mostra cioè nel suo corpo glorioso e nella Chiesa primitiva resa bianca dalla grazia della rigenerazione e irradiata dalla luce della sua resurrezione. Sedendo su di essa, Cristo uscì nel “campo” del mondo non pavido o infermo, ma con somma magnanimità e insuperabile virtù. Condusse infatti nel mondo i suoi apostoli come leoni animosi e potenti nell’operare miracoli. In essi aveva l’arco della predicazione capace di saettare e di penetrare i cuori. Gli era stata data anche la corona regale, secondo quanto si dice in Matteo 28, 18: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra”. La corona riguarda anche i suoi apostoli, che aveva fatto principi e re spirituali di tutta la Chiesa e di tutto il mondo. Con l’arco saetta i reprobi con sentenze di condanna, con la corona glorifica i buoni. Cristo “uscì vittorioso per vincere”, cioè, secondo Riccardo di San Vittore, convertendo quelli tra i Giudei che aveva eletto per vincere, per mezzo di essi, i Gentili che aveva predestinato. Nella sua stessa uscita nel mondo apparve vittorioso come se avesse già vinto tutto.
Il tema del “campo” assume molteplici forme, dalla “buia campagna” che trema prima dello svenimento di Dante in Inf. III, 130-132, alla “grande campagna, / piena di duolo e di tormento rio” che il poeta vede appena varcata la porta della città di Dite (Inf. IX, 109-111), a Brunetto Latini, che “parve di coloro / che corrono a Verona il drappo verde / per la campagna; e parve di costoro / quelli che vince, non colui che perde” (Inf. XV, 121-124); al “campo maligno” di Malebolge che ha nel mezzo “un pozzo assai largo e profondo” (Inf. XVIII, 4-6), alla “campagna” che precede il monte al quale fuggono per purgarsi le anime adunate ad ascoltare il canto di Casella e disperse da Catone (Purg. III, 1-3).
Se la “grande campagna” in cui entra il poeta è il “campo” sul quale esce Cristo vittorioso all’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2), essa è però “piena di duolo e di tormento rio”; non è la campagna santa dell’Eden “che d’ogne parte auliva”, piena di ogni semenza (Purg. XXVIII, 5-6, 118-119).
piena di duolo e di tormento rio (IX, 111). La parte finale della settima guerra (Ap 14, 19-20; esaminata altrove), nella quarta visione apocalittica, vede l’angelo gettare l’uva vendemmiata nel grande tino (“lacus”) dell’ira divina. Il “lago” è “calcato” fuori della città di Dio, cioè fuori del luogo e del collegio dei beati, nella valle di Giosafat posta tra il monte Sion e il monte degli Ulivi, in cui staranno gli empi il giorno del giudizio. Dice Isaia (Is 30, 33) che la valle Tofet, che sta fuori Gerusalemme, è “preparata, profonda e larga” e che in essa “fuoco e legna abbondano e il soffio del Signore come torrente di zolfo” per incendiarvi il re degli Assiri col suo esercito. Dal “lago” “uscì sangue fino al morso dei cavalli per una distanza di 1600 stadi”. Il numero MDC, in cui sono compresi il sei, il cento e il mille, che sono numeri designanti la perfezione, indica il livello di perfezione del tormento dei dannati, minore, mediocre o perfetto. Significa pure che le pene dei dannati sono varie e adattabili in modo multiforme (Ap 14, 19-20).
Nel Flegetonte, “riviera del sangue”, i violenti contro il prossimo hanno la pena graduata secondo l’altezza del sangue in cui sono immersi: i tiranni, violenti contro le persone e le cose, stanno sotto “infino al ciglio” (Inf. XII, 103-105); gli omicidi, violenti solo contro le persone, fino alla gola (vv. 115-117); altri dannati, con pena via via meno grave (feritori, guastatori, predoni), tengono fuori del sangue bollente la testa e il busto o tutto il corpo salvo i piedi (vv. 121-125). Come spiega Nesso nel portare Dante sulla groppa, se da una parte il “bulicame” si riduce progressivamente in profondità, dall’altra ‘preme’ sempre più il suo fondo (il ‘premere’ della pena di Ap 19, 15) fino a raggiungere la massima altezza nel luogo dove sono puniti i tiranni (vv. 127-132).
Simile gradualità della pena si verifica nel “lago” di Cocito, per quanto in progressione ascendente rispetto a quella discendente registrata nel Flegetonte: i traditori dei parenti e i traditori della patria stanno immersi nel ghiaccio fino al collo col viso rivolto in giù, rispettivamente nella Caina e nell’Antenora (Inf. XXXII, 31-39); i traditori degli ospiti giacciono nella Tolomea col viso rivolto verso l’alto (Inf. XXXIII, 91-93); i traditori dei benefattori sono infine tutti coperti dal ghiaccio, in varie posizioni, nella Giudecca (Inf. XXXIV, 10-15).
Anche le arche roventi degli eresiarchi sono differenziate: “e i monimenti son più e men caldi” (Inf. IX, 131). L’uscita del sangue dal “lago”, ad Ap 14, 20, indica pure l’uscita del dolore provocato dalla violenza dei tormenti, come se tutto il sangue e tutti i visceri dei dannati fossero effusi fuori così da ridondare in un grande fiume o in un mare di amarissimo dolore. La compresenza dei motivi da Ap 14, 20 (l’uscita del dolore, il tormento, l’amaro, le varie proprietà delle pene dei dannati) conduce allo spettacolo che si presenta al poeta una volta varcata la porta della città di Dite (Inf. IX, 109-123). La grande campagna è “piena di duolo e di tormento rio”; il luogo è reso “varo”, cioè disuguale, dai sepolcri come accade nelle necropoli di Arles e di Pola, ma in modo “più amaro” per la presenza delle fiamme che li arroventano; dai coperchi sospesi dei monumenti “fuor n’uscivan sì duri lamenti”. Nel canto seguente, Virgilio afferma che i sepolcri verranno chiusi quando le anime avranno ripreso i propri corpi il giorno del giudizio, che avverrà nella valle di Giosafat, citata anch’essa nell’esegesi scritturale (Inf. X, 10-12).
che ferro più non chiede verun’ arte. … e fuor n’uscivan sì duri lamenti (IX, 120, 122); “S’ïo avessi le rime aspre e chiocce … Oh sovra tutte mal creata plebe / che stai nel loco onde parlare è duro” (Inf. XXXII, 1, 13-14) – Sicque es sonorum mutatur in ferrum asperum et durum”.
La discesa per gradi dal vertice della perfezione al fondo, con la conseguente necessità di risalire alla carità originaria, a poco a poco venuta meno, è uno dei temi più importanti dell’istruzione data ad Efeso, la prima e la metropolita delle sette chiese d’Asia, di cui tratta la prima visione (ad Ap 2, 5). Il tema, attorno al quale ruota una rosa ricca di motivi, si presta a molteplici variazioni nel poema, in primo luogo con il dare un senso spirituale all’andamento del viaggio. Nella prima parte dell’istruzione data alla chiesa di Efeso, Olivi utilizza il De eruditione hominis interioris (opera citata come Super Danielem) di Riccardo di San Vittore. Ivi si adduce l’esempio della statua sognata da Nabucodonosor, che discendeva di grado in grado dall’oro all’argento al rame al ferro e infine alla terracotta (Dn 2, 31-36). L’oro del capo indica il fulgido e fervido desiderio delle cose celesti, l’argento del petto e delle braccia la certezza del retto consiglio e il retto operare, le membra di rame la simulazione, quelle di ferro l’indignazione, quelle di terracotta la fiacchezza dissoluta. L’oro designa pure la devozione, l’argento la discrezione. Nelle virtù, come si sale per gradi al culmine, così si discende a poco a poco dal più alto all’infimo livello. Nessuno diviene turpe immediatamente, ma scivolando a poco a poco a partire dalla minima negligenza iniziale. Lo si può vedere in quanti sono all’inizio della conversione gioiosi di speranza, pazienti nella tribolazione, solleciti nell’operare, studiosi nella lettura, devoti nella preghiera, aurei per la carità, e che poi nel tempo della tentazione si tirano indietro, non però subito sprofondandosi ma cadendo prima dal bene in un bene minore e di qui nel male e infine nel peggio, secondo quanto si dice in Giobbe 14, 18-19: “un monte che cade scivola a poco a poco e la terra viene consumata dall’alluvione”.
Si è detto che il discendere per gradi, perdendo a poco a poco la carità per poi ritrovarla risalendo, sempre per gradi (cardine dell’esposizione di Riccardo su Daniele), è il tema che dà il movimento al viaggio, che si svolge prima “giù per lo mondo sanza fine amaro”, poi “salendo e rigirando la montagna / che drizza voi che ’l mondo fece torti” e infine “per lo ciel, di lume in lume” (Par. XVII, 112-115; Purg. XXIII, 125-126). Numerosi sono i luoghi del poema cuciti sul medesimo panno esegetico, da Minosse al volo in groppa a Gerione, dal Veglio di Creta ai gradini della scala d’oro discesa da Pier Damiani nel cielo di Saturno. Ma ciò che preme qui sottolineare è che l’esegesi di Riccardo, fatta propria dall’Olivi, può servire anche al discendere per gradi negli eloqui e negli stili, che acquista così un afflato cosmico e di storia universale nel viaggio concesso dalla Provvidenza. Nella discesa graduale del precipizio a partire dall’aurea carità iniziale, ad un certo punto il rame sonoro si trasforma nel ferro aspro e duro. Si tratta di una trasformazione che il poeta prova quando si trova “giù nel pozzo scuro”, nel fondo dell’inferno, “dove Cocito la freddura serra”. È un luogo “onde parlare è duro”, a meno di non possedere “le rime aspre e chiocce, / come si converrebbe al tristo buco / sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce”. Il poeta dichiara di non possederle, e confessa il proprio timore di non riuscire a esprimersi chiaramente: “non sanza tema a dicer mi conduco; / ché non è impresa da pigliare a gabbo / discriver fondo a tutto l’universo, / né da lingua che chiami mamma o babbo” (Inf. XXXII, 1-15). Teme di non essere adeguato alla materia che impone una caduta di stile, e non sottovaluta il pericolo, come il vescovo di Efeso non deve prendere alla leggera la caduta verso un bene minore. Gli aggettivi aspro e duro conducono alla “selva selvaggia e aspra e forte”, dire della quale, come parlare del fondo dell’inferno, “è cosa dura” e “che nel pensier rinova la paura” (Inf. I, 4-6).
Il ferro e la durezza sono propri anche delle arche arroventate degli eresiarchi, per quanto in questo caso venga taciuto il tema del ridire quanto visto. Né ad esse è estranea l’esegesi della prima tromba (Ap 8, 7; cap. XI), che suona contro la Giudea, terra indurita e infiammata (“e noi movemmo i piedi inver’ la terra”: Inf. IX, 104), e contro il carnale amor sui.
«Sicque es sonorum mutatur in ferrum asperum et durum (Ap 2, 5) … Predicta autem duritia et flamma … Per “terram” autem significatur hic Iudea (Ap 8, 7) … tanto plus induratur quasi grando et accenditur quasi ignis (cap. XI) – ché tra gli avelli fiamme erano sparte [1], / per le quali eran sì del tutto accesi, / che ferro più non chiede verun’ arte … e fuor n’uscivan sì duri lamenti (Inf. IX, 118-120, 122)».
Sì come ad Arli, ove Rodano stagna, / sì com’ a Pola, presso del Carnaro / ch’Italia chiude e suoi termini bagna (IX, 112-114). I versi relativi ai confini d’Italia, incisi sulla corona di bronzo e d’argento posta nel 1921 ai piedi del sepolcro di Dante, sono pregni di significati spirituali. L’accostamento del “Carnaro” al ‘chiudere’ insinua il senso, inversamente parodiato, del chiudere le cose spirituali agli uomini carnali (Ap 10, 4), senso cui perfino “Pola” – “palea” sembra partecipare, poiché gli spirituali vengono separati dai carnali come il grano dalla paglia (Ap 11, 1-2). Il bagnare deriva da Ap 1, 5, per cui Cristo ci lavò dai nostri peccati col prezzo del suo sangue. Anche il Rodano che “stagna” assume un significato negativo (ad Ap 19, 20 si afferma che la bestia e il falso profeta verranno messi vivi nello “stagno” di fuoco), tanto più se lo si confronta, a molti anni di distanza nella stesura, con “quel che fé” Cesare, visto da “ogne valle onde Rodano è pieno” (Par. VI, 58-60), e con quel che dice Carlo Martello della Provenza, “quella sinistra riva che si lava / di Rodano poi ch’è misto con Sorga” (Par. VIII, 58-60): il Rodano scorre per Avignone, il luogo dove nel 1309 il gigante capetingio ha tratto il “mostro” e la “puttana sciolta” (Purg. XXXII, 157-158); il lavarsi appartiene allo stesso gruppo tematico, da Ap 1, 5, del lavarsi dai peccati col sangue della redenzione, cui deve alludere “Sorga”, il purissimo fiume di Valchiusa. E i “termini”, cioè i confini, sono da ricondurre alla citazione del Deuteronomio 32, 8 – “Quando l’Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell’uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli Israeliti” – che illumina ad Ap 21, 17 il fatto che i quattro lati della Gerusalemme celeste hanno misura regolare, divina e non umana, nella lunghezza, larghezza, altezza. Il cingere la città rientra nell’esegesi di Ap 20, 8, allorché Gog e Magog, l’ultima delle tribolazioni, cingono d’assedio l’accampamento dei santi e la città diletta, la quale, secondo Agostino, non si trova in un solo luogo ma è diffusa in tutto il mondo e fra tutte le genti.
L’Italia, separata o cinta dai carnali, ad essi chiusa o da essi circondata, è figura in terra della città celeste. È l’“Italia bella” evocata da Virgilio in apertura della digressione sulle origini di Mantova (Inf. XX, 61). L’espressione, per il motivo della “pulchritudo” che contiene, è da ricondurre alla quinta chiesa di Sardi, al suo bel principio in cui la Chiesa apparve, in forma di mirabile bellezza, come una regina ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei vari doni e nelle varie grazie delle diverse membra (il verso “Per mille fonti, credo, e più, si bagna”, v. 64, fa ancora riferimento al lavare i peccati degli uomini per opera della redenzione di Cristo da Ap 1, 5). La città celeste è “civium unitas”, unità concorde dei cittadini, simile a vetro terso per la pura confessione della verità che dichiara i propri peccati con chiarezza, umiltà e senza falsa simulazione (Ap 21, 18.21). Di essa l’Italia è figura peregrinante in terra: come dice Sapìa senese, “O frate mio, ciascuna è cittadina / d’una vera città; ma tu vuo’ dire / che vivesse in Italia peregrina” (Purg. XIII, 94-96). È “quella umile Italia” della quale il Veltro “fia salute” (Inf. I, 106). Ad Ap 8, 7 (prima tromba) si afferma che la Giudea fu da Dio resa terra abitabile e separata dalle acque perché potesse dedicarsi al culto divino nella quiete e dare i frutti delle buone opere, le verdi “erbe” che designano i “semplici” e gli alberi che designano i perfetti. Le verdi “erbe”, che alle locuste viene proibito di ledere (Ap 9, 4), sono coloro che conservano, in modo onesto e pio, l’umiltà e il verde della fede. Il tema è appropriato a Francesco che, per trovare troppo acerba alla conversione la gente saracena, “redissi al frutto de l’italica erba” (Par. XI, 103-105). E sarà proprio il popolo d’Israele – figura dell’Italia – ad essere convertito a Cristo per ultimo, alla fine dei tempi.
Tutti li lor coperchi eran sospesi (IX, 121). La descrizione della pena degli eresiarchi conduce anche ai primi versetti del capitolo IV, in relazione al cielo, cioè alla Scrittura, che viene aperto a Giovanni elevato a visioni sempre più nuove e ardue (Ap 4, 2: “et ecce ostium apertum in celo”; un esame compiuto è stato condotto altrove). Come sulla porta della tomba di Cristo era posta una pietra grande e pesante che fu rimossa al momento della resurrezione, così il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso all’intelligenza spirituale. Nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. L’assenza di grandi opere nella Chiesa era anch’essa come una porta chiusa che impediva di contemplare la “fabrica ecclesie”. Colui che per primo aprì la porta e diede la prima voce che ci fece salire al cielo fu Cristo, con la sua illuminazione e dottrina. La voce degli antichi profeti, che chiuse la porta con figure e promesse terrene, depresse il senso carnale dei Giudei piuttosto che elevarlo. Cristo, invece, con l’esempio della sua vita spiritualissima, con la morte della sua carne e con l’abbondante infusione del suo spirito, fece in modo che gli apostoli e qualunque uomo spirituale fossero in spirito e quasi non in carne (“et statim fui in spiritu”), secondo quanto detto ai Corinzi da san Paolo: “L’uomo animale non percepisce né può comprendere le cose dello Spirito di Dio, l’uomo spirituale invece giudica ogni cosa”, cioè è dotato di discernimento (1 Cor 2, 14-15). Cristo, in Giovanni 10, 1-9, definisce sé “porta” e “portinaio”. Chi con chiara fede e intelligenza si fissa in lui in modo che gli venga incontro in ogni luogo della Scrittura e in ogni fatto della Chiesa, lo avrà in quei luoghi e in quei fatti come il sole che irraggia fugando le tenebre.
Il tema, da Ap 4, 2, della pietra rimossa che chiude la tomba, congiunto con quello della durezza sopra considerato, si trova nelle arche degli eretici, “monimenti”, o “sepolcri”, dai “coperchi … sospesi … levati” fino al momento in cui verranno chiusi nel giorno del giudizio, ma dai quali “fuor n’uscivan sì duri lamenti” (Inf. IX, 121-123; X, 7-12).
Questi significati, appropriati alle arche infuocate, non escludono il senso letterale, in cui sono racchiusi; si tratti di un calco dei roghi comminati come pena degli eretici da Federico II [2] oppure del Salmo 48, 12-13, dove è presente la medesima equiparazione fra uomini e bestie data da Ecclesiaste 3, 18-19, con l’aggiunta: “sepulchra eorum domus illorum in aeternum”, luogo addotto da Salimbene nel noto passo su Federico II epicureo.
L’essere “sospesi” ha qui un senso proprio, da connettere alla contemplazione. Dei quattro animali (o esseri viventi) che ad Ap 4, 7-8 sono in mezzo e intorno al trono della sede divina, quello simile a un’aquila che vola designa coloro i quali “sono sospesi nella contemplazione”. L’apertura del coperchio ‘sospeso’ delle arche allude alla possibilità di vedere il futuro da parte dei dannati. Farinata vede, cioè contempla, le cose che sono lontane nel tempo, senza sapere nulla degli eventi vicini o presenti (Inf. X, 97-108; cfr. infra). Ma questa “mala luce”, cui fa riferimento la sospensione del coperchio, verrà meno il giorno del giudizio, allorché non ci sarà più futuro e l’avello verrà chiuso e con esso l’accesso all’illuminazione divina che “cotanto ancor ne splende” e consente al ghibellino di profetizzare l’esilio di Dante.
L’essere sospesi nella contemplazione come un’aquila (Ap 4, 7-8) si accompagna allo stare fissi nel tempio come una colonna, proprio della sesta vittoria (Ap 3, 12). Ne è esempio Beatrice la quale, nell’attesa che le schiere del trionfo di Cristo discendano al cielo delle stelle fisse, “stava eretta / e attenta … sospesa e vaga” verso il mezzogiorno, come sta l’uccello che con ardente affetto attende la luce del sole (Par. XXIII, 10-15: l’attendere è tema del quinto sigillo, ad Ap 6, 11; il meriggio è proprio del sesto stato, quando la faccia di Cristo riluce come il sole in tutta la sua virtù, ad Ap 1, 16). Ne è ulteriore esempio il pellegrino che, pervenuto all’Empireo, “si ricrea / nel tempio del suo voto riguardando” e comprende con lo sguardo la forma generale del paradiso “in nulla parte ancor fermato fiso”, per cui si rivolge a Beatrice desideroso di domandare “di cose / di che la mente mia era sospesa” (Par. XXXI, 43-44, 52-54, 56-57).
La contemplazione (corrispondente al senso anagogico) viene resa con l’immagine dell’aquila: “in aquila (accipiamus) contemplatione suspensos”, si dice appunto nell’esegesi di Ap 4, 7-8, citando Gioacchino da Fiore, a proposito dei quattro esseri viventi che circondano la sede divina: leone, bue o vitello, uomo, aquila. Di qui il valore equivoco dell’esser “sospesi”, che designa sì lo stato di coloro che, nel Limbo, vivono in eterno nel desiderio di Dio senza speranza di appagamento, ma pure lo stato di chi, contemplando, è capace di vedere più degli altri. Il volare di Omero sopra gli altri è un filo tratto dalla quarta tromba (il quarto stato è per antonomasia quello dei contemplativi): si tratta di un’altra citazione gioachimita, relativa a Gregorio Magno che molto scrisse sulla fine del mondo e che seppe meglio di chiunque altro percorrere i sentieri dell’allegoria, “ardue vie del cielo” (Ap 8, 13): “quique allegoriarum semitas ac si arduas celi vias altius pre ceteris prevolavit – che sovra li altri com’ aquila vola” (Inf. IV, 96).
In tal senso è da intendere la curiosa terzina riferita a Maometto (Inf. XXVIII, 61-63), il quale parla di Fra Dolcino ‘sospendendo’, cioè alzando, un piede per rimettersi in cammino e distendendolo poi a terra, finito di parlare, nell’allontanarsi. Maometto è dotato di spirito profetico, per cui contempla la futura fine dell’eretico novarese per “stretta di neve” e fa concordare il movimento del piede con il quarto senso della Scrittura, l’anagogico, assimilato all’aquila sospesa nella contemplazione e al profetare. Cessata la profezia, il piede si distende per terra in quanto dal senso anagogico, in virtù del quale stava sospeso, scende al senso letterale designato dal vitello (o bue) che solca la terra. Maometto riprende “la dolente strada” verso il diavolo che riapre le ferite con la spada, perché tale è “il martiro” inflitto ai seminatori di scandalo e di scisma, e anche questo concorda con l’animale sofferente, aggiogato, destinato al martirio che designa il senso storico o letterale.
E io: “Maestro, quai son quelle genti …” (IX, 124). All’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 13-14), un vegliardo domanda (“risponde”) a Giovanni: “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono”, cioè di quali e quante dignità sono insigniti, “e donde vengono?”, cioè per quali meriti e quale via di santità sono pervenuti a tanta gloria; e Giovanni, quasi discepolo a maestro: “Signore mio, tu lo sai”, come per dire: io non lo so ma insegnamelo tu che lo sai; e il vegliardo: “Essi sono coloro che sono venuti”, a tanta gloria, “attraverso la grande tribolazione”, cioè attraverso le grandi tribolazioni patite per Cristo. Questi versetti, con i motivi che recano, sono ancillari di numerose agnizioni del poema. Si tratta di temi banali, per cui qualcuno chiede chi sia un altro, e da dove venga, tanto ovvi che li si ritrova nelle parole di Nestore a Telemaco (Odissea, III, 71); qui però si registra una rosa semantico-tematica, che rende unica quella forma comune di dire e la applica a qualsivoglia situazione.
E quelli a me: “Qui son li eresïarche / con lor seguaci, d’ogne setta, e molto / più che non credi son le tombe carche” (IX, 127-129). “E il nome della stella è assenzio” (Ap 8, 11; terza visione, terza tromba), poiché dopo la caduta quella stella fu amarissima come l’assenzio e per questo restò famosa. “E molti uomini morirono nelle acque”, a causa cioè dell’erronea esposizione della Scrittura molti persero la vita della fede e della grazia per cadere in peccato mortale e nella morte eterna. Qui non parla di “terza parte degli uomini”, ma dice “molti uomini” per indicare che in tutto il mondo furono innumerevoli coloro che morirono a causa dell’eresia di Ario e degli altri eresiarchi, che in un primo tempo erano apparsi grandi stelle ardenti in cielo.
I “molti uomini” morti per l’errore sono ricordati due volte da Virgilio: la prima a proposito delle arche degli eresiarchi – “e molto / più che non credi son le tombe carche” (Inf. IX, 127-129) -, la seconda con le turbate parole dette in Purg. III, 34-45 nell’invitare l’“umana gente” a stare “al quia”, a non desiderare cioè di conoscere con la ragione le cose trascendenti, come fecero invece coloro ai quali questo desiderio inappagato è dato come pena eterna nel Limbo – “io dico d’Aristotile e di Plato / e di molt’ altri”. Ciò non significa, naturalmente, che Dante non distingua fra eretici ed erranti, ma che i motivi dei primi invadono parzialmente l’ambito dei secondi.
La comunanza degli eresiarchi nel peccato e nella pena (“Simile qui con simile è sepolto”, Inf. IX, 130) rinvia ad Ap 17, 11 (i peccati commessi dalla bestia, cioè dai malvagi, nei sette stati) collazionato con Ap 2, 1 (la compartecipazione della chiesa con il proprio vescovo nelle azioni lodate o vituperate da Cristo nelle istruzioni date tramite Giovanni nella prima visione).
e al disio ancor che tu mi taci. (X, 18) È Virgilio a disporre virtuosamente il cuore di Dante al successivo desiderio di vedere Farinata (vv. 16-21). Desiderio che è recondita preghiera che piace (“com’ a te piace”, v. 5; Ap 5, 8); il poeta pagano conosce, come Cristo (e Beatrice), ogni pensiero del suo discepolo (Ap 2, 1); questi tace come ai discepoli spirituali (designati da Giovanni), desiderosi di propalare i significati spirituali dei sette tuoni che risuonano nei loro cuori, viene imposto di tacere (Ap 10, 4).
[1] Il tema della dispersione per tutta l’area dell’impero romano dei reprobi e dei giusti, che corrono insieme in questa vita, presente ad Ap 17, 1 in una citazione di Gioacchino da Fiore dove viene spiegato il significato del nome della meretrice – Roma – pare pure ritrovarsi nella descrizione della “grande campagna” vista dal poeta appena entrato nella città di Dite: “ché tra li avelli fiamme erano sparte” (cfr. Par. XXVIII, 31-33).
[2] Cfr. GIROLAMO ARNALDI, Dante Alighieri, in Enciclopedia Fridericiana, I, 2005, p. 464.
Tab. I
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7 (IIIa visio, Ia tuba)] “Grando” significat duritiam et pertinaciam Iudeorum, que ad predicationem Christi et apostolorum fuit fortius congelata et indurata, sicut ad Moysi verba et signa Pharao fortius induravit cor suum.
|
[LSA, cap. XI (Ia tuba)] Moraliter vero possunt sic exponi hec septem predicta tubicinia. Primus enim angelus tubicina<t> contra inordinatum sui amorem. Amor enim sui est fundamentum om-nium affectuum, sicut terra est fundamentum herbarum et arborum. Due autem partes eius sunt bone, scilicet amare Deum sibi et amare se Deo et suis. Tertia vero pars, scilicet amare se carnaliter seu propter se est mala, et quanto plus voci divine rebellat tanto plus induratur quasi grando et accenditur quasi ignis et corruptioni carnis et impietati quasi sanguini commiscetur.[LSA, cap. VI, Ap 6, 2 (IIa visio, apertio Ii sigilli)] In prima autem apertione apparet Christus resuscitatus sedens in equo albo (Ap 6, 2), id est in suo corpore glorioso et in primitiva ecclesia per regenerationis gratiam dealbata et per lucem resurrectionis Christi irradiata, in qua Christus sedens exivit in campum totius orbis non quasi pavidus aut infirmus, sed cum summa magnani-mitate et insuperabili virtute. Nam suos apostolos deduxit in mundum quasi leones animosissimos et ad mirabilia facienda potentissimos, et “habebat” in eis “archum” predicationis valide ad corda sagit-tanda et penetranda. |
|
|
Purg. VIII, 52-57, 61, 67-81Ver’ me si fece, e io ver’ lui mi fei:
|
|
[LSA, cap. VII, Ap 7, 10.13-14 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] “Et clamabant voce magna” (Ap 7, 10), id est magna devotione, “dicentes: Salus Deo nostro”, id est salus nostra non nobis ascribatur, quia non est a nobis, sed ascribatur illi a quo est, scilicet “Deo nostro, qui sedet super tronum”, id est divinitati magnifice regnanti, “et Agno”, id est Christo homini. Vel “salus”, quam habet deitas per naturam et Christi humanitas per gratiam, decante<tur> per nos ad eius laudem. […] “Et respondit” (Ap 7, 13), id est prolocutus est, “unus de senioribus”, per quem secundum Ricardum designatur universitas prophetarum et apostolorum et doctorum docens iustitiam et gloriam electorum*. Et secundum hoc sumitur hic “unus” quasi loquens in persona omnium. Secundum vero Ioachim, iste “unus” est beatus Iohannes, cuius est liber iste. Ipse enim s<cis>citatur et excitat nos ad querendum et intelligendum et ad imitandum istos sanctos. Ipse est enim unus et magnus de hiis viginti quattuor senioribus. Nos sumus hic designati per ipsum in quantum edocebatur ab angelo tenente formam senioris*. “Et dixit michi: Hii, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis, “et unde venerunt”, id est ex quibus meritis et per quam viam sanctitatis ad tantam gloriam pervenerunt ? “Et dixi illi: Domine mi, tu scis” (Ap 7, 14), quasi dicat: ego nescio, sed tu doce me, quia tu hoc scis. “Et dixit michi: Hii sunt qui venerunt”, scilicet ad tantam gloriam, “de tribulatione magna”, id est pro magnis tribulationibus, quas ab impiis et etiam a se ipsis contra suas concupiscentias concertantibus pro Christo passi sunt. “Et laverunt stolas suas”, id est corpora et animas, “et dealbaverunt eas”, scilicet candore perfecte gratie, “in sanguine Agni”, id est in merito passionis Christi per fidem et baptismum et per penitentiales mortificationes et tandem per martirium participato.[LSA, cap. V, Ap 5, 4 (radix IIe visionis)] Deinde subditur gemitus Iohannis procedens ex desiderio apertionis et ex visa impossibilitate et indignitate omnium ad ipsam complendam. Ait enim: “Et ego flebam multum, quoniam nemo dignus inventus est aperire librum nec videre illum” (Ap 5, 4). Iohannes tenet hic typum omnium sanctorum patrum salvatorem et divine gratie et glorie promeritorem et impetratorem et largitorem desiderantium et pro eius dilatione et inaccessibilitate gementium. Hic autem gemitus pro tanto est in sanctis post Christi adventum pro quanto ad ipsum pro consumatione totius ecclesie et pro gratia et gloria per ipsum impetranda et largienda toto corde suspirant, et pro quanto cum humili gemitu recognoscunt nullum ad hoc fuisse potentem et dignum nisi solum Christum; potissime tamen designat cetum et statum contemplativorum, qui pre ceteris altius et viscerosius ad istud suspirant.
|
||
[LSA, cap. XX, Ap 20, 8 (VIIa visio)] Et subdit: «Quod vero ait: “Et ascenderunt super <la>titudinem terre, et circuierunt castra sanctorum et civitatem dilectam” (Ap 20, 8), non ad unum locum venisse vel venturi esse significati sunt, quasi in uno loco futura sint castra sanctorum et dilecta civitas, cum hec non sit nisi Christi ecclesia toto orbe diffusa; ac per hoc ubicumque tunc erit, que in omnibus gentibus erit, quod significatur per latitudinem terre, ibi erunt castra sanctorum et civitas Deo dilecta, ibique a suis inimicis cingetur, id est in angustias tribulationis artabitur et concludetur». Hec Augustinus (De civ. Dei, XX, 11).[LSA, cap. XXI, Ap 21, 17 (VIIa visio)] Tanta autem equalitas designat summam concordiam beatorum in regno Dei. Quod autem subdit (Ap 21, 17): “Et mensus est muros eius centum quadraginta quattuor cubitorum”, pro singulis millenariis singuli cubiti accipiendi sunt, ut illud esse videatur numerus perfectus in sanctorum collegiis quod circa murorum spatia cubitus in mensura. Quod autem dicitur “mensura hominis, que est angeli” (Ap 21, 17), ostendit esse mensuram unam angelorum et sanctorum hominum, iuxta illud Deuteronomii XXXII°: “Constituit terminos gentium iuxta numerum angelorum Dei” (Dt 32, 8), secundum litteram septuaginta. Et Matthei XXII°, dicit Christus quod sancti in resurrectione “erunt in celo sicut angeli Dei” (Mt 22, 30), et Luche XX° dicit quod “sunt equales angelis” (Lc 20, 36).[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7 (IIIa visio, Ia tuba)] Per “terram” autem significatur hic Iudea, quia sicut terra habitabilis fuit segregata a mari et discooperta aquis, ut posset homo habitare in ea et ut ipsa ad usum hominis posset fructificare et herbas et arbores fructiferas ferre, sic Deus mare infidelium nationum et gentium separaverat a terra et plebe Iudeorum, ut quiete colerent Deum et facerent fructum bonorum operum, et ut essent ibi simplices in bono virentes ut herbe, et perfecti essent ut arbores grandes <et> solide et fructuose. |
||
[LSA, cap. X, Ap 10, 4 (IIIa visio, VIa tuba)] Sequitur (Ap 10, 4): “Et ego scripturus eram, et audivi vocem de celo dicentem: signa”, id est quasi sigillo firmo in tuo corde claude illa “que locuta sunt septem tonitrua, et noli ea scribere”. Hic demonstratur primo pium desiderium spiritalium discipulorum ad propalandum omnibus spiritales sensus septem tonitruorum in eorum cordibus vehementer et stupende resonantium. Secundo monstratur quomodo a Christo et eius Spiritu et a sanctis doctoribus prohibentur ne pandant ea homini carnali et animali quibus non licet talia loqui, iuxta illud Christi: “Vobis datum est nosse misterium regni Dei, ceteris autem in parabolis” (Lc 8, 10), et “nolite sanctum dare canibus neque porcis” (Mt 7, 6). Sunt enim quedam sic omnibus communia quod sunt omnibus publice predicanda, quedam vero non sunt omnibus dicenda et precipue ante tempus, iuxta illud Matthei XVII° (Mt 17, 9): “Nemini dixeritis visionem, donec Filius hominis a mortuis resurgat”. Unde et sub sexto signaculo Veteris Testamenti dicit angelus Danieli: “Tu autem, Daniel, claude sermones et signa librum usque ad tempus statutum” (Dn 12, 4), quod quidem erat sexta etas in qua apparuit Christus, et precipue sextus status ecclesie sue in quo liber erat plenius aperiendus, non tamen malivolis aut indispositis. Ante enim mortem magni Antichristi oportebit multa tunc sanctis aperta claudere emulis et etiam fidelibus vel adhuc animalibus. |
[LSA, cap. XI, Ap 11, 1-2 (IIIa visio, VIa tuba)] Sicut enim in trituratione messium multitudo palee segregatur a grano, sic in illa cribratione et trituratione ecclesie separabuntur publice ab electis palee et quisquilie, et hoc tam per vim tribulationis paleas dispergentis et palam apostatare seu veritati repugnare facientis, tum quia tunc spiritales et precipue eorum rectores summe studebunt se et suos sequestrare a carnalibus et a quibuscumque non consentaneis evangelice veritati et puritati.
Par. XI, 103-105e per trovare a conversione acerba
|
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 5 (septem notabiles primatus Christi secundum quod homo)] Quinto primatum nostre iustificationis et redemptionis, quam iustificationem tangit dicendo: “et lavit nos a peccatis nostris”; redemptionem vero cum subdit: “in sanguine suo”, id est in merito sue passionis et mortis cuius modum et speciem exprimit sanguis effusus. Servat autem methaforam leprosorum, qui per balneum sanguinis mundi et calidi expurgantur et sanantur. Premisit autem “qui dilexit nos”, ad monstrandum quod ipse nos redemit et lavit non ex sua necessitate vel utilitate, vel ex debito vel ex timore aut ex coactione, sed ex sua sola misericordia et gratuita caritate. |
||
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 20 (IVa visio, VIIum prelium)] Secundum vero Ricardum, per exitum sanguinis usque ad frenos equorum designatur quod crudelitas eterne dampnationis non tantum cruciabit pravos homines, qui sunt equi demonum, sed etiam ipsos demones, qui sunt rectores eorum*. Per stadia vero mille sescenta, id est quater quadringenta, designatur quod eorum culpa est diffusa per quattuor partes mundi et per quattuor tempora anni et contra precepta quadriformis evangelii. Et etiam in senario et centenario et millenario stadiorum sanguinis designatur minor et mediocris et perfectissima perfectio cruciatus dampnatorum, quia isti numeri perfectionem significant, ut sic per hunc numerum simul describatur omnium dampnatio ut singulis in suo gradu competat proportionaliter et perfecte**.
|
||
[segue 14, 20] Per exitum autem sanguinis designatur emissio mortiferi doloris per vim tormentorum educti, ac si totus sanguis et omnia viscera dampnatorum violenter effunderentur extra, ita quod redundaret in magnum flumen seu mare doloris amarissimi.
|
|
|
2. Farinata: l’agnizione (X, 22-39)
O Tosco. Eco solenne dei Tusci virgiliani fronteggianti i Rutuli (Aen, XI, 629; XII, 551) [1], ma significante, in modo più amaro, una maledetta terra di Toscana intossicata, avvelenata e inselvatichita, da ‘calcare’ come il diavolo gettato a terra ad Ap 12, 9 (cfr. nota).
Vivo ten vai così parlando onesto. La canna simile a una verga (il “calamus similis virge”, dato a Giovanni, che corregge e piega i duri cuori degli uomini: terza visione, sesta tromba), che designa il potere e la discrezione nel reggere la Chiesa, viene interpretata anche come la “lingua erudita”, che serve a correggere i duri cuori degli uomini, come con la verga si piegano le bestie indomite (Ap 11, 1). Questa “lingua erudita” è altresì propria dell’angelo che ad Ap 14, 14 (quarta visione, settima guerra) siede sopra una nube candida con in capo la corona d’oro e in mano la falce acuta: secondo Gioacchino da Fiore, l’immagine designa un ordine di giusti ai quali è dato di imitare in modo perfetto il Figlio dell’uomo e di possedere l’eloquio per diffondere il Vangelo del regno e per raccogliere nel campo del Signore l’ultima messe. La nube candida indica che la “conversatio” dell’angelo, cioè la sua vita religiosa, non è gravata da oscurità ma è lucida e spirituale.
La “lingua erudita”, di cui si parla ad Ap 11, 1 e ad Ap 14, 14, è anche honesta. Se si confronta infatti Ap 11, 1 con Ap 1, 13, dove si tratta della terza perfezione di Cristo sommo pastore (prima visione), si può notare che all’autorità pontificale si addice tanto il “calamus similis virge”, cioè l’eloquio, quanto la “honestatis sanctitudo”.
Se si confronta ancora Ap 14, 14 con Ap 3, 18 (prima visione, esegesi della settima chiesa, Laodicea), si vede che la “conversatio non … ponderosa et obscura sed lucida et spiritalis”, propria di quanti hanno la “lingua erudita” (Ap 14, 14) è “conversatio honesta” e consiste nell’“ornatus” esteriore delle buone opere (Ap 3, 18; il “parlare onesto” e la “parola ornata” di Virgilio, come affermato da Beatrice a Inf. II, 67, 113).
Il potere di correzione, che ad Ap 11, 1 si dice dato al pontefice, al maestro o comunque a chi governa, è quello proprio della nona perfezione di Cristo sommo pastore (Ap 1, 16), per cui la giustizia retta e severa si esprime nella parola viva, nel “sermo vivus” che penetra efficace come una spada a doppio taglio, secondo quanto affermato nella Lettera agli Ebrei 4, 12.
La collazione di tutti questi passi, collegati tra loro da parole-chiave (“pontificalis” per Ap 11, 1 e 1, 13; “conversatio” per Ap 14, 14 e 3, 18; “corrigere / correctio” per Ap 11, 1 e 1, 16) e vertenti anche sul tema dell’eloquio, fornisce il panno per tessere le parole con cui Farinata si rivolge a Dante: “O Tosco che per la città del foco / vivo ten vai così parlando onesto” (Inf. X, 22-23).
Certamente è presente, nel parlare ornato e onesto, una “concezione classico-umanistica della poesia (di lunghissima durata), i cui valori principali sono il decoro formale, l’efficacia etica, la fama” [2]. Ma i significati ciceroniani dell’“oratio erudita” contrapposta all’“oratio popularis”, degli illuminati “erudita saecula” che Dante contrapporrebbe alle “etati grosse”, sono congiunti con ben altro valore. La “lingua eudita”, nella citazione dall’Expositio in Apocalypsim di Gioacchino da Fiore riportata da Olivi ad Ap 14, 14, è la lingua della conversione finale e universale “ad evangelizandum evangelium regni et colligendam in aream Domini ultimam messionem”. Essa è propria di quanti, designati dall’angelo che sta su una nube candida (per purezza spirituale), appartengono a un ordine di giusti imitatori del Figlio dell’uomo.
Virgilio che guida, mosso dalla “donna del ciel”, e Beatrice incarnano entrambi due distinte prerogative di Cristo. Corrispondono il primo all’insegnamento di Cristo in quanto uomo e in quanto “lux simplicis intelligentie”, o verbale sapienza del Padre; la seconda ai suggerimenti, per gusto interiore d’amore, dello Spirito di Cristo, ai quali prepara la voce esteriore del Figlio dell’uomo. Beatrice rappresenta il gusto e il sentimento dell’amore, appropriato allo Spirito Santo (Ap 2, 7). Mossa da amore, fa muovere Virgilio alla salvezza del suo amico: “Or movi, e con la tua parola ornata … l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata. … amor mi mosse, che mi fa parlare” (Inf. II, 67-72: il Paraclito è ‘consolatore’). Virgilio e Beatrice operano entrambi, come Cristo, per mezzo della “locutio”, cioè della favella; il primo con la “parola ornata”, la seconda con il parlare dettato da amore che suggerisce all’altro ciò che debba fare.
La tua loquela ti fa manifesto. Ad Ap 22, 16, quasi a conclusione del libro, Cristo si definisce “stella splendida”, illuminatrice dei santi, e “matutina”, che promette, predica e mostra la luce futura dell’eterno giorno. È stella in quanto fu uomo mortale e sole in quanto Dio. Prima ancora, si definisce “radice e stirpe di David”, il che comporta un confronto con altro e più importante passo, ad Ap 5, 5.
Nel quinto capitolo, un angelo forte chiede a gran voce chi sia degno di aprire il libro e di scioglierne i sigilli (Ap 5, 2). Segue il gemito e il pianto di Giovanni, a nome di tutti coloro che sospirano l’apertura del libro ma constatano che nessuno è in grado di aprirlo e leggerlo (Ap 5, 4). Uno dei vegliardi dice a Giovanni di non piangere più, perché ha vinto il leone della tribù di Giuda, la radice di David (Ap 5, 5). È Cristo, nato dalla tribù di Giuda, che aprirà il libro risorgendo possente e invincibile come un leone verso la preda. Egli nascerà dalla radice di David in quanto radice di tutta la vita spirituale precedente e successiva, sia dei fedeli venuti dopo di lui, sia dei santi padri che precedettero. Come tutti i rami di un albero procedono dalla radice e in essa trovano solidità, così tutto l’albero dei santi del Vecchio e del Nuovo Testamento procede da Cristo e da lui prende vigore. Viene fatto riferimento a David, piuttosto che ad altri santi padri, sia perché fu l’istitutore del regno e del culto divino, sia per mostrare che Cristo ha dignità regale e potere sui presenti e sui futuri, sia perché a David fu singolarmente promesso che Cristo sarebbe nato dalla sua stirpe e avrebbe compiuto la costruzione del tempio e del regno e del culto di Dio, sia perché la chiave di David, cioè il giubilo della salmodia spirituale, è quella che apre il libro (cfr. Ap 3, 7).
■ Dante aveva ben presente il valore dell’espressione “radice di David”. Di questa parla nel Convivio (IV, v, 5-6), per dimostrare che il disegno divino di inviare un “celestiale rege” da una “progenie santissima” – quella di Iesse padre di David, secondo la profezia di Isaia – dalla quale nascesse Maria, “la baldezza e l’onore dell’umana generazione”, coincise con l’altro disegno, la divina elezione dell’impero romano: David nacque infatti nello stesso tempo in cui nacque Roma, cioè in cui Enea venne da Troia in Italia.
Cunizza (Par. IX, 25-33) racconta di sé con i motivi della radice di David, del vecchio e del nuovo (Ap 5, 5; 22, 16). Sorella di Ezzelino da Romano – di “una facella / che fece a la contrada un grande assalto” – è una con lui nello stipite: “D’una radice nacqui e io ed ella” (v. 31). Il forte contrasto tra il feroce tiranno punito nel Flegetonte che bolle di sangue (Inf. XII, 109-110) e la sorella vinta in terra dall’inclinazione amorosa, per influsso di Venere, stella dove ora rifulge, sembra accennare ai due Testamenti, il Vecchio e il Nuovo, che hanno entrambi una sola radice in Cristo.
Il tema della radice di David (Ap 5, 5; 22, 16), per cui Cristo, nato dalla tribù di Giuda, aprirà il libro segnato da sette sigilli risorgendo possente e invincibile come un leone verso la preda, radice di David in quanto stipite di tutta la vita spirituale a lui precedente e successiva, risuona alto nell’incontro tra Virgilio e Sordello. L’anima del trovatore, altera e disdegnosa, se ne sta “sola soletta … solo sguardando / a guisa di leon quando si posa” (Purg. VI, 58-66). Il ‘posarsi’ deriva da Ap 21, 16 (la misura della città celeste, nella settima visione) e indica in senso paolino (1 Cor 9, 24) lo stare trionfale (elemento che collega questo passo ad Ap 5, 5) di chi, dopo aver corso nello stadio, ha ottenuto il premio corrispondente al merito: Sordello è ormai già spirito eletto, sicuro di arrivare a vedere l’alto Sole. Al suo opposto, al termine dell’invettiva contro la “serva Italia”, sta la dolorosa Firenze, “quella inferma / che non può trovar posa in su le piume” (vv. 148-151). A Virgilio che lo interroga sulla migliore via per salire la montagna, Sordello non risponde ma a sua volta interroga “di nostro paese e de la vita”. Al nome “Mantüa …” pronunciato da Virgilio, Sordello “surse ver’ lui”: il leone, prima posato, risorge all’udire che di una sola radice nacque lui e il suo concittadino. Una è la vita spirituale che unisce l’antico poeta e il nuovo, per cui “e l’un l’altro abbracciava” (vv. 67-75).
Variazione del tema è nelle parole di Ugo Capeto, “radice” suo malgrado “de la mala pianta … per cui novellamente è Francia retta”, dopo il venir meno de “li regi antichi … / tutti, fuor ch’un renduto in panni bigi” (Purg. XX, 43-54).
I motivi connessi alla ‘radice di David’, di Cristo risorgente stipite della vita sia dei fedeli che vennero dopo come dei santi padri che precedettero, è cantato, ancora, dalle due corone degli spiriti sapienti nel cielo del Sole, pronte a dire “Amme!” dopo il discorso di Salomone, mostrando così il desiderio di ricongiungersi coi loro corpi morti, “forse non pur per lor, ma per le mamme, / per li padri e per li altri che fuor cari / anzi che fosser sempiterne fiamme”: versi in cui il motivo del desiderio (che ad Ap 5, 4 è per l’apertura del libro) è accostato a quello della resurrezione e a quello degli antichi padri (Par. XIV, 61-66). Nel cielo seguente, Cacciaguida si definisce “radice” di Dante (Par. XV, 88-90).
■ La Chiesa, nella settima visione apocalittica, viene descritta come una città nobilissima, edificata, illuminata, abitata e onorata con molti doni, opulenta, irrigata, ornata di alberi fruttuosi e segregata da ogni male. È sede regia, perché “Il trono di Dio e dell’Agnello sarà in essa” (Ap 22, 3). Affinché non si creda trattarsi alla lettera di una città di pietra o d’oro, viene dapprima chiamata dall’angelo “sposa e moglie” dell’Agnello (Ap 21, 9). “Sposa”, perché unita al celeste sposo con amore spirituale e nuziale. “Moglie”, perché fecondata dalla grazia di Cristo per la procreazione spirituale di molti figli e di buone opere. Questa nobilissima città (l’aggettivo compare riferito sia alla città [ad Ap 21, 12], sia al fiume che scorre nel mezzo [ad Ap 22, 1]) si trasforma nella “nobil patrïa” di cui dice Farinata rivolgendosi a Dante (Inf. X, 26). Il ricordo terreno della propria patria, nelle parole del magnanimo ghibellino, è tanto più intenso quanto più manifestato in un luogo agli antipodi della patria celeste. La città di Dio, che da questi è illuminata e assume l’immagine come il ferro s’accalora al fuoco (Ap 21, 11), diventa infatti, nella sua proiezione infernale, “la città del foco” dalle mura ferrigne.
Le parole di Farinata (Inf. X, 25) – “La tua loquela ti fa manifesto” – non sono solo calco del passo di Matteo 26, 73 – “loquela tua manifestum te facit” – riferito alla negazione di san Pietro. Questo episodio evangelico non appare certo fuori luogo. Si tratta di “citazione ostentata”, e può essere ben intesa come “un’obliqua ammissione di avere rinnegato la lingua della patria”, contribuendo a illuminare l’abbandono del De vulgari eloquentia, opera non calzante con la lingua poetica fiorentina della Commedia [3]. Ma – come sempre avviene nella Commedia per qualsivoglia fonte, che deve concordare con l’esegesi della Lectura [4] – l’armatura apocalittica di Ap 22, 16, che fascia la citazione evangelica, afferma regalmente la validità di quell’eloquio prima rinnegato. Ivi infatti Cristo parla manifestando – “loquitur ut … manifestator” – la propria regale autorità e la sua “claritas” magistrale ed esemplare e dice: “Io sono la radice e la stirpe di David” (Ap 22, 16). Non a caso, nel prosieguo del viaggio, Brunetto Latini definirà Dante “sementa santa” dei Romani (Inf. XV, 76-78), cioè unico depositario di una lingua gloriosa come l’antico latino, che supplisce l’assenza apparente di una Curia imperiale. Una traccia di quella maglia apocalittica – “loquitur ut … manifestator” – è riscontrabile ancora nell’esame sulla fede di fronte a san Pietro, che è un esprimere bene i concetti parlando: «“Dì, buon Cristiano, fatti manifesto: / fede che è?”. … / l’appostolico lume al cui comando / io avea detto: sì nel dir li piacqui!”» (Par. XXIV, 52-53, 153-154; da confrontare con “piacciati di restare in questo loco” detto da Farinata, che ha ascoltato il ‘parlare onesto’ di Dante). Signacula dell’esegesi di Ap 22, 16 (David, le stelle, la promessa dell’eterno giorno) si trovano anche nel parlare di Dante sulla speranza di fronte a san Giacomo (Par. XXV, 70-72, 87).
Afferma Olivi che, come a causa della superba torre di Babele le lingue furono confuse e divise e la lingua prima e retta rimase nella casa di Eber e degli Ebrei, e poi, mentre le altre lingue precipitavano nell’idolatria diabolica, la fede e il culto di un solo vero Dio rimase nella casa di Abramo, così a causa della superbia di molti fedeli la lingua e la confessione della sola vera fede di Cristo venne divisa e confusa in più eresie, mentre la prima vera lingua e confessione rimase nella casa di Pietro (prologo, Notabile XIII). Il volgare fiorentino è assimilabile alla lingua del pescatore di Galilea, quella della casa di Eber. Con questa lingua – “non lingua confusionis, sed gratie” (cfr. De vulgari eloquentia, I, vi, 5-7), di cui si avvalse il nostro Redentore, Dante può far sentire al simoniaco Niccolò III “lo suon de le parole vere espresse” (Inf. XIX, 121-123).
Subitamente questo suono uscìo / d’una de l’arche. All’inizio della parte narrativa della sua esposizione, Giovanni precisa sette circostanze generali e degne di lode proprie delle visioni successivamente descritte. La sesta circostanza (Ap 1, 10-11) consiste nel fatto che all’evangelista viene ingiunto solennemente di scrivere la visione e di inviarla alle chiese d’Asia, come intendesse dire: non per mia iniziativa, ma per speciale comando divino ho scritto ed invio. Per cui soggiunge: “E udii una voce dietro di me”.
Il comando proviene da una voce udita dietro le spalle. Stare dietro può essere inteso nel senso che Giovanni era in quel momento dedito alla quiete della contemplazione, lontano dalla sollecitudine derivante dall’attività pastorale, che aveva lasciata alle spalle: la voce dunque lo richiama dalla visione delle cose supreme, che gli stanno dinanzi, alla cura d’anime che sta dietro (è l’interpretazione di Riccardo di San Vittore). Oppure (è l’interpretazione di Olivi), considerando che le cose che ci stanno dietro sono invisibili e pertanto superiori, si può intendere che Giovanni ascolti una voce alle spalle che lo elevi e riconduca verso l’alto, mentre con il volto è rivolto in basso, verso cose inferiori. In questo senso, nel Vangelo di Giovanni, si dice che Maria Maddalena, volta indietro, vide Gesù (Jo 20, 14).
Ricevuto il comando di scrivere il libro e di mandarlo alle sette chiese, delle quali viene specificato il nome, Giovanni si volta per vedere attentamente da quale persona provenga la voce (è la settima circostanza, Ap 1, 12). Questo vedere può essere inteso come un apprendimento totale: sebbene abbia già appreso la voce al momento del suo primo ascolto, ora si converte più fortemente ad essa per apprenderla in modo compiuto.
Il parlare dietro le spalle, di cui si tratta ad Ap 1, 10-12, è anche quello che proviene dalla propria guida, che sta dietro come custode e conducitrice della cavalcatura, per cui in Ezechiele si dice: “uno spirito mi sollevò e dietro a me udii una voce” (Ez 3, 12). È “vox magna”, in quanto il suono esce da una persona di grande virtù, eccitando mirabilmente Giovanni; è “come una tromba”, sia perché esorta alla guerra contro i vizi e contro l’esercito dei reprobi, sia perché invita a banchetti di gloria. La tromba designa inoltre la predicazione, la quale fu come occulta fino al tempo dei profeti, più manifesta nel periodo che va da Isaia a Giovanni Battista e infine portata a compimento nel coro degli apostoli, per cui, secondo san Paolo ai Romani, “in ogni terra uscì il loro suono” (Rm 10, 18; cfr. Ps 18, 5).
L’esegesi di questi passi si mostra fondamentale per le agnizioni nel poema; è inoltre collazionabile con altri luoghi parzialmente analoghi.
Per due terzine risuona la voce del magnanimo Farinata, che invita Dante a restare presso di lui (Inf. X, 22-27). Nella terzina successiva si precisa trattarsi di un suono improvviso, uscente “d’una de l’arche”, che suscita timore nell’ascoltatore, per cui questi si stringe alla sua guida (vv. 28-30). I temi derivano per una parte da Ap 11, 11 (sesta tromba), dove si tratta della sùbita resurrezione dei due testimoni uccisi dall’Anticristo, i quali, eretti e vivi, suscitano timore negli osservatori; per l’altra da Ap 14, 17 (settima guerra), dove l’angelo con la falce esce repentinamente dagli ‘arcani’ dei cieli verso gli uomini, scuotendone di timore i cuori.
Al richiamo del maestro Dante si volge (“Volgiti! Che fai?”), e come Maria vide Cristo risorto, così vede “Farinata che s’è dritto”, anch’egli a suo modo risorto, e questo vedere, come dice Virgilio, è “tutto” dalla cintola in su (Inf. X, 31-33). Anche Dante, come Giovanni, ha prima ascoltato il suono della “vox magna” e si è poi voltato per apprenderla in modo totale. Una conversione a chi parla che si ripete nel volgere il viso verso Manfredi (Purg. III, 103-106) e verso la voce di Beatrice che nell’Eden chiama il poeta con il proprio nome (Purg. XXX, 62-63). Un nome pregno di significato, che qui viene specificato come vengono specificati i nomi delle sette chiese alle quali deve essere inviata la visione.
Il tema della guida (“dux”) che richiama e riconduce si trova ancora verso la fine dell’episodio di Farinata (Inf. X, 115). Un altro esempio è nell’incontro con Beatrice, che asserisce di aver cercato, dopo la morte, di richiamare Dante a sé ispirandolo in sogno o altrimenti (Purg. XXX, 133-135). Connesso con il tema del volgere le spalle, il motivo della guida si presenta nelle spiegazioni date a Brunetto Latini sul viaggio: l’avere il poeta volto le spalle alla selva per salire il “dilettoso monte” (che può corrispondere al lasciarsi alle spalle da parte di Giovanni le sollecitudini pastorali per dedicarsi alla contemplazione), il ricondurre a casa da parte di Virgilio (Inf. XV, 52-54).
I motivi da Ap 1, 10-12 si ritrovano, con varia appropriazione, in apertura di Purg. V (prima il riferimento alla guida, poi il rivolgersi al suono di parole che provengono da dietro) e di Purg. XXI (l’apparizione di Stazio, paragonata a quella di Cristo risorto ai due discepoli sulla via di Emmaus, ma commista con quella di Cristo alla Maddalena perché Virgilio e Dante sentono la voce alle spalle e subitamente si volgono).
Matelda rimprovera il poeta intento a guardare con sì ardente affetto le vive luci dei candelabri aurei, che nell’Eden aprono la processione, da non considerare quello che viene dietro ad essi, cioè i ventiquattro seniori (Purg. XXIX, 61-65; non c’è il tema del volgersi ma, in variazione, quello dello stare dietro e della guida).
ed el s’ergea col petto e con la fronte. Il “magnanimo” Farinata “s’ergea col petto e con la fronte”, sulla quale, come si dice ad Ap 7, 3 per i “segnati” all’apertura del sesto sigillo, si mostrano i segni dell’audacia e della risolutezza oppure della viltà e dell’inerzia. La fronte è la parte superiore del viso a tutti aperta, sulla quale tutti possono leggere immediatamente quanto vi è scritto: caratteristica dei contemplativi che ad Ap 14, 1 stanno con l’Agnello sul monte Sion, i quali portano impresso sulla fronte il nome del Figlio e del Padre, cioè la maestà di Dio trino e del Figlio fatto uomo. La figura del ghibellino è all’opposto di quella di Cavalcante, che si rivolge a Dante piangendo e ricade supino nell’avello, in modo disperato: anche per costui interviene una parte del tema dell’iscrizione sulla fronte, nel momento in cui il poeta riesce subito a ‘leggerne’ il nome (Inf. X, 64-65).
La magnanimità, però, ha anche un’accezione negativa, proposta ad Ap 13, 5: si tratta del “loqui magna”, del parlare con superba audacia contro Cristo e i suoi da parte della bestia che sale dal mare, alla quale viene dato il potere di far male per quarantadue mesi, di muovere guerra contro i santi e di vincerli. Questo tipo di magnanimità, che non esclude il primo, si addice al ‘parlar nemico’ di Farinata nel profetizzare a Dante che non passeranno cinquanta pleniluni perché possa sperimentare la difficoltà di rientrare a Firenze.
La fronte, nell’esegesi della sfrontata meretrice “tincta” ed “ebria” del capitolo XVII (Ap 17, 3-6), assume un valore negativo al quale rinviano più luoghi del poema.
Al “s’ergea” di Farinata non è estraneo il senso negativo attribuito alla bestia che muove guerra ai santi: “Quid aliud datur intelligi nisi quod prius dabit operam percutere Babilonem sibi diutius resistentem, postea vero, circa finem regni sui, eriget contra Deum cornu contumacie sue et faciet prelium contra sanctos incipiens disputare de fide Christi, ut omnes sibi temporaliter subditos ad perfidiam trahat” (ad Ap 9, 13, riferito, nella citazione di Gioacchino da Fiore, ad Ap 11, 7, cioè all’uccisione dei due testimoni).
L’ergersi “col petto”, invece, potrebbe mantenere il significato positivo offerto dall’esegesi dell’istruzione data ad Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia, ad Ap 2, 5, nella citazione di Riccardo di San Vittore: “Quid est fulgor capitis aurei nisi fervor celestis desiderii, et claritas argentei pectoris et brachii quam certitudo recti consilii et rectitudo operis certi? Sancta itaque desideria faciunt caput aureum, recta autem consilia et opera pectus et brachium argenteum”. Per quanto non si tratti di “santo petto”, come nel caso di Catone, certo e retto fu il consiglio di Farinata a Empoli, quando difese Firenze dalla distruzione.
com’ avesse l’inferno a gran dispitto. Ad Ap 11, 8-9 si dice che i corpi dei due testimoni Enoch ed Elia, uccisi dall’Anticristo, “giaceranno nelle piazze della grande città, che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso”. Secondo Gioacchino da Fiore, la grande città designa il regno di questo mondo – la città dei reprobi – e le sue piazze quegli uomini che scelsero le ampie vie che conducono alla perdizione, nelle quali giaceranno morti i corpi dei santi poiché l’intelligenza spirituale della Scrittura sarà morta con essi, una volta uccisi dalla bestia, e la verità, come dice Daniele (Dn 8, 12), sarà prostrata in terra. In questa Gerusalemme terrena l’Anticristo, predicando in qualità di messia e di salvatore, convocherà i Giudei. Concorda con questo Daniele: “uomini violenti del tuo popolo insorgeranno per adempiere la visione” (Dn 11, 14), per mantenere cioè le promesse della lettera dei profeti sulla Gerusalemme terrena e sul suo messia. Secondo Riccardo di San Vittore, la cui esegesi non si discosta su questo punto da quella di Gioacchino, nelle piazze della grande città, che un tempo fu grande per la giustizia e allora sarà grande per la malizia, giaceranno i corpi dei santi in modo che, al vederli, tutti paventino il seguire la loro fede, ed anche tengano in maggiore dispregio i due testimoni morti e la dottrina da essi predicata. La città viene chiamata “Sodoma”, cioè muta; ed “Egitto”, cioè tenebrosa, poiché sarà muta nel confessare la vera fede e tenebrosa per pravità. Oppure, aggiunge Olivi, l’appellativo “Egitto” designa l’eccesso di persecuzione verso Israele, cioè verso i santi, al modo del Faraone, che fece crudelmente tribolare il popolo di Dio, in particolare dal momento in cui ebbe l’ordine di uscire dall’Egitto. Come a quel tempo vi fu somma idolatria e avarizia, così anche qui ci sarà una grande idolatria dell’errore e un’abominevole adorazione dell’Anticristo. Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e gente, confluiti da diverse parti nella città regia, vedranno i due testimoni giacere “occisi et despecti” per tre giorni e mezzo, fino alla loro inopinata resurrezione. Gli uomini dell’Anticristo “non permetteranno che i loro corpi vengano deposti nei monumenti”, cosicché di essi non resti alcuna memoria nei posteri, i loro cadaveri imputridiscano ed emanino fetore davanti a tutti e tutti li abbiano di conseguenza in maggiore dispregio. Questo passo della sesta tromba è richiamato in più punti del poema.
L’esegesi di Ap 11, 8-9, congiunta al disprezzare i fatti e i detti altrui proprio dell’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 3.5), offre motivi anche alla figura di Farinata, sia per il dipregio – “com’ avesse l’inferno a gran dispitto” (Inf. X, 36) -, sia per il riferimento ai “monimenti” (così sono chiamate le arche roventi degli eresiarchi in Inf. IX, 131), sia per l’interpretazione del nome “Egitto” dato alla grande città come eccesso di persecuzione contro Israele, che ricorda da vicino le parole del ghibellino: “di quella nobil patrïa natio, / a la qual forse fui troppo molesto” (Inf. X, 26-27).
E l’animose man del duca e pronte / mi pinser tra le sepulture a lui. Le pungenti locuste, che al suono della quinta tromba escono senza freno dal fumoso pozzo dell’abisso (Ap 9, 1-3), hanno otto “male proprietates”, che possono essere considerate, come tutta l’esegesi della quinta tromba, da tre punti di vista corrispondenti alle tre tentazioni che gravano sul periodo. La prima proprietà consiste nell’avere “l’aspetto simile ai cavalli pronti per la guerra” (Ap 9, 7). Esse sono forti, animose, pronte e agitate dai diavoli, quasi cavalli dai cavalieri, ad ogni rissa, vendetta, litigio.
In questo caso la parodia va dalle mani animose e pronte di Virgilio che spingono [5] il discepolo tra le sepolture verso Farinata (Inf. X, 37-38) all’esser “presto” alla Fortuna dichiarato a Brunetto Latini (Inf. XV, 93), alla “zuffa” tra Calcabrina e Alichino (Inf. XXII, 133-135; XXIII, 5), all’ira di Virgilio che per poco non si rissa con Dante troppo intento a seguire l’alterco tra Sinone di Troia e maestro Adamo (Inf. XXX, 131-132), allo scuotersi forte e presto di Fialte come una torre per un terremoto (Inf. XXXI, 106-108), all’armarsi di ogni ragione come il baccelliere o il discente per essere pronto alle domande di san Pietro sulla fede o di san Giacomo sulla speranza (Par. XXIV, 49-51; XXV, 64-66). Non sorprendono variazioni tanto distanti fra loro, se si considera che i temi delle subdole e pungenti locuste vengono appropriati anche a san Giovanni (Par. XXVI, 49-57).
[1] Cfr. INGLESE, Inf. X, 22 (p. 129).
[2] Ibid., Inf. II, 113-114, pp. 58-59.
[3] Cfr. GIULIANO TANTURLI, Dante poeta fiorentino (su Inf. X), in “Studi danteschi”, 65 (2000), p. 51.
[4] Cfr. quanto scritto sui Salmi plurisensi, in «In mensura et numero et pondere». Nella fucina della Commedia: storia, poesia e arte della memoria, 4.
[5] “Mi pinser tra le sepulture a lui” (Inf. X, 38) è da confrontare con “ripinse al ciel Tommaso, per ammenda” (Purg. XX, 69): si tratta ancora di un senso, positivo nel primo caso, negativo nel secondo, che rinvia all’esegesi delle ipocrite locuste, le quali operano “quasi sub pio zelo erudiendi eos ab errore et dampnatione et reducendi eos ad viam salutis”. Affini sono i verbi “propulsare” e “impellere”, propri del martirio, non corporale ma psicologico, degli ultimi tempi, allorché il pio martire viene ‘sospinto’, da una falsa Scrittura (Francesca) o da una falsa immagine di autorità pontificale (Guido da Montefeltro), o da falsi segni premonitori (conte Ugolino), a rinnegare la fede nel vedere con i propri occhi i miracoli fatti dal carnefice (prologo, Notabile X).
Tab. III
[LSA, cap. XI, Ap 11, 11 (IIIa visio, VIa tuba)] “Et post tres dies et dimidium spiritus vite”, id est anima eternaliter vivificans, “intra<v>it a Deo in eos”, id est a Deo spiritum reviventem corpori. “Et steterunt super pedes suos”, scilicet erecti et vivi. Ponit autem hic more prophetico preteritum pro futuro. “Et timor magnus”, scilicet ex tam subita et stupenda eorum resurrectione, “cecidit super eos qui viderunt eos”, scilicet ita repente suscitatos et glorificatos. |
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 17 (IVa visio, VIIum prelium)] Alius (angelus) vero de celo, ubi manebat occultus, est repente egressus, quia qui solitudinis remotiora et secretiora petunt, si quando egrediuntur ad homines, veluti de archanis celorum advenisse putantur, adeo ut multorum corda timore concu-tiantur admirantium tam perfectionem vite quam novitatem presentie. |
|
Inf. X, 28-36, 115, 121-122Subitamente questo suono uscìo
|
Inf. XV, 52-54Pur ier mattina le volsi le spalle:
|
|
Purg. III, 103-106E un di loro incominciò: “Chiunque
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 10-12 (VI-VIIa circumstantia visionum)] Sexta circumstantia est sollempnis iussio sibi facta ut visiones has sollempniter scribat et septem ecclesiis Asie mittat, quasi dicat: non meo motu, sed Dei speciali iussu hec scripsi et mitto. Unde subdit: “et audivi post me vocem” (Ap 1, 10).
Secundum Ricardum, ideo post se audivit vocem in signum quod a subditis elongatus et quieti deditus omnem pastoralem sollicitudinem post se longe reliquerat, et ideo dum nunc ad subditorum eruditionem a supernis reducitur, quasi de anterioribus ad posteriora revocatur*.
Vel pro quanto ea que sunt post nos sunt nobis invisibilia, et conversis secundum faciem ad inferiora sunt ea que post tergum nobis superiora, pro tanto vocem post se audit quia ad invisibilia et superiora ipsum sublevat et reducit. Unde et in huius signum, Iohannis XX°, Maria conversa retrorsum dicitur vidisse Ihesum (Jo 20, 14).
Item per hoc significatur quod loquens erat dux eius, quasi post tergum eius existens more custodis et ductoris sui equi vel iumenti, unde Ezechielis III° dicitur: “Assumpsit me spiritus et audivi post me vocem” et cetera. (Ez 3, 12).
Dicit autem “magnam”, tum quia magna significabat, tum quia a magna persona et virtute exibat et Iohannem magnifice ex<c>itabat. Dicit etiam “tamquam tube”, tum quia ad bellum contra vitia et contra exercitus reproborum exhortabatur, tum quia ad epulas glorie invitabat et ad audiendum Dei et angelorum consilium convocabat, tum quia forma tube gerit typum predicatorum ecclesie. In quibus a principio usque ad tempora prophetarum fuit predicatio quasi occulta, a diebus vero Isaie manifestior esse cepit usque ad Iohannem Baptistam, ibique consumata est in apostolico choro: “in omnem” enim “terram exivit sonus eorum” (Ps 18, 5; Rm 10, 18). Consimiliter autem intellige de sexto statu ecclesie.
“Quod vides” (Ap 1, 11), id est quod visurus es et videre iam cepisti, “scribe in libro”, id est fac inde librum sollempnem, “et mitte septem ecclesiis”. Secundum correctores peritos, “que sunt in Asia” non est hic de textu, sed subintelligitur ex hoc quod positum fuit supra. Specificat autem nomina ecclesiarum dicens: “Ephesum”, id est ad Ephesum, et est sicut dicimus ‘vado Romam’. Nota quod per has septem designatur universalis ecclesia non solum propter septem status sepius memoratos, sed etiam propter septiformem spiritum quo tota ecclesia sanctificatur.
Septima circumstantia est Iohannis attenta conversio ad videndum, unde subdit (Ap 1, 12): “Et conversus sum, ut viderem vocem que loquebatur mecum”, id est ut viderem cuius persone erat vox ista. Vel videre sumitur pro omni apprehensione: quamvis enim quando prius audivit eam apprehendisset eam, nichilominus fortius convertitur ad eam ut eam plenius apprehendat. “Et conversus vidi”. Premissis septem generalibus circumstantiis visionum sequentium, hic narrat ipsas visiones.
* In Ap I, iv (PL 196, coll. 704 D-705 A).
Purg. XXIX, 61-65
La donna mi sgridò: “Perché pur ardi
sì ne l’affetto de le vive luci,
e ciò che vien di retro a lor non guardi?”.
Genti vid’ io allor, come a lor duci,
venire appresso, vestite di bianco
Purg. XXX, 62-63, 133-135
quando mi volsi al suon del nome mio,
che di necessità qui si registra
Né l’impetrare ispirazion mi valse,
con le quali e in sogno e altrimenti
lo rivocai: sì poco a lui ne calse!
Inf. XXIII, 67-69, 76-81
Oh in etterno faticoso manto!
Noi ci volgemmo ancor pur a man manca
con loro insieme, intenti al tristo pianto
E un che ’ntese la parola tosca,
di retro a noi gridò: “Tenete i piedi,
voi che correte sì per l’aura fosca!
Forse ch’avrai da me quel che tu chiedi”.
Onde ’l duca si volse e disse: “Aspetta,
e poi secondo il suo passo procedi”.
Purg. V, 1-7; XXI, 4-15
Io era già da quell’ ombre partito,
e seguitava l’orme del mio duca,
quando di retro a me, drizzando ’l dito,
una gridò: “Ve’ che non par che luca
lo raggio da sinistra a quel di sotto,
e come vivo par che si conduca!”.
Li occhi rivolsi al suon di questo motto
mi travagliava, e pungeami la fretta
per la ’mpacciata via dietro al mio duca,
e condoleami a la giusta vendetta.
Ed ecco, sì come ne scrive Luca
che Cristo apparve a’ due ch’erano in via,
già surto fuor de la sepulcral buca,
ci apparve un’ombra, e dietro a noi venìa,
dal piè guardando la turba che giace;
né ci addemmo di lei, sì parlò pria,
dicendo: “O frati miei, Dio vi dea pace”.
Noi ci volgemmo sùbiti, e Virgilio
rendéli ’l cenno ch’a ciò si conface.
Inf. XXVI, 114-117, 124-126
a questa tanto picciola vigilia
d’i nostri sensi ch’è del rimanente
non vogliate negar l’esperïenza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
e volta nostra poppa nel mattino,
de’ remi facemmo ali al folle volo,
sempre acquistando dal lato mancino.
Tab. IV
Inf. II, 55-57Lucevan li occhi suoi più che la stella;
|
Purg. XX, 67-69, 73-75Carlo venne in Italia e, per ammenda,
|
|
[LSA, cap. V, Ap 9, 5-6 (IIIa visio, Va tuba)] Quinto describit gravitatem doloris predictorum lesuram consequentis et concomitantis, unde subdit: (Ap 9, 5) “sed ut cruciarent mensibus quinque, et cruciatus eorum ut cruciatus scorpii, cum percutit hominem. (Ap 9, 6) Et in diebus illis querent homines mortem et non invenient eam et desiderabunt mori, et fugiet mors ab illis”. […] Per cruciatum autem designatur hic pungitivus remorsus conscientie et timor gehenne, qui fidelibus in gravia peccata cadentibus non potest de facili deesse. Designat etiam iram et offensam quam temporaliter dampnificati et iniuriati a predictis locustis habent contra eas, et designat etiam merorem et consternationem quam multi habent de tantis malis per locustas factis, ita quod tedet eos vivere et maxime quia timent incidere in tantam temptationem et per consequens dampnari. Multi etiam per evasionem tantorum malorum cupiunt et desiderant martiria, sed non inveniunt propter pacem quinto tempori datam. […] Quod autem ait (Ap 9, 5), “dictum” esse “illis”, id est prohibitum seu non permissum, “ne occiderent eos, sed ut cruciarent mensibus quinque”, dicit Ioachim non esse hoc dictum de morte eterna, sed de totali extinctione fidei*. Quod est intelligendum respectu illorum carnalium quos non omnino in suum errorem trahunt, sed solum suis stimulis in dubium valde cruciativum inducunt, detrahendo scilicet fidelibus et mala exempla clericorum et prelatorum eis ingerendo et contra quasdam difficultates fidei arguendo per sensibiles auctoritates scripture et per quedam exempla plana et sensibilia, et e contra fictam sanctitatem suorum, quos perfectos vocant, eis demonstrando et commendando. Hoc autem instar scorpii faciunt sub blanda specie et quasi sub pio zelo erudiendi eos ab errore et dampnatione et reducendi eos ad viam salutis. […]* Expositio magni prophete, pars III, f. 131va. |
||
[LSA, cap. IX, Ap 9, 7 (IIIa visio, Va tuba] Sexto describit plenius malas proprietates locustarum, ponens septem malas et ultimo octavam superius tactam sed <hic> quoad aliquid magis explicitam, scilicet quod habent vim scorpionis et potestatem nocendi quinque mensibus.
|
Inf. XXI, 109-111E se l’andare avante pur vi piace,
|
|
3. Farinata: la statua (X, 39-51)
Così con un colpo solo di scalpello Dante ha abbozzata la statua dell’eroe, e ti ha gittata nell’anima l’impressione di una forza e di una grandezza quasi infinita.FRANCESCO DE SANCTIS[Il Farinata di Dante, p. 334] |
■ Nell’incontro con Farinata si distinguono due momenti, di tono assai diverso, fra i quali si colloca l’episodio di Cavalcante [1]. Nel primo (Inf. X, 31-51, dal momento in cui Virgilio invita il discepolo a volgersi), Farinata appartiene, si potrebbe dire, al Vecchio Testamento, o perlomeno a quanto del Vecchio è rimasto nel Nuovo. Farinata incarna la vecchia Sinagoga e i suoi capi, sdegnosa perché forte di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’ (cioè degli avi) e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo: fu questa la tentazione giudaica contro Cristo, come spiegato nell’esegesi della prima tromba (Ap 8, 7) [2]. Tale tentazione tornerà più intensa nel sesto stato, nella grande guerra contro l’Anticristo condotta durante il secondo avvento di Cristo nello Spirito (Ap 13, 18), quando la bestia che sale dalla terra (i falsi profeti) avrà dalla sua la sentenza dei maestri e dei dottori e l’opinione della moltitudine cui appare stolto, insano ed eretico contraddire. Ben si addice al ghibellino, che domanda “quasi sdegnoso” chi furono “li maggior” del proprio interlocutore, e che alla risposta alza in alto le ciglia dichiarando di averli per due volte cacciati in quanto a lui avversi [3], l’immagine dei pontefici e dei prìncipi della vecchia legge i quali, superbi per l’altezza del magistero e della fama conseguita presso tutto il popolo con il favore di questo, non si sottomettono alla correzione di Cristo, che anzi sdegnano e disprezzano per l’abiezione.
■ Al termine dell’esegesi del capitolo XIII dell’Apocalisse, che tratta della grande guerra mossa nel sesto stato dalla bestia, della quale viene spiegato anche il mistero del numero del nome – il DCLXVI -, Olivi riporta l’opinione di alcuni, i quali, sulla base degli scritti che allora si ritenevano di Gioacchino da Fiore e di quanto sarebbe stato rivelato in segreto da san Francesco a frate Leone suo confessore e ad altri compagni, affermano che Federico II e il suo seme è la testa della bestia che sembrava uccisa e che rivive di Ap 13, 3 (“Et vidi unum de capitibus suis quasi occisum in mortem, et plaga mortis eius curata est”). Secondo costoro, al tempo dell’Anticristo mistico (che precede quello aperto), in questo discendente di Federico non solo rivivrà l’impero romano, ma egli conquisterà pure il regno di Francia e gli saranno alleati gli altri cinque re cristiani. Farà eleggere papa un falso religioso nemico della regola francescana, che contro questa escogiterà dolose dispense, promuovendo vescovi a lui consenzienti ed espellendo i chierici e i precedenti vescovi che erano stati avversi al seme di Federico e specialmente a quell’imperatore, a lui e al suo stato (Ap 13, 18) [4].
In questa pagina si misura la portata della metamorfosi della Lectura nella Commedia, perché l’operato del falso papa che caccia coloro qui semini Frederici et specialiter illi imperatori et sibi et suo statui fuerant adversati risuona in bocca al ghibellino Farinata, uditi i nomi de “li maggior” di Dante: Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte (Inf. X, 46-47; la forma “furo avversi” ricorre solo in questo luogo).
Alla chiesa di Gerusalemme, subentrata nel primato alla Sinagoga con la nuova fede, viene assimilata Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione apocalittica. Nel suo eccessivo e superbo mantenere le cerimonie della vecchia legge giudaica, la chiesa “ex circumcisione” fu troppo zelante contro la fede di Cristo e venne meno all’originario fervore di carità. Così fece Farinata nei confronti di Firenze, “nobil patrïa” assimilata alla Chiesa di Cristo, come egli stesso riconosce dicendo: “a la qual forse fui troppo molesto” (v. 27).
La chiesa di Efeso si distinse per l’“inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et primitate”, per cui viene minacciata di traslazione del primato, come avvenne per la Sinagoga (Ap 2, 5). Così Farinata: “Fieramente furo avversi … a miei primi”. Alla Sinagoga dell’Antico Testamento corrisponde nel Nuovo Babylon, la Chiesa corrotta della fine del quinto stato, come a Cristo corrisponde la Chiesa del sesto stato, quella che Dante rappresenta, che sarà, una volta liberatosi dal vecchio con cui ancora concorre, “novum saeculum”, per cui essa si ricongiungerà circolarmente, quasi fosse una sfera, ai suoi inizi. In tal modo al ghibellino sono appropriati temi propri della sesta e grande guerra combattuta dalla Chiesa. Vicende private ed episodi locali, del microcosmo toscano, trovano collocazione in una storia universale, quale è quella della Chiesa insita nell’Apocalisse secondo Olivi.
Il verso successivo, “sì che per due fïate li dispersi” (Inf. X, 48), rinvia ad Ap 16, 19, dove si introduce il tema della divisione della grande città in tre parti, provocata da discordie intestine (“la città partita” di Ciacco, assalita da tanta discordia, di Inf. VI, 60-63; “’l giglio … per divisїon fatto vermiglio” evocato da Cacciaguida a Par. XVI, 152-154), designata dal terremoto descritto nel secondo preambolo della sesta visione che, in quanto segno premonitore della caduta della nuova Babilonia che avviene nel sesto tempo della Chiesa, indica l’accecamento della chiesa carnale, la quale sotto l’Anticristo mistico si muove contro lo spirito evangelico di Cristo. Un passo del profeta Zaccaria (Zc 13, 7-9), applicato alla divisione in tre parti della religione evangelica, precisa che due parti verranno disperse, mentre la terza, popolo di Dio, verrà condotta e provata attraverso il fuoco. Si può intendere che, dispersi i ‘maggiori’ di Dante nel 1248 e nel 1260, la terza parte, Dante stesso, non lo sarà (cfr. quanto gli dice Cacciaguida a Par. XVII, 68-69: “sì ch’a te fia bello / averti fatta parte per te stesso”).
Questo Farinata, tessuto nel suo parlare con il panno, pregno di scritti pseudogioachimiti, del falso papa imposto dall’Anticristo mistico-Federico II, ma che dice delle fazioni di Firenze come fossero divisioni della religione evangelica, giace mell’arca “con più di mille” epicurei, “che l’anima col corpo morta fanno”. Fra costoro c’è “’l secondo Federico”, nominato ma che non si drizza dal suo sepolcro (Inf. X, 118-119). Nell’episodio, il rivivere del seme di Federico sembra tacere, ma al ghibellino il poeta augura il riposo della sua discendenza (v. 94). “Deh, se riposi mai vostra semenza”: è augurio di pace delle fazioni, per cui gli sbanditi Uberti possano ritornare a Firenze.
L’esame dei testi rivela un metodo per il quale la poesia trasforma in senso positivo, di prossimo rinnovamento, quanto nell’esegesi dell’Apocalisse viene appropriato a figure o a situazioni negative. Così per la discendenza di Federico II, che Olivi, sulla base di scritti ritenuti di Gioacchino da Fiore, connette con l’Anticristo mistico, e che invece per Dante è “sementa santa”. Così nella descrizione delle luci degli spiriti giusti, che nel cielo di Giove risorgono formando la figura di un’aquila, viene utilizzata l’esegesi della bestia la cui testa sembrava uccisa e che invece risorge (Ap 13, 3).
■ Il tema del seme imperiale che rivive è messo in bocca a Brunetto Latini, per il quale “le bestie fiesolane” (i fiorentini) non dovranno toccare Dante, pianta in cui riviva la sementa santa / di que’ Roman che vi rimaser quando / fu fatto il nido di malizia tanta, che parteciparono cioè alla fondazione di Firenze (Inf. XV, 76-78; unico caso nel poema del verbo ‘rivivere’, proprio congiunto al seme come ad Ap 13, 18). Anche il ‘rimanere’ del seme ha un valore, come spiegato ad Ap 12, 17, al momento della guerra del quinto stato. La quinta guerra viene condotta dal drago contro le rimanenze (le reliquie) del seme della donna, rappresentate da coloro che custodiscono i precetti divini e danno testimonianza di Cristo. Secondo Gioacchino da Fiore, il seme della donna è Cristo rapito in cielo e questo è seme che precede; quello che ‘rimane’ viene designato con l’evangelista Giovanni, cioè con i contemplativi propri del quarto stato. Olivi ritiene tuttavia che il testo sacro, nella quarta visione, dopo aver trattato le guerre sostenute in primo luogo da Cristo, in secondo dai martiri e in terzo e quarto dalla Chiesa prima dispersa e poi riunita da Costantino e dotata delle ali dei dottori e degli anacoreti per volare nel deserto dei Gentili e in quello della vita contemplativa, si riferisca ora in parte ad eventi successivi allo stato degli anacoreti, e precisamente a quanti fra essi rimasero sopravvivendo alle distruzioni operate dai Saraceni e, comunque, alle reliquie lasciate al quinto stato (che inizia con Carlo Magno e dura circa cinquecento anni). In entrambi i casi si parla di ‘reliquie’ poiché, come in un vaso di vino purissimo, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e più pura, rimangono solo poche reliquie vicine alle impurità e quasi con esse mescolate, così della pienezza e purezza del vino dei dottori e degli anacoreti del terzo e del quarto stato rimasero prima solo le reliquie, al momento della devastazione saracena; poi, nel quinto stato, occupate molte chiese dai Saraceni e separatisi i Greci dalla fede romana, rimase solo la Chiesa latina come reliquia della Chiesa che prima era diffusa in tutto l’orbe. Dante è pertanto ‘reliquia’ del seme che rimane – assimilato alla Chiesa romana – accanto e commisto al letame delle bestie fiesolane. È da notare che, nelle parole di Brunetto, il “romanus populus … ille sanctus, pius et gloriosus” (Monarchia, II, v, 5), di cui Dante è seme rimasto, è ammantato dalla veste che nell’esegesi scritturale spetta alla Chiesa di Roma, la sola ‘rimasta’ di una Chiesa prima diffusa su tutto l’orbe, della quale il seme degli antichi Romani è dunque prefigurazione. Il tema del purissimo seme della donna che rimane, da Ap 12, 17, è anche singolarmente consonante con quanto affermato in Convivio IV, v, 5-6: “E però [che] anche l’albergo dove ’l celestiale rege intrare dovea, convenia essere mondissimo e purissimo, ordinata fu una progenie santissima … Per che assai è manifesto la divina elezione del romano imperio, per lo nascimento della santa cittade, che fu contemporaneo alla radice della progenie di Maria”.
L’espressione di Brunetto – “e non tocchin la pianta, / s’alcuna surge ancora in lor letame” (Inf. XV, 73-75) – trasforma un tema della sesta vittoria (Ap 3, 12), allorché il nuovo nome di Cristo viene iscritto intendendo ‘cristiano’ come ‘unto del Signore’, nel senso del Salmo 104, 15: “Non toccate i miei consacrati”. Chi consegue la sesta vittoria – ed è uomo evangelico che sta fisso in Cristo come una colonna nel tempio – ha iscritto nella mente il nome di Dio padre, immagine paterna che si imprime come quella di un padre spirituale nella prole, di un abate nella propria religione. Nella mente di Dante è “fitta … la cara e buona imagine paterna” di Brunetto Latini che gli insegnava “come l’uom s’etterna”, immagine che ora l’“accora” (Inf. XV, 82-85). Anche nell’inferno esistono momenti di apertura all’imitazione di Cristo, per quanto solo nel ricordo della vita passata che la poesia registra.
■Olivi (ad Ap 13, 18) rimette alla volontà divina l’avverarsi dell’opinione che l’Anticristo mistico nasca dal seme di Federico II. Ricorda tuttavia che i sostenitori di questa tesi affermano pure che la ‘caduta’ del regno di Francia avverrà in coincidenza con il terremoto che segna l’apertura del sesto sigillo, e che allora si verificherà quanto dice l’Apostolo ai Tessalonicesi sul fatto che l’apostasia, il discedere dall’obbedienza del vero papa per seguire il falso papa non eletto canonicamente, scismatico ed errante contro la verità della povertà e della perfezione evangelica, dovrà venire prima del ritorno di Cristo nella parusia (2 Th 2, 3). Dell’espressione paolina – “nisi venerit discessio primum” – è pregno il verso di invettiva contro la lupa – “quando verrà per cui questa disceda?” -, nel quale il ‘discedere’ è appropriato alla lupa e il ‘venire’ al Veltro. L’invettiva è collocata all’inizio di Purg. XX (vv. 13-15), canto che si chiude con il terremoto sentito “come cosa che cada” e che fa tremare la montagna (vv. 124-141). Stazio spiegherà che il terremoto si verifica allorché un’anima purgante si sente monda e libera nella sua volontà di salire al cielo (Purg. XXI, 58-72). Tra l’invettiva contro la lupa e il terremoto è descritto l’incontro con Ugo Capeto, il quale chiede vendetta a Dio sulla “mala pianta” di cui fu radice. Il terremoto – che assume testualmente, comunque, le caratteristiche dell’apertura del sesto sigillo –, al di là dei motivi dati da Stazio (anch’essi propri del sesto stato), è allusione alla prossima caduta del regno di Francia.
All’apertura del quinto sigillo (Ap 5, 1; 6, 9-10) i santi, rattristati fino alla disperazione per i mali che invadono la Chiesa, chiedono a gran voce che venga subito fatta vendetta contro i carnali del quinto tempo che dispregiano Cristo e i suoi. Con grande desiderio gridano a Dio: “Fino a quando, Signore, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?”. Nel “fino a quando” sta la loro insofferenza ad attendere ancora una vendetta rinviata per seicento anni e che la giustizia divina non può ulteriormente procrastinare. Poiché santo, Dio non può non odiare l’iniquità, e in quanto vero non può non mettere in pratica i mali minacciati e i beni promessi. Tuttavia ai santi del quinto stato viene detto di quietarsi e di aspettare le grandi cose che avverranno all’apertura del sesto sigillo, quando saranno rivelati segreti fino allora chiusi e si rinnoveranno i gloriosi martìri in modo che il numero degli eletti sia completato. Il tema del santo desiderio di vendetta che chiama contro i malvagi e che non soffre altra attesa, risuona in più punti del poema. Compare ben tre volte tra gli avari e i prodighi del purgatorio, in una zona che principalmente si riferisce al quinto stato. La prima volta è il poeta a maledire l’antica lupa e a domandare al cielo il momento dell’arrivo del Veltro (Purg. XX, 10-15). La seconda volta è Ugo Capeto a chiedere sùbita vendetta a colui che tutto giudica a nome di Douai, Lille, Gand, Bruges vessate da Filippo il Bello (vv. 46-48), come i santi del quinto stato dai quali “expetitur instanter et alte iusta vindicta”. Ancora Ugo Capeto si rivolge a Dio chiedendogli quando potrà godere la gioia di vedere attuata la vendetta per ora nascosta nel suo segreto, chiusa cioè fino a quando, nel sesto stato, verrà il giudizio di Babylon (vv. 94-96). Terminato l’episodio di Ugo Capeto, un terremoto scuote la montagna: si tratta di un’allusione al terremoto con cui si apre il sesto sigillo (vv. 124-141).
■ Nell’incontro con Farinata, da un lato sta la superbia per antica nobiltà di sangue, assimilata a quanto si dice nell’esegesi scritturale circa l’altezza del magistero e la fama conseguita presso tutto il popolo da quanti non si sottomettono alla correzione di Cristo, che anzi disdegnano e disprezzano per l’abiezione. Dall’altro c’è l’umile desiderio di Dante di ubbidire al ghibellino, per cui il poeta gli si apre rivelandogli quali fossero stati i suoi ‘maggiori’, apertura che ripete quanto Cristo dice sull’aurea carità alla settima chiesa d’Asia, Laodicea (Ap 3, 18.20): «Deinde incitat et allicit eum fortius, exhibendo se ei ut paratissimum et desideratissimum associalissime et intime convivendum et convivandum cum eo […] “Si quis audierit”, id est cordaliter seu obedienter receperit, “vocem meam”, scilicet monitionum mearum predictarum, “et aperuit michi ianuam” […] – Io ch’era d’ubidir disideroso, / non gliel celai, ma tutto gliel’ apersi (Inf. X, 43-44)».
■ Non solo umile è il discorso di Dante. La terzina «“S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte”, / rispuos’ io lui, “l’una e l’altra fïata; / ma i vostri non appreser ben quell’ arte”» (Inf. X, 49-51) usa un registro raffinato, proveniente da Ap 14, 2 (esegesi dall’ampio sviluppo). Le opere divine, scrive Olivi elaborando una citazione dall’Expositio di Gioacchino da Fiore, sono come il suono di un maestro citarista che sa concordare “iustitia” e “lenitas”, rigore e dolcezza; diversamente si tratta di un suonare discordante che non deriva dall’arte e dal frequente uso. Quest’arte i ‘maggiori’ di Dante l’hanno appresa (rientrando a Firenze nel 1251 e nel 1266), a differenza di quelli di Manente. Giustizia e pietà, le due vie di Dio, valgono anche per l’esule. Non diversamente in Tre donne, nel secondo congedo, l’esule fiorentino scriveva: “camera di perdon savio uom non serra, / ché ’l perdonare è bel vincer di guerra”. Fra “sì duri lamenti” che escono dalle arche infuocate, il motivo della “lenitas” è ripetuto tre volte nel canto: da Cavalcante (“lo dolce lume”), Farinata (“nel dolce mondo”), Virgilio (“al dolce raggio”) [5].
[1] Qualsiasi elemento distintivo è naturalmente da considerare nel complesso, perché “l’organicità strutturale del canto X non soffre d’essere compromessa da sottosezioni e riparti interni”: cfr. GIORGIO PETROCCHI, Tre postille in margine a Farinata, in IDEM, Itinerari danteschi, Bari 1969 (Biblioteca di critica e letteratura, III), pp. 290-291.
[2] PETROCCHI, Itinerari danteschi, p. 292: “Il linguaggio di Farinata, per converso, lungi dalle spezzature dubitose del fragile consuocero, è quello del capo popolo e del capitano d’arte. Il suo ‘popolo’ è la nobiltà più altera di quella Firenze antica, ed egli disprezzerà qualsiasi modo d’espressione che non sia quello elevato e sostenuto che la sua gente è abituata ad intendere da lui”.
[3] ond’ ei levò le ciglia un poco in suso (Inf. X, 45). Alzare le ciglia è sinonimo di superbia luciferina (Inf. XXXIV, 35: “e contra ’l suo fattore alzò le ciglia”), di orgoglioso minacciare (così i Malebranche a Inf. XXI, 71, 132, forti dei loro “runcigli”). Corrisponde all’“altivolum supercilium vite anachoritice” (prologo, Notabile VI) proprio del quarto stato; gli anacoreti, un tempo fiorenti nella vita contemplativa, furono infine disfatti dai Saraceni per la loro superbia. Chinare le ciglia associa un verbo del condiscendente quinto stato, “declinans”, in senso positivo aperto e piano verso le moltitudini e la vita associata (soprattutto in terra latina) dopo l’arduo e solitario (si potrebbe dire ‘alpestre’) stato anacoretico (anche in un contesto geografico, di pianura: “lo dolce piano / che da Vercelli a Marcabò dichina”, Inf. XXVIII, 74-75; o astronomico, di declinare del giorno, poiché il vespro è appropriato al quinto stato); in senso negativo di discesa torpida, rilassata e rovinosa verso il precipizio (Par. XXXII, 138: “quando chinavi, a rovinar, le ciglia”).
[4] Sulla questione cfr. ROBERT E. LERNER, Frederick II, Alive, Aloft and Allayed in Franciscan-Joachite Eschatology, in The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages, edited by W. Verbeke, D. Verhelst, A. Welkenhuysen, Louvain 1988, pp. 359-384, trad. it. (Federico II mitizzato e ridimensionato post mortem nell’escatologia francescano-gioachimita) in IDEM, Refrigerio dei santi. Gioacchino da Fiore e l’escatologia medievale, Roma 1995 (Centro Internazionale di Studi Gioachimiti. S. Giovanni in Fiore, Opere di Gioacchino da Fiore: testi e documenti, 5), pp. 147-167.
[5] PETROCCHI, Itinerari danteschi, pp. 291-292.
Tab. V
[LSA, cap. XII, Ap 12, 17 (IVa visio, Vum prelium)] Dicit ergo: “Et iratus est draco in mulierem”. […] “Et abiit facere bellum cum reliquis de semine eius, qui custodiunt mandata Dei et habent testimonium Ihesu”, id est fidelem confessionem Christi per quam testimonium perhibent de Christo. Duo ponit necessaria ad salutem, scilicet observantiam mandatorum et fidem Christi exteriori professione et confessione expressam. Ioachim dicit quod semen mulieris est Christus raptus ad tronum cum martiribus suis, et istud semen precesserat; aliud autem remanserat designatum in Iohanne evangelista, scilicet ordo monachorum quarti temporis meridianam plagam incolentium. Et ideo vocat eos reliquos seu residuos de semine mulieris*.
|
||
|
Inf. XV, 73-85“Faccian le bestie fiesolane strame
|
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Si vero queratur plenior ratio sui casus vel translationis predicte, potest colligi ex tribus. Primum est inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et primitate, quam scilicet habuit non solum ex hoc quod prima in Christum credidit, nec solum ex hoc quod fideles ex gentibus ipsam honorabant et sequebantur ut magistram et primam, tamquam per eam illuminati in Christo et tracti ad Christum, sed etiam ex gloria suorum patriarcharum et prophe-tarum et divine legis ac cultus legalis longo tempore in ipsa sola fundati.[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7 (IIIa visio, Ia tuba)] Vel per hoc designatur quod temptationem que simul habet magnam speciem boni et veri, et auctoritatem et testimonium maiorum et antiquiorum et in sapien-tia famosiorum, et sequelam maioris et quasi totalis partis populi, nullus potest vincere nisi sit in fide et caritate firmus ut terra vel arbor et non fragilis et instabilis et cito arefactibilis sicut fenum. Talis autem fuit temptatio iudaica contra Christum. |
||
[Ap 13, 18] Prefatum autem cleri et regni Francie casum et aliquem alium illi annexum vel previum dicunt designari per terremotum in initio apertionis sexti sigilli tactum, quamvis etiam preter hoc designet spiritalem subversionem et excecationem fere totius ecclesie tunc fiendam. Quid autem horum erit vel non erit, dispensationi divine censeo relinquendum. Addunt etiam predicti quod tunc in parte implebitur illud Apostoli <IIa> ad Thessalonicenses II° (2 Th 2, 3), scilicet “nisi venerit discessio primum”. |
||
Purg. XX, 13-15, 43-51, 127-128O ciel, nel cui girar par che si creda
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (Vum sigillum)] In quinta autem (apertione), contra torporem accidie et otii quinti temporis, quod est sentina luxurie et omnis iniqui-tatis, clamant sancti martires eorum sanguinem, id est penales labores et dolores usque ad mortem, vindicari in illos. […] In quinta autem apertione, contra carnales eiusdem quinti temporis contemp-tores macerationum et martiriorum Christi et sanc-torum precedentium, expetitur instanter et alte iusta vindicta (cfr. Ap 6, 10). Contra etiam ignominiam, est non solum spiritalis sed etiam temporalis pax et gloria sanctorum quinti status, designata per hoc quod ibi dicitur sanctis ut interim quiescant et in sui ornatum recipiant stolam albam (cfr. Ap 6, 11). |
|
Inf. VI, 60-63ma dimmi, se tu sai, a che verranno
|
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 19; VIa visio] Ex hiis autem sequetur divisio que subditur: “Et facta est civitas magna in tres partes”. […] Potest etiam per hoc designari quecumque intestina discordia et divisio tunc temporis futura in ipsa. Nam et Zacharie XIII° (Zc 13, 7-9) dicitur evangelica religio consimiliter dividenda tunc temporis in tres partes, cum dicitur: “Et convertam manum meam ad parvulos, et erunt in omni terra: partes due in ea dispergentur et deficient, et ducam tertiam partem per ignem et probabo eos sicut probatur aurum. Ipse invocabit nomen meum, et dicam: Populus meus es” et cetera, quamvis hoc in parte in primitiva ecclesia sub apostolis sit impletum.
|
|
Tab. VI
[LSA, cap. I, Ap 1, 16-17 (radix Ie visionis)] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2).
|
||
Par. XIII, 13-24aver fatto di sé due segni in cielo,
|
||
Inf. X, 49-51“S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte”,
|
Inf. XI, 103-105
che l’arte vostra quella, quanto pote,
segue, come ’l maestro fa ’l discente;
sì che vostr’ arte a Dio quasi è nepote.
Par. XIII, 73-78, 115-123
Se fosse a punto la cera dedutta
e fosse il cielo in sua virtù supprema,
la luce del suggel parrebbe tutta;
ma la natura la dà sempre scema,
similemente operando a l’artista
ch’a l’abito de l’arte ha man che trema.
ché quelli è tra li stolti bene a basso,
che sanza distinzione afferma e nega
ne l’un così come ne l’altro passo;
perch’ elli ’ncontra che più volte piega
l’oppinïon corrente in falsa parte,
e poi l’affetto l’intelletto lega.
Vie più che ’ndarno da riva si parte,
perché non torna tal qual e’ si move,
chi pesca per lo vero e non ha l’arte.
Inf. XXXI, 46-51
E io scorgeva già d’alcun la faccia,
le spalle e ’l petto e del ventre gran parte,
e per le coste giù ambo le braccia.
Natura certo, quando lasciò l’arte
di sì fatti animali, assai fé bene
per tòrre tali essecutori a Marte.
Par. XXV, 1-9
Se mai continga che ’l poema sacro
al quale ha posto mano e cielo e terra,
sì che m’ha fatto per molti anni macro,
vinca la crudeltà che fuor mi serra
del bello ovile ov’ io dormi’ agnello,
nimico ai lupi che li danno guerra;
con altra voce omai, con altro vello
ritornerò poeta, e in sul fonte
del mio battesmo prenderò ’l cappello
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 2 (IVa visio, VIum prelium)] Quarto erat suavissima et iocundissima et artificiose et proportionaliter modulata, unde subdit: “et vocem, quam audivi, sicut citharedorum citharizantium cum citharis suis”. Secundum Ioachim, vacuitas cithare significat voluntariam paupertatem. Sicut enim vas musicum non bene resonat nisi sit concavum, sic nec laus bene coram Deo resonat nisi a mente humili et a terrenis evacuata procedat*.
Corde vero cithare sunt diverse virtutes, que non sonant nisi sint extense, nec concorditer nisi sint ad invicem proportionate et nisi sub consimili proportione pulsentur. Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi et sub debitis circumstantiis unam virtutem et eius actus aliis virtutibus et earum actibus proportionaliter concordare et concorditer coherere, ita quod rigor iustitie non excludat nec perturbet dulcorem misericordie nec e contrario, nec mititatis lenitas impediat debitum zelum sancte correctionis et ire nec e contrario, et sic de aliis.
Cithara etiam est ipse Deus, cuius quelibet perfectio, per affectuales considerationes contemplantis tacta et pulsata, reddit cum aliis resonantiam mire iocunditatis.
Cithara etiam est totum universum operum Dei, cuius quelibet pars sollempnis est corda una a contemplatore et laudatore divinorum operum pulsata.
Dicit autem “sicut citharedorum”, quia citharedus non dicitur nisi per artem et frequentem usum, sicut magister artificiose citharizandi. Reliqui enim discordanter et rusticaliter seu inartificialiter citharizant, et si aliquando pulsant bene casualiter contingit, unde ascribitur casui potius quam prudentie artis.
* Expositio, pars IV, distinctio IV, f. 172ra.
Inf. XXI, 16-18
tal, non per foco ma per divin’ arte,
bollia là giuso una pegola spessa,
che ’nviscava la ripa d’ogne parte.
Inf. XXXII, 76-78, 106-108
se voler fu o destino o fortuna,
non so; ma, passeggiando tra le teste,
forte percossi ’l piè nel viso ad una.
quando un altro gridò: “Che hai tu, Bocca?
non ti basta sonar con le mascelle,
se tu non latri? qual diavol ti tocca?”.
4. Cavalcante (X, 52-72)
4.1 La nuova era s’avvicina, ma quando inizia?
Nell’esegesi di Ap 12, 6 – quando la donna (la Chiesa) fugge dall’ostinata durezza giudaica nel deserto della gentilità, e ivi rimane per 1260 anni, ovvero per “un tempo, (due) tempi e la metà di un tempo”, come detto in seguito (Ap 12, 14) – Olivi propone numerose citazioni dalla Concordia di Gioacchino da Fiore. Precisa che esse non esprimono asserzioni ma opinioni. Questa presa di distanza da parte del francescano è più volte ribadita, soprattutto quando il testo sacro, attraverso i numeri mistici in esso contenuti, induce a determinare con precisione gli eventi del prossimo futuro. In questi casi Olivi tende a destoricizzare Gioacchino, a sottolinearne le incertezze, a lasciare in sospeso l’identificazione dei fatti e delle persone verso le quali si appuntano i termini del computo delle generazioni. Se, scrive Raoul Manselli, sottolinea tutta l’importanza di una “figura così terribile” come l’Anticristo mistico, il finto cristiano capo della Chiesa carnale e persecutore dei seguaci della regola evangelica, non la applica concretamente a questo o a quello, come farà poi il suo discepolo Ubertino da Casale: “tendeva piuttosto a pensare ad un antipapa, sostenuto ed appoggiato da qualche grande potenza politica. Ma più non volle dire; e mai si pronunciò sull’altra grande figura apocalittica, ‘Babilon’, la ‘meretrix magna’ che è certo a Roma, ma che non è mai fatta esplicitamente coincidere con la Curia papale” (cfr. la citazione di Gioacchino ad Ap 17, 1) [1].
Convinto di trovarsi sulla soglia dell’apertura del sesto sigillo (il “novum seculum” dell’Olivi), corrispondente all’età dello Spirito che si apre nella quarantunesima generazione, l’abate calabrese in più di un punto della Concordia si mostra volutamente incerto: “esito e preferisco esitare piuttosto che determinare”. Non c’è da meravigliarsi, afferma Olivi, se pur tra tanta luce datagli, quasi nell’aurora del terzo stato, permangono le tenebre del tempo precedente (il quinto stato della Chiesa per Olivi, l’età del Figlio per Gioacchino) che avvolgono la notizia delle cose future. Circa l’apertura del sesto sigillo, Gioacchino afferma che il tempo è vicino ma che il giorno e l’ora sono conosciuti solo da Dio: “i tempi e i momenti mi sono ad ogni modo sospetti”. E trattando delle quarantadue generazioni del secondo stato, ciascuna di trent’anni, e dei 1260 anni che le compongono, esita a stabilire se, per integrare il numero, Zaccaria e suo figlio Giovanni Battista siano da considerare nel primo stato come due generazioni, oppure se alla quarantesima generazione, che è quella in cui vive, ne seguano altre due che non abbiano la medesima durata delle precedenti ma vengano abbreviate per gli eletti.
■ Il ‘sospetto’ di Gioacchino da Fiore sui tempi e le generazioni segna il comportamento dell’epicureo Cavalcante, il padre di Guido: ‘risorto’ dal sepolcro (cfr. Ap 4, 1-2) infuocato, anzi levatosi in ginocchio accanto al dritto Farinata (cfr. Ap 5, 5 e relativo esame), guarda intorno a Dante per vedere se altri sia con lui, “e poi che ’l sospecciar fu tutto spento”, chiede nel pianto: “mio figlio ov’ è? e perché non è teco?” (Inf. X, 55-60).
Osserva Gioacchino da Fiore, nel V libro della Concordia: “Se dunque Zaccaria, il padre di Giovanni Battista posto tra la Sinagoga e la Chiesa, predisse vicino il tempo e la nascita di Cristo, ma non gli fu concesso di far sapere nella loro successione le cose che Cristo avrebbe fatto, così anche a noi, posti tra il secondo e il terzo stato, è concesso di contemplare molte cose del terzo, ma non possiamo determinarne l’ordine per numero e distinzione di fatti, se non forse qualcosa del principio” (ad Ap 12, 6).
L’incertezza di Gioacchino da Fiore nella contemplazione del tempo che s’appressa e nella determinazione delle ultime generazioni si trasforma nel limite posto ai dannati nel vedere il futuro prossimo o il presente. Le parole di Cavalcante – «Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora? / non fiere li occhi suoi lo dolce lume?» (Inf. X, 67-69) – mostrano come egli ignori se il figlio, nell’anno 1300, sia ancora in vita. Eppure Ciacco aveva profetato il futuro prossimo di Firenze (Inf. VI, 64-75). Di qui la preghiera del poeta dubbioso a Farinata, anch’egli profeta del suo destino (Inf. X, 79-81), di spiegargli come mai i dannati prevedano gli eventi futuri ma non conoscano il presente. La risposta di Farinata conferma la “mala luce” dei dannati, che vedono le cose lontane ma hanno vano intelletto di quelle che si avvicinano o che sono (Inf. X, 97-108).
Talora, afferma Gioacchino, le generazioni sono doppie, come nel caso di Ioacaz, deposto dal faraone Necao e sostituito nel regno con Ioiakìm (4 Rg 23, 34); e di Ieconia, figlio di Ioiakìm, deposto da Nabucodonosor e sostituito con Sedecia (4 Rg 24, 15-17; 1 Par 3, 16-17). E gli esclusi talora restano nel numero delle precedenti generazioni, talora sono esclusi anche da queste, come Samgar, che al tempo di Aod giudice difese Israele contro i Filistei (Jd 3, 31) e come Isboset, il figlio di Saul che regnò su Israele al tempo in cui David regnò in Hebron su Giuda (2 Rg 2, 10-11; 4).
Ancora, se non è certo sotto quale generazione avvenne la distruzione di Babilonia o si verificarono le persecuzioni dei tempi di Giuditta e di Ester, così anche nel Nuovo Testamento non si può avere concordia certa. È infatti necessario che l’intelletto venga meno nel Nuovo dove consta sia venuto meno per confusione nel Vecchio, non nel senso che si ignori la vicinanza del tempo, ma che non si conosca il giorno e l’anno.
Il tema della sostituzione nelle generazioni mentre si è in vita – “cum viventi adhuc … substitutus est …” – risuona nella disperata domanda di Cavalcante: «Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora?» (Inf. X, 67-68). Una ripresa del tema è al v. 111, allorché il poeta prega Farinata di dire a Cavalcante, “caduto” per disperazione nell’avello, “che ’l suo nato è co’ vivi ancor congiunto”, e se egli ha indugiato a rispondere provocando la disperazione del padre è stato per il dubbio sulla prescienza dei dannati che il ghibellino gli ha risolto. La poesia fa risuonare due registri differenti: Cavalcante pensa alla morte corporale; Dante, nella risposta, pensa alla sostituzione in vita (cfr. infra). L’amico Guido, ancora vivo nella primavera 1300, non è infatti con lui. Zaccaria, il padre di Giovanni Battista divenuto muto sulle cose che avverranno, è figura che ben si addice al padre di Guido, che non vede il tempo che s’appressa. Guido stesso, “quelli cui io chiamo primo delli miei amici”, è controfigura del Battista nella sua donna, quella monna Vanna-Primavera che nella Vita Nova (cap. 15 [XXIV]) viene prima di monna Bice-Amore, «però che lo suo nome Giovanna è da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce dicendo: “Ego vox clamantis in deserto: parate viam Domini” (Mt 3, 3; Lc 3, 4; Jo 1, 23)».
Si possono notare le tracce di questa esegesi nel caso della Tolomea, lì dove i traditori degli ospiti ‘cadono’ prima di morire, mentre un demonio ne “governa” il corpo in terra. Un’invenzione di Dante, che il figlio Pietro si affrettò a difendere contro possibili riserve teologiche affermando trattarsi di finzione poetica, di un’allegoria dello stato di disperazione di quei peccatori. Ma la meravigliata domanda a frate Alberigo: «“Oh!” diss’ io lui, “or se’ tu ancor morto?”» (Inf. XXXIII, 121-123) è una variante di quella fatta dal padre di Guido: “non viv’ elli ancora?”, ed è cucita, e ad essa rinvia, con gli stessi fili di un’esegesi che sottolinea, utilizzando Gioacchino da Fiore, l’incertezza sulle generazioni e la traslazione ad altri del governo di chi è ancora in vita.
■ Il caso di Cavalcante non resta isolato, perché un momento simmetrico, per la presenza dei temi del ‘sospetto’ e del guardarsi attorno, si ha in Purg. XXII, 115-126, allorché Virgilio e Stazio, sulla soglia del sesto girone della montagna, tacciono “di novo attenti a riguardar dintorno”, presi dal “sospetto” su quale via prendere, finché Virgilio determina che, come fatto fino allora, si debba volgere “le destre spalle” all’orlo esterno del balzo. Stazio, “anima degna”, dà il suo assenso. L’ora – indicata dall’essere già le prime “quattro ancelle … del giorno / rimase a dietro, e la quinta era al temo” – è fra le dieci e le undici antimeridiane: l’ora del sesto stato è il mezzogiorno, e ciò significa che i tre poeti si trovano prossimi al sesto periodo ma ancora sotto il regime del quinto. Il sesto e il settimo stato della Chiesa coincidono, nella teologia dell’Olivi, con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Che la consuetudine tenuta per il passato, di girare verso destra, venga mantenuta nella circostanza – “così l’usanza fu lì nostra insegna” – corrisponde al fatto che a illuminare il sesto stato cooperano tutte le illuminazioni degli stati precedenti e la fama di Cristo, della fede e della Chiesa diffusa per il mondo a partire dal primo stato fino ai tempi moderni (Ap 3, 7; il termine “usanza” è parodia di “usus pauper”). Il “nuovo” è segno del sesto stato, che è di “renovatio” della vita evangelica: così Virgilio e Stazio sono “di novo attenti a riguardar dintorno”. Il sesto girone del purgatorio è quello dove Dante incontra Bonagiunta da Lucca, il poeta che gli chiede se sia “colui che fore / trasse le nove rime” (Purg. XXIV, 49-51). Nel Limbo, alle quattro grandi ombre di Omero, Orazio, Ovidio e Lucano si aggiunge la quinta di Virgilio: “tra cotanto senno” Dante è sesto (Inf. IV, 102). Da notare altre simmetrie tra Inf. X, 55-60 e i versi che precedono Purg. XXII, 115-126, nel colloquio tra Stazio e Virgilio: “per questo cieco carcere / nel primo cinghio del carcere cieco”, “mio figlio, ov’ è? / dimmi dov’ è Terrenzio nostro antico”, “e perché non è teco? / che sempre ha le nutrice nostre seco”. Virgilio dunque determina, con l’assenso di Stazio, la via da seguire per andare al sesto stato, che è la compiuta età dello Spirito (già iniziata in Purg. IX con l’apertura della porta del purgatorio, la “porta di san Pietro”). Come Virgilio, Cavalcante dubita sull’imminente inizio dell’età dello Spirito ma, a differenza del poeta pagano, equivoca nella risposta di Dante sulla sorte del figlio (cfr. infra) [2].
Una curiosa variazione è a Purg. XII, 127-136, quando Dante, passato l’angelo dell’umiltà, scopre di essere libero dalla prima delle sette “P” incise sulla sua fronte dall’angelo portiere con la punta della spada. Anche qui è presente il tema del sospetto: “Allor fec’ io come color che vanno / con cosa in capo non da lor saputa, / se non che ’ cenni altrui sospecciar fanno”, per cui, senza vedere, si aiuta con la mano a ritrovare le sei lettere restanti impresse sulla fronte.
■ Le citazioni di Gioacchino da Fiore sul proprio “sospetto”, riportate ad Ap 12, 6, possono essere confrontate con un passo del quarto libro della Concordia citato da Olivi prima di procedere, nella terza visione, all’esegesi della sesta tromba (Ap 9, 13). Gioacchino ritiene incauto definire con precisione gli anni dopo la quarantesima generazione, cioè a partire dal sesto stato, che coincide con la quarantunesima generazione. Usa l’immagine dei marinai, i quali in vista del porto ammainano le vele e utilizzano altri strumenti per venire a proda, oppure quella di coloro che, dopo aver navigato per lidi sicuri e conosciuti, iniziano a solcare acque sconosciute in modo cauto e circospetto.
Sono questi alcuni dei motivi presenti nell’episodio della corda che Virgilio, volgendosi verso il lato destro, getta nel burrone dove cade il Flegetonte verso Malebolge (Inf. XVI, 106-120). Dante pensa tra sé a questo atto come a un “novo cenno”, che il maestro segue con attento sguardo e al quale “e’ pur convien che novità risponda”. Poi afferma apertamente che si deve essere “cauti” (hapax) presso a coloro i quali, come Virgilio, non solo vedono gli atti esteriori ma penetrano col senno nei pensieri altrui. Comune con l’immagine di Gioacchino da Fiore è l’essere cauti (proprio di Dante nei confronti di Virgilio) o circospetti (proprio di Virgilio) di fronte alle novità. La corda, “novo cenno” al quale viene in su Gerione, è uno dei momenti che nell’Inferno sono segnati, topograficamente, dalla prevalenza dei temi del sesto stato.
Purg. XII, 127-129, luogo sopra ricordato, sembra riferibile ad Ap 9, 13 per l’espressione “come color che vanno / con cosa in capo non da lor saputa”; ad Ap 12, 6 per il “sospecciar”. Da confrontare il “novo cenno” di Inf. XVI, 116 (la corda gettata) con i “cenni altrui” di Purg. XII, 129. È da considerare che siamo nel primo girone della montagna dopo l’apertura della porta del purgatorio, che coincide con l’inizio del sesto stato oliviano o con l’età dello spirito di Gioacchino. Non sarà pertanto casuale l’espressione “trovai pur sei le lettere che ’ncise / quel da le chiavi a me sovra le tempie” (Purg. XII, 134-135) , che un esperto lettore o ascoltatore non avrebbe mancato di rilevare.
■ Il tema del “sospetto” si trova anche in Purg. VI, 43-45, quando Virgilio invita Dante a non fermarsi “a così alto sospetto”, cioè a un dubbio sì profondo, senza una spiegazione data da Beatrice – “se quella nol ti dice / che lume fia tra ’l vero e lo ’ntelletto” -, dalla sua donna che potrà vedere sulla cima della montagna. Il dubbio è il seguente: nell’Eneide la Sibilla, supplicata dall’insepolto Palinuro di portarlo oltre l’Acheronte, aveva risposto che i decreti divini non si possono modificare con la preghiera – “desine fata deum flecti sperare precando” (Aen., VI, 376) -; è dunque vana la preghiera delle tante anime purganti che pregano Dante perché ricordi al mondo di pregare per loro? Virgilio risponde che la preghiera dei pagani non era udita in cielo e che, adesso, il giudizio divino non subisce alcun mutamento per il fatto che l’ardore della carità soddisfi “in un punto”, cioè in un istante, quanto dovuto dai peccatori per il riscatto delle loro colpe. Il “sospetto” di Dante riguarda dunque la possibilità che le preghiere abbrevino la permanenza nel purgatorio delle anime già elette – “sì che s’avacci lor divenir sante” -, come l’esitazione di Gioacchino da Fiore verte sul fatto se i giorni delle ultime due generazioni siano o meno abbreviati in favore degli eletti (Purg. VI, 25-42). Da notare che, secondo quanto Olivi afferma nel notabile VIII del prologo della Lectura, il sesto stato è il “punto” da cui dipendono gli altri stati, perché esso appare nel testo dell’Apocalisse in modo più evidente degli altri, che da esso assumono chiarezza quanto alla loro manifestazione nella storia, come l’intelligenza delle cose ordinate ad un fine dipende dal fine. È questo un tema che si ritrova nel punto luminosissimo – Dio – da cui dipende il cielo e la terra, circondato dai nove cerchi di fuoco, che Dante vede nel Primo Mobile, nono ma sesto, a partire dal cielo del Sole, dei cieli senza il cono d’ombra proiettato dalla terra (Par. XXVIII, 16-18, 40-42, 94-96).
Il discorso di Virgilio, nel quale il poeta pagano si rimette a quanto dirà Beatrice, “quella … / che lume fia tra ’l vero e lo ’ntelletto” (Purg. VI, 44-45), corrisponde in parte a quanto Olivi dice delle affermazioni di Gioacchino da Fiore, molte delle quali ritiene non asserzioni ma opinioni. Nell’esegesi della quinta tromba (Ap 9, 11), il francescano sostiene che come per mezzo della naturale luce dell’intelletto conosciamo alcune cose in modo certo, quali i primi princìpi (“lo ’ntelletto / de le prime notizie”, che l’uomo non sa da dove venga, a Purg. XVIII, 55-56); alcune come necessariamente da essi dedotte, altre invece opiniamo in base a ragioni probabili, e in queste opinioni possiamo errare senza che per questo sia falso il lume dell’intelletto a noi concreato, ma non erriamo in quanto siamo consapevoli che si tratta di opinioni e non di scienza infallibile, così per mezzo del lume dato in virtù della gratuita rivelazione conosciamo alcune cose come princìpi indubitabili, altre come conclusioni necessarie, altre ancora come probabili congetture (cfr. le espressioni “nec pro tanto fallimur … e la speranza di costor non falla”, Purg. VI, 35). A una precedente domanda su quanto sia lunga l’ascesa della montagna, Virgilio ha risposto che la salita, grave all’inizio, si fa poi sentire sempre più leggera, concludendo: “Più non rispondo, e questo so per vero” (Purg. IV, 96). Sa queste cose in modo indubitabile come fossero primi princìpi.
Dante evita di applicare ai ragionamenti di Virgilio il termine “opinioni”, come fa Olivi a proposito di Gioacchino da Fiore; il poeta pagano è mosso dal lume di Beatrice, per cui le sue sono asserzioni della ragione illuminata. È il “lume che nel ciel s’informa”, che muove l’“alta fantasia”, cioè l’“imaginativa” che fa a meno dei sensi. La fantasia è la virtù organica che media tra il sensibile e l’intelletto: chi la fa operare, si chiede il poeta, se la materia non è fornita dalle percezioni sensibili? Essa, nelle visioni estatiche di ira punita apparse nel terzo girone della montagna, viene stimolata da un lume che prende forma nel cielo, o per influsso astrale o perché mandato da Dio (Purg. XVII, 13-45). Così è per Virgilio, che nel secondo girone si è rivolto al lume del sole, perché guidi il cammino coi suoi raggi (Purg. XIII, 13-21). ‘Opinione’ è quando la ragione va dietro ai sensi, per cui “ha corte l’ali”, ed “erra … dove chiave di senso non diserra”, come afferma Beatrice all’inizio della confutazione circa la provenienza delle macchie lunari dal raro e dal denso della materia, teoria averroista creduta da Dante (Par. II, 52-57). Virgilio non rappresenta soltanto, come si suole affermare, la ragione in quanto tale, ma la ragione vittoriosa sui sensi. Questa vittoria è prerogativa del terzo stato, dei dottori che confutano con la ragione le eresie e i loro fantastici e sensibili errori. Questo stato, che è della Chiesa ma che ha una sua prefigurazione nella legge data nell’Antico Testamento, Dante lo appropria agli Antichi, convinti sostenitori del libero arbitrio: “Color che ragionando andaro al fondo, / s’accorser d’esta innata libertate; / però moralità lasciaro al mondo” (Purg. XVIII, 67-69). Il terzo stato corrisponde all’intelligenza morale della Scrittura, che gli Antichi non conobbero, ma dei cui sviluppi furono ‘figura’ per essere poi da essa ricompresi attraverso la loro ‘vita nova’ nel poema sacro. La ragione illuminata ‘aspetta’ la fede, e qui Virgilio riconosce il suo limite: «Ed elli a me: “Quanto ragion qui vede, / dir ti poss’ io; da indi in là t’aspetta / pur a Beatrice, ch’è opra di fede”» (Purg. XVIII, 46-48).
Grande valore, considerata l’esegesi del “sospetto” sulla concordia gioachimita tra Vecchio e Nuovo Testamento, assume l’espressione di Virgilio sul fatto che non ci sia contraddizione tra la preghiera un tempo disgiunta da Dio (per cui fu vana la richiesta alla Sibilla di essere traghettato da parte dell’insepolto Palinuro) e l’odierno “foco d’amor” che soddisfa la colpa: “La mia scrittura è piana” (Purg. VI, 34). L’antico poeta non intende soltanto ‘il mio testo scritto’, bensì ‘quel che scrissi, che è anch’essa Scrittura antica da concordare con la nuova’. Essa è come l’angelica favella di Beatrice, “soave e piana” (Inf. II, 56-57), di cui è figura, per cui l’alta tragedia si è fatta, convertendosi, “sermo humilis”.
■ Nel Notabile VII del prologo della Lectura, Olivi inserisce il celebre passo sulla “commutatio” del pontificato. I temi presenti in questo passo sono principalmente due: l’alterno succedersi delle stirpi sacerdotali nell’Antico Testamento, per disegno divino o per deposizione da parte di un re (il caso di Abiatar da parte di Salomone), e una sorta di corsi e di ricorsi tra povertà e ricchezza del pontificato nel Nuovo Testamento fino al definitivo ritorno, nel sesto stato, alla stabilità dell’originaria povertà evangelica. Se si collazionano i temi della sesta vittoria (Ap 3, 12) con quelli propri della “commutatio” del pontificato (Notabile VII), si deduce che il sesto stato si presenta come “novum seculum” che rinnova il vecchio e in cui ritorna l’originaria povertà del primo stato. La nuova Gerusalemme, ossia la pace, discende dal cielo e una nuova progenie spirituale viene creata. La virginea prole è pure tema della quarta visione, che inizia con il capitolo XII, dove appare la donna (la Chiesa) vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle (cfr. l’esegesi ad Ap 12, 7). Questi motivi sono la veste spirituale, perfettamente aderente, dei versi della quarta egloga virgiliana che celebrano la rinnovata età dell’oro, versi che Stazio ripete nel dichiarare il suo debito verso Virgilio: “Per te poeta fui, per te cristiano” (Purg. XXII, 64-73). Se tra i due poeti sta il mistero della predestinazione per cui uno fu toccato dalla Grazia e l’altro no, qui Virgilio è non solo profeta del primo avvento di Cristo ma anche della seconda e altrettanto grande “renovatio”, quella del sesto stato, in cui ha luogo la conversione delle genti e del popolo d’Israele fino allora escluso. La lode che Stazio fa di Virgilio assomiglia a quella che nel cielo del Sole Bonaventura pronuncia del “calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato” (Par. XII, 139-141), il quale, come dice Olivi, vide in spirito il sesto stato. Si noterà che “Secol si rinova” non c’è in Virgilio, ma in Olivi; e se ciò non bastasse, si aggiunga “torna giustizia e primo tempo umano”.
[1] RAOUL MANSELLI, Pietro di Giovanni Olivi ed Ubertino da Casale (a proposito della Lectura super Apocalipsim e dell’Arbor vitae crucifixae Jesu), in “Studi medievali”, ser. III, 6 (1965), pp. 95-122: pp. 117-118, ripubblicato in IDEM, Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo. Studi sul francescanesimo spirituale, sull’ecclesiologia e sull’escatologisno bassomedievali, introduzione e cura di PAOLO VIAN, Roma 1997 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici, 36), pp. 79-107: pp. 101-102.
[2] Duplice è, secondo Gioacchino da Fiore, la causa della somiglianza tra vecchio e nuovo. Talora infatti due popoli vengono designati con due eletti, talvolta con due dei quali il primo è reprobo e l’altro è eletto. Il popolo antico, generato secondo la carne da Abramo e dagli altri padri, fu infatti secondo certi rispetti reprobo e secondo certi altri eletto. Nella Scrittura è detto, a proposito di Ismaele che l’egiziana Agar aveva partorito ad Abramo: “il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera” (cfr. Genesi 21, 10): «Et paulo ante dicit quod “duplex est causa similitudinis inter vetus et novum. Aliquando enim duo populi ipsorum designantur in duobus electis; aliquando in duobus, quorum primus est reprobus et alius electus. Cuius ratio est quia populus antiquus, ex Abraam et ceteris patribus secundum carnem genitus, fuit secundum aliquid reprobus et secundum aliquid electus. Unde scriptura dicit de utroque: Non erit heres filius ancille cum filio libere”. Hec Ioachim» (citato ad Ap 12, 6).
Considerata l’importanza dell’esegesi oliviana e dei temi che contiene, nonché della sua capillare utilizzazione parodica nel poema, non si può non notare la simmetria tra la domanda di Cavalcante a Dante – “mio figlio ov’ è? e perché non è teco?” (Inf. X, 60) -, che si è visto partecipe dell’incertezza di Gioacchino da Fiore circa l’appressarsi della terza età, e quella di Stazio a Virgilio – “dimmi dov’ è Terrenzio nostro antico, / Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: / dimmi se son dannati, e in qual vico” (Purg. XXII, 97-99) -, due momenti tra l’altro accomunati anche dalle circostanti rime meco–cieco–teco / cieco–seco (Inf. X, 56.58.60; Purg. XXII, 103.105). Virgilio risponde a Stazio (Purg. XXII, 100-114) elencando una serie di personaggi, storici o mitologici, in aggiunta a quelli già presenti nel Limbo (aggiunta anticipata, ai versi 13-15, dal nome di Giovenale). Tra questi c’è anche Manto: “èvvi la figlia di Tiresia, e Teti” (v. 113). Si tratta di una delle più spinose ‘cruces’ dantesche: già collocata nella quarta bolgia degli indovini, come può stare Manto anche nel Limbo? Le varie soluzioni sono puramente congetturali, contro di esse sta la lezione concorde di tutti i manoscritti. Gioacchino da Fiore, citato da Olivi ad Ap 12, 6, non solo afferma che le generazioni (che corrispondono a persone) possono essere, nel computo generale, sottratte o ripetute, ma anche che talora due popoli vengono designati con due eletti, talvolta con due dei quali il primo è reprobo e l’altro è eletto. Il popolo antico fu secondo certi rispetti reprobo e secondo certi altri eletto. Viene il dubbio che Manto sia consapevolmente ripetuta due volte. “La figlia di Tiresia” è citata fra “le genti tue”, cioè fra i personaggi celebrati da Stazio nella Tebaide e nell’Achilleide. Stazio, poco prima, nel racconto della sua conversione, ha affermato: “E pria ch’io conducessi i Greci a’ fiumi / di Tebe poetando, ebb’ io battesmo” (Purg. XXII, 88-89), cioè ‘fui battezzato prima che giungessi a comporre quell’episodio del poema in cui rappresento l’arrivo dei Greci sulle rive dei fiumi tebani’, episodio che, secondo l’interpretazione corrente, è nel libro IX della Tebaide (vv. 225 sgg.); oppure, più precisamente, nel libro VII, 424-425 (“Iam, ripas, Asope, tuas Boeotaque ventum / flumina”). In questo poema Manto compare quale vergine che aiuta il padre Tiresia nei suoi sortilegi, libando il sangue delle greggi sacrificate ad Ecate, alle Erinni, le figlie dell’Acheronte, a Plutone e a Proserpina, spargendone le viscere ancora palpitanti (Theb., IV, 463-469); il che corrisponde alla “vergine cruda” di Inf. XX, 82. Nel X libro della Tebaide, però, Manto compare sotto ben altro aspetto. Per convincere Meneceo a sacrificarsi per la patria, scende in terra Virtù, una dea compagna di Giove, che sta vicino al suo trono. Per rendersi più credibile assume le sembianze di Manto, la profetessa, con le vesti che scendono fino ai piedi e le nere chiome legate dalla benda. Questa Virtù che penetra le anime che possono contenerla, alla cui scesa fanno via gli astri, che convince il giovane figlio di Creonte, il “pius Menoeceus”, ad accettare una morte gloriosa e che riascende infine dalla terra verso il cielo (Theb., X, 632ss.), doveva apparire virtù quasi cristiana a Dante, consapevole che Stazio aveva scritto da “chiuso cristian” quell’episodio del libro X. Da notare anche qualche simmetria tra le genti notate in Inf. XX e quelle elencate in Purg. XXII: “Ma dimmi, de la gente che procede, / se tu ne vedi alcun degno di nota (Inf. XX, 103-104) … dimmi dov’ è Terrenzio nostro antico … Quivi si veggion de le genti tue (Purg. XXII, 97, 109)”, quasi che il tema della “gentilitas”, toccato con Anfiarao, Tiresia, Arunte, Manto, Euripilo nella quarta bolgia infernale, abbia una sua ripresa più elevata nell’incontro tra i due alti tragici, Stazio e Virgilio, il primo dei quali ebbe come madre e nutrice l’Eneide e si convertì per i versi del “cantor de’ buccolici carmi”. Sotto la larva della ‘vecchia’ e crudele profetessa, la ‘nuova’ Manto si cambia in Virtù. Il dubbio, legittimo, resta. In ogni caso, stare nel Limbo non equivale ad essere beati. Ma come lì si sospira per l’apertura del libro, che solo Cristo può aprire, nel suo secondo avvento nel sesto stato della Chiesa, nel quale Dante è “sesto tra cotanto senno”, così il Purgatorio porta a compimento il tempo che san Paolo definisce della “plenitudo gentium” (Rm 11, 25-26): il viaggio che sale e rigira la montagna dura tre giorni e mezzo, esattamente come la permanenza della donna nel deserto dei Gentili, che vengono incorporati nella Chiesa “per un tempo, (due) tempi e la metà del tempo” (Ap 12, 14). Al termine della sua integrazione circa le “genti” nel Limbo, Virgilio determina la via per andare al sesto girone. Lì i temi del “novum seculum”, cioè del sesto stato dell’Olivi, sono maggiormente presenti, e nel sesto stato si completa la conversione dei Gentili, prima della finale conversione di Israele.
Tab. VII
[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio); non si segue l’ordine consequenziale dei passi]Item de hoc ultimo (Ioachim) dicit libro V° (Concordie) circa finem prime partis […] Et aliquantulum supra dicit: «Si enim Zacharias pater Iohannis, inter sinagogam et ecclesiam constitutus, predixit adesse tempus et nativitatem Christi, sed tamen ea que Christus erat facturus non est seriatim intimare permissus, ita et nos, qui inter secundum et tertium statum constituti sumus, multa quidem de tertio illo statu contemplari permittimur, ordinem vero rei iuxta numerum et distinctiones operum assignare nequimus, nisi forte aliquid de principio». […]*Item, libro IIII°, ostendit quod sicut ex sacro textu non est nobis certum sub qua generatione fuerit destructio Babilonis aut persecutio facta sub Iudith vel alia facta sub Hester, sic nec per concordiam possunt similia sciri in Novo, propter quod infert: «Igitur, ut sepe dixi, in tempore confusionis omnia non immerito sunt confusa. Etsi per exemplaria veterum intelligimus nova, necesse est ut ibi ex parte aliqua deficiat intellectus in Novo ubi defecisse constat in Veteri, non ut ignoretur vicinitas temporis sed ut dies ignoretur et annus». […]** |
Inf. X, 97-105“El par che voi veggiate, se ben odo,
|
Docet etiam aliquando simul poni generationes duplices, ut cum viventi adhuc Io<achaz> substitutus est Ioachim, et viventi Ieconi<e> substitutus est Sedechias. Et de talibus dicit quod aliquando secundum aliquid manent in numero aliarum et secundum aliquid excluduntur, sicut Sangar qui tempore Aioht iudicis defendit Israel, et sicut Isbozet qui regnavit super Israel tempore quo David regnavit in Ebron super Iudam*.
|
Inf. X, 67-72, 109-111Di sùbito drizzato gridò: “Come?
|
Tab. VIII
[LSA, cap. IX, Ap 9, 11 (IIIa visio, Va tuba)] Super quo et consimilibus advertendum quod ipse plura dicit non assertorie sed opinative. Sicut enim ex naturali lumine intellectus nostri quedam scimus indubitabiliter ut prima principia, quedam vero ut conclusiones ex ipsis necessario deductas, quedam vero nescimus sed solum opinamur per probabiles rationes, et in hoc tertio sepe fallimur et possumus falli, nec tamen ex hoc lumen nobis concreatum est falsum nec pro tanto fallimur pro quanto opiniones nostras scimus non esse scientias infallibiles, sic lumen per gratuitam revelationem datum quedam scit ut prima principia et indubitabilia revelata, quedam vero ut conclusiones ex ipsis necessario deductas, quedam vero ex utrisque solum probabiliter et coniecturaliter opinatur, et sic videtur fuisse intelligentia scripturarum et concordie Novi et Veteris Testamenti per revelationem abbati Ioachim, ut ipsemet asserit, data. |
||
Purg. IV, 96; XVIII, 46-48, 55-57Più non rispondo, e questo so per vero.Ed elli a me: “Quanto ragion qui vede,
|
Purg. VI, 25-36, 43-45Come libero fui da tutte quante
|
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio)] Quod autem ultra hoc Ioachim opinative dixit futuram persecutionem Antichristi esse complendam in primis quadraginta annis huius centenarii, aut etiam in tribus annis et dimidio prime partis eorum, unde et super illo verbo infra XIII° (Ap 13, 4): “Quis similis bestie, et quis poterit pugnare cum illa?”, dicit: «Heu, quot arbitror natos esse in mundo, qui tante huius calamitatis angustias non evadent!»1, non mireris si cum magna luce sibi data, quasi in aurora tertii status, habuit permixtas tenebras in notitiam futurorum, et maxime cum nocturne tenebre quinti temporis suo tempore inundarent. Quod autem non assertorie sed opinative talia dixerit, patet ex pluribus superius a me tactis super quinta et sexta tuba. |
||
[segue Ap 12, 6] Preterea hoc patet ex hoc quod libro III° Concordie, circa finem ubi agit de apertione sexti sigilli, dicit: «Tempus autem quando hec erunt, dico manifeste quia prope est, diem autem et horam Dominus ipse novit. Quantum autem secundum coaptationem concordie estimare queo, si pax conceditur ab hiis malis usque ad annum millesimum ducentesimum incarnationis dominice, exinde, ne subito ista fiant, suspecta michi sunt omnimodis tempora et momenta»2.
|
[LSA, cap. IX, Ap 9, 13 (IIIa visio, VIa tuba)] Item (Ioachim) IIII° libro (Concordie), ubi agit de quadragesima secunda generatione, dicit quod «articulus temporis eius melius relinquitur Deo, qui hec et multa alia in sua posuit potestate. Non enim pertinet ad concordiam querere numerum annorum in novo, ubi non habetur in veteri, et ultra quadragesimam generationem aliquid per certum numerum incautius diffinire. Nec mirum. Solent enim et naute, conspecto comminus portu, navis armamenta deponere et aliis auxiliis competenter inniti»4. Item supra eodem, agens de generatione quadragesima, dicit: «Usque ad presentem locum per experta, ut ita dicam, littora navigantes securo navigio iter faciebamus. Amodo cautius est agendum et hinc inde circumspecte reli<quum> itineris peragendum, utpote qui per incognita navigare incipimus», et cetera5.Inf. XVI, 115-120‘E’ pur convien che novità risponda’,
|
|
Purg. XII, 127-136Allor fec’ io come color che vanno
|
Purg. XXII, 94-105, 115-126Tu dunque, che levato hai il coperchio
|
|
Tab. IX
La terza vittoria (la cui esegesi conclude l’istruzione data a Pergamo, la terza chiesa d’Asia) consiste nella vittoriosa ascesa al di sopra della fantasia mossa dal senso, che è causa di errore e di eresia. Questa salita avviene tramite la prudenza che mette in fuga le nebbie, gli errori e gli impulsi precipitosi e temerari. È propria dei dottori che vincono gli errori della fantasia eretica, a loro spetta il premio del singolare apprendimento e del gusto dell’arcana sapienza di Dio. Così alla terza chiesa d’Asia (Pergamo) viene detto: “Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza lucida sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve” (Ap 2, 17). La fantasia erronea è pure il difetto che rende chiuso il terzo sigillo (ad Ap 5, 1).
|
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (Ia visio, IIIa ecclesia)] Tertia autem commendatur de servando et confitendo fidem inter magistros erroris, in quibus quasi in cathedra pestilentie Sathanas sedet. Increpatur tamen quia ex quorundam suorum negligentia quosdam hereticos habebat. Competunt autem hec tempori tertio, scilicet doctorum. Tunc enim aliqui catholici nimis participabant cum aliquibus hereticis, quamvis ceteri essent constantissimi contra eos. Hec autem ecclesia congrue vocatur Pergamus, id est dividens cornua, quia superbam potentiam et scissuram hereticorum potentissime frangebat et dissolvebat.[LSA, cap. II, Ap 2, 12 (Ia visio, IIIa ecclesia)] Hiis autem premittuntur duo, scilicet preceptum de scribendo hec sibi et introductio Christi loquentis, cum subdit (Ap 2, 12): “Hec dicit qui habet rumpheam”, id est spatam, “ex utraque parte acutam”. Hec congruit ei, quod infra dicit: “pugnabo cum illis in gladio oris mei” (Ap 2, 16).
|
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (IIIus defectus in nobis claudens intelligentiam huius libri)] Tertius est nostre phantasie proterva et erronea cervicositas.[LSA, prologus, Notabile I (IIIus status)] Tertius est confessorum seu doctorum, homini rationali appropriatus. […] In tertio sonus predicationis seu eruditionis et tuba magistralis. |
[LSA, cap. II, Ap 2, 17 (Ia visio, IIIa victoria)] Tertia est victoriosus ascensus super phantasmata suorum sensuum, quorum sequela est causa errorum et heresum. Hic autem ascensus fit per prudentiam effugantem illorum nubila et errores ac impetus precipites et temerarios ac tempestuosos. Hoc autem competit doctoribus phantasticos hereticorum errores expugnantibus, quibus et competit premium singularis apprehensionis et degustationis archane sapientie Dei, de quo tertie ecclesie dicitur: “Vincenti dabo manna absconditum, et dabo ei calculum lucidum, et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo novit, nisi qui accipit” (Ap 2, 17). |
Purg. XV, 115-117; XVII, 7-9, 13-21, 25-26Quando l’anima mia tornò di fori
|
Purg. XVII, 31-33, 40-45, 106-114E come questa imagine rompeo
|
Tab. X
[LSA, prologus, Notabile VI] Tertia ratio magis litteralis est quia ut quidam finis sollempnis et quoddam sollempne initium novi seculi monstretur esse in sexto statu et plenius in septimo […][LSA, prologus, Notabile VII] […] sicque tertio, reiecta tota vetustate huius seculi, renovaretur et consumaretur seculum per gloriam et in gloria Christi. […]
|
|
Purg. XXII, 67-72Facesti come quei che va di notte,
|
Egloga IV, 5-7Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo
|
4.2 “forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”: morte corporale o sostituzione nel primato della “gloria de la lingua”?
Cosa intendeva dire Dante a Cavalcante – «E io a lui: “Da me stesso non vegno: / colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”» (Inf. X, 61-63)? Cosa comprende il padre di Guido – «Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora? / non fiere li occhi suoi lo dolce lume?» (vv. 67-69)? Per intendere bene l’equivoco fra i due bisogna esaminare il tessuto spirituale di Purg. XI.
■ Al vescovo di Efeso, il metropolita delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione, viene minacciato lo spostamento del candelabro, cioè la “translatio” del primato ad altra chiesa, qualora nel suo allontanarsi, discendendo in basso, non ritorni, risalendo, alla carità originaria: “Memor esto itaque unde excideris et age penitentiam et prima opera fac. Sin autem, venio tibi et movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi penitentiam egeris” (Ap 2, 5).
Efeso viene assimilata all’“Ecclesia ex circumcisione”, che aveva sede a Gerusalemme. Questa peccò di vanagloria nella superba presunzione del suo primato che le derivava dall’essere stata la prima a credere in Cristo, dal fatto che i Gentili la onoravano e seguivano come maestra che li aveva illuminati e tratti a Cristo, dalla gloria dei suoi patriarchi e profeti e dalla legge e dal culto di Dio per lungo tempo in essa sola fondati. Tra i motivi della traslazione, avvenuta con la fissazione della sede in Roma da parte di san Pietro, rientra anche quello per cui i Giudei dovevano essere, all’avvento di Cristo, abbandonati nella loro cecità e la sede somma di Cristo posta a Roma, nella principale sede dell’impero dei Gentili. Ad umiliazione di questo superbo primato, Cristo si mostra all’inizio dell’istruzione rivolta alla chiesa di Efeso come “Colui che tiene le sette stelle nella sua destra” (Ap 2, 1), cioè tutti i preclari prìncipi e prelati di ogni chiesa, e che è presente in tutte le chiese attuali e future, che percorre e visita. Egli è il sommo re e pontefice, molte altre importanti chiese sono e dovranno porsi sotto di lui oltre alla superba Gerusalemme. Olivi, a differenza di Riccardo di San Vittore che si mantiene nell’interpretazione letterale e morale, fa della “translatio” uno dei motori della storia. Essa infatti non avviene solo con la chiesa di Gerusalemme, perché si verificherà ancora, alla fine del quinto stato della Chiesa, con la traslazione del primato della nuova Babilonia alla nuova Gerusalemme e, al termine dell’ultima e prava parte del settimo stato, nella traslazione alla Gerusalemme celeste.
Se alla chiesa di Efeso (la prima delle sette chiese d’Asia) viene minacciato lo spostamento del candelabro, alla sesta chiesa, Filadelfia (il sesto stato è il tempo di Olivi e Dante), viene minacciata la perdita della corona se non persevererà nella fede e nelle buone opere. Come infatti il primo stato della Chiesa, designato con la chiesa di Efeso, ebbe il primato rispetto al secondo stato generale del mondo (la gioachimita età del Figlio), definito da san Paolo il tempo della pienezza delle genti (Rm 11, 25-26), così il sesto stato avrà il primato rispetto al terzo stato generale, che durerà fino alla fine del mondo (l’età dello Spirito, che coincide appunto con gli ultimi due stati della Chiesa, il sesto e il settimo). La traslazione viene minacciata affinché le chiese e i loro vescovi non insuperbiscano credendo che altri non possa sostituirle in modo ugualmente degno. Inoltre, sia la Chiesa primitiva sia quella del sesto stato subentrano nella gloria ad un’altra, la prima alla Sinagoga, la seconda alla meretrice Babilonia, che verrà condannata agli inizi del sesto stato (Ap 3, 11).
■ La collazione dei due luoghi relativi alla chiesa di Efeso (Ap 2, 5) e alla chiesa di Filadelfia (Ap 3, 11) conduce al primo girone del purgatorio, quello dei superbi, dove Oderisi da Gubbio riconosce la superiorità nell’arte della miniatura di Franco Bolognese e cita altri due celebri esempi di “translatio”. Come Cimabue è stato superato da Giotto nella pittura, “così ha tolto l’uno a l’altro Guido / la gloria de la lingua; e forse è nato / chi l’uno e l’altro caccerà del nido” (Purg. XI, 79-84, 94-99). L’essere onorati e “illuminati”, vanto della chiesa di Efeso, viene appropriato a Oderisi, “l’onor d’Agobbio” e, in senso equivoco, all’arte della miniatura, “ch’alluminar chiamata è in Parisi” (il francese “enluminer”). Oderisi, con atto di umiltà, afferma che tutto l’onore è di chi gli è subentrato, ed è suo solo in parte.
“Credette Cimabue ne la pittura / tener lo campo”: il verbo tenere designa il potere di Cristo che “tiene” nella mano destra le sette stelle, cioè tutte le chiese presenti e future (cfr. Ap 2, 1), le quali ‘tengono’ un primato solo temporaneo. Non diversamente Provenzan Salvani, un altro purgante nel girone dei superbi, “fu presuntüoso / a recar Siena tutta a le sue mani” (Purg. XI, 121-123).
La gloria preparata per la Sinagoga e poi traslata alla Chiesa di Cristo, o quella che dal quinto stato viene passata al sesto, è appropriata ai due Guidi (per lo più intesi come Guido Cavalcanti e Guido Guinizzelli) [1], che verranno superati dalle nuove rime di Dante (il quale non a caso è “sesto tra cotanto senno” nella “bella scola” dei poeti del Limbo, Inf. IV, 100-102). L’espressione “ha tolto l’uno a l’altro Guido” corrisponde all’evellere per cui il candelabro viene spostato.
I temi propri del primato della chiesa di Gerusalemme, onorata maestra illuminatrice e per lungo tempo sola depositaria della legge divina e del culto, si trovano nelle parole che Dante rivolge a Virgilio subito dopo l’apparizione di questi nella “diserta piaggia”: egli è “onore e lume” degli altri poeti, solo maestro da cui il fiorentino ha tolto “lo bello stilo che m’ha fatto onore”, cioè lo stile tragico o elevato (Inf. I, 82-87). L’espressione “da cu’ io tolsi”, considerato il significato, di passaggio del primato, che il verbo ‘togliere’ assume nel discorso di Oderisi relativo ai due Guidi, adombra forse un’idea di onorevole “translatio” del primato poetico da Virgilio a Dante (senza, ovviamente, alcun riferimento alla superbia). Non diversamente si rivolge Stazio a Virgilio, che per primo lo avviò alla poesia e lo illuminò nella fede cristiana (Purg. XXII, 64-66: non c’è il verbo ‘togliere’, ma a Virgilio è attribuito per due volte un “prima”).
Lo stesso calembour che collega il verso 92 al verso 94 di Purg. XI – “com’ poco verde in su la cima dura”, “Credette Cimabue ne la pittura” [2] – è tessuto sul medesimo panno, perché del vescovo di Efeso si dice, ad Ap 2, 4 con citazione di Riccardo di San Vittore, che “de culmine sue perfectionis ceciderat ad minorationem sue perfectionis”. Cimabue ha visto oscurata la propria fama, ed il verso relativo (v. 96: “sì che la fama di colui è scura”) è un filo tratto dal tessuto esegetico relativo alla quarta tromba (l’interpretazione morale delle sette tubicinazioni in fine del cap. XI), per la quale viene oscurata la fama mondana (il “mondan romore”, v. 100), la gloria e la superba presunzione di chi si ritiene perito e santo, e come tale dagli altri è glorificato (nel quarto stato a essere “alti” per superbia nella scienza divina sono i contemplativi anacoreti). Così dell’alta vita degli anacoreti Olivi nota (Notabile V del prologo) che non può durare troppo a lungo a causa dell’“infectio humani generis” (nei versi è la “vana gloria de l’umane posse”, v. 91, a durar poco). I temi dalla quarta tromba sono incidentali rispetto ai principali, propri della prima chiesa; per tutto il primo girone della montagna prevalgono i temi del primo stato (intrecciati, come di consueto, con quelli di tutti gli altri periodi della storia della Chiesa).
■ In Purg. XI, per bocca di Oderisi da Gubbio che purga la superbia nel primo girone della montagna, Dante fa dunque risuonare i temi propri del primato della superba chiesa di Gerusalemme, onorata maestra illuminatrice e per lungo tempo sola depositaria della legge divina e del culto, primato traslato ad altri per presunzione e minacciato ad Efeso, la principale delle sette chiese d’Asia. L’esegesi della prima chiesa (Ap 2, 5) è da collazionare con quella della prima tromba (Ap 8, 7), la quale risuona contro la durezza giudaica che non volle riconoscere Cristo. Il male venuto sui Giudei viene così espresso: “e la terza parte della terra fu combusta, e la terza parte degli alberi fu bruciata e ogni erba verde fu combusta”. Secondo una delle interpretazioni proposte, nessuno che non sia fermo nella fede e nella carità come la terra o un albero può vincere quella che fu la tentazione giudaica contro Cristo, forte di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’ (cioè degli avi) e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo. A questa tentazione non può resistere chi è fragile e instabile come l’erba che inaridisce.
Il panno, che cuce insieme Ap 2, 5 (prima chiesa) e Ap 8, 7 (prima tromba), si mostra il medesimo per Inf. X e Purg. XI. Si confrontino, ad Ap 2, 5, le espressioni “Si vero queratur plenior ratio sui casus vel translationis predicte … Primum est inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et primitate, quam scilicet habuit” con le parole “forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”, dette da Dante a Cavalcante (Inf. X, 63), e con “ogn’ uomo ebbi in despetto tanto avante” dette da Omberto Aldobrandesco (Purg. XI, 64), ed anche la superbia di Capaneo, che “ebbe e par ch’elli abbia / Dio in disdegno, e poco par che ’l pregi” (Inf. XIV, 69-70). Per quanto le situazioni siano diverse o solo parzialmente simili e i motivi variamente appropriati, la memoria del lettore consapevole doveva essere sollecitata verso quei punti esegetici. In ogni caso habuit, nell’esegesi, è tempo incontestabilmente legato a una “translatio” avvenuta. Nella risposta di Dante a Cavalcante, “ebbe” è parola chiave dell’equivoco: il padre di Guido pensa alla morte corporale; Dante pensa alla traslazione del primato, vivente ancora il primo dei suoi amici, nella “gloria de la lingua”. La domanda di Cavalcante – «piangendo disse: “Se per questo cieco / carcere vai per altezza d’ingegno, / mio figlio ov’ è? e perché non è teco?”» (Inf. X, 58-60) – vuole anche dire: ‘perché mio figlio non è come te sesto, cioè della generazione che ha messo fuori le nove rime?’.
Unito alla primitas da Ap 2, 5, l’avere dalla propria parte “auctoritatem et testimonium maiorum et antiquiorum”, da Ap 8, 7, è nella domanda di Farinata – «guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, / mi dimandò: “Chi fuor li maggior tui?”» (Inf. X, 41-42) –, nelle successive parole dopo che l’ubbidiente poeta tutto gli ha aperto in merito – «poi disse: “Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte”» (vv. 46-47; cfr. supra) -, nonché nel riconoscimento della propria arroganza da parte di Omberto – “L’antico sangue e l’opere leggiadre / d’i miei maggior mi fer sì arrogante” (Purg. XI, 61-62).
“Ma i vostri non appreser ben quell’ arte … forse cui Guido vostro ebbe a disdegno” (Inf. X, 51, 63): alla presunzione del primato politico in Farinata, il quale viene a sapere da Dante che i suoi ghibellini non hanno appreso l’arte di rientrare a Firenze, a differenza degli avversari per due volte dispersi che ne sono stati capaci in entrambi i casi, fa seguito la presunzione che alla poesia basti l’“altezza d’ingegno” senza guida.
[1] Secondo il Gorni si tratterebbe di un passaggio da Guittone a Guinizzelli e a Dante, a motivo della “promulgazione postuma di gloria, che relativizza con valore retroattivo la perdita del primato”, fatta a Guinizzelli in Purg. XXVI (GUGLIELMO GORNI, Dante prima della Commedia, Fiesole 2001, pp. 15-42: pp. 31, 34). Si osserva in proposito: a) Guido Cavalcanti non può considerarsi ripudiato o definitivamente escluso dopo essere stato menzionato da Dante, di fronte al padre, per il suo “disdegno” (Inf. X, 63). L’“ombra” di Guido è ben presente a Purg. XXI, 19-24. b) Tra Purg. XI (i due Guidi) e Purg. XXVI (il primato di Arnaut Daniel) c’è una differenza fondamentale: a Purg. XI si parla di traslazione del primato, a Purg. XXVI non di un trasferimento, ma di una falsa opinione, circa il primato poetico (di Guittone o di Giraut de Bornelh rispetto ad Arnaut), ritenuta per vera e che poi si è rivelata erronea. In Purg. XI Cavalcanti ha tolto a Guinizzelli la gloria della lingua (che entrambi i Guidi hanno effettivamente avuto); in Purg. XXVI Guinizzelli dice che questo primato è stato falsamente apposto ad altri (a “quel di Lemosì”, a Guittone). c) Guinizzelli è definito da Dante “il padre / mio e de li altri miei miglior che mai / rime d’amor usar dolci e leggiadre” (Purg. XXVI, 97-99). Corrisponde, per il “dolce stil novo”, ad Adamo, il “padre antico / a cui ciascuna sposa è figlia e nuro” che Dante incontra nel cielo delle stelle fisse (Par. XXVI, 92-93; non sarà casuale che il numero del canto sia il medesimo di quello in cui avviene l’incontro con Guinizzelli). Come “padre”, è il rappresentante delle “nove rime” di Dante nell’Antico Testamento (si fa per dire, perché i tempi sono sempre quelli dell’“uso moderno”). Queste “nove rime” sono già state definite da Bonagiunta da Lucca due canti prima, ponendo una cesura con lo “stilo” precedente: «“O frate, issa vegg’ io”, diss’ elli, “il nodo / che ’l Notaro e Guittone e me ritenne / di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo! / Io veggio ben come le vostre penne / di retro al dittator sen vanno strette, / che de le nostre certo non avvenne”» (Purg. XXIV, 55-60). Tale definitivo riconoscimento poetico è collocato in una ‘zona’ del poema dove i temi del sesto stato della Chiesa, che è stato di novità, sono al sommo della loro metamorfosi parodica. All’illuminazione del sesto stato, sempre presentato come “novum saeculum”, cooperano tutte le illuminazioni precedenti. Così Dante è “sesto tra cotanto senno”, accolto nella schiera dei sommi poeti del Limbo (Inf. IV, 100-102); nel sesto girone del purgatorio, nel colloquio con Bonagiunta da Lucca, è data delle “nove rime” e del “dolce stil novo” un’interpretazione che traspone nei canoni poetici la vita cristiforme, il rendersi simili a Cristo dettatore interiore, il seguirlo fedelmente proprio della sesta chiesa: «E io a lui: “I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro vo significando”» (Purg. XXIV, 52-54). A Filadelfia, la sesta chiesa, è data la porta aperta al parlare per dettato interiore, ma questo ricevere liberamente tutta l’illuminazione precedente avviene dopo una “translatio”, una perdita del primato da parte della quinta chiesa, Sardi, quella che aveva tutte le perfezioni e i doni stellari, ma li ha perduti a seguito della rilassata caduta nei beni mondani (e anche nella filosofia mondana, ritenuta da sola sufficiente). Dunque, quando Bonagiunta parla, questo passaggio alla sesta chiesa si consuma. Due canti più avanti, Guinizzelli non può più neanche accennare a una “translatio”, perché essa è già avvenuta, e non è più tempo. Il poeta bolognese del “fino amor” resta come padre antico delle dolci rime, superato nella “gloria de la lingua” dall’altro Guido, a sua volta superato, o meglio sostituito in vita in un primato presuntuoso nel fare a meno di una guida. Non a caso Guinizzelli si purga nel settimo e ultimo girone della montagna, che è una ‘zona’ dove prevalgono i temi del settimo stato della Chiesa. Questo stato, designato da Laodicea, l’ultima delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione, viene da Cristo invitato a ripensare il primo inizio della creazione di tutte le cose e il primo inizio della formazione della Chiesa e la prima causa. Come ai primi viene rappresentato il giudizio finale, così agli ultimi il primo principio, per insegnarci a stare fissi in entrambi, ad umiliarci nella loro contemplazione, ad infiammarci d’amore per la somma causa e a rendere grazie del nostro inizio e della finale consumazione.
[2] Cfr. GORNI, Dante prima della Commedia, pp. 34-35.
Tab. XI
[LSA, cap. II, Ap 2, 5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Deinde, si non se correxerit, comminatur ei casum totalem dicens (Ap 2, 5): “Sin autem, venio tibi”, id est contra te. Dicit autem “venio”, non ‘veniam’, ut ex imminenti propinquitate sui adventus ipsum fortius terreat. “Et movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi penitentiam egeris”, id est evellam a me et a fide mea in quo es fundata, secundum illud Apostoli Ia ad Corinthios III°: “Fundamentum aliud nemo potest ponere, preter id quod positum est, quod est Christus Ihesus” (1 Cor 3, 11). […]
|
[LSA, cap. III, Ap 3, 11 (VIa ecclesia)] Item sicut soli primo comminatus est translationem sue ecclesie de loco suo, sic soli sexto significat quod, si non perseveraverit, eius corona ad alium transferetur. Cuius mistica ratio est quia sicut primus status habuit primatum respectu totius secundi generalis status mundi, qui ab Apostolo vocatur tempus seu ingressus plenitudinis gentium (Rm 11, 25), sic sextus habebit primatum respectu totius tertii generalis status mundi duraturi usque ad finem seculi. Ne ergo de suo primatu superbiant aut insolescant, quasi non possint ipsum perdere aut quasi alius nequeat substitui eis et fieri eque dignus, insinuatur eis predicta translatio. Secunda ratio est quia uterque eorum substitutus est alteri. Nam gloria que fuerat sinagoge parata et pontificibus suis, si in Christum credidissent, translata fuit ad primitivam ecclesiam et ad pastores eius. Sic etiam gloria parata finali ecclesie quinti status transferetur propter eius adulteria ad electos sexti status, unde et in hoc libro vocatur Babilon meretrix circa initium sexti status dampnanda. Notandum tamen quod per hoc verbum docemur numerum electorum ad complendam fabricam civitatis superne sic esse prefixum quod si unus per suam culpam corruat, alterum oportet substitui ne illa fabrica remaneat incompleta.Purg. XI, 79-84, 88, 94-99, 121-123“Oh!”, diss’ io lui, “non se’ tu Oderisi,
|
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Si vero queratur plenior ratio sui casus vel translationis predicte, potest colligi ex tribus. Primum est inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et primitate, quam scilicet habuit non solum ex hoc quod prima in Christum credidit, nec solum ex hoc quod fideles ex gentibus ipsam honorabant et sequebantur ut magistram et primam, tamquam per eam illuminati in Christo et tracti ad Christum, sed etiam ex gloria suorum patriarcharum et prophe-tarum et divine legis ac cultus legalis longo tempore in ipsa sola fundati. |
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7 (IIIa visio, Ia tuba)] Vel per hoc designatur quod temptationem que simul habet magnam speciem boni et veri, et auctoritatem et testimonium maiorum et antiquiorum et in sapientia famosiorum, et sequelam maioris et quasi totalis partis populi, nullus potest vincere nisi sit in fide et caritate firmus ut terra vel arbor et non fragilis et instabilis et cito arefactibilis sicut fenum. Talis autem fuit temptatio iudaica contra Christum. |
|
|
Purg. XI, 61-66L’antico sangue e l’opere leggiadre
|
|
Inf. X, 40-42, 61-63Com’ io al piè de la sua tomba fui,
|
Purg. XI, 61-66L’antico sangue e l’opere leggiadre
|
Tab. XII
[LSA, prologus, Notabile V (IVus status)] Quia vero intelligentia divinorum parum aut nichil prodest absque vita divina, ideo in quarto statu refulsit celestis vita anachoritarum, et precipue in desertis Arabie et Egipti tali vite congruis. Quia vero infectio humani generis et sue carnis non patitur tam arduam vitam diu in hoc seculo perdurare, casus autem a statu tam arduo gravem ypocrisim et remissionem aut apertam apostasiam inducit. Talis autem casus cum primo lapsu perfidarum heresum dignus est iudicio et exterminio grandi, idcirco circa finem quarti status congrue contra hereticos et ypocritas et remissos supervenit secta sarracenica omnia fere devastans et sibi subiugans.[LSA, ex cap. XI (IVa tuba)] Quia vero de divinorum scientia et gustu sepe quis superbe presumit, et precipue cum ab aliis glorificatur tamquam peritus et sanctus, idcirco contra tertiam partem lucis superbientis et sanctitatis per vanam gloriam in ypocrisim cadentis est quartum tubicinium. Vel quia ex copia mundane scientie et voluptatis oritur magna fama et gloria apud mundanos, ita quod videntur ceteris presidere et superlucere sicut sol et luna et stelle, ideo hanc gloriam percutit et obscurat quartum tubicinium. |
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 4-5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Subdit ergo (Ap 2, 4): “Sed habeo adversum te” (quidam addunt “pauca”, sed non est de textu nisi solum in tertia ecclesia [cfr. Ap 2, 14], non autem hic nec in quarta [cfr. Ap 2, 20]) “quod caritatem tuam primam reliquisti”. Ricardus: «id est, quia te in dilectione Dei et proximi minorasti. Non dicit absolute ‘quod caritatem reliquisti’, sed “quod caritatem primam”, ex quo animadvertere possumus quod in bono quidem fuit minoratus sed non omnino bono evacuatus. In gratia enim accepta nimis secure vixerat et quedam negligenter egerat, et ideo de culmine sue perfectionis ceciderat ad minoratio-nem sue perfectionis. […]»*. […]
|
Purg. XI, 91-101, 121-123Oh vana gloria de l’umane posse!
|
4.3 Divieto di andare senza guida
■Se “Cavalcante parla sempre in forma interrogativa” [1], il suo dubbio si appunta sulla lacrimosa espressione relativa al figlio Guido: «piangendo disse: “Se per questo cieco / carcere vai per altezza d’ingegno, / mio figlio ov’ è? e perché non è teco?”» (Inf. X, 58-60) [2]. A lui, dannato, è appropriato il forte pianto di Giovanni ad Ap 5, 4. Questo pianto, sostiene Olivi, è proprio dei momenti (al tempo degli apostoli, delle grandi eresie e dell’Anticristo) nei quali quanti sono inconsapevoli della ragione che permette le tribolazioni e le “pressure” causate dalle eresie, e il terrore provocato dall’imminenza dei pericoli, piangono e sospirano affinché il libro segnato da sette sigilli venga aperto, almeno per la parte che è consentito aprire in quel tempo. Il pianto di Cavalcante, quasi un lamento femminile [3], si ritroverà nel pianto di Lavinia per la morte suicida della madre Amata, della quale non comprende il motivo (“O regina, / perché per ira hai voluto esser nulla?”, Purg. XVII, 35-36) [4]. Il dubbio inconsapevole si insinuerà più avanti anche nella statuaria effigie di Farinata: “E se tu mai nel dolce mondo regge, / dimmi: perché quel popolo è sì empio / incontr’ a’ miei in ciascuna sua legge?” (Inf. X, 82-84). A differenza di Cavalcante, nel ghibellino non vi sarà pianto, ma solo sospiro dopo la risposta di Dante.
■ Dice piangendo Cavalcante a Dante: “Se per questo cieco / carcere vai per altezza d’ingegno” (Inf. X, 58-59). L’“altezza d’ingegno” trova, nell’esegesi della quinta tromba (Ap 9, 1-2), un esplicito riferimento alla dottrina di Aristotele e di Averroè. L’astro caduto dal cielo sulla terra, al quale fu data la chiave del pozzo dell’abisso, designa i religiosi d’alto ingegno – “[…] quorundam altiorum et doctiorum et novissimorum religiosorum casus […]. Acceperunt enim ingenium […]” – caduti nella filosofia mondana di quei due pensatori, da essi ritenuta sufficiente di per sé all’umana condotta. Questa filosofia, secondo Olivi, oscura invece la sapienza cristiana e la pura aria della vita evangelica con il fumo che esce dal pozzo dell’abisso, una volta che ai suoi seguaci è stato permesso di sciogliere il freno della rigida e severa disciplina imposta dai santi prelati. Dicendo “per altezza d’ingegno”, quasi fosse “una facoltà umana intesa laicamente, in stretta connessione con la capacità dell’espressione poetica” [5], Cavalcante pensa che Dante abbia intrapreso il viaggio con il solo sostegno della filosofia mondana. In questo senso, tra i filosofi mondani che negano la libertà umana rientrano anche gli epicurei, “che l’anima col corpo morta fanno”, puniti fra gli eresiarchi. Essi sostituiscono Aristotele e Averroè, già posti nell’onorata sede del Limbo insieme agli “spiriti magni”. Ma anche per lo Stagirita e il suo grande commentatore l’“altezza d’ingegno” non basta, in un viaggio dalla felicità terrena a quella eterna.
■ L’espressione “Da me stesso non vegno” (v. 61), nella risposta di Dante al padre di Guido, è tessuta con fili tratti da Ap 10, 8. Scrive Giovanni: «Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: “Va’, prendi il libro aperto dalla mano dell’angelo che sta ritto sul mare e sulla terra”. Allora mi avvicinai all’angelo (l’angelo della sesta tromba, che ha la faccia come il sole, che per l’Olivi designa Francesco, come l’angelo del sesto sigillo di Ap 7, 2) e lo pregai di darmi il libro» (Ap 10, 8-9). Secondo Gioacchino da Fiore, l’ordine figurato in Giovanni udrà questa voce “dal cielo”, cioè dalla Sacra Scrittura, perché se non ci fosse altra voce nella Scrittura che lo ordinasse, basterebbe la voce che discende da questo grande cielo, cioè da questo libro aperto; e anche quella che dice la stessa cosa nel terzo capitolo di Ezechiele (Ez 3, 1 sgg.). Quest’ordine andrà dunque dall’angelo con la verità conosciuta e assentirà con reverenza ai nunzi della verità di Dio. Questa voce, sempre secondo Gioacchino, consiste in ogni ispirazione di Dio che incita o accende ad apprendere la sapienza del libro dai sacri dottori designati da questo angelo e in particolare da Cristo. Dio infatti insegnerà loro a non presumere di poter partecipare della sapienza del libro con le proprie forze e senza il magistero di questo angelo.
Il tema del non presumere delle proprie forze venendo da soli e della necessità di una “guida” viene più volte proposto nella Commedia: dal poeta di fronte al padre di Guido Cavalcanti, che gli si è rivolto per la sua “altezza d’ingegno” (Inf. X, 61), oppure nel ricordare quanto visto nell’ottava bolgia, in modo da frenare l’ingegno “perché non corra che virtù nol guidi” (Inf. XXVI, 21-22); da Catone che vuole che si spieghi chi sia stata la guida o la lucerna nell’uscire dalla “valle inferna” (Purg. I, 43-45); dall’angelo portiere del purgatorio che chiede dove sia “la scorta” (Purg. IX, 86; in entrambi i casi, verso Catone e l’angelo, è dovuta reverenza da parte di Dante); nel riconoscimento dell’impossibilità di ridire l’amore visto negli occhi santi di Beatrice se la mente non venga guidata da altri (Par. XVIII, 10-12).
Così avviene nell’avvio del colloquio tra Virgilio e Stazio (Purg. XXI, 21, 28-29). Anzi, all’inizio del canto successivo c’è un esempio di voce che basta a sé stessa, quella dell’angelo che cancella il quinto “P” dalla fronte di Dante e volge al “sesto giro” (qui il numero allude al sesto stato), la quale, dichiarando beati “quei c’hanno a giustizia lor disiro”, non dice tutta la beatitudine secondo Matteo 5, 6 (“Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam”): “e le sue voci / con ‘sitiunt ’, sanz’altro, ciò forniro” (Purg. XXII, 1-6; l’“esuriunt” è riservato alla voce dell’angelo – “esurïendo sempre quanto è giusto”: Purg. XXIV, 154 – udita al termine della pemanenza fra i golosi; sul piano letterale, cioè, Dante scinde nella beatitudine la ‘sete’ e la ‘fame’ di giustizia, applicando la prima agli avari e prodighi, la seconda ai golosi). Già Catone aveva detto a Virgilio: “Ma se donna del ciel ti move e regge … bastisi ben che per lei mi richegge” (Purg. I, 91-93).
■ Tra tanti temi che percorrono i primordi del duetto tra Virgilio e Stazio, se ne scorge in filigrana un altro non secondario. Prima di procedere all’esegesi dell’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12), Olivi ricorda quanto già affermato nei notabilia del prologo, che cioè la vita di Cristo nel sesto e settimo stato verrà glorificata e magnificata con la conversione di tutto il mondo e di tutto Israele. Per attestazione autentica e conferma della Chiesa romana, consta che la regola dei Minori data dal beato Francesco è veramente e propriamente la regola evangelica, quella osservata da Cristo, imposta agli apostoli e scritta nel Vangelo. Ciò consta per inconfutabili testimonianze dei libri scritturali e dei loro espositori. Consta per la testimonianza del santissimo Francesco, confermata dalla sua indicibile santità e da innumerevoli miracoli di Dio, e soprattutto dalle gloriosissime stimmate impresse da Cristo, che dimostrano come egli sia l’angelo che apre il sesto sigillo (Ap 7, 2), il quale ha il segno del Dio vivente, cioè delle piaghe di Cristo crocifisso, e della totale trasformazione e configurazione in lui, secondo una tradizione, chiara e degna di fede, ascoltata dall’Olivi nel 1266 da san Bonaventura predicante a Parigi in modo solenne nel capitolo generale dei Frati minori.
Sullo stesso panno dell’esegesi di Ap 6, 12, dove Olivi dichiara che Francesco è angelo del sesto sigillo, sono ritagliate le parole che designano i “sette P” descritti nella fronte del poeta con la punta della spada dall’angelo portinaio dei sette gironi della montagna. Essi sono “piaghe”, “segni” che rendono il poeta conforme all’angelo che ha il «“signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi”». Non è casuale che, nei versi in cui Virgilio spiega a Stazio che chi porta quei segni “coi buon convien ch’e’ regni”, compaia il verbo ‘imporre’, appropriato a Cloto che “la conocchia … impone a ciascuno e compila”, che cioè, letteralmente, compone e aggiusta sulla rocca la quantità di fibra filata da Lachesi (Purg. XXI, 22-30). La regola evangelica imposta agli apostoli equivale alla vita di Cristo, che deve essere da noi perfettamente imitata e partecipata come fine della nostra vita (prologo, Notabile VII). Anche la parca che “impone” la conocchia della vita, grazie all’esegesi dell’Olivi, diventa ancella di Cristo perché la nostra vita non può essere che trasformazione e configurazione in lui. Da notare l’espressione “venendo sù”, che traspone il tema dell’angelo del sesto sigillo, che sale da Oriente (Ap 7, 2); da confrontare, ancora, i “segni che questi porta” (Purg. XXI, 22-23) con le stimmate che le membra di Francesco “due anni portarno” (Par. XI, 106-108).
Quando Dante scriveva i versi di Purg. XXI, 19-33, aveva in mente una vicenda letterale, l’incontro tra due poeti, uno pagano ma il cui calore giovò, illuminando, alla poesia e alla conversione dell’altro; l’altro cristiano, ma chiuso per tepidezza. Il confronto con la Lectura mostra come Dante avesse in mente anche molti significati spirituali, relativi ai tempi moderni designati dal sesto stato, “novum seculum” per Francesco e il suo Ordine come lo fu l’età di Augusto per il primo avvento di Cristo. Uno di questi significati spirituali risiede nella necessità di una guida, nel non poter far da soli, e ciò congiunge i versi ad altri luoghi del poema, tra i quali ce n’è uno memorabile, la risposta data al padre di Guido Cavalcanti a Inf. X, 61-63: «E io a lui: “Da me stesso non vegno: / colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”». Così, accanto alla lettera e allo spirito, dai versi che narrano l’incontro tra il poeta mantovano e quello “tolosano” emerge la memoria del “primo delli miei amici”: «S’io fosse quelli che d’amor fu degno – se voi siete ombre che Dio sù non degni │E tu, che se’ de l’amoroso regno … riguarda se ’l mi’ spirito ha pesanza: / ch’un prest’ arcier di lui ha fatto segno – E ’l dottor mio: “Se tu riguardi a’ segni / che questi porta e che l’angel profila, / ben vedrai che coi buon convien ch’e’ regni ”». Si tratta della risposta di Cavalcanti al sonetto Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io, il cui andar per mare senza impedimento “al voler vostro e mio” si ritrova nel salire veloce, per libera volontà, ancora di tre: Virgilio, Stazio e Dante. Quello che nel sonetto è “il motivo sentimentale principe del dolce stile in quanto ‘scuola’, cioè a dire la necessità corale dell’amicizia, che non può scompagnarsi dall’amore cortese” [6], si è trasformato nel poema nell’amore fraterno che segna la “renovatio” moderna; il desiderio di evasione diventa anelito a una compiuta libertà dell’arbitrio e della parola che liberamente è “quasi come per sé stessa mossa”. Se “ebbe” segna il punto di una “translatio” nella “gloria de la lingua”, interpretato con disperazione dal padre di Guido nel suo cadere supino [7], l’ombra di Cavalcanti non si dileguerà mai del tutto nel corso del viaggio. La memoria del cominciare delle “nove rime” è ben presente nella zona del poema dove più che in ogni altra prevalgono i temi del sesto stato dell’Olivi, che è stato di novità. È questo solo un modo di interpretare la propria poetica a tanti anni di distanza, oppure anche quell’inizio, apparentemente spontaneo, mischiò le sue acque con il grande fiume della teologia dell’Olivi, lettore della materia a Santa Croce nei tre anni che precedettero la morte di Beatrice?
[1] PETROCCHI, Itinerari danteschi, pp. 290-291.
[2] “Cieco” rinvia alla “cecitas intellectus”, causa per cui il primo sigillo resta chiuso (ad Ap 5, 1). “Carcere” è un tema, dalle molte variazioni, dell’esegesi di Smirne, la seconda chiesa d’Asia (prima visione, Ap 2, 10), come pure lo stare “teco”, che nell’esegesi ha un valore solo confortativo (lo stare di Cristo con la chiesa carcerata, Ap 2, 10). L’essere “cieco” sarebbe dunque da connettere all’“altezza d’ingegno”; l’essere “teco” al “carcere”. In entrambi i casi, Cavalcante equivoca: la ‘guida’ di Dante non è il figlio ‘Guido’, che non sta come Cristo accanto alla chiesa o al vescovo messo in carcere; è Virgilio (il Cristo uomo) che lo porta a Beatrice (lo Spirito di Cristo).
[3] Cfr. AUERBACH, Mimesis, I, pp. 196-197, che propone come modello l’apparizione di Andromaca in Aen. III, 310 sgg.; TANTURLI, Dante poeta fiorentino (su Inf. X), pp. 55-57. L’eco virgiliana è però armata dai temi apocalittici tratti dal commento dell’Olivi, con cui concorda.
[4] Così piange la Roma «vedova e sola, e dì e notte chiama: / “Cesare mio, perché non m’accompagne?”» (Purg. VI, 112-114), nella “pressura / d’i tuoi gentili» (vv. 109-110): l’apostrofe ad Alberto tedesco ripete quattro volte (vv. 106, 109, 112, 115) il “veni et vide” apocalittico detto a Giovanni all’apertura dei primi quattro sigilli (cfr. Ap 6, 11). Anche Virgilio mostra di non comprendere la ragione della ‘pressura’ di Dante nella “diserta piaggia”: “Ma tu perché ritorni a tanta noia?” (Inf. I, 76). Il lutto, proprio di Lavinia, segna anche Aristotele e Platone e molti altri, di cui dice Virgilio, che desiderarono vedere tutto senza frutto, “tai che sarebbe lor disio quetato, / ch’etternalmente è dato lor per lutto” (Purg. III, 34-45); in questo caso il sospiroso desiderio, che fu già dei Padri nel Limbo, di vedere tutto il libro aperto (che solo Cristo, nei suoi tre avventi, avrebbe aperto compiutamente) sostituisce il pianto.
[5] ASOR ROSA, Identità e storia, p. 116.
[6] Cfr. DANTE ALIGHIERI, Rime, a cura di GIANFRANCO CONTINI, Torino 19952, p. 34.
[7] L’undecima perfezione di Cristo sommo pastore consiste nell’imprimere negli inferiori, di fronte a tante sublimità descritte nella perfezione precedente, un sentimento di umiliazione, di tremore e di adorazione, per cui Giovanni dice: «e vedendolo, cioè tanto e tale, “caddi ai suoi piedi come morto”» (Ap 1, 17). Bisogna intendere che cadde col viso a terra in atto di adorazione, perché il cadere supino è segno di disperazione. Il cadere di Dante, venuto meno per la pietà dopo aver udito il discorso di Francesca – “E caddi come corpo morto cade” (Inf. V, 142) – non è però disperato (la “mente”, chiusa per la pietà e confusa di tristezza per il peccato, torna poi alla ragione), non come quello del padre di Guido Cavalcanti, che “supin ricadde e più non parve fora” di fronte all’indugiare della risposta di Dante alla domanda se il proprio figlio sia ancora in vita (Inf. X, 72).
Tab. XIII
[LSA, cap. IX, Ap 9, 1-2 (IIIa visio, Va tuba)] “Et data est <illi> clavis putei abissi, et aperuit puteum abissi” (Ap 9, 1-2), id est data est eis potestas aperiendi ipsum. Puteus abissi habet infernalem flammam et fumositatem obscuram et profunditatem voraginosam et quasi immensam et societatem demoniacam. Aperire ergo puteum abissi in populo quinti status fuit perverso exemplo et malo regimine solvere frenum carnalis concupiscentie et avaritie et terrene astutie et malitie et secularis lacivie ac demoniace seu pompose superbie, quod quidem frenum erat prius in ecclesia tam per Dei et suorum preceptorum ac iudiciorum timorem quam per sanctorum prelatorum disciplinam rigidam et severam ad se et suos subditos fortiter infrenandos, et etiam per sancte societatis exemplum et zelum nequeuntem in se vel in sociis tolerare enormitates et effrenationes predictas. Fuit autem prelatis in predicta gradatim ruentibus data seu permissa potestas aperiendi puteum cordium ad concipiendum et effundendum mala predicta, tum quia malum quod a prelatis geritur facile trahitur a subditis in exemplum et sequuntur ipsum ut caput et ducem, tum quia prelatis non solum dissimulantibus et negligentibus mala subditorum corripere et punire sed etiam favorem prebentibus hiis qui peccant, grex subditorum de se pronus ad malum cito labitur et tandem precipitatur; tum quia ob huiusmodi culpam prelatorum Deus permisit subditos temptari et a demonibus instigari et tandem ruere. […]
|
|
Inf. X, 58-59, 61piangendo disse: “Se per questo cieco
|
Inf. XXVI, 19-24Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio
|
[LSA, cap. X, Ap 10, 8.11; IIIa visio, VIa tuba] Sequitur (Ap 10, 8): “Et vox”, supple facta est, vel sonuit secundum Ricardum, “quam audivi de celo iterum loquentem mecum et dicentem: Vade, et accipe librum apertum de manu angeli stantis supra mare et super terram. (Ap 10, 9) Et abii ad angelum dicens ei ut daret michi librum”. Secundum Ioachim, iste ordo qui signatur in Iohanne auditurus est hanc vocem “de celo”, id est de scriptura sacra, quia si nusquam esset alia vox in scriptura sacra que hoc preciperet, sufficeret ista vox que de isto celo magno, id est de hoc libro aperto, descendit, et etiam illa que hoc ipsum dicit in Ezechiele, scilicet capitulo tertio (Ez 3, 1ss.). Ibit autem ordo iste ad angelum cum agnita veritate, de nuntiis veritatis Dei reverenter assentiet eis. Potest etiam dici quod ista vox est omnis inspiratio Dei eos instigans et accendens ut sapientiam libri addiscant a doctoribus sacris per hunc angelum designatis et potissime a Christo. Docebit enim eos Deus non presumere ex propriis viribus et absque huius angeli ministerio posse participare sapientiam libri. […] Sequitur: (Ap 10, 11) “Et dixit michi: Oportet te iterum prophetare in gentibus et populis et linguis et regibus multis”. In ipsa sapientia libri expresse continetur quod oportet iterum predicari evangelium in toto orbe, et Iudeis et gentibus, et totum orbem finaliter converti ad Christum. Sed quod per istum hoc esset implendum non poterat sciri nisi per spiritualem revelationem, et hoc dico prout per Iohannem designantur hic singulares persone quia, prout per ipsum designatur in communi ordo evangelicus et contemplativus, scitur ex ipsa intelligentia libri quod per illum ordinem debet hoc impleri. |
|
Tab. XIV
[LSA, cap. X, Ap 10, 8-9 (IIIa visio, VIa tuba)] Sequitur (Ap 10, 8): “Et vox”, supple facta est, vel sonuit secundum Ricardum*, “quam audivi de celo iterum loquentem mecum et dicentem: Vade, et accipe librum apertum de manu angeli stantis supra mare et super terram. (Ap 10, 9) Et abii ad angelum dicens ei ut daret michi librum”. Secundum Ioachim, iste ordo qui signatur in Iohanne auditurus est hanc vocem “de celo”, id est de scriptura sacra, quia si nusquam esset alia vox in scriptura sacra que hoc preciperet, sufficeret ista vox que de isto celo magno, id est de hoc libro aperto, descendit, et etiam illa que hoc ipsum dicit in Ezechiele, scilicet capitulo tertio (Ez 3, 1ss.). Ibit autem ordo iste ad angelum cum agnita veritate, de nuntiis veritatis Dei reverenter assentiet eis*.
|
||
Purg. I, 43-45, 49-54, 91-93Chi v’ha guidati, o che vi fu lucerna,
|
Inf. XXVI, 19-22Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio
|
|
Tab. XV
Rime, 9 [LII]Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
|
Guido Cavalcanti, XXXVIII [xxxix]S’io fosse quelli che d’amor fu degno,
|
Purg. XXI, 16-33, 58-69Poi cominciò: “Nel beato concilio
|
[LSA, prologus, Notabile VII] Secunda (ratio) est eius singularis et exemplaris vita, quam apostolis imposuit et in se ipso exemplavit et in libris evangelicis sollempniter scribi fecit. Huius autem vite perfecta imitatio et participatio est et debet esse finis totius nostre actionis et vite.[LSA, cap. VI, Ap 6, 12 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Ad evidentiam autem huius sexte apertionis est primo ad memoriam reducendum quod supra in principio est in tredecim notabilibus prenotatum, et specialiter illa in quibus est monstratum quia vita Christi erat in sexto et septimo statu ecclesie singulariter glorificanda et in finali consumatione ecclesie et in omnis Israelis ac totius orbis conversione magnificanda. Ex quo igitur, per romane ecclesie autenticam testificationem et confirmationem, constat regulam Minorum, per beatum Franciscum editam, esse vere et proprie illam evangelicam quam Christus in se ipso servavit et apostolis imposuit et in evangeliis suis conscribi fecit, et nichilominus constat hoc per irrefragabilia testimonia librorum evangelicorum et ceterarum scripturarum sanctarum et per sanctos expositores earum, prout alibi est superhabunde monstratum, constat etiam hoc per indubitabile testimonium sanctissimi Francisci ineffabili sanctitate et innumeris Dei miraculis confirmatum. Et precipue gloriosissimis stigmatibus sibi a Christo impressis patet ipsum fore angelum apertionis sexti signaculi “habentem signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi, et etiam signum totalis transformationis et configurationis ipsius ad Christum et in Christum. Et hoc ipsum per claram et fide dignam revelationem est habitum, prout a fratre Bonaventura, sollempnissimo sacre theologie magistro ac nostri ordinis quondam generali ministro, fuit Parisius in fratrum minorum capitulo me audiente sollempniter predicatum. |
||
4.4 Il cammino verso la beatitudine
Gioacchino da Fiore, secondo Olivi che lo cita ad Ap 12, 6, fonda tutto il suo libro della Concordia sull’espressione “un tempo, (due) tempi e la metà di un tempo” (tre anni e mezzo, espressione che propriamente si trova ad Ap 12, 14, al momento della terza e della quarta guerra sostenuta dalla Chiesa; ad Ap 12, 6 sono citati i 1260 giorni/anni, un periodo di tempo equivalente nel quale la donna, fuggita dal serpente, rimane nel deserto dei Gentili). Il lettore, afferma l’abate calabrese, deve pensare a queste parole, dette, oltre che nell’Apocalisse, anche nella profezia di Daniele, come a quelle che racchiudono in breve quanto esposto in modo diffuso nel corso della Concordia, che altro non ha inteso far conoscere se non ciò che questo versetto suona: “fra un tempo, (due) tempi e la metà di un tempo si compiranno tutte queste cose meravigliose” (Dn 12, 6-7). I tre anni e mezzo, formati da 42 mesi di 30 anni ciascuno, per complessivi 1260 anni, corrispondono alle quarantadue generazioni sulla base delle quali procede la Concordia di Gioacchino. Il passo di Daniele 12, 6-7 – nel quale l’uomo vestito di lino, che sta sulle acque del fiume, alza la destra e la sinistra al cielo e giura per colui che vive in eterno – ha stretta connessione con l’angelo della sesta tromba apocalittica, il quale alza la destra verso il cielo e giura con veemente certezza e affermazione che il tempo di questo mondo finirà del tutto nel momento in cui l’angelo della settima tromba farà udire la sua voce (Ap 10, 5-7). Inoltre, a Daniele 7, 25 si dice che il re undicesimo distruggerà i santi dell’Altissimo che gli saranno dati in mano “per un tempo, (due) tempi e la metà di un tempo”.
Una difficoltà, rileva Olivi, proviene dal fatto che nella profezia di Daniele è detto poco dopo (Dn 12, 11-12) che “dal tempo in cui sarà tolto il sacrificio perpetuo e sarà eretto l’abominio della desolazione ci saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e perviene a 1335 giorni”. Siamo pertanto di fronte a tre numeri per indicare la fine del tempo di questo mondo: 1260, 1290, 1335.
I numeri di Daniele, osserva Olivi, possono essere considerati in due modi. Secondo il primo modo, essi designano il tempo della Chiesa che va dalla morte di Cristo, o dalla fuga della Chiesa dalla Giudea e dalla sua desolazione abominevole, fino al grande Anticristo e al beato silenzio che seguirà la sua morte e alla piena conversione di Israele e di tutto il mondo nell’apertura del settimo sigillo. Questo periodo può essere computato in tre modi. Preso senza le “minutie temporum”, senza cioè le frazioni di tempo che vengono ogni anno trascurate nel calcolo, sono 1260 anni. Se si aggiungono le “minutie”, computate con un mese di 30 giorni (che sono in realtà anni), si arriva a 1290. Per questo alcuni credono che l’Anticristo verrà al più tardi 1290 anni dopo la morte di Cristo, ma Olivi ritiene che ciò sia tutt’altro che sicuro, dovendosi dimostrare che il numero, come termina con precisione con l’Anticristo, altrettanto precisamente cominci dalla morte di Cristo: sarà l’evidenza dei fatti a provare questa tesi o quella opposta.
L’aggiunta di 45 giorni (anni) al secondo numero – il 1290 – conduce al 1335, cioè al giubileo di pace e di grazia del settimo stato, e pertanto in Daniele 12, 12 viene chiamato “beato chi aspetta” chi con fervida fede, speranza e carità perviene ad esso.
Un secondo modo di considerare i numeri di Daniele li fa cominciare con la persecuzione dell’Anticristo, che durerà tre anni e mezzo (secondo Daniele 7, 25), e questi coincideranno sia con 1260 sia con 1290. Il periodo di tempo considerato ha infatti differenti inizi e conseguentemente differenti conclusioni, e ciò avviene, secondo l’opinione di alcuni, per accecare i reprobi e per tentare ed esercitare gli eletti. Così nei Vangeli gli anni della predicazione di Cristo vengono fatti iniziare talvolta dalla predicazione di Giovanni Battista, talvolta dalla sua incarcerazione e talvolta dal battesimo.
■ Il passo di Daniele 12, 11-12 – “dal tempo in cui sarà tolto il sacrificio perpetuo e sarà eretto l’abominio della desolazione ci saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e perviene a 1335 giorni” -, come ha dimostrato Guglielmo Gorni [1], è ben conosciuto all’autore della Vita Nova. Il quale, dopo aver perduto la sua Beatrice, va lacrimando “in questa desolata cittade” e scrive ai principi della terra introducendo la lettera con il tema tratto dalle Lamentazioni del profeta Geremia: “Quomodo sedet sola civitas” (Vita Nova, 19.8 [XXX 1]). Beatrice, nata nel 1266 e morta l’8 giugno 1290, si colloca tra due numeri mistici presenti nella profezia di Daniele. Non solo il 1290, continua il Gorni, è anno-chiave, ma anche il 1335: Dante, infatti, nato nel 1265, sarebbe nel 1335 arrivato a settant’anni, ossia alla beatitudine, dopo aver effettuato il suo viaggio ultraterreno, nel 1300, a trentacinque anni (la metà di settanta che segna il colmo dell’arco della vita umana, come affermato in Convivio IV, xxiv, 3).
Si può aggiungere che anche la “mirabile visione” apparsa al poeta e sulla quale si chiude la Vita Nova (31.1-2 [XLII 1-2]) risente della profezia di Daniele: come al profeta viene detto di nascondere e sigillare fino al tempo della fine le parole dette dall’uomo che era sulle acque del fiume e che con le mani alzate aveva giurato per colui che vive in eterno che le cose mirabili si compiranno fra “un tempo, (due) tempi e la metà di un tempo”, così il poeta intende tacere la “mirabile visione, nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedecta infino a tanto che io potessi più degnamente tractare di lei”.
Passando dalla Vita Nova alla Commedia, per la quale il confronto non è col solo testo biblico ma con la sua esegesi offerta dalla Lectura, il passo di Daniele 12, 11-12, proposto nel contesto gioachimita citato ad Ap 12, 6, conduce a Inf. X, 61-63, alla celebre risposta data da Dante a Cavalcante che gli ha chiesto piangendo perché Guido, suo figlio, non sia con lui: «E io a lui: “Da me stesso non vegno: / colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”». Nella terzina si trova l’accostamento del “beatus qui <ex>spectat ” di Daniele con il “perducere ad iubileum pacis et gratie septimi status” dell’esegesi, che corrisponde al 1335 (cfr., a Purg. VII, 62, menane, detto da Virgilio a Sordello, esattamente sul secondo verso della 21a terzina come il mi mena detto a Cavalcante; attenderemo, detto da Sordello, è al v. 69).
Il tema si ritrova una volta terminato l’episodio di Farinata, allorché Dante volge i passi verso l’antico poeta, ripensando smarrito al parlar nemico del ghibellino che gli ha profetizzato l’esilio. Virgilio lo rincuora invitandolo a conservare nella mente quanto udito e poi gli dice: «“e ora attendi qui”, e drizzò ’l dito: / “quando sarai dinanzi al dolce raggio / di quella il cui bell’occhio tutto vede, / da lei saprai di tua vita il vïaggio”» (Inf. X, 129-132). L’attendere stavolta è appropriato a Dante, nel significato di fare attenzione alle parole che Virgilio sta per pronunciare, ed è accostato alla beatitudine (“di quella”, cioè di Beatrice). Nei versi sono presenti anche temi da Ap 1, 3, dove si tratta della causa finale del libro dell’Apocalisse, che è appunto la beatitudine, e si dice: “Beatus qui legit … qui audit … et servat ea”. Per cui Virgilio premette, rivolgendosi al discepolo: “La mente tua conservi quel ch’udito / hai contra te” (Inf. X, 127-128), cioè “quel parlar che mi parea nemico” di Farinata nel profetizzare l’esilio. Altro esempio di variazione consequenziale di questo gruppo tematico è il ‘serbare’ alle chiose di Beatrice quanto narrato al poeta sul proprio destino da Brunetto Latini: la donna saprà spiegare la profezia dell’infallibile conseguimento del glorioso porto insieme a quanto oscuramente dettogli da Farinata sul peso dell’arte del rientrare in patria (Inf. XV, 88-90).
A Purg. XVIII, 46-48 c’è un’altra variazione del tema profetico: Virgilio, prima di spiegare il rapporto tra amore e libero arbitrio, precisa che la sua esposizione è fatta secondo ragione; per quello che è materia di fede, dice al discepolo, “t’aspetta pur a Beatrice”. Si tratta di un’espressione che traduce, torcendolo ad altro senso quasi hysteron proteron interiore, il “beatus qui spectat ” di Daniele. Come spiega Olivi, “beato” può venire definito solo chi con fervida fede si sforza di raggiungere la meta.
Alle “minutie temporum” da aggiungere o meno al 1260, fa riferimento la “centesma ch’è là giù negletta”, nel parlare di Beatrice sulla “fortuna che tanto s’aspetta” (il soccorso divino) a Par. XXVII, 142-148.
■ Sul “disdegno” di Guido [2] sono da considerare i seguenti punti:
a) Le parole di Dante – “Da me stesso non vegno” – ripetono l’esegesi di Ap 10, 8 circa la reverenza con cui Giovanni e l’Ordine da lui impersonato (che può corrispondere anche a delle “singulares persone”) si recano dall’angelo per prendere il libro. Non possono infatti presumere di poter partecipare alla sapienza del libro con le proprie forze e senza il magistero di questo angelo. Si tratta di un tema che ritorna in vari luoghi del poema e in particolare a Purg. XXI, 28-30. Ivi, alla mente di Dante che descrive la salita veloce in tre (Virgilio, Stazio e lui stesso), è ben presente il sonetto Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io; ma ora al posto di Guido sta Virgilio, il quale sa bene che da soli, senza guida, non si può salire. Il “disdegno” di Guido fu nei confronti di una guida (cui), che renda partecipe la sapienza mondana (“per altezza d’ingegno”) di una storia sacra che procede verso una nuova era terrena ordinata “ad inmortalem felicitatem” (cfr. Monarchia, III, xv, 17-18). In tale storia si è inserito Virgilio, la cui Eneide è diventata anch’essa Scrittura antica da concordare con la nuova.
b) La guida conduce a Beatrice, come mostra l’accostamento, nell’esegesi, dell’attendere e della beatitudine: “colui ch’attende là (Virgilio, “qui spectat”), per qui mi mena (“videtur perducere”) / forse cui (“ad iubileum pacis et gratie septimi status”, cioè ad beatitudinem, che è la causa finale dell’Apocalisse) Guido vostro ebbe a disdegno”. Il “forse” (‘come spero’) è nel senso per cui Dante dirà a Brunetto Latini: “a donna che saprà, s’a lei arrivo” (Inf. XV, 90). Nell’esegesi l’essere beato è infatti condizionale: “ne credatur quod qui absque spe et caritate pertingit ad finem illorum dierum seu annorum sit beatus”.
c) Secondo un principio costante, i temi esegetici sono separati e variamente attribuiti nei versi. La stessa esegesi di Daniele 12, 11-12 è, in Inf. X, diffusa sia ai vv. 61-63 come ai vv. 129-132. In modo simmetrico, ma in un diverso contesto, Purg. XVIII registra il nome di Beatrice senza l’ausilio di pronomi (vv. 47-48; 73-75).
d) “Ebbe” è tratto da un contesto (l’istruzione data a Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia, ad Ap 2, 5) in cui non si fa riferimento a una morte corporale, come equivoca il padre di Guido, ma a una traslazione del primato (nel caso, del primato poetico di mettere fuori le “nove rime”, corrispondenti all’età dello Spirito che si apre con il sesto stato, apertura prossima che a Cavalcante non è concesso di vedere, come a Zaccaria, il padre di Giovanni, di dire di Cristo). Questa traslazione a Dante, taciuta in Inf. X, è palesemente confermata da Oderisi da Gubbio in Purg. XI, canto per molti aspetti simmetrico a Inf. X. Alla stessa esegesi di Ap 2, 5 appartiene il “disdegno” di Guido, assimilato alla superba presunzione della Sinagoga o della Chiesa “ex circumcisione” di Gerusalemme, e quindi di Efeso stessa, minacciata di traslazione del suo primato metropolitano.
e) Il “disdegno” di Guido Cavalcanti è stato dunque verso una guida che conduce alla beatitudine, nel poema rispettivamente impersonate da Virgilio e Beatrice. Virgilio, causa prossima, parla di Beatrice come causa finale, per cui dirà al discepolo nel momento di riprendere la strada: “quando sarai dinanzi al dolce raggio / di quella il cui bell’ occhio tutto vede, / da lei saprai di tua vita il vïaggio” (Inf. X, 130-132).
Virgilio e Beatrice sono due ‘figure’ storiche della stessa persona, cioè di Cristo, nella sua umanità e nella sua divinità. Il poeta pagano è assimilato alla voce esteriore propria del Cristo uomo, preparazione di quella interiore dello Spirito, espressa da Beatrice, che subentra nell’Eden. Come poté il “disdegno” di Guido Cavalcanti esercitarsi solo contro Virgilio, cioè contro l’umanità di Cristo e non anche contro la sua divinità? Beatrice rappresenta il gusto e il sentimento dell’amore, appropriato allo Spirito Santo. Mossa da amore, fa muovere Virgilio alla salvezza del suo amico: “Or movi, e con la tua parola ornata … l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata … amor mi mosse, che mi fa parlare” (Inf. II, 67-72; Ap 2, 7). Virgilio e Beatrice operano entrambi per mezzo della “locutio”, cioè della favella, il primo con la “parola ornata”, la seconda con il parlare dettato da amore che suggerisce all’altro ciò che debba fare. E come nella Chiesa, peregrinante in terra, del settimo e ultimo stato non ci sarà più bisogno delle dottrine precedenti, poiché nell’eccesso della contemplazione lo Spirito di Cristo le insegnerà ogni verità senza l’ausilio della voce esteriore e, denudata di quanto è temporale, adorerà Dio Padre in spirito e verità (cfr. Giovanni 4, 24), così la “voce esteriore” di Virgilio, all’apparire di Beatrice, sparisce (Purg. XXX, 49-51).
Virgilio rappresenta la ragione umana (“Quanto ragion qui vede, dir ti poss’ io”, Purg. XVIII, 46-47), ma bisogna precisare che si tratta della ragione vittoriosa sull’esperienza sensibile e fondata sull’etica, cioè sull’innato libero arbitrio di cui si accorsero “color che ragionando andaro al fondo” (vv. 67-69). Egli partecipa dunque anche della “lux simplicis intelligentie”, che designa Cristo in quanto verbale sapienza del Padre. Ma qui il poeta pagano è, in più, guida, e il criptico calembour, “per qui mi mena … Guido vostro”, allude a una sostituzione. Se Virgilio riassume la razionalità degli Antichi, è però anche uomo del sesto stato e lo percorre insieme a Dante nella salita della montagna, tirocinio della vita evangelica e spirituale. Virgilio è l’alta tragedia che ha ascoltato nel Limbo Beatrice dall’angelica voce “soave e piana” e dagli occhi lucenti e lacrimanti, cioè la Scrittura, “sermo humilis” e precetto divino che illumina e purga. Gli “alti versi” si sono fatti anch’essi Scrittura, ‘figura’ della sacra pagina. Il “disdegno” di Guido (e l’oggetto del dissidio con Dante) non oppone unicamente l’amore irrazionale cantato in Donna me prega a quello frenato dal libero arbitrio, secondo la dottrina di Virgilio in Purg. XVIII: è anche un “disdegno” verso un’idea di poesia che concorda con la sacra pagina e con la sua esposizione secondo una precisa teologia della storia che fa capo all’Olivi.
f) Il fatto che nella Commedia Dante parli delle sue “nove rime” nell’incontro con Bonagiunta da Lucca, in una zona del poema dove prevalgono i temi, per eccellenza oliviani, del sesto stato, che è stato di novità, induce a credere che l’incontro virtuale con il frate, già morto, sulla via dell’esilio (che avvenne, probabilmente per il tramite di Ubertino da Casale, fra il 1306 e il 1308) fosse stato preceduto da altro reale a Santa Croce, proprio negli anni antecedenti la morte di Beatrice (1290) in cui l’Olivi vi insegnò (1287-1289). L’esegesi di Olivi, fondata sull’interiorità per cui Cristo, interno dettatore, muove nei predicatori la volontà al parlare, suggerendo le parole che aprano alla conversione i cuori degli ascoltatori, è singolarmente coincidente con la poetica delle “nove rime” di Dante, dettate “dentro” da Amore e significate con la lingua “quasi come per sé stessa mossa” (cfr. Purg. XXIV, 52-54; Vita Nova, 10.13 [XIX 2]) [3].
[1] GUGLIELMO GORNI, Lettera Nome Numero. L’ordine delle cose in Dante, Bologna 1990, pp. 126-127.
[2] Sulla questione cfr. ENRICO MALATO, Dante e Guido Cavalcanti. Il dissidio per la Vita Nuova e il «disdegno di Guido», Roma 1997 (Quaderni di «Filologia e critica», XI), secondo il quale “converrà …, restando alla lettera del testo e a quella che è stata riconosciuta come la più ovvia interpretazione, tornare all’ipotesi Virgilio” (p. 93); il “disdegno” è per Beatrice in CHIAVACCI LEONARDI, Inf. X, 63 (p. 330), per il duca in INGLESE, Inf. X, 61-63 (p. 133).
[3] Si può notare che i primi 1335 versi del poema arrivano a Inf. X, 120, dove termina l’episodio di Farinata e inizia quello del tornare smarrito di Dante verso Virgilio: se poi si conta non dal primo verso del poema ma dal decimo, escludendo le prime tre terzine introduttive, si perviene a Inf. X, 129, cioè proprio sulla soglia della terzina che contiene il tema di Daniele, applicato dal poeta alla donna meta del suo viaggio.
Se i versi dei primi nove canti del Purgatorio, fino alla porta, assommano a 1260 (lo stesso numero si consegue se si sostituiscono gli ultimi 13 versi di Purg. IX con gli ultimi 13 versi di Inf. XXXIV, che descrivono la salita “a riveder le stelle”), contando 1335 versi a partire dall’inizio del canto IX (che si apre con l’immagine dell’Aurora che si imbianca, corrispondente all’aurora del terzo stato generale del mondo) si perviene a Purg. XVIII, 39, verso con cui termina la spiegazione data da Virgilio della dottrina d’amore. Con il verso 40 inizia l’esposizione del rapporto tra amore e libero arbitrio che contiene, dopo nove versi (terzo della terza terzina), il nome della donna che Dante deve “aspettare”. È da ricordare che Singleton considerava i versi di Purg. XVIII, 40-75 (al v. 73 è di nuovo citata Beatrice) il centro mistico di tutto il poema [Ch. S. Singleton, Il numero del poeta al centro, in La poesia della Divina Commedia, trad. it., Bologna 1978 (1965), pp. 451-462].
L’aspettare e la beatitudine sono ancora motivi contenuti nelle ultime parole pronunciate da Virgilio, che sanciscono la piena libertà dell’arbitrio del discepolo il quale, nell’attesa di Beatrice – “mentre che vegnan lieti li occhi belli / che, lagrimando, a te venir mi fenno” – non deve più aspettare parola o cenno del maestro (Purg. XXVII, 136-142).
All’imbrunire del primo giorno di permanenza nel purgatorio, Sordello è invitato da Virgilio a ‘guidare’ lui e Dante lì (nella valletta dei principi), dove si ‘attende’ il nuovo giorno (Purg. VII, 62, 69; da notare la variata simmetria con Inf. X, 62: “menane … per qui mi mena / e là il novo giorno attenderemo … colui ch’attende là”). Nella sesta età del mondo, che comincia con il primo avvento di Cristo, la Chiesa si forma prima tra i Giudei ma poi, a causa della loro durezza e ostinazione, si rivolge ai Gentili. Inizia così quel tempo che san Paolo chiama della “pienezza delle Genti” (Rm 11, 25-26), che si concluderà nel sesto stato con la conversione delle reliquie delle Genti e poi dei Giudei, che per ultimi si volgeranno a Cristo. Secondo il disegno divino, la conversione di Israele deve essere preceduta da quella delle Genti. Ciò trova corrispondenza nell’esegesi di Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra), dove si dice che la donna (la Chiesa), il cui figlio era stato rapito (Cristo risorto e asceso al cielo), “fuggì in solitudine”. Per “solitudine” si intende la terra dei Gentili, che allora era deserta, priva cioè di Dio e del suo culto, nella quale la Chiesa si rifugiò dall’ostinata incredulità e dalla persecuzione dei Giudei. Con ciò viene pure designata la vita spirituale e celeste alla quale fuggì e ascese la Chiesa dopo aver ricevuto con abbondanza lo Spirito Santo, affinché potesse attendere a nutrirsi di sole cose divine nascondendosi e difendendosi dalle tentazioni diaboliche. La donna trova così nel deserto dei Gentili, della fede e della contemplazione cristiana “il luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni”. Il suo è un pasto spirituale, con il quale incorpora i Gentili nella fede. La durata temporale di questo nutrirsi nel deserto viene riproposta, sempre nella quarta visione, al momento della terza e quarta guerra (che sono riunite in un’unica trattazione), allorché viene detto che alla donna furono date due ali della grande aquila, per volare nel deserto per esservi nutrita “per un tempo, tempi e la metà di un tempo” cioè per tre anni e mezzo (Ap 12, 14; “tempo” equivale ad “anno”, “tempi” a due anni), ovvero per 1260 anni, computando i giorni come anni (30 giorni al mese x 42 mesi).
La montagna del Purgatorio possiede le caratteristiche del “deserto” della gentilità. L’aggettivo “gentile” vi ricorre sette volte (più la forma sostantivata a Purg. VI, 110), contro quattro occorrenze nell’Inferno e nessuna nel Paradiso (se si esclude l’altra forma sostantivata a Par. XX, 104). Dante vi rimane tre giorni e mezzo (la seconda cantica si chiude al meriggio del quarto giorno), ossia un periodo di tempo corrispondente ai 1260 anni della permanenza della donna nel deserto. Essa è “lito diserto, / che mai non vide navicar sue acque / omo, che di tornar sia poscia esperto” (Purg. I, 130-132). A quel lido finì il viaggio dell’eroe greco: “quando n’apparve una montagna, bruna / per la distanza” (Inf. XXVI, 133-134). Ulisse volle sperimentare con i sensi il “mondo sanza gente”. La terra proibita alla ragione umana – la sapienza di questo mondo che la croce avrebbe dimostrato stolta – non era solo quella senza abitanti, era figura della terra che sarebbe stata data alle Genti, luogo della loro conversione alla Chiesa di Cristo.
L’episodio di Cavalcante è incastonato tra due parti dell’episodio di Farinata. Esso consta di 21 versi, e se si considerano i 21 versi che lo precedono e i 21 che lo seguono si ottengono tre blocchi: il primo (vv. 31-51) va dal momento in cui Dante vede Farinata – «Ed el mi disse: “Volgiti! Che fai? / Vedi là Farinata che s’è dritto”» alla risposta data dal poeta alle sdegnose parole del ghibellino sui suoi ‘maggiori’; il secondo (vv. 52-72) riguarda solo Cavalcante; il terzo (vv. 73-93) si apre con la persistente immutabilità del magnanimo Farinata e si chiude col suo sospirare e muovere il capo ricordando la solitaria difesa a viso aperto di Firenze. La somma dei versi relativi ai tre blocchi è 63, che, secondo Gioacchino da Fiore citato da Olivi ad Ap 12, 6, è il numero delle generazioni che vanno da Adamo a Cristo, divise in tre gruppi di 21: «Et secundum hoc subdit quod in prima distinctione, que extenditur ab Adam usque ad Isaac, intermittende sunt due generationes ultime, ut in secunda distinctione sumatur initium ab Abraam usque ad Christum. Vocat autem ibi primam distinctionem respectu trine distinctionis sexaginta trium generationum que sunt ab Adam usque ad Christum, quarum quelibet habet viginti unam». E in effetti dietro le ultime tre terzine del terzo gruppo compare, quasi in filigrana, l’immagine di Cristo: il ricordo della strage di Montaperti è assimilato al sacrificio del Figlio di Dio, il muovere il capo sospirando che rompe l’immobilità iniziale di Farinata è qualcosa di nuovo che spezza la durezza lapidea del vecchio, l’aver difeso la propria città “a viso aperto” fa per un attimo assurgere il ghibellino ai segnati di Cristo, ai quali nel sesto stato sarà data la costante e magnanima libertà di difendere pubblicamente la sua fede.
Tab. XVI
[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio)] Notandum autem quod Ioachim totum librum suum Concordie Veteris et Novi Testamenti fundavit super numero hic posito. Unde libro V° Concordie, circa finem pertractans verba illa angeli dicta Danieli, quod “in tempus et tempora et dimidium temporis” erit “finis horum mirabilium” (Dn 12, 6-7), dicit: «Verba hec Danielis ita a lectore huius operis pensari debere vellem, ut quicquid a principio huius operis usque huc late et diffuse contulimus sub uno quam brevi coart<ar>emus sermone. Nichil enim aliud nos intimasse credimus, nisi hoc quod sonat versiculus iste: ‘in tempus et tempora et dimidium temporis omnium istorum mirabilium esse finem’. Quia sicut iam per multas vices nos dixisse meminimus, in hiis quadraginta duabus generationibus septem signacula continentur, nichilque aliud est dicere “in tempus et tempora et dimidium temporis” complebuntur quam illud quod, sub sexto angelo tuba canente, alter angelus aut forte unus et idem ait: “tempus iam non erit amplius, sed in voce septimi angeli, cum ceperit tuba canere” (Ap 10, 6-7)»*. […]
|
|
[segue Ap 12, 6] Additio vero quadraginta quinque dierum, id est annorum, que cum superiori numero facit mille trecentos triginta quinque, videtur perducere ad iubileum pacis et gratie septimi status, et ideo dicit beatum esse qui cum fervida fide et spe pertingit ad ipsum. Ideo enim premisit (Dn 12, 12): “Beatus qui spectat”, ne credatur quod qui absque spe et caritate pertingit ad finem illorum dierum seu annorum sit beatus.
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 3] Ostensa igitur causa formali et effectiva et materiali, subdit de causa finali, que est beatitudo per doctrine huius libri intelligentiam et observantiam obtinenda. Unde subdit (Ap 1, 3): “Beatus qui legit” et cetera. Quantum ad ea que proprio visu vel per propriam investigationem addiscimus, dicit: “qui legit”; quantum vero ad ea que per auditum et alterius eruditionem addiscimus, dicit: “qui audit”. Primum etiam magis spectat ad litteratos vel ad doctores, qui aliis legunt et exponunt ; secundum vero ad laicos vel auditores. Quia vero ad salutem non sufficit solum addiscere vel scire, nisi serventur in affectu et opere, ideo subdit: “et servat ea”. Quedam enim ibi scribuntur ut a nobis agenda, quedam vero ut credenda et speranda vel metuenda, et sic omnia sunt a nobis servanda vel agendo illa vel credendo ea cum caritate et spe vel timore. Quod autem talis beatus sit, nunc in spe et merito et tandem cito in premio, ostendit subdens: “Tempus enim”, scilicet future retributionis, “prope est”, quasi dicat: observans cito remunerabitur, et non observans cito dampnabitur, et ideo quoad utrumque beatus est qui hec observat. |
Inf. X, 61-63, 127-132E io a lui: “Da me stesso non vegno:
|
Purg. VII, 61-63, 67-69Allora il mio segnor, quasi ammirando,
|
5. Farinata: l’uomo (X, 73-93)
Ora noi vogliamo assistere al più magnifico spettacolo a cui l’umanità possa essere invitata: vogliamo vedere questo concetto moversi, animarsi, prender carne, divenire una forma. E quando lo vedremo lì, dirimpetto a noi, compiutamente realizzato, potremo dire: – Ecco l’uomo! -.FRANCESCO DE SANCTIS[Il Farinata di Dante, p. 331] |
Ma quell’ altro magnanimo. La magnanimità ha nella Lectura una doppia accezione, negativa e positiva. Il primo senso è proposto ad Ap 13, 5: si tratta del ‘loqui magna’, del parlare con superba audacia contro Cristo e i suoi da parte della bestia che sale dal mare, alla quale viene dato il potere di nuocere per quarantadue mesi, di fare guerra contro i santi e di vincerli. Questo tipo di magnanimità si addice al “parlar nemico” di Farinata nel profetizzare a Dante che non passeranno cinquanta pleniluni perché possa sperimentare la difficoltà di rientrare a Firenze (è apparente inimicizia, assimilata alla passione del Figlio di Dio: Ap 5, 1). Ap 13, 5-6 – “Et datum est ei os loquens magna et blasphemias […] Et aperuit os suum in blasphemias ad Deum, blasphemare nomen eius” – è d’altronde un luogo servente (in collazione con altri luoghi), nell’Antenora, il blasfemo Bocca degli Abati (Inf. XXXII, 85-86, 106) e, ancor prima, nella nona bolgia, “Curïo, ch’a dir fu così ardito” (Inf. XXVIII, 102). Il Farinata che “s’ergea col petto e con la fronte / com’avesse l’inferno a gran dispitto”, che alza le ciglia all’udire dei ‘maggiori’ di Dante, partecipa di questo tipo di magnanimità. Ma la sua bocca è, per così dire, a doppio taglio.
Il secondo senso, proposto ad Ap 7, 3, consiste nella libertà data ai segnati sulla fronte, all’apertura del sesto sigillo, di difendere la fede fino al martirio, per essere ascritti con nome e con pregio all’alta milizia di Cristo. Un pregio attribuito anche a Farinata, il magnanimo difensore “a viso aperto” di Firenze dalla distruzione (Inf. X, 91-93). È la stessa libertà di parlare per virtù dell’interno dettatore che sta a fondamento delle “nove rime” dantesche.
“Magnanimo” compare solo due volte nel poema, riferito a Virgilio e a Farinata. Nel primo caso (Inf. II, 44-45) è presente, nel contesto, unitamente alla “viltade” di Dante e, più avanti, all’amicizia di Beatrice per cui egli è uscito dalla “volgare schiera” (vv. 61, 104-105); nel secondo caso (Inf. X, 73) è unito alla “fronte” e al difendere: temi, non tutti ovviamente accostabili per il comune sentire del linguaggio, presenti anche nell’esegesi della “signatio” ad Ap 7, 3.
Le due ombre ‘magnanime’, di Virgilio e di Farinata, non lo sono sotto lo stesso rispetto. Sulla prima, in un senso completamente positivo, si può richiamare l’aristotelico “colui che si reputa degno di grandi cose, essendone definitivamente degno” [1], un concetto “assunto da Dante – come da Tommaso d’Aquino – all’interno del suo universo cristiano, dove è centrale il sentimento della dignità e grandezza dell’uomo, ma fondata su Dio” [2]. La seconda ombra passa invece da una magnanimità negativa ad una positiva. In entrambi i casi l’essere magnanimo è legato al parlare. Virgilio, che contrappone la propria alla parola di Dante offesa da viltà, parla di Beatrice, come è da lui scesa, come è stata mossa; lo stesso parlare di Virgilio, ornato e onesto, è mosso da Beatrice. La magnanimità del fiero ghibellino non è solo insensibile al dolore altrui (di Cavalcante) o al proprio (il tormento per l’esilio dei suoi) [3], consiste soprattutto nella libertà di parlare difendendo Firenze “a sua posta”.
a cui posta / restato m’era. Il confronto è con l’esegesi di Ap 1, 4, dove si toccano i “sette spiriti che stanno dinanzi al suo trono”. Si precisa trattarsi dello Spirito increato, semplice per natura e settiforme per grazia nei suoi doni, radice e forma esemplare dei sette stati della Chiesa che costituiscono l’oggetto principale dell’Apocalisse. Viene detto che i sette spiriti sono dinanzi al trono perché fanno stare nel cospetto di Dio e della sua sede coloro i quali ne sono pieni, secondo le parole di san Paolo ai Romani (Rm 8, 26): “è lo stesso Spirito che postula per noi”, perché ci fa domandare.
Purg. XXX inizia allorché i sette candelabri, che aprono la processione nell’Eden, si fermano. Essi sono definiti “il settentrïon del primo cielo, / che né occaso mai seppe né orto”, cioè l’Orsa dell’Empireo che, come l’Orsa terrestre (cfr. Par. XIII, 7-9), non viene mai meno e segna il cammino da percorrere. I sette candelabri designano i sette doni dello Spirito increato, che non ha principio né fine. Il “settentrion” rende ciascuno consapevole di quello che debba fare e, fermandosi, fa in modo che i ventiquattro seniori che lo seguono si volgano al carro (il carro-Chiesa militante tirato dal grifone-Cristo). I seniori si volgono al carro “come a sua pace”, e uno di loro invoca (cioè ‘postula’ per dettato interiore dello Spirito) l’arrivo di Beatrice cantando tre volte “Veni, sponsa, de Libano”, seguito da tutti gli altri. Nel canto precedente, “posta” e “sosta” sono in rima attribuiti a Dante intento a vedere meglio i sette candelabri (Purg. XXIX, 70-72).
Spirito, stare (fermo, immobile), postulare (cioè parlare per dettato interiore): dalla collazione di Ap 1, 4 con Ap 4, 3 (immutabilità di Dio giudice nella sua sede) e con Ap 8, 3 (immutabile stare della divinità di Cristo) gli elementi semantici si travasano nei versi con le più singolari variazioni (lo ‘stare’, di per sé, si può arricchire di altri temi come lo ‘stare fisso’, cfr. Ap 3, 12).
Vi è un libero parlare del poeta ai tre sodomiti fiorentini – “felice te se sì parli a tua posta!” (Inf. XVI, 81) -, che è sì da intendere “in senso politico”, un rivolgersi senza rispetti umani nei confronti dei propri cittadini [4], ma che è un dire per dettato interiore dello Spirito che fa postulare e regge, nel senso paolino, il timone dell’umana virtù [5]. Più giù, nella nona bolgia, c’è uno spirito (Geri del Bello) sul quale lo sguardo del poeta è “sì a posta” (in quanto la sua uccisione non è stata vendicata), ma che Virgilio fa distogliere non concedendo “lo star”. L’unità degli elementi: stare (fermarsi)-spirito-postulare (cioè parlare, come Dante vorrebbe fare) è in questo caso rotta (Inf. XXIX, 13-21). Ancor più giù, l’“ultima posta” infernale è anche l’ultimo luogo dove un dannato (frate Alberigo) parli, prima che l’ombre siano tutte coperte dal ghiaccio (Inf. XXXIII, 111). Che ‘posta’ sia un termine venatorio (cfr. Inf. XIII, 113; XXII, 148) non fa venir meno i riferimenti ad Ap 1, 4 [6]; i singoli luoghi devono poi essere inquadrati nell’esegesi della zona dove si collocano.
Lo Spirito, come l’Orsa, rende accorti di ciò che si debba fare, fa stare e domandare. L’invito di Farinata – “piacciati di restare in questo loco”, fatto dal “magnanimo, a cui posta / restato m’era” (Inf. X, 24, 73-74) -, è anch’esso mosso dallo Spirito di Cristo. Per quanto possa apparire dissonante e dissacrante in un dannato, conserva qualcosa di quanto Beatrice ha detto di sé a Virgilio – “amor mi mosse, che mi fa parlare” (Inf. II, 72).
non mutò aspetto. Nella seconda visione apocalittica, Dio Padre appariva a Giovanni sotto forma di un re che siede sul trono (Ap 4, 3). La descrizione è quella del momento precedente l’apertura dei sette sigilli da parte di Cristo, desiderata con tanti pianti e sospiri dagli antichi Padri. La sede designa, in primo luogo, l’altissimo “stare” dell’essenza divina nella quale e per la quale Dio sussiste nella sua maestà. L’“aspetto” di colui che siede sul trono è simile a pietra di diaspro e di cornalina, cioè di colore verde e rosso sangue (Ap 4, 3). Si dice che Dio è simile a una pietra poiché per sua natura è fermo e immutabile, solido e stabile nella giustizia, tutto governa e stabilisce con la potenza infrangibile della propria virtù. Il diaspro è di colore verde come l’erba, e rappresenta l’immarcescibile verdeggiare di Dio, assai dilettevole e grazioso agli eletti. La cornalina è rossa sia per la carità e la pietà verso gli eletti come per l’ira e l’odio verso i reprobi. L’arrossare di Dio, inoltre, è perché per noi volle e fece il Figlio colorato nel rosso del suo sangue. I due colori della veste di Beatrice (oltre al bianco del velo) che appare nell’Eden corrispondono al verde diaspro e alla rossa cornalina dell’aspetto di Colui che siede sul trono: “sotto verde manto / vestita di color di fiamma viva” (Purg. XXX, 32-33).
Il tema della potenza infrangibile della virtù di Dio Padre e giudice, dall’aspetto immutabile – dove risuona quell’“esistenza immutabile” di cui scriveva Auerbach citando le Lezioni di Estetica di Hegel – [7], si trasforma nell’immagine del magnanimo Farinata il quale, alla disperazione di Cavalcante che crede morto il figlio, “non mutò aspetto, / né mosse collo, né piegò sua costa” (Inf. X, 73-75). Ad Ap 8, 3, lo “stare” immobile dinanzi all’altare, cioè a Cristo uomo al quale si offrono preghiere affinché preghi il Padre, ripete il tema, proprio di Ap 4, 3, della stabilità di Dio che siede sul trono da cui regge e giudica, simile nell’aspetto a una pietra di diaspro e di cornalina. La collazione di Ap 4, 3 con Ap 8, 3 (passi entrambi collegati dalla chiave dell’immutabilità) consente di far rientrare anche il participio “restato”, cioè l’essersi Dante fermato a richiesta del ghibellino, nell’infrangibile corazza del verso: “a cui posta / restato m’era, non mutò aspetto”. Pregare e stare, dal medesimo panno esegetico, sono in tutt’altra appropriazione ai vv. 116-117.
né mosse collo. Muovere ciò che è duro e immutabile è proprio del terremoto. Il termine ricorre più volte nell’Apocalisse (8, 5; 11, 13.19; 16, 18). Ad Ap 8, 5 (‘radice’ della terza visione) la sequenza folgore-voce-tuono-terremoto significa che l’ascolto dell’eloquio folgorante, alto (proprio del tuono) e discreto (proprio della ‘voce’, moderata e razionale, come quella umana) dei dottori muove i cuori degli uomini alla penitenza e alla conversione a Cristo, per cui mutano la precedente vita, scossi da un forte terremoto interiore. La menzionata sequenza viene riferita all’infuocata predicazione di Cristo, che causò un grande terremoto in tutta la Giudea, tanto da provocare l’accusa di commuovere il popolo fatta dai prìncipi dei sacerdoti (Luca 23, 5).
Un grande terremoto si verifica dopo la resurrezione e l’ascesa al cielo dei due testimoni (Elia ed Enoch) che sembravano essere stati uccisi dall’Anticristo (Ap 11, 13). Anche in questo caso vengono scossi i cuori di coloro che vedono o ascoltano, con la conseguenza che alcuni si rimproverano per la propria incredulità, altri invece si disperano e divengono deteriori tanto da rovinare e da far cadere molti dalla vera fede. La città, la cui decima parte cade per il terremoto, è pertanto la santa Chiesa, della quale, come si dice in Daniele, rovinano alcune persone esperte (Dn 11, 35), e molto più rovinano laici e imperiti, e per questo si aggiunge, a designarne il gran numero, che “nel terremoto vennero uccisi i nomi di più di settemila uomini”, in quanto un’innumerevole moltitudine di laici che si pensava cristiana nel nome e che comunemente si riteneva ferma nella fede, presa in mezzo alla gente esperta che precipita, viene estinta dalla fede. E forse cadrà allora la parte più solenne della città, come il campidoglio o il tempio o il palazzo dell’Anticristo, e i seguaci della sua setta di peggiore nomea, designati con i settemila uomini, saranno uccisi nel terremoto.
All’inizio della quarta visione, quando viene aperto il tempio di Dio in cielo e si vede l’arca al suo interno, è riproposta la sequenza presente nella ‘radice’ della terza visione (Ap 8, 5), con la variante della grandine in luogo del tuono (Ap 11, 19). Il terremoto designa, come altrove, un forte scuotimento con commozione dei cuori terreni alla penitenza e mutazione in uno stato migliore.
Di un altro terremoto tratta il preambolo alla sesta visione, che concerne la caduta di Babylon (Ap 16, 18). Esso avviene dopo che il settimo angelo ha versato la coppa nell’aria (Ap 16, 17) ed è preceduto dai consueti “fulgura, voces et tonitrua”. Si tratta di un grande terremoto, “di cui non vi era mai stato l’uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra”. In quanto si verifica nel sesto tempo della Chiesa, il terremoto è quello proprio dell’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12). Esso può essere anche riferito alla fine del mondo, nell’imminenza del giudizio estremo. Come premessa alla caduta di Babylon che avviene nel sesto tempo, coincide con lo sconvolgimento per cui, con l’Anticristo mistico, tutta la Chiesa carnale sarà accecata e commossa contro lo spirito evangelico di Cristo. Designa anche lo sconvolgimento che verrà successivamente recato dal venire sopra di essa dei dieci re con i loro eserciti (Ap 17, 12.16). La conseguenza è la divisione della città: “La grande città si divise in tre parti” (Ap 16, 19), che stanno ad indicare, tra l’altro, le discordie e le divisioni intestine.
Quando nell’Apocalisse si parla di “terremoto” (Ap 8, 5; 11, 13.19; 16, 18), l’esegesi dell’Olivi insiste sullo sconvolgimento operato nei cuori, sul mutamento di vita verso uno stato migliore, sulla conversione a Cristo: “mota sunt corda hominum ad compunctionem, et mutata vita priori conversi sunt ad Christum … ‘Commovet populum docens per universam Iudeam’ (Luca 23, 5) … magnus terremotus, id est magna concussio cordium hec videntium vel audientium … fortis concussio et commotio terrenorum cordium ad penitentiam et ad immutationem status in melius. … stupenda immutatio totius seculi … maxima commotio electorum ad spiritum Christi et per spiritum Christi”. Si noterà quanto intensamente le parole-chiave, ‘signacula’ che rinviano al ‘terremoto’ anche senza citarlo, siano presenti nel poema collocati nelle situazioni e con le modalità più varie.
■ Un forte terremoto, accompagnato dalla folgore, il cui ricordo bagna ancora di sudore la mente, si verifica al momento del passaggio dell’Acheronte: il poeta è vinto in ciascun sentimento, e cade “come l’uom cui sonno piglia” (Inf. III, 130-136). Il motivo del tuono, cui è applicato lo scuotersi proprio del terremoto, segna il risveglio (Inf. IV, 1-3). Il tema del sonno appartiene al quinto stato, al torpore rimproverato alla chiesa di Sardi, il cui vescovo è tanto intorpidito dall’ozio da non ricordare più il primo stato di grazia e di perfezione (Ap 3, 3). È la situazione di Dante tanto pieno di sonno al momento di abbandonare la verace via da non saper ripetere come fosse entrato nella selva oscura la cui immagine, tuttavia, ritornandogli alla memoria, rinnova la paura (Inf. I, 4-6, 10-12). Al suono della sesta tromba, l’angelo che ha la faccia come il sole ruggisce come un leone per risvegliare dal sonno della morte alla vita della fede, dopo di che i sette tuoni fanno udire le loro voci (Ap 10, 3). Da notare l’espressione “Finito questo” (Inf. III, 130), che introduce i versi relativi al terremoto, formula che “suona stranamente incerta e approssimativa” (Sapegno). Non solo vuole dire: ‘appena Virgilio ebbe concluso il suo discorso’; essa è probabilmente da ricondurre ad Ap 11, 7 (sesta tromba), allorché i due testimoni, Elia ed Enoch, “finita la loro testimonianza”, vengono vinti dalla bestia che sale dall’abisso e uccisi. Ma ciò avverrà solo secondo l’umana apparenza, perché i due risorgeranno dopo tre giorni e mezzo per ascendere al cielo, mentre il grande terremoto descritto ad Ap 11, 13 farà perire settemila nemici e farà sì che gli altri, presi da terrore, rendano gloria al Dio del cielo convertendosi. Sia nei versi come nel testo apocalittico c’è una certa conseguenzialità tra il finire, l’esser vinti in apparenza e il terremoto, per cui il passaggio (non descritto) dell’Acheronte sarebbe un apparente morire, dopo la testimonianza resa dai due poeti di fronte a Caronte [8].
■ Al terremoto verificatosi al momento della morte di Cristo fa riferimento Virgilio spiegando l’origine della rovina infernale che consente di discendere verso il Flegetonte (Inf. XII, 37-45). Poco prima che Cristo venisse al Limbo per rapire a Lucifero gran preda d’anime – dice il poeta pagano – l’inferno “tremò sì, ch’i’ pensai che l’universo / sentisse amor, per lo quale è chi creda / più volte il mondo in caòsso converso”. Virgilio allude alla dottrina di Empedocle, cui si oppone Aristotele nella Metafisica, secondo la quale l’ordine dell’universo risulterebbe dalla discordia degli elementi: ove questa cessasse subentrando la concordia, ne deriverebbe un ritorno al caos originario. È proprio questo l’effetto, descritto ad Ap 6, 8 (apertura del quarto sigillo) della setta saracena la quale, assimilata alla morte e all’abisso, aggregando a sé l’universo e tutte le altre sette degli erranti, terrà ferma, come in un grande caos, la voragine degli articoli di fede opposti alla fede cristiana. Il terremoto, di cui dice Virgilio, storicamente è quello che segue la morte del Redentore; nell’esegesi corrisponde a quello descritto ad Ap 8, 5, riferibile all’infuocata predicazione di Cristo per tutta la Giudea (è da notare la ‘conversione’ causata dal terremoto, che nei versi è appropriata al ritorno al caos).
■ Se il gigante Fialte si agita come una torre scossa da un forte terremoto (Inf. XXXI, 106-108), è un terremoto interiore quello che provoca il parlare nelle fiamme che fasciano Ulisse e Guido da Montefeltro (Inf. XXVI, 85-87; XXVII, 15, 63).
■ Nel quinto girone del purgatorio un forte terremoto scuote la montagna (Purg. XX, 127-141). Stazio, che accompagna Virgilio e Dante a partire dal passaggio fra il quinto ed il sesto girone, spiega che il tremare avviene quando un’anima purgante si sente monda da poter salire al cielo. Così è avvenuto per lui stesso, che si è sentito “tutto libero a mutar convento”, scosso da un terremoto interiore e mutato ad uno stato migliore: “E io, che son giaciuto a questa doglia / cinquecent’ anni e più (è la durata del quinto stato), pur mo sentii / libera volontà di miglior soglia” (Purg. XXI, 58-72). Questo terremoto si presenta testualmente con le caratteristiche di quello che apre il sesto sigillo (Ap 6, 12) ed è spiegato da Stazio con motivi propri del sesto stato, come il sentire libera la volontà di salire e di parlare; la rimozione dell’impedimento a salire anticipa il ricordo, nell’incontro con Bonagiunta, dell’inizio delle “nove rime” avvenuto per dettato interiore. Ma il grande terremoto in apertura del sesto sigillo reca anche sovvertimenti politici (nell’esegesi si tratta sempre del regime ecclesiastico, che Dante rovescia sull’intero mondo umano), designati dal muoversi delle isole e dei monti, di quanto cioè sembrava più stabile in mare e in terra. Questa tematica viene applicata ad eventi inopinati come il Vespro siciliano o la cattività avignonese. Per cui il terremoto che scuote la montagna della purgazione, maggiore di quello che scosse l’isola di Delo al momento della nascita di Apollo e Diana, è anche allusione alla caduta del regno di Francia (Ap 13, 18). Mutar vita in meglio (nel senso di passare all’altra) è proprio di Forese (Purg. XXIII, 76-78) e di Beatrice (Purg. XXX, 124-126).
■ In altri luoghi si mostrano gli effetti del terremoto – non nominato – che commuove interiormente: Beatrice quieta “l’animo commosso” di Dante appena asceso al cielo e lo invita a ‘scuotere’ il suo falso immaginare di essere ancora in terra (Par. I, 85-90). Nel cielo di Saturno (Par. XXI, 136-142; XXII, 1-18) il poeta è “mosso” dal grido degli spiriti contemplanti che hanno confermato l’invettiva di Pier Damiani contro i moderni prelati, e Beatrice spiega a lui, “oppresso di stupore”, che ancor più lo avrebbe “trasmutato” (la “stupenda immutatio” di Ap 16, 18) il canto dei beati o il suo sorriso: il tema del terremoto si accompagna a quello della folgore (il ridere della donna), delle voci (il canto), del tuono (il grido degli spiriti, che vince il poeta come un tuono). Il grido sono le preghiere affinché Dio esegua la vendetta contro Babylon.
■ All’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12-17), se da una parte il terremoto si accompagna al muoversi dei monti e delle isole, sovvertendo quanto di più stabile potesse credersi, d’altra parte gli stessi monti, le pietre, i sassi e i colli, interpretati come i santi sublimi e fermi nella fede, si fanno pietosi e condiscendenti verso quanti, presi dal terrore, ad essi fuggono: “Tunc incipient dicere montibus: Cadite super nos, et collibus: Cooperite nos” (Luca, 23, 30). L’esegesi subisce nel poema molte metamorfosi: nella roccia discoscesa che dà via verso il Flegetonte, o nei margini di pietra che fan via sotto la pioggia di fuoco o nel drammatico passaggio dalla quinta alla sesta bolgia, agevolato dalla “pendente roccia”, o ancora nell’insperato rovinoso sasso che consente di montare verso la settima o nel passaggio analogico ‘colle che cade’-‘collo che si muove’, per cui muovere il collo indica una rottura della durezza iniziale (cfr. Inf. XXIII, 43-44, 53-54: “e giù dal collo de la ripa dura / supin si diede a la pendente roccia … ch’e’ furon in sul colle / sovresso noi”) [9]. Farinata, nella sua “esistenza immutabile”, ancor non si muove: “né mosse collo”.
né piegò sua costa. Il ‘piegare’ e la “costa” sono temi del quinto stato, e alludono al pietoso condiscendere verso gli inferiori o gli infermi, o comunque a un rompersi dello “stare”. Il quinto stato è infatti il momento della pia condescensione che frange l’ardua e ripida altezza dello stato precedente dei contemplativi anacoreti. Nel Notabile VII del prologo si recano gli esempi di Cristo che condiscese agli infermi e di Adamo al quale venne sottratta una forte “costa” (simbolo della solitudine austera degli anacoreti del quarto stato), che Dio nel creare Eva riempì di pietas. Più volte nel poema la “costa” della ripa infernale, o della montagna del purgatorio, che giace o che è corta o che cala o che pende, si abbina allo “scendere” in modo da far via in giù o in su, indicando la rottura della solitaria arditezza, del luogo “alpestro” a vantaggio del condiscendere pietoso, del dar via.
e sé continüando al primo detto. Beatrice, starà “ferma” sulla sponda sinistra del carro nel momento di rimproverare Dante (cioè di giudicarlo, Purg. XXX, 100-101), al modo dello stare “firmus et immutabilis et in sua iustitia solidus et stabilis” di Dio nella sua sede (Ap 4, 3). Stesso atteggiamento di Farinata (“non mutò aspetto, / né mosse collo, né piegò sua costa”), e anche stesso modo di parlare: “e sé continüando al primo detto … continüò come colui che dice … ricominciò, seguendo sanza cunta” (Inf. X, 76; Purg. XXX, 71; XXXI, 4), specchio del parlare di Cristo che viene al giudizio ad Ap 22, 10-11: “Et continuat se ad immediate premissum”.
“S’elli han quell’ arte”, disse, “male appresa, / ciò mi tormenta più che questo letto”. Si tratta del “lectus doloris” di cui ad Ap 2, 22 (una variante, senza far risuonare il motivo del ‘letto’, è l’inferma e dolorante Firenze a Purg. VI, 149-151).
Ma non cinquanta volte fia raccesa / la faccia de la donna che qui regge, che tu saprai quanto quell’ arte pesa. Sviluppo rovesciato del tema, da Ap 12, 1-2, della donna vestita di sole che tiene la luna (in questo caso Proserpina) sotto i piedi.
E se tu mai nel dolce mondo regge, / dimmi: perché quel popolo è sì empio / incontr’ a’ miei in ciascuna sua legge? Sul “perché” cfr. supra. Il ricordo della strage di Montaperti, dice il poeta, “tal orazion fa far nel nostro tempio”, cioè lo zelo contro gli Uberti non è ingiusto, ma santo in quanto ‘proviene dal tempio’. L’orazione a Cristo da parte dei santi affinché tolga dalla terra gli “empi” viene figurata ad Ap 14, 15 con l’angelo che esce dal tempio, il quale grida all’altro seduto sulla nube di mietere. Ad Ap 14, 17 un altro angelo esce dal tempio per far vendemmia dei reprobi, e ciò significa che proviene dalla contemplazione e dall’orazione santissima e celeste, che cioè la sua severità non può attribuirsi a un’ira ingiusta. Questa esegesi è già stata utlizzata in occasione dell’agnizione di Farinata. La tabella mostra le variazioni sul tema dello zelo.
Ond’ io a lui: “Lo strazio e ’l grande scempio / che fece l’Arbia colorata in rosso, / tal orazion fa far nel nostro tempio”. Se il Farinata ‘di diaspro’ esprime i disegni provvidenziali sul destino di Dante, un dubitoso “perché” insinua l’altra qualità della sede divina (Ap 4, 3). La volontà del Padre che fece il Figlio di color rosso col sangue versato per la nostra salvezza – “Rubet etiam in eo quod voluit et fecit suum Filium pro nobis sanguine rubificari” – è parodiato nel verso “che fece l’Arbia colorata in rosso”, riferito a “lo strazio e ’l grande scempio” della battaglia di Montaperti. Se il tanto sangue sparso fa ricordare il sacrificio del Figlio di Dio, lo strazio e lo scempio sono temi appropriati nell’esegesi di Ap 17, 3 alla bestia scarlatta su cui siede la prostituta, tinta di color sangue per la strage un tempo dei martiri e ora degli uomini spirituali (cfr., ad Ap 16, 4, l’acqua della fede, designata da fiumi e fonti, che si fa sangue per le eresie).
Di fronte al “muro” della fiamma che lo separa dalla sommità della montagna, la “durezza” di Dante si apre al nome di Beatrice, “come al nome di Tisbe aperse il ciglio / Piramo in su la morte, e riguardolla” (Purg. XXVII, 34-42). Dante, per il timore della fiamma, sta “pur fermo e duro”, con la stessa immobilità di Farinata; il suo aprirsi “udendo il nome / che ne la mente sempre mi rampolla” è anche apertura del “libro della vita” (Ap 20, 12), memoria del sangue sparso, della donna che gli apparve morta “con quelle vestimenta sanguigne colle quali apparve prima agli occhi miei”, facendolo pentire del vile desiderio generato dalla Donna Gentile o Pietosa (Vita Nova, 28.1 [XXXIX 1]). Non è parentesi erudita, come voleva il Tommaseo, il verso “allor che ’l gelso diventò vermiglio”, o “nota di colore” (Sapegno); è segno figurale del sacrificio di Cristo, di cui Beatrice fu imitatrice, per cui Dio “voluit et fecit suum Filium pro nobis sanguine rubificari” (Ap 4, 3). La stessa esegesi fa da velo sacro allo “strazio” di Montaperti e all’albero che mantiene per sempre i “signa caedis” ovidiani (Met. IV, 55-166) a memoria del lutto e del doppio sangue di Piramo e Tisbe.
Poi ch’ebbe sospirando il capo mosso. Alla risposta del poeta, che la causa dell’esilio perpetuo degli Uberti è la memoria del sangue sparso a Montaperti, Farinata, fino allora immutabile nell’aspetto e immobile nella figura, sospirando [1o] muove il capo. Subisce quasi un terremoto interiore, come nel crollarsi de “lo maggior corno de la fiamma antica” che invola lo schivo Ulisse, segno che la novità del sesto stato, al quale è dato di parlare liberamente per adesione della volontà a Cristo interno dettatore, rompe la durezza della vecchia roccia infernale. È il momento nuovo, tanto caro a De Sanctis, che spezza la lapidea durezza del vecchio, in cui la passione terrena trasforma la statua in uomo e gli apre il libro della memoria, ricordandogli il suo muovere contro Firenze con gli altri non senza ragione, quasi ministro della giustizia divina, e la sua solitaria difesa a viso aperto della città contro tutti, che per un attimo lo fa assurgere ai segnati di Cristo, ai quali nel sesto stato, all’apertura del sesto sigillo, è data la costante e magnanima libertà di difendere pubblicamente la fede (Ap 7, 3).
“A ciò non fu’ io sol”, disse, “né certo / sanza cagion con li altri sarei mosso”. Capopopolo e capitano d’arte, nella parodia Farinata assume la veste di vescovo di una chiesa detentrice di un primato solo temporaneo e soggetto a “translatio”. Ad Ap 2, 1 si dice che i sette vescovi d’Asia vengono lodati, rimproverati o istruiti non solo per sé ma anche per le chiese cui sovraintendono. Ciò è reso evidente sia dall’espressione, che si applica a ogni chiesa e non è rivolta solo ai vescovi, “chi ha orecchio ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese” (Ap 2, 7), sia dal fatto che nella quinta chiesa si eccettuino pochi nomi di buoni (Ap 3, 4), sia dal rivolgersi alla quarta chiesa – “dico questo a voi e agli altri che siete di Tiàtira” (Ap 2, 24) -, sia dal fatto che la pena del trasferimento del candelabro minacciata al primo vescovo, di Efeso, cioè di passare ad altra chiesa il primato, riguarda tanto il vescovo quanto la chiesa che partecipa della colpa attribuita al suo primate (Ap 2, 5). Il tema della compartecipazione della chiesa con il vescovo, che non è il solo a operare il bene o il male, è nelle parole di Farinata a Dante che gli ha spiegato come le spietate leggi fiorentine contro gli Uberti siano conseguenza del ricordo della strage di Montaperti, “lo strazio e ’l grande scempio / che fece l’Arbia colorata in rosso”: non fu solo lui, capo della parte ghibellina, a muovere, lo fece con gli altri. Non fu un muovere senza ragione, e in questo il magnanimo recita il tema che ad Ap 16, 1 è proprio degli angeli ministri del giudizio divino, che si muovono all’esecuzione del proprio ufficio di versare le coppe, per punire o purgare, non per propria volontà o animosità ma per compiere un mandato superiore (Inf. X, 88-90), come nel caso di Cesare, che si mosse “per voler di Roma” (Par. VI, 55-57).
In precedenza, il tema si trova nelle parole di Ciacco, che non è la sola “anima trista” ad essere fiaccata dalla pioggia, “ché tutte queste a simil pena stanno / per simil colpa”, espressione probabilmente memore della bestia ottava di Ap 17, 11, la quale “similter peccat et similiter punietur” come le altre sette (Inf. VI, 55-57; cfr. Inf. IX, 130-131: “Simile qui con simile è sepolto”). Una variazione del tema è in Ugo Capeto, che tra gli avari e prodighi purganti non è il solo a dire del bene, cioè degli esempi virtuosi ripetuti nel girone durante il giorno (Purg. XX, 121-123).
Ma fu’ io solo. “Soli pauci electi tunc servabuntur”, come Noè nell’arca, a salvare il seme della fede, nel caso Firenze, la futura patria di Dante (Ap 3, 10).
là dove sofferto / fu per ciascun di tòrre via Fiorenza. Il verbo “tòrre via” è variante dell’“evellere”, che esprime minaccia di traslazione del primato fatta a Efeso, superba prima chiesa d’Asia (Ap 2, 5; cfr., a Purg. XI, 97-98, “così ha tolto l’uno a l’altro Guido / la gloria de la lingua”); “là dove sofferto / fu” è parodia della pazienza nel tollerare il male con il cuore in pace (terzo motivo di lode per il vescovo di Efeso, ad Ap 2, 3).
colui che la difesi a viso aperto. A lui, per la sua magnanima fronte aperta, fu data la difesa di Firenze, quasi fosse la verità evangelica, contro quanti a Empoli, dopo la vittoria di Montaperti, ne avrebbero voluto la distruzione. Firenze, anche se “nido di malizia tanta”, era pur sempre il luogo dove cinque anni dopo sarebbe nato Dante, pianta in cui rivive “la sementa santa” dei Romani, come dice Brunetto Latini. Salvando Firenze col suo “meritorio atto d’amor patrio” [11], Farinata ha salvato il seme della fede.
Deh, se riposi mai vostra semenza. L’auspicio per la discendenza del magnanimo ghibellino – “Deh, se riposi mai vostra semenza” – ripete il tema con cui ad Ap 14, 13 inizia la settima parte della quarta visione, riferito a quanti muoiono nella fede e nella carità di Dio: “Da ora in poi, dice lo Spirito, riposino dalle loro fatiche”, cioè dalla passata tribolazione, per cui gli Uberti sono esclusi, come il poeta stesso, da Firenze. Dopo il momento sesto cristiforme, del difensore “a viso aperto” di Firenze, subentra la pace in terra del settimo stato, impossibile per Manente, ma non per i suoi ancor vivi. Ogni stato, cioè ogni momento della storia umana e dei singoli individui, ha un suo aspetto ‘sesto’, cioè dello stato più cristiforme e aperto al parlare quasi per moto interiormente dettato; ha anche un suo risvolto ‘settimo’, cioè di pace silente nel patire. Francesca aveva parlato “mentre che ’l vento, come fa, ci tace”; a Farinata il poeta dice: “Deh, se riposi mai vostra semenza”.
prega’ io lui, “solvetemi quel nodo / che qui ha ’nviluppata mia sentenza”. Il pianto di Giovanni (Ap 5, 4: “Et ego flebam multum”) designa i momenti nei quali i santi, inconsapevoli della causa che permette le tribolazioni (le ‘pressure’), piangono e sospirano affinché il libro venga aperto, almeno per la parte che è consentito aprire in quel tempo. Tre sono in particolare i periodi interessati (Ap 5, 5): il tempo degli apostoli, prima della discesa dello Spirito Santo; quello delle eresie (in particolare l’ariana) e quello dell’Anticristo, o che precede di poco l’apertura del sesto sigillo. In quest’ultimo periodo gli eletti patiranno un tale aggrovigliarsi delle coscienze da essere indotti nell’errore. Così Gregorio Magno (la cui autorità, come nel passo del “certamen dubitationis” del Notabile X del prologo, è addotta da Olivi a testimone degli insidiosi ultimi tempi), commentando il passo di Giobbe 40, 12, “Nervi testiculorum eius perplexi sunt”, spiega che gli argomenti dei predicatori dell’Anticristo, allo scopo di attirare i buoni, sono annodati, quasi come nervi intrecciati, con asserzioni dolose che non è possibile sciogliere e che avvelenano i cuori con le parole mostrando innocenza nell’operare.
Di qui il “dubbio” (che è “error” e “nodo” che Farinata scioglie) di Dante di fronte alla “mala luce” dei dannati, che vedono il futuro ma non il tempo che s’appressa (Inf. X, 94-96, 112-114), e anche la questione posta a Virgilio sugli usurai, che è “groppo” (Inf. XI, 91-96). Brunetto Latini dice dei “mal protesi nervi” lasciati a Vicenza dal vescovo di Firenze Andrea dei Mozzi, dove Bonifacio VIII l’aveva trasferito (“colui … che dal servo de’ servi / fu trasmutato d’Arno in Bacchiglione”, Inf. XV, 112-114).
L’aggrovigliarsi dei nodi, proprio degli argomenti dolosi dei predicatori dell’Anticristo che mostrano un aspetto innocente, si trasforma nei “nodi” e nelle “rotelle” di cui Gerione ha dipinto il dorso, il petto e i fianchi: la fiera, “sozza imagine di froda”, ha la faccia di uomo giusto con pelle di fuori benigna (Inf. XVII, 10-15). Groviglio richiamato dalla corda “aggroppata e ravvolta” porta da Dante a Virgilio e che questi getta nell’“alto burrato” verso Malebolge per far salire su Gerione (Inf. XVI, 106-111), del quale è archetipo il Falsembiante che altrui ‘aviluppa’. Si rispecchia infatti nel poema, armato con l’esegesi della Lectura oliviana, il verbo ‘aviluppare’ presente in Fiore XCII, 2 (“Color con cuï sto sì ànno il mondo / Sotto da lor sì forte aviluppato”).
L’avviluppare di Gerione è incastonato in una vasta elaborazione dei temi della quinta tromba. Alle locuste è dato il potere di nuocere come gli scorpioni (Ap 9, 3). Lo scorpione è blando nella faccia (ad Ap 9, 7 si dice pure che le locuste hanno la faccia umana, cioè si fingono umane e modeste e paiono fare tutto razionalmente), ha le braccia aperte all’amplesso ma con la coda punge e infonde il suo veleno. Così gli ipocriti, mentre blandiscono esteriormente e anteriormente, realizzano infine da dietro le loro maliziose intenzioni estorcendo i beni temporali, soddisfacendo lussurie e lascivie con quanti si congiungono e infondendo i propri pravi costumi. Dalle locuste il mostro infernale deriva la faccia d’uomo giusto, le “branche” (cioè le zampe, che però concordano nel suono con “brachia”, cioè con le chele degli scorpioni) e la coda con la velenosa forca a guisa di scorpione. Altri motivi presenti in Gerione derivano da Ap 9, 19 (sesta tromba), dove si parla delle code dei cavalli simili a serpenti che hanno teste (gli pseudoprofeti). Gerione viene su nuotando “per quell’ aere grosso e scuro”, tema della quinta tromba (Ap 9, 2).
[1] INGLESE, Inf. II, 44 (p. 54); Eth. 1123b 2.
[2] CHIAVACCI LEONARDI, Inf. II, 44 (p. 54); cfr. Convivio, I, xi, 18-20.
[3] Ibid., Inf. X, 73 (pp. 319-320).
[4] CHIAVACCI LEONARDI, Inf. XVI, 79 (p. 498).
[5] Cfr. PETRI IOHANNIS OLIVI Lecturae super Pauli Epistolas, cura et studio A. Boureau, Turnhout 2010 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis, 233), pp. 139-140 (Super Romanos, VIII, 26-27): «Ne autem ex inuisibilitate rei sperate credatur nos duci in incertum quasi causaliter, ideo subdit: Similiter etiam Spiritus adiuuat infirmitatem nostram, quasi dicens: “uirtus sapientie et spei solide facit nos solide expectare et similiter ipse Spiritus sanctus adiuuat debilitatem uirium nostrarum et dirigit incertitudinem nostre ignorantie”. Nam quid oremus sicut oportet, nescimus. Nec enim ipsum bonum quod est petendum nec modus sub quo expedit illud peti, sciuntur bene a nobis. Sed ipse Spiritus postulat pro nobis, id est facit nos postulare, gemitibus inenarrabilibus, quia interna desideria et suspiria sanctorum a Spiritu sancto creata et mota non possunt per uocem enarrari seu explicari, quia non solum transcendunt sensualia sed etiam intellectualia. Sunt enim superintellectualia secundum Dyonisium libro De mistica theologia, unde dicit quod sunt diuine uniones et immissiones siue susceptiones superignote et de superignoto. Quod autem dicit ‘postulat’ pro ‘postulare facit’ modus est loquendi emphaticus, id est uehementis expressionis. Est etiam modus quo causam per effectum significamus; est enim predicatio causalis, non formalis. Deinde subdit quod sicut sanctorum desideria sunt nobiscum mirabilia, Deus autem optime nouit et approbat illa tamquam secundum Deum formata a Spiritu sancto. Vnde subdit: dico quidem inenarrabilibus nobis. Qui autem scrutatur corda, id est Deus inspector cordium, scit, id est nouit et approbat, quid desideret, id est quid desiderare faciat, spiritus, quia secundum Deum, id est secundum placitum Dei, postulat, id est postulare facit, pro sanctis». Di questo superintellettuale modo di esprimere, da parte dei santi, i propri desideri e sospiri e del conoscerli da parte di Dio, che li fa ‘postulare’ per mezzo dello Spirito, è pregno il dialogo tra Dante e Virgilio (mosso da Beatrice, lo Spirito di Cristo): «“O virtù somma, che per li empi giri / mi volvi”, cominciai, “com’ a te piace, / parlami, e sodisfammi a’ miei disiri”. … “Però a la dimanda che mi faci / quinc’ entro satisfatto sarà tosto, / e al disio ancor che tu mi taci”» (Inf. X, 4-6, 16-18). Il desiderio di Dante è di vedere Farinata, ‘postulante’ anch’egli, mosso dall’interno dettatore.
[6] Ad esempio, nella bolgia dei barattieri Ciampolo storpia l’esegesi di Ap 5, 6-7, sempre relativa al settiforme Spirito.
[7] AUERBACH, Mimesis, I, p. 207: «Gli abitatori dei tre regni danteschi si trovano però in un’esistenza immutabile (espressione usata da Hegel nelle Lezioni di estetica, in una delle più belle pagine che mai siano state scritte su Dante), e tuttavia Dante immerge “il mondo vivente del fare e del patire, e più precisamente delle azioni e dei destini individuali, in questa esistenza immutabile”».
[8] Virgilio, a dire il vero, è morto da tempo; ma il nuovo Virgilio, che vive “in disio” nel Limbo (Inf. IV, 42), ha già assunto i panni del Cristo uomo, il quale insegna con la voce esteriore e prepara a Beatrice, voce e gusto interiore. L’espressione “Finito questo” si ritrova a Par. XXIV, 112, a conclusione dell’esame sulla fede sostenuto da Dante di fronte a san Pietro. All’apostolo viene attribuito (vv. 109-110) il tema del ‘campo’ (“ché tu intrasti povero e digiuno / in campo …”), da confrontare con la “buia campagna” di Inf. III, 130 (ad Ap 6, 2 Cristo esce vittorioso nel campo del mondo) e poi (vv. 125-126) anche il vincere, che nell’esegesi è prerogativa della bestia (“O santo padre, e spirito che vedi / ciò che credesti sì, che tu vincesti / ver’ lo sepulcro più giovani piedi”).
[9] Il pietoso condiscendere dai colli (più bassi degli alti monti) può essere strumento della giustizia divina (cfr. maestro Adamo a Inf. XXX, 64-66: “Li ruscelletti che d’i verdi colli / del Casentin discendon giuso in Arno, / faccendo i lor canali freddi e molli”; ‘piegare i colli’, cioè muovere l’originaria durezza, non serve ai fratelli Alberti, stretti e rinserrati dal gelo a Inf. XXXII, 43-48). In questo caso la collazione analogica è con l’essere molle della giustizia divina, designata dai capelli di Cristo (modello del sommo pastore) ad Ap 1, 14, molle lana e rigida neve insieme secondo i livelli di giustizia, rigida e congelata o pietosamente calda, temperata, purgativa: Dante, nell’Eden, ne sentirà gli effetti tramite Beatrice. Ma la condescensio, tipica del quinto stato, si congiunge con la mollezza, anch’essa segno del quinto nella sua rilassata e corrotta fase finale, nei capelli delle locuste (Ap 9, 8; quarta proprietà), per cui: «Pro quarta dicit (Ap 9, 8): “Et habebant capillos sicut capillos mulierum”, quia realiter sunt molles et effeminati et alios ad mollitiem protrahentes. […] per “capillos” vero “mulierum”, qui longiores sunt capillis virorum, designatur assiduitas operandi, quia quasi de suo labore viventes religiosos esse iactitant et modestos. Puto tamen per hoc magis designari mollitiem carnalem et superfluitatem rerum quam in occulto habent, et etiam quia principibus carnalibus et effeminatis adulatorie blandiuntur et adherent sicut capilli ornantes capita mulierum, et etiam quia suis credentibus, qui non sunt de suis perfectis, concedunt omnem luxuriam et avaritiam. – Inf. XVIII, 120-126: E io a lui: “Perché, se ben ricordo, / già t’ho veduto coi capelli asciutti, / e se’ Alessio Interminei da Lucca: / però t’adocchio più che li altri tutti”. / Ed elli allor, battendosi la zucca: / “Qua giù m’hanno sommerso le lusinghe / ond’ io non ebbi mai la lingua stucca”; Inf. XIX, 85-87: Nuovo Iasón sarà, di cui si legge / ne’ Maccabei; e come a quel fu molle / suo re, così fia lui chi Francia regge; Purg. XXIV, 124-126: e de li Ebrei ch’al ber si mostrar molli, / per che no i volle Gedeon compagni, / quando inver’ Madïan discese i colli; Par. XIX, 124-125: Vedrassi la lussuria e ’l viver molle / di quel di Spagna e di quel di Boemme».
[10] Variante del gemere e sospirare degli antichi padri nel Limbo, desiderosi che il libro segnato dai sette sigilli venga aperto (Ap 5, 4).
[11] PETROCCHI, Itinerari danteschi, pp. 277, 285-286. Se “il patriottico ergersi contro i distruttori di Firenze nel raduno empolitano, a nulla può valere perché non determinato da amore per gli uomini come riflesso dell’amore per Dio”, la passione partigiana ha svolto, sia pure per l’attimo che torna alla memoria di Manente, il quale per la sua pena non può chiamarsi ‘amico di Dio’, un ruolo importante nel processo della storia provvidenziale.
[LSA, cap. III, Ap 3, 19 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Deinde ut ipsum efficacius inducat et trahat ad ista, ostendit se ex singulari amore ipsum corripere et alios, quos consimiliter corripit et emendat, in exemplum imitandum proponere sibi, unde subdit (Ap 3, 19):
|
||
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 15.17-18 (IVa visio)] Per angelum vero clamantem priori ut metat (Ap 14, 15), dicit significari sanctos, qui non iubendo sed orando clamant ad Christum ut suo tempore tollat de terra impios. […] Nota etiam quod ille qui vindemiat reprobos dicitur exivisse “de templo quod est in celo” (Ap 14, 17), id est de contemplatione seu oratione sanctissima et celesti, ne eius severitas possit male et iniuste ire ascribi et non potius sanctissimo et altissimo zelo glorie et iustitie Dei. Item angelus qui huic clamat seu imperat dicitur exisse “de altari” et habere “potestatem super ignem” (Ap 14, 18), supple super ignem altaris, ad consimiliter insinuandum summam sanctitatem ardentissimi zeli superiorum angelorum vel sanctorum iubentium malos vel eorum mala succidi et dignis penis calcari. Nam in altari incensi vel holocaustorum Dei erat ignis a Deo celitus missus a principio et soli Dei cultui consecratus et divina incensa vel holocausta concremans et offerens Deo. Sicut ergo solus Dei sacerdos habebat in templo potestatem super istum ignem et super oblata per ipsum, eratque assidue et immediate circa Dei altare assistens, sic supremi angeli aut sancti apostoli vel pontifices sunt immediatius circa Christum et habentes “potestatem super ignem”, id est ad inflammandum divino igne se et alios et ad puniendum et increpatorie comburendum vitia per zelum igneum caritatis. |
[LSA, cap. XX, Ap 20, 9 (VIIa visio)] Sequitur: “Et descendit ignis a Deo de celo et devoravit eos” (Ap 20, 9). Secundum Augustinum, XX° de civitate Dei, capitulo XII°, non est hoc extremum supplicium de quo dicitur: “Ite, maledicti, in ignem eternum” (Mt 25, 41), quia ipsi tunc mittentur in ignem eternum, non ignis veniet de celo super ipsos. Et subdit quod ignis iste est ardens zelus de celo, id est de firmitate sanctorum, quo cruciabuntur hostes eo-rum.
|
|
Par. XXI, 109-114, 136-142; XXII, 7-15, 50-51“e fanno un gibbo che si chiama Catria,
|
Inf. XIV, 31-37Quali Alessandro in quelle parti calde
|
|
Tab. XVIII
[LSA, cap. XVI, Ap 16, 4 (Va visio, IIIa phiala)] “Et tertius angelus” (Ap 16, 4), id est ordo sanctorum zelatorum tertii temporis, “effudit phialam suam super flumina et super fontes aquarum”, id est super doctrinam erroneam doctorum et episcoporum hereticorum, quam ipsi tamquam dulcem aquam bibebant et aliis propinabant. “Effudit”, inquam, non solum ipsam improbando, sed etiam ipsam et eius sectatores et fautores anathematizando et ab omni communion<e> ecclesie catholice sententialiter ex-cludendo.
|
Inf. XIII, 34Da che fatto fu poi di sangue brunoInf. XXVIII, 1-3, 76-81, 103-105Chi poria mai pur con parole sciolte
|
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 3 (radix IIe visionis)] “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id est aspectibili seu visibili forme, “lapidis iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dicitur similis, quia Deus est per naturam firmus et immutabilis et in sua iustitia solidus et stabilis, et firmiter regit et statuit omnia per potentiam infrangibilem proprie virtutis.
|
||
Purg. XXVII, 34-42Quando mi vide star pur fermo e duro,
|
Purg. XXX, 31-33, 70-72, 100-102sovra candido vel cinta d’uliva
|
|
[LSA, cap. XXII, Ap 22, 10-12 (VIIa visio)] Loquitur autem Christus primo ut contestator propinquitatis sui adventus ad iudicium, de quo paulo ante dixit angelus: “Tempus enim prope est” (Ap 22, 10). Et continuat se ad immediate premissum, ac si ironice contra malos dictum sit: “Qui nocet noceat”, quia “ecce venio cito” (Ap 22, 11-12), quasi dicat: in penam suam hoc faciet, quia ego cito veniam ad iudicandum. |
||
Tab. XIX
[LSA, cap. III, Ap 3, 10 (Ia visio, VIa ecclesia)] Potest etiam dici quod Christus promittit servare eum ab hora finalis temptationis, ne scilicet sit in tempore illo in quo tantum habundabit iniquitas quod refrigescet seu extinguetur multorum caritas et in quo fere ducentur in errorem electi. Unde <et> Apostolus, IIa ad Thessalonicenses II°, ubi loquitur quomodo Antichristus venturus est in “signis et prodigiis mendacibus et in omni seductione ini-quitatis” (2 Th 2, 9-10), subdit se et suos pro magna gratia habere quia sunt electi longe ante illud tempus, unde ait: “Nos autem debemus gratias agere Deo pro vobis semper, fratres, quod elegerit nos Deus primitias in salutem, in quam et vocavit vos per evangelium nostrum” (2 Th 2, 13-14).
|
Par. XXIV, 58-60“La Grazia che mi dà ch’io mi confessi”,
|
Tab. XX
[LSA, cap. VII, Ap 7, 3 (IIa visio, apertio VIi sigilli] Signatio hec fit per administrationem fidei et caritatis et per assumptionem ac professionem sacra-mentorum Christi distinctivam fidelium ab infi-delibus. In hac etiam signatione includitur fides et devotio ad Christi passionem adorandam et imi-tandam et exaltandam. Fit autem “in frontibus”, quando signatis datur constans et magnanimis libertas ad Christi fidem publice confitendam et observandam et predicandam et defendendam. In fronte enim apparet signum audacie et strenuitatis vel formidolositatis et inhertie, et signum gloriationis vel erubescentie. […] Ex predictis autem patent alique rationes quare ante temporale exterminium nove Babilonis sit veritas evangelice vite a reprobis sollempniter impugnanda et condempnanda, et e contra a spiritalibus suscitandis ferventius defen-denda et observanda et attentius et clarius intelligenda et predicanda, ut merito ibi sit quoddam sollempne initium sexte apertionis.
|
[LSA, cap. XIV, Ap 14, 1 (IVa visio)] Tertium est fidei et amoris et contemplationis Dei Patris et Filii humanati in istorum corde et ore singularis et patens inscriptio et expressio, unde subditur: “habentes nomen eius et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis”. Per “nomen” famosa notitia desi-gnatur, que respectu Dei non reputatur nisi sit amativa. Frons vero est suprema pars faciei omnibus patula, et ideo quod est scriptum in fronte omnibus se prima facie offert, ita quod potest statim ab omnibus legi. In fronte etiam signa audacie vel sui oppositi cognoscuntur. Est ergo sensus quod maiestas Dei trini et Filii humanati sic erat in cordibus istorum impressa et sic per apertam et constantem confessionem oris et operis expressa, quod ab omnibus poterat statim legi et discerni quod ipsi erant de familia Agni et singulares socii eius.
|
“Fiorenza … si stava … sobria e pudica. / Non avea catenella … / Non faceva, nascendo, ancor paura / la figlia al padre … / Non avea case di famiglia vòte … / Non era vinto ancora Montemalo …”. Nella Quaestio de altissima paupertate Olivi cita un’omelia di Crisostomo che, nell’elogio della povertà, ha lo stesso andamento caratterizzato dal succedersi di negazioni presente nel parlare di Cacciaguida circa la sua Firenze: «Non enim est illic tinea, non est illic fur, non sollicitudo vitae huius negotiorum … Non subiacet daemonibus … Non habet arcas … Non habet thesaurum, sed caelum. Non indiget servis …» (cfr. La settima visione, cap. IV.2). Può solo trattarsi della ripetizione di un cursus diffuso, ma bisogna tener conto che Dante mostra di conoscere bene altre quaestiones dell’Olivi. |
|
Quaestio de altissima paupertate, ed. J. Schlageter, Das Heil der Armen und das Verderben der Reichen. Petrus Johannis Olivi OFM. Die Frage nach der höchsten Armut, Werl/Westfalen 1989 (Franziskanische Forschungen, 34), p. 124 (Responsio principalis, 15).Pro istis autem facit quod dicit Chrysostomus super Iohannem (!Matthaeum) Homilia XLVIIa: “Anima inopis, inopis quidem voluntarii, fulget velut aurum, splendet velut margarita fulgens, florescit autem ut rosa. Non enim est illic tinea, non est illic fur, non sollicitudo vitae huius negotiorum, sed sicut angelus ita conversatur. Vis animae huius pulchritudinem videre? Vis inopiae divitias addiscere? Non subiacet daemonibus, non assistit regi, sed assistit Deo, non militat cum hominibus, sed militat cum angelis. Non habet arcas duas vel tres vel viginti, sed talem abundantiam, ut hunc mundum universum nihil esse aestimet. Non habet thesaurum, sed caelum. Non indiget servis, magis autem servos habet passiones et cogitationes quae regum dominantur. Regnum autem et aurum et omnia talia quemadmodum puerorum ludibria deridet, et sicut rotas et pilam haec omnia aestimat esse contemptibilia. Habet enim mundum quem neque videre, qui in his ludunt, possunt. Quid igitur paupere hoc est melius umquam? Pavimentum denique habet caelum. Si autem pavimentum tale est, excogita tectum. Sed non habet equos et currus? Quid autem ei his opus est qui supra nubes vehi debet et esse cum Christo”. Item super Matthaeum Homilia ultima: “Mihi paupertas puellae cuidam pulchrae et speciosae similis esse videtur. Cum hac Elias educatus raptus est beata illa rapina; cum hac Elisaeus claruit, cum hac Iohannes, cum hac Apostoli omnes. Si et ipsam puellae huius pulchritudinem intueamur, etenim oculus eius est purus et praeclarus, nihil habens turbulentum, sed mansuetus, tranquillus, delectabilis, ad omnes respiciens mitis, humilis, nullum odio habens, nullum avertens. Os illi et lingua sana est, continua gratiarum actione plena et benedictione et mitibus verbis et amicabilibus. Si autem vis et proportionem membrorum eius videre, longa est et multum excelsior quam superabundantia. Si autem fugiunt eam tam multi, ne mireris; etenim et alias virtutes fugiunt insipientes”. |
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 2.16.18.21 (VIIa visio)] In prima (parte) autem primo describitur sub typo sponse precellenter adornate et Deo tamquam sponso suo familiariter iuncte. Vocatur autem “civitas” (Ap 21, 2), quia ibi est mira unitas omnium sanctorum tamquam concivium. Vocatur vero “Iherusalem”, quia ibi est visio summe pacis et principalis metropolis et sedes Dei et sanctorum. […] Tanta autem equalitas designat summam concordiam beatorum in regno Dei. […] Per utrumque autem designatur generalis ecclesia et principaliter contem-plativorum, sicut per muros militia martirum et pugilum seu defensorum interioris ecclesie, que est per unitatem concordie “civitas”, id est civium unitas, et per fulgorem divine caritatis et sapientie aurea, et per puram confessionem veritatis propria peccata clare et humiliter confitentis et nichil falso simulantis est “similis vitro mundo”, et per latitu-dinem caritatis et libertatem ac communitate<m> evangelice paupertatis est “platea” celis patula, non tectis clausa, nec domibus occupata, nec domorum distinctionibus divisa, nec isti vel illi instar domorum appropriata, sed omnibus communis et indivisa. Et quia in tertio generali statu, statutis duodecim portis eius, fulgebit singulariter evangelica paupertas et contemplatio, ideo non fit mentio de platea nisi post portas, et ubi mox subditur quod solus Deus est templum et sol huius civitatis (cfr. Ap 21, 22-23). Unde et platea non solum dicitur esse “aurum simile vitro mundo”, id est perspicuo et polito et nulla macula vel pulvere obumbrato, sed etiam dicitur esse sicut “vitrum perlucidum”, id est valde lucidum, quia tunc maior erit cordis et oris puritas et clarior veritas. In ecclesia vero beatorum erit tanta, ut omnia interiora cordium sint omnibus beatis mutuo pervia et aperta.
|
Par. XV, 97-135Fiorenza dentro da la cerchia antica, 21, 15
|
Tab. XXI
[LSA, cap. V, Ap 5, 5 (radix IIe visionis)] Attamen hec revelatio et fletus Iohannis potius respicit illa tempora in quibus, propter pressuras heresum et terrores imminentium periculorum, et propter nescientiam rationis seu rationabilis permissionis talium pressurarum et periculorum <et> iudiciorum, flent et suspirant sancti pro apertione libri, quantum ad illa precipue que pro illo tempore magis expedit eos scire. Hoc autem potissime spectat ad triplex tempus. […]
|
|
Inf. X, 94-96, 112-114; XI, 91-96“Deh, se riposi mai vostra semenza”,
|
Inf. XV, 109-114; XVI, 106-111, 130-131Priscian sen va con quella turba grama,
|
[LSA, cap. IX, Ap 9, 2 (IIIa visio, Va tuba)] Secundo tangitur gravitas mali de aperto iam puteo exeuntis, cum ait: “et ascendit fumus putei sicut fumus fornacis magne, et obscuratus est [sol et] aer de fumo putei” (Ap 9, 2). Fumus iste est omne extrinsecum malum opus et signum de cordali flamma luxurie et avaritie et superbie et ire et invidie et malitiose astutie procedens. Et quanto iste fumus est maior et gro<ss>ior et de maiori ac peiori flamma exiens, tanto plus pungit et confundit oculos intuentium, et tanto plus non solum coram fidelibus sed etiam coram infidelibus diffamat et obscurat solarem claritatem fidei et ecclesie et religionis perducentis ad cultum veri solis Christi, sicut aer sua perspicuitate perducit nostrum visum ad solem et radios solis usque ad oculum nostrum. Vel per hoc designatur quod multi prelati ecclesiarum et religionum, qui prius erant quasi sol, et multi spirituales, qui prius erant quasi aer purus a sole illuminatus, corrumpuntur et denigrantur a fumo tante laxationis. |
|
[LSA, cap. IX, Ap 9, 3.7 (IIIa visio, Va tuba] Quarto describit potestatem nocendi eis a Deo permissam et cohibitionem ipsius ab aliquibus non permissis, unde subdit: “et data est illis potestas”, scilicet nocendi, “sicut habent potestatem scorpiones terre” (Ap 9, 3). Scorpio apparet facie blandus et quasi brachiis ad amplexandum expansis, sed cauda retro pungit et nocet suum toxicum infundendo. Sic prefati ypocrite cum quodam exteriori et anteriori blandimento et favore explent finaliter suas malitiosas intentiones sive temporalia extorquendo, sive suas luxurias seu lascivias cum hiis quibus se iungunt implendo, sive suos pravos mores eis quasi infundendo. […]
|
Inf. XVII, 7-15, 25-27
|
[LSA, cap. IX, Ap 9, 19 (IIIa visio, VIa tuba)] “Potestas enim equorum in ore eorum est” (Ap 9, 19), scilicet quoad tria predicta, “et in caudis eorum; nam caude eorum similes serpentibus habentes capita, et in hiis nocent”. Leo palam sevit, serpens vero occultis insidiis ferit et feriendo suum occultum venenum infundit; sic etiam os in facie se aperte ingerit, cauda vero post tergum latet. In leonino igitur capite et ore equorum designatur temptatio aperta et violenta, in cauda vero serpentina temptatio latens et fraudulenta. Secundum enim Ioachim, minantur mortem ut tormentis penarum possint etiam constantes milites frangere; secreto autem blandiuntur et negantibus fidem promittunt felicem vitam, ut sic frangant eos quos nequeunt superare tormentis*.
|
|
6. Federico II (X, 119)
In Inferno X, come nel precedente incontro con Ciacco, Dante si mantiene al di sopra delle parti politiche. Il ghibellino Farinata dice che con lui stanno, fra “più di mille”, Federico II e Ottaviano degli Ubaldini (arcivescovo di Bologna dal 1240 al 1244, appellato “’l Cardinale”), cioè altri due ghibellini. Ma dalla stessa tomba si leva in ginocchio il guelfo Cavalcante, il padre di Guido. Tutti sono puniti in quanto epicurei. Non fa eccezione colui che nel De vulgari eloquentia (I, xii, 4), insieme al figlio Manfredi, era stato insignito della nobiltà d’animo propria degli “illustres heroes”. Dante, come sottolineato da Raoul Manselli, “ammira Federico, ma non si sente di assolverlo di una mancanza di fede che gli sembra provata e non manca perciò al dovere difficile di giudice che egli si è proposto con tutta l’ardua esigenza di obbedire alla verità, a qualunque costo” [1]. Una condanna che non sembra tenere in alcun conto le disposizioni contro gli eretici emanate con le Costituzioni melfitane, né è temperata, nel prosieguo del viaggio, dall’inopinata salvazione di Manfredi (Purg. III, 103-145) né dal parlare di Piccarda su “’l terzo e l’ultima possanza” (Par. III, 118-120).
“Manfredi è unito al padre nel mito politico-letterario della grande curia-scuola siciliana” [2]. È però da lui, che giace nelle arche infuocate degli eresiarchi con Farinata e Cavalcante, il padre di Guido (Inf. X, 119), eternamente diviso. Perché questa differenza fra padre e figlio? Se si può sottolineare la prospettiva antiangioina e antifrancese che segna la seconda cantica [3], dove Ugo Capeto maledice la propria discendenza, vero nido di apocalittiche locuste come rivelano i significati spirituali, perché Dante ha messo all’inferno Federico II, “ultima possanza” del seme imperiale?
Il Farinata, tessuto nelle sue prime parole con il panno del falso papa imposto dall’Anticristo mistico, seme di Federico II (Ap 13, 18), giace “con più di mille” epicurei [4]. Fra costoro c’è proprio “’l secondo Federico”, nominato ma che non si drizza dal suo sepolcro (Inf. X, 118-119). Nell’episodio, il rivivere del seme imperiale (tema dall’alto valore per Dante, a differenza di Olivi) sembra tacere, ma al ghibellino il poeta ha augurato il riposo della sua semenza (v. 94; Ap 14, 13). “Deh, se riposi mai vostra semenza”: è augurio di pace delle fazioni, per cui gli sbanditi Uberti possano ritornare a Firenze.
Nel silenzio che lo fascia, qualcosa accomuna l’imperatore a Farinata e a Guido. Con l’Uberti, e con Omberto Aldobrandesco purgante nella cornice dei superbi, Federico II doveva condividere la concezione della nobiltà per “antico sangue” e “opere leggiadre”. Così viene citato, e contestato nonostante il rilievo provvidenziale dato all’autorità imperiale, in Convivio IV, iii, 6: “domandato che fosse gentilezza, rispuose ch’era antica ricchezza e belli costumi”. È l’ultima menzione di Federico II prima che Farinata ne riveli l’eterna dannazione come epicureo. Nel mezzo sta la vocazione di Dante al viaggio, il suo sentirsi eletto, segnato con gli amici di Dio per un’alta missione, “sesto tra cotanto senno” non per nobiltà acquisita dai propri “maggior” ma per quella nobiltà di spirito che discende direttamente dalla grazia donata. È Dio, “appo cui non è scelta di persone” in base alla presunzione dell’antico, che rende i singoli “quasi dèi” (Convivio, IV, xx, 3-6). Questa idea di nobiltà fu la porta per cui i Gentili dall’“onrata nominanza” avrebbero di lì a poco trovato albergo nel “nobile castello” del Limbo, posti ivi da Dio in quanto giusti; per interiore gusto spirituale, tratto dagli occhi di Beatrice, il poeta sarebbe asceso al cielo “qual si fé Glauco nel gustar de l’erba / che ’l fé consorto in mar de li altri dèi” (Par. I, 67-69). Nel sesto stato della storia della Chiesa, sostiene Olivi, si compie la conversione dei Gentili, solo iniziata con il primo avvento di Cristo. Questa incorporazione degli infedeli, “non per viam carnis, nec per viam naturae, sed per viam gratiae ad Dei filiationem et propinquitatem”, fu fatta nel tempo della legge di natura, prima della circoncisione, e nel tempo della pienezza delle genti (di cui dice san Paolo ai Romani 11, 25-26), e avverrà di nuovo nel tempo della conversione finale di ciò che rimane dei Gentili e di Israele [5].
Brunetto Latini, dannato fra i sodomiti, asserisce che “le bestie fiesolane” (i fiorentini) non dovranno toccare Dante, pianta “in cui riviva la sementa santa / di que’ Roman che vi rimaser quando / fu fatto il nido di malizia tanta”, che parteciparono cioè alla fondazione di Firenze (Inf. XV, 76-78). Il ‘rimanere’ del seme ha un particolare valore, come spiegato ad Ap 12, 17, al momento della guerra del quinto stato (quarta visione), condotta dal drago contro le rimanenze (le reliquie) del seme della donna, rappresentate da coloro che custodiscono i precetti divini e danno testimonianza di Cristo. Queste reliquie designano l’evangelista Giovanni (secondo Gioacchino da Fiore) o la Chiesa latina (secondo Olivi), sola rimasta dopo le devastazioni saracene e lo scisma greco, come in un vaso di vino purissimo, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e più pura, rimangono solo poche reliquie vicine alle impurità e quasi con esse mescolate. Dante è pertanto ‘reliquia’ del seme che rimane – assimilato alla Chiesa romana – accanto e commisto al letame delle “bestie fiesolane”. Nelle parole di Brunetto, il “romanus populus … ille sanctus, pius et gloriosus” (Monarchia, II, v, 5), di cui Dante è seme rimasto, è ammantato dalla veste che nell’esegesi scritturale spetta alla Chiesa di Roma, la sola ‘rimasta’ di una Chiesa prima diffusa su tutto l’orbe, della quale il seme degli antichi Romani è dunque prefigurazione. Il tema del purissimo seme della donna che rimane, da Ap 12, 17, è anche singolarmente consonante con quanto affermato in Convivio IV, v, 5-6: “Per che assai è manifesto la divina elezione del romano imperio, per lo nascimento della santa cittade, che fu contemporaneo alla radice della progenie di Maria”, “una progenie santissima”, ordinata a “l’albergo dove ’l celestiale rege intrare dovea”, il quale “convenia essere mondissimo e purissimo”.
Essere “sementa santa” dei Romani, esclusa ogni discendenza per nobiltà di sangue, è appellativo che designa il primato nella lingua, in quella volgare, nuova e universale quanto fu il latino antico, in attesa che riviva l’imperiale Curia dispersa, dopo la morte dell’“ultima possanza”. Se Federico II ha in comune con Farinata la concezione della nobiltà fondata su uno stare antico, è congiunto con Guido Cavalcanti nel trovarsi al di qua delle “nove rime”. Se, grazie a lui e al suo degno figlio Manfredi, nella regale sede di Sicilia vide la luce “quicquid nostri predecessores vulgariter protulerunt” (De vulgari eloquentia, I, xii, 4), ora una nuova lingua supplisce alla vacanza imperiale, di un istituto comunque indefettibile.
Chiuso nella sua durezza lapidea e ferrea, aspra a dirsi, l’Inferno corrisponde all’Antico Testamento, articolato nelle prime cinque età del mondo. Il volgersi di Virgilio sull’anca di Lucifero segna il passaggio alla sesta età, la quale è il tempo della Chiesa, rivissuto nel moderno viaggio di Dante che va verso il sesto stato, il novum saeculum che tanto s’aspetta. Ciò non sminuisce affatto la credenza nelle pene dell’inferno o del purgatorio. Il sentimento storico di speranza del nuovo, che Gioacchino da Fiore aveva scorto nell’Apocalisse e che Olivi aveva ricondotto allo Spirito di Cristo operante nella storia attraverso i suoi moderni discepoli, si accompagna in Dante a una ferma positività della legge e della morale. Federico II fu realmente epicureo, Brunetto Latini sodomita. La misericordia divina ha salvato Manfredi dai suoi orribili peccati nonostante la maledizione dei pastori, tuttavia il sovrano svevo, morto “in contumacia … di Santa Chiesa”, deve attendere fuori della “porta di san Pietro”. L’inferno non è un simbolo. Ma in esso il viaggio che percorre la storia dell’umanità, marcata dai segni della divina provvidenza, si lascia alle spalle non solo la cruda, vecchia roccia infernale, ma anche l’antico modo di poetare, proprio di quanti vennero prima nella Curia imperiale siciliana, i quali, posti al di qua del “dolce stil novo”, non seguirono l’interno dettatore come una regola evangelica imposta e accettata e che, in qualche modo, appartennero all’Antico Testamento della poesia (cfr. Purg. XXIV, 49-63). Nei “monimenti” del sesto cerchio, come nel sepolcro di Cristo, non sono sepolti solo “con Epicuro tutti suoi seguaci, / che l’anima col corpo morta fanno”; vi giace anche una poesia che non è riuscita a trasmigrare, ben guidata, ‘in Galilea’, dalla vita attiva alla contemplativa [6].
Dante è cosciente che il cammino verso il glorioso porto è ancora lungo, “ché ’l nome mio ancor molto non suona”, come dirà a Guido del Duca nel secondo girone della montagna (Purg. XIV, 21). Ma già Farinata lo apostrofa in tal senso: “La tua loquela ti fa manifesto / di quella nobil patrïa natio, / a la qual forse fui troppo molesto” (Inf. X, 25-27). Non è solo citazione del passo di Matteo 26, 73 – “loquela tua manifestum te facit” – riferito alla negazione di san Pietro. Rinvia anche all’esegesi dell’ultima visione apocalittica (Ap 22, 16), allorché Cristo parla manifestando – “loquitur ut … manifestator” – la propria regale autorità e la sua “claritas” magistrale ed esemplare e dice: “Ego sum radix et genus David”, cioè radice della progenie da cui discese la “sementa santa”, della quale Dante è ora unico depositario.
Nel finale di Inf. XV non viene assegnata a Brunetto una vittoria postuma quasi che – come voleva Auerbach [7] – la figura, “la cara e buona imagine paterna”, rompa la cornice della pena. Il suo correre non è degradante come quello degli ignavi, è però solo parvenza di vittoria, un’imitazione di Cristo non riuscita, una corsa senza vero premio. Chi prenderà quel premio – “la gloria de la lingua” -, togliendolo ad altri, sarà Dante il quale, come dice lo stesso Latini, è “sementa santa” dei Romani, vero loro erede nell’universalità dell’eloquio.
[1] RAOUL MANSELLI, Federico II (Federigo), in Enciclopedia Dantesca, II (19842), p. 828.
[2] Cfr. ARSENIO FRUGONI, Il canto III del “Purgatorio”, in “Nuove letture dantesche”, III, Firenze 1969, pp. 267-290: 270, riedito in IDEM, Scritti su Manfredi, Roma 2006 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici, 72), pp. 85-108: 88.
[3] Ibid., p. 89 [271].
[4] Nella tomba di Epicuro, come sostenuto da Arsenio Frugoni contro Raoul Manselli, non giacciono catari o patarini, ma solo, appunto, epicuri. Cfr. RAOUL MANSELLI, L’eresia del male, Napoli 1963, p. 118; Eresia, in Enciclopedia Dantesca, II, pp. 721-722; ARSENIO FRUGONI, Il canto X dell’«Inferno», Firenze, 1967, pp. 9-11.
[5] Cfr. PETER OF JOHN OLIVI, On the Bible. Principia quinque in Sacram Scripturam, ed. D. Flood – G. Gál, St. Bonaventure University, New York 1997 (Franciscan Institute Publications, Text Series, 18), III, De doctrina Scripturae, 44-45, pp. 91-93.
[6] Dante conosceva bene l’interpretazione (già in Girolamo) di “Galilea” come “transmigratio” e passaggio dalla vita attiva alla contemplativa. L’applica infatti, in Convivio IV, xxii, 14-18, a Marco 16, 1 sgg., nel senso che le tre maggiori sette filosofiche dell’antichità (Epicurei, Stoici e Peripatetici: “le tre sette della vita attiva”), designati dalle tre donne al sepolcro (Maria Maddalena, Maria Iacobi, Maria Salomè), cercarono vanamente la beatitudine (il Salvatore) al “monimento”, cioè “al mondo presente che è recettaculo di corruttibili cose”; il Salvatore invece, come dice l’angelo alle tre donne di riferire a Pietro, che l’ha negato, li precederà in Galilea, cioè nel biancore della contemplazione. Nei “monimenti” giacciono gli Epicurei del sesto cerchio infernale, “che l’anima col corpo morta fanno”; a Fiorenza, “nobil patrïa”, è nato il poeta imitatore di Cristo, che ha rinnovato, nel viaggio verso la beatitudine, l’idioma di Galilea.
[7] Cfr. CHIAVACCI LEONARDI, Inf. XV, 124 (p. 475).
“E poi ch’a la man destra si fu vòlto” (Inf. IX, 132)
“Fatto nuovo” – osservava lo Scartazzini [1], dandogli un senso ripreso nel commento (1991) di Anna Maria Chiavacci Leonardi (eretici e fraudolenti indicano ipocrisia e falsità; a destra sta la rettitudine che le combatte) [2] – volutamente notato in questo caso, all’ingresso del cerchio degli eretici, e nell’andare verso Gerione ipocrita per antonomasia (Inf. XVII, 31): i soli due casi destrorsi nella prima cantica, dove per regola ci si volge sempre a sinistra. “Il significato allegorico della mossa non trova, nell’antica esegesi, una decifrazione minimamente plausibile”: così nel commento di Giorgio Inglese [3].
Non sembra tuttavia che l’interpretazione scartazziniana regga a un confronto con i ben diversi significati suggeriti dalla Lectura super Apocalipsim, collazionando i passi dove si tratta della ‘mano destra’.
■ Fra le dodici perfezioni di Cristo sommo pastore trattate nella prima visione, l’ottava consiste nel potere di presiedere e contenere non solo le chiese ma anche i loro rettori, cioè i vescovi, che rilucono sopra le chiese come una lucerna o una stella sopra il candelabro del santuario. Per questo si dice: “e aveva nella sua destra sette stelle” (Ap 1, 16). Un vescovo deve sempre avere in sé “potestative, exemplariter et causaliter”, come Cristo, tutte le perfezioni stellari dei prelati inferiori e le deve tenere nella mano destra, cioè dalla parte che designa il potere spirituale, mentre la mano sinistra designa il potere temporale e mondano.
Alla chiesa di Efeso (la chiesa del primo stato) Cristo si propone ancora come colui che tiene nella sua destra le sette stelle, che cioè ha potestà sui vescovi, e che cammina nel mezzo dei candelabri, cioè delle chiese (Ap 2, 1). Lo fa per tre motivi. In primo luogo per mostrare che egli conosce intimamente ogni male e bene operato dai vescovi, ogni loro atto o pensiero, tenendoli, stando nel loro mezzo, visitandoli continuamente, scrutandoli, penetrandoli, osservandoli. Egli è infatti colui che percorre e visita tutte le chiese presenti e future. In secondo luogo per mostrare che essi debbono temere le minacce, i giudizi, i moniti da lui fatti, osservare i suoi precetti e le sue parole, amarlo e sperare in lui, in quanto egli è il giudice e signore che ha potestà su di essi e li scruta con la massima circospezione. È anche il pio pastore che li protegge e custodisce. In terzo luogo perché il vescovo metropolitano (tale è la sede di Efeso) ha potestà e cura sulle altre chiese.
Nel capitolo quinto, il libro segnato con sette sigilli appare a Giovanni nella mano destra di Dio, sia perché è nella sua potenza e facoltà l’aprirlo, sia perché contiene le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo e anche le elargizioni e le preparazioni che spettano alla mano destra come le avversità e le cose temporali spettano alla sinistra (Ap 5, 1).
La mano destra indica dunque il potere di colui che guida e regge, penetra i pensieri altrui, si volge secondo i disegni divini, minaccia, tiene. Questi motivi spiegano perché nell’inferno Dante e Virgilio si volgano sempre a sinistra, salvo che verso Farinata e verso Gerione (Inf. IX, 132; XVII, 31). Nei due casi l’andare a destra, fra le arche roventi o nel torcersi della via verso la bestia, non ha alcuna attinenza con gli eretici o con la frode. Virgilio, come Cristo, tiene nella destra le sette stelle, cioè ha piena potestà sulle chiese che visita. Nel primo caso, subito dopo aver notato che la direzione è la destra, Dante si rivolge alla sua guida: “O virtù somma, che per li empi giri / mi volvi … com’ a te piace” (Inf. X, 4-5). Virgilio conosce il desiderio celato da Dante di vedere Farinata, come un vescovo conosce ogni atto o pensiero dei suoi sottoposti (v. 18).
Nell’episodio della corda, per la quale Gerione viene in su dall’abisso di Malebolge, Virgilio è considerato fra “color che non veggion pur l’ovra, / ma per entro i pensier miran col senno” (Inf. XVI, 118-120). Così, nell’andare verso la bestia, scendere “a la destra mammella” (Inf. XVII, 31) indica la potestà che Virgilio ha su di essa, che pure possiede tutte le caratteristiche dell’Anticristo. All’ordine di montare in groppa al fiero animale Dante si sente come il malarico che prova ribrezzo del freddo, ma gli è minaccia la vergogna, che rende forte il servo sull’esempio del suo signore valoroso (vv. 85-90). Una volta salito, Virgilio l’abbraccia e lo sostiene (vv. 94-96). A Virgilio, come a un perfetto prelato, sono pertanto adattati per analogia alcuni aspetti delle proprietà di Cristo sommo pastore, secondo quanto scritto da Olivi ad Ap 1, 18:
Notandum autem quod perfectiones predicte possunt anologice coaptari perfectis prelatis sub Christo, ita quod eorum perfectiones ascribantur Christo sicut cause efficienti et exemplari. Possunt sibi etiam ascribi tamquam capiti corporis mistici, et tunc per membra Christi hic posita possunt significari diversi electi, qui sunt mistica membra Christi, puta per oculos contemplativi, per pedes activi, per os autem seu per vocem doctores et iudices seu correctores.
Questo vestire di panni vescovili i personaggi, imitatori di Cristo, è sintomo di come il “saeculum humanum” e il sapere classico abbiano conquistato la propria autonomia partecipando alla storia sacra e appropriandosi di sacre prerogative. Non solo Virgilio, per il quale Beatrice riporterà lodi a Dio (Inf. II, 73-74), ma, per converso, anche “l’anime più nere” fra le quali è Farinata (cfr. Inf. X, 89-90).
■La mano destra designa anche il pieno possesso delle perfezioni stellari (Ap 1, 16: da intendere come i doni dello Spirito, ai quali presiedono i sette vescovi), unitamente alle elargizioni della grazia divina (promesse contenute nel libro, ad Ap 5, 1 tenuto nella destra di Colui che siede sul trono, chiuso da sette sigilli che Cristo, nella storia, progressivamente apre).
Nel suo ultimo viaggio, Ulisse si lascia “da la man destra … Sibilia” (Inf. XXVI, 110). Da un punto di vista geografico si tratta di Siviglia. “Sibilia” tuttavia può contenere un’allusione, per concordanza di suono, alla Sibilla cumana, ossia all’andata di Enea “ad immortale secolo” dove “intese cose che furon cagione / di sua vittoria e del papale ammanto” (Inf. II, 13-27): la mano destra contiene infatti le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo. Passate le colonne d’Ercole, il viaggio prosegue verso sinistra (“sempre acquistando dal lato mancino”), cioè verso sud-ovest, mentre nelle notti appaiono tutte le stelle dell’altro emisfero (Inf. XXVI, 126-128): la perfezione stellare, nel caso di Ulisse, è tenuta nella mano sbagliata. All’opposto è Dante il quale, uscito dall’aura morta infernale, si volge “a man destra” verso il polo australe e vede “quattro stelle / non viste mai fuor ch’a la prima gente” (Purg. I, 22-24): esse designano le quattro virtù cardinali; le altre tre (le virtù teologali) saliranno al posto delle prime allorché il poeta si troverà nella valletta dei principi (Purg. VIII, 88-93). Così di Dante si può dire che abbia anch’egli, come Cristo, nella sua destra sette stelle.
A Dante sono ancora appropriati, nelle parole di rimprovero pronunciate da Beatrice nell’Eden, i motivi connessi alla “destra di Dio” che contiene le leggi (l’“alto fato”) e le elargizioni della grazia provenienti dall’alta mente divina (“che sì alti vapori hanno a lor piova, / che nostre viste là non van vicine”), a lui date “ne la sua vita nova” (l’espressione si trova ad Ap 5, 9, nell’esegesi del “canticum novum”) prima che il “mal seme e non cólto” togliesse vigore a “ogne abito destro” (Purg. XXX, 112-120, 142). Elargizioni stellari attestate infine, senza riferimento esplicito alla ‘destra’, nell’invocazione ai Gemelli (Par. XXII, 112-120).
Cacciaguida discende verso Dante per il braccio destro della croce greca formata dai lumi che si manifestano nel cielo di Marte: a chi, come al suo discendente, è stata elargita tanta grazia che gli sia aperta per due volte la porta del cielo? (Par. XV, 19-21, 28-30).
■ È attestato anche il rispettivo valore ‘politico’ di destra e sinistra. San Bonaventura dichiara di aver sempre posposto la “sinistra cura” nei grandi uffici, cioè di aver privilegiato il potere spirituale sul temporale (Par. XII, 127-129). San Pietro afferma che non fu intenzione sua e dei primi pontefici dividere il popolo cristiano parte alla destra e parte alla sinistra mano, alludendo al favore dato dal papato ai Guelfi contro i Ghibellini (Par. XXVII, 46-48).
■ (sviluppi da Ap 2, 1)
Cristo, che tiene nella destra le sette stelle, visita le chiese, le tiene in suo potere (“tentio … significat potestatem”), le percorre, ne ha cura (“deambulatio”). È il “pius pastor”; sua è la “plenitudo pietatis” (nella citazione, ad Ap 22, 2, del Lignum vitae di Bonaventura) propria del “pastor bonus” (Jo 10, 14). Beatrice, nell’Eden, è “quasi ammiraglio che in poppa e in prora / viene a veder la gente che ministra / per li altri legni, e a ben far l’incora”; ha visitato “l’uscio d’i morti” affinché Virgilio le conducesse Dante (Purg. XXX, 58-60, 139-141). Dante, nelle parole di Francesca, visita l’inferno e prova pietà dei mali (Inf. V, 88-93). Buonconte da Montefeltro, nel purgatorio, gli si rivolge come al buon pastore: “con buona pïetate aiuta il mio! … Giovanna o altri non ha di me cura” (Purg. V, 85-90).
Il verbo ‘tenere’ assume un’accezione particolare nella perdita del primato minacciata alla chiesa di Efeso, qualora insuperbisca e perda l’aurea carità originaria (Ap 2, 5).
■ (sviluppi da Ap 5, 1)
Il libro, tenuto nella destra da Dio Padre, contiene le leggi, i precetti e le sentenze del sommo imperatore e giudice. È “scritto dentro e fuori” perché, come la Scrittura, ha di fuori un senso letterale o storico, mentre dentro sono i sensi più nascosti (allegorico, morale, anagogico) e di più profonda sapienza, che richiedono un’alta mente per comprenderli intellettualmente.
● I temi propri del libro, da Ap 5, 1, sono presenti nella presentazione che Giustiniano fa di sé stesso (Par. VI, 10-12, 22-27): trarre “d’entro le leggi” (il libro contiene all’interno le leggi del sommo imperatore); “l’alto lavoro” (che corrisponde all’alta mente richiesta per l’intelligenza del libro); “la destra del ciel … sì congiunta” alle imprese di Belisario (il libro sta nella destra di Dio e contiene le promesse della grazia e della gloria; il congiungere è tema appropriato ai forti angoli – segno di futura vittoria – delle mura della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione [Ap 21, 12], come pure il ‘posarsi’ è tema connesso con lo stadio, che è misura della città [Ap 21, 16]). Da Ap 5, 8, dove si tratta delle coppe (“phiale”) tenute in mano dai seniori, deriva il tema dello spirare da parte del primo d’amore e quello del beneplacito divino. Su quest’ultimo punto è possibile una collazione con il passo simmetrico di Ap 16, 1, in cui i ministri del giudizio si apprestano a versare le coppe per ispirazione, comando e beneplacito di Dio, passo che si riverbera nelle parole di Ulisse – “com’ altrui piacque” (Inf. XXVI, 141) – e in quelle, dello stesso Giustiniano, sul “sacrosanto segno” per cui “Cesare per voler di Roma il tolle” (Par. VI, 57; il volere del popolo romano coincise con il volere divino).
●Sulle stesse parti del panno esegetico di Ap 5, 1.8 sono tessute le parole di Tommaso d’Aquino relative a Salomone, la più splendente fra le luci nel cielo del Sole: gli elementi semantici sono i medesimi, ma non c’è alcun riferimento alla “destra” (Par. X, 109-114). Che questa abbia comunque un valore connesso all’impero è indicato dal maggior risplendere di Costanza d’Altavilla, la genitrice di Federico II – “’l terzo e l’ultima possanza” -, alla destra di Piccarda (“da la mia destra parte”), nel cielo della Luna (Par. III, 109-111, 118-120).
■ Non “sanza voler divino e fato destro” – come promesso nel libro che contiene i divini decreti – Virgilio va a “tal baratta” coi Malebranche (Inf. XXI, 79-84). La ‘destra mano’, segno di sicura andata, non si registra nell’inferno unicamente con il volgersi verso gli eretici e nello scendere all’approdo di Gerione. Nel drammatico passaggio dalla quinta alla sesta bolgia, sovrastati dai diavoli che li inseguono, Virgilio e Dante sono aiutati dalla “destra costa” che giace, che cioè pende meno ripida (Inf. XXIII, 31-33). La costa che giace o che cala, aprendo la via verso il basso nell’inferno, verso l’alto nel purgatorio, è segnale della pietas condiscendente del quinto stato che frange l’arditezza insostenibile del precedente quarto stato anacoretico. Sempre “alla man destra giace” la “foce” per passare dalla sesta alla settima bolgia, della quale dice il frate Catalano dei Malavolti: “ Più che tu non speri / s’appressa un sasso che da la gran cerchia / si move e varca tutt’ i vallon feri, / salvo che ’n questo è rotto e nol coperchia; / montar potrete su per la ruina, / che giace in costa e nel fondo soperchia” (vv. 127-138). Muoversi dei sassi e delle pietre è proprio dell’apertura del sesto sigillo (siamo nella sesta bolgia), in concomitanza con il grande terremoto (Ap 6, 12-17); il ‘giacere in costa’ appartiene al precedente pietoso quinto stato (gli stati sono connessi fra loro per “concurrentia”), pietas portata al sommo dal più alto stato seguente. La domanda di Virgilio al frate bolognese accosta alla “man destra” un’espressione – “Non vi dispiaccia” (con il limitativo “se vi lece”, perché è domanda rivolta a un dannato) – in un modo che sarà poi proprio di Giustiniano esecutore della volontà divina: “… a Dio per grazia piacque di spirarmi / l’alto lavoro … / e al mio Belisar commendai l’armi, / cui la destra del ciel fu sì congiunta …” (Par. VI, 22-27). Se ad Ap 5, 1 il libro sta nella destra di Colui che siede sul trono, ad Ap 5, 8 le coppe dei seniori, che fanno onore all’Agnello degno di aprire il libro, designano le preghiere che piacciono e sono accette. Questo “sasso che da la gran cerchia / si move e varca tutt’ i vallon feri” designa il sesto stato, preminente sui primi cinque precedenti, “rotto” sulla sesta bolgia per il terremoto verificatosi in occasione della morte di Cristo (che si rinnova nel sesto stato, nel secondo avvento di Cristo nello Spirito), ma le cui macerie consentono di salire sull’argine: «Dixeruntque “montibus et petris”, id est sanctis sublimibus et firmis in fide: “Cadite super nos”, per piam scilicet affectionem et condescensionem … Ex ipso etiam timore fugient et abscondent se “in speluncis” et inter saxa montium (cfr. Ap 6, 15-17)». Anche in questo caso, dunque, la ‘mano destra’ segna il cammino sicuro, voluto nel cielo, come scritto nel libro, promesso ed elargito. Si tratta di un’elargizione liberale, indicata nelle parole del frate Catalano: «Rispuose adunque: “Più che tu non speri / s’appressa un sasso …”». Il sesto stato, amato più che amante, paziente più che agente (Ap 3, 7), riceve più degli altri stati i segni dell’amicizia divina. La liberalità è prerogativa della tribù di Levi, una delle dodici da cui verranno eletti i 144.000 segnati all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 7).
■Fra i falsari dell’ultima bolgia, “due tapini / che fumman come man bagnate ’l verno” – la moglie di Putifarre e Sinone greco di Troia – giacciono stretti alla destra (ai “destri confini”) di maestro Adamo (Inf. XXX, 91-93). L’accostamento del ‘giacere’ alla ‘destra’ non ha, in questo caso, il valore positivo del giacere della “destra costa” nel passaggio dalla quinta alla sesta bolgia (Inf. XXIII, 31-33). La mano destra, più forte della sinistra (Ap 1, 16), è comica allusione alla successiva rissa tra il falsario toscano e quello greco, un “piato”, come dice l’adirato Virgilio a Dante che si è fermato a guardarlo, tutt’altro che spirituale, come dovrebbe essere ciò che sta a destra. La rissa è in parte (Inf. XXX, 100-108) elaborata sui temi dell’esegesi di Ap 13, 3, relativa ai tre anni e mezzo di guerra mossi dall’Anticristo per conseguire la monarchia universale, prima perduta e poi recuperata (Olivi segue il V libro della Concordia di Gioacchino da Fiore). Nel primo anno di guerra l’Anticristo, una volta che gli sarà stato restituito il regno prima perduto, subito muoverà una guerra assai atroce, della quale si dice in Daniele: “Le braccia del combattente (brachia pugnantis) saranno annientate davanti a lui e sarà stroncato anche il capo dell’alleanza” (Dn 11, 22). Infatti, dopo essergli stato amico lo ingannerà. Nel secondo anno di guerra, verrà percosso nelle proprie membra, e ciò lo accenderà maggiormente in ardore d’ira. Questi motivi – le braccia, il ‘pugnare’, l’essere percossi, le membra – sono appropriati ora all’uno ora all’altro dei due falsari. Nel canto successivo, sono attribuiti a Fialte, il gigante che tentò la scalata all’Olimpo, la sede del sommo Giove: “le braccia ch’el menò, già mai non move”; il suo braccio destro è incatenato indietro (Inf. XXXI, 85-90, 94-96).
■Nel rigirare la montagna del purgatorio, si tiene sempre la destra. L’angelo che volge dal primo al secondo girone promette “sicura l’andata”. Infatti, “a man destra” (dal lato delle promesse e delle elargizioni: Ap 5, 1) “s’allenta la ripa che cade / quivi ben ratta da l’altro girone” (qui nel salire, come a Inf. XXIII, 31-33 la “destra costa” infernale che giace consentendo di scendere). Questa ripa ‘condescensiva’ è paragonata alle scale che salgono a San Miniato al Monte, là dove “si rompe del montar l’ardita foga” (cioè si passa da uno stato troppo arduo e alto, l’anacoretico e contemplativo quarto, ad uno più consono alla vita associata delle moltitudini, che per l’Olivi è quello delle canonie e dei conventi, mentre Dante estende l’esegesi al vivere civile; Purg. XII, 97-108). L’ironica localizzazione della chiesa di San Miniato, la quale sovrasta il ponte costruito dal potestà Rubaconte di Mandella (oggi Ponte alle Grazie) – “per salire al monte / dove siede la chiesa che soggioga / la ben guidata sopra Rubaconte” -, rientra nella tematica della sede divina, dove siede Colui che ha nella mano destra il libro, il quale designa la sede metropolitana che sovrasta e guida le altre (Ap 4, 2-3). L’angelo, che promette, si fregia delle qualità di Cristo descritte ad Ap 22, 16-17: è “mattutina stella” che preannunzia, promettendola, la solare chiarezza del gran giorno; invita, per ispirazione interiore, alla cena delle nozze dell’Agnello (Purg. XII, 88-94, 99).
■ Il libro, che sta nella destra, è scritto dentro e fuori. Questi motivi sono presenti nell’incontro con Adriano V, che giace a terra nel quinto girone del purgatorio, fra gli avari “ne’ piedi e ne le man legati e presi” (Purg. XIX, 79-84). Alla preghiera di Virgilio di indicare la via, viene risposto che “le vostre destre sien sempre di fori”. Dante nel parlare avvisa però “l’altro nascosto”, cioè non ancora visibile ma solo udibile. Come detto ad Ap 9, 16-17 (dove si distingue tra l’ascoltare il numero dei cavalieri e il vedere i cavalli dell’esercito sciolto al suono della sesta tromba, nel senso che l’ascoltare viene riferito ai più sapienti – i cavalieri -, mentre il vedere alle plebi sensuali – i cavalli), con l’udito percepiamo ciò che è sottile, segreto e intelligibile senza vederlo o palparlo. Il motivo si ritroverà nell’incontro con Forese (Purg. XXIII, 43-45) e si è registrato in precedenza con Marco Lombardo (Purg. XVI, 34-36) e ancor prima nel ruscelletto il cui suono accompagna i poeti nell’uscita dall’inferno (Inf. XXXIV, 127-132). “L’altro nascosto”, che corrisponde all’interno del libro “scritto dentro e fuori”, può appunto significare un senso interno, allotrio: allora l’espressione “le vostre destre sien sempre di fori” – detta dal papa che in un mese e poco più provò “come / pesa il gran manto a chi dal fango il guarda”, che da “roman pastore” scoprì “la vita bugiarda” improntata all’avarizia – avrebbe il senso: ‘i vostri desideri siano sempre manifestamente volti alle cose spirituali (“palese e coverto … per un cammino”: cfr. Par. XXX, 143-144), che sono alla destra di Dio’. Insomma, come dirà san Bonaventura nel cielo del Sole, “ne’ grandi offici / sempre posponete la sinistra cura”.
■ (Ap 5, 1 → 2, 10-11) Il libro, che sta nella destra di Dio padre, contiene le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo (Ap 5, 1). A Smirne, la chiesa dei martiri, seconda delle sette d’Asia (prima visione), Cristo promette singolare gloria: non deve temere per la sofferenza che uccide i corpi, poiché i martiri sono così sicuri del regno della vita eterna da non temere la “seconda morte” (Ap 2, 10-11). Il concetto di ‘destra’ si estende, in modo analogico, all’essere sicuri, la sicurezza alla sofferenza e al non temere questa. Virgilio va alla “baratta” coi Malebranche “sicuro” e non “sanza voler divino e fato destro”, ma prima dice a Dante di non temere (Inf. XXI, 61-66, 79-84). La promessa dell’angelo che volge al secondo girone della montagna è di “sicura” andata “a man destra”, una sicurezza ribadita nella similitudine con le scale di San Miniato al Monte, “che si fero ad etade / ch’era sicuro il quaderno e la doga”, quando cioè l’amministrazione fiorentina non era ancora corrotta (Purg. XII, 97-108) [4]. Virgilio “passò di là dal co del ponte” verso i diavoli (Inf. XXI, 64); l’andata destrorsa al secondo girone della montagna è verso “il passo / possibile a salir persona viva” (Purg. XI, 49-51), più lieve degli altri ma sempre erto (“ma quinci e quindi l’alta pietra rade”: Purg. XII, 108). ‘Passare‘ non significa solo andare oltre, ma farlo patendo e sostenendo una prova.
Ancora, nel parlare di Adriano V qui sopra considerato, Virgilio e Dante sono “sicuri” dai “soffriri” delle anime, già elette, che scontano la pena giacendo a terra con “i dossi al sù” (Purg. XIX, 76-79). Più avanti, come dice Virgilio, Dante non deve temere di entrare nel fuoco che lo separa dall’Eden dove sta Beatrice: vi entri “sicuro”, come un martire, perché “qui può esser tormento, ma non morte”, da intendere come “seconda morte”, non del corpo, ma dell’anima (Purg. XXVII, 19-21, 31-32; l’espressione “volgiti in qua” è da connettere con Ap 1, 10-11, cfr. qui di seguito).
■ (Ap 1, 10-11) All’inizio della parte narrativa della sua esposizione, Giovanni precisa sette circostanze generali e degne di lode proprie delle visioni successivamente descritte. La sesta circostanza (Ap 1, 10) consiste nel fatto che all’evangelista viene ingiunto solennemente di scrivere la visione e di inviarla alle chiese d’Asia, come se l’autore intendesse dire: non per mia iniziativa, ma per speciale comando divino ho scritto ed invio. Per cui soggiunge: “E udii una voce dietro di me”. Il comando proviene da una voce udita dietro le spalle. Lo stare dietro può essere inteso nel senso che Giovanni era in quel momento dedito alla quiete della contemplazione, lontano dalla sollecitudine derivante dall’attività pastorale, che aveva lasciata alle spalle: la voce dunque lo richiama dalla visione delle cose supreme, che gli stanno dinanzi, alla cura d’anime che sta dietro (è l’interpretazione di Riccardo di San Vittore). Oppure (è l’interpretazione di Olivi), considerando che le cose che ci stanno dietro sono invisibili e pertanto superiori, si può intendere che Giovanni ascolti una voce alle spalle che lo elevi e riconduca verso l’alto, mentre con il volto è rivolto in basso, verso cose inferiori. In questo senso, nel Vangelo di Giovanni, si dice che Maria Maddalena, volta indietro, vide Gesù (Jo 20, 14). Il parlare dietro le spalle, di cui si tratta ad Ap 1, 10-12, è anche quello che proviene dalla guida di Giovanni, che sta dietro come custode e conduce la sua cavalcatura, per cui in Ezechiele si dice: “uno spirito mi sollevò e dietro a me udii una voce” (Ez 3, 12).
Questa esegesi, centrale nelle agnizioni, la si ritrova nel comando dato da Virgilio a Dante: «Ed el mi disse: “Volgiti! Che fai? / Vedi là Farinata che s’è dritto: / da la cintola in sù tutto ’l vedrai”» (Inf. X, 31-33). Volgersi (voltarsi indietro) è un passaggio verso cose superiori, al suono della voce della propria guida; così la mano destra designa ciò che è spirituale, è la mano che guida i sottoposti. Non è dunque casuale che la destra, nei versi, si accompagni al volgersi. Virgilio, ascoltato dal discepolo il suo essere pronto a subire i colpi della Fortuna, “allora in su la gota / destra si volse in dietro e riguardommi”, per poi dirgli: “Bene ascolta chi la nota”, ripetendo il “Beatus qui audit verba prophetie huius et servat ea que in ea scripta sunt” di Ap 1, 3, che costituisce la causa finale del libro (Inf. XV, 97-99; i temi da Ap 1, 10 sono anticipati, con diverso senso, ai vv. 52-54: Dante ha vòlto le spalle alla selva, Virgilio lo riconduce “a ca”, cioè verso l’alto). Il volgersi di Virgilio è dunque promessa di sicura andata a Beatrice, meta che coincide con la causa finale dell’Apocalisse.
Anche il volgersi a man destra di Virgilio a Inf. IX, 132 è riconducibile ad Ap 1, 10 (così pertanto, a Inf. X, 133, il suo volgersi a sinistra).
Il centauro Chirone si volge “in su la destra poppa” per dire a Nesso di guidare i due poeti sul Flegetonte dal bollore sanguigno (Inf. XII, 97-99). Nel purgatorio, come sa Virgilio, si deve sempre tenere il lato destro (“le destre spalle”) verso l’orlo esterno del balzo (Purg. XXII, 121-123). Nell’Eden, “lo glorïoso essercito” (la processione) si volge “’n sul braccio destro” (verso oriente, donde era venuta) (Purg. XXXII, 16-18).
Da notare, qui e altrove, la presenza del verbo ‘tornare’. Con l’eccezione di Inf. XV, 53 (il tornare di Dante nella selva), assume sempre un valore positivo, restitutorio e salutifero: il centauro Nesso, dalla voglia sempre tosta, che fa da guida (Inf. XII, 98); la processione che ‘torna’ “come sotto li scudi per salvarsi / volgesi schiera” (Purg. XXXII, 16-24). ‘Tornare’ è un verbo precipuo della sesta vittoria, ingresso in Cristo e ritorno in lui della Gerusalemme discesa in terra (Ap 3, 12). Le anime degli scomunicati che attendono nell’‘antipurgatorio’ – “quella gente degna” che procede venendo “da man sinistra” -, richieste di indicare la via verso l’alto, dicono: «“Tornate … intrate innanzi dunque”, / coi dossi de le man faccendo insegna» (Purg. III, 58-60, 100-102). La luce del sole, che prima colpiva Dante da dietro (vv. 16-18; ciò che sta dietro è superiore), è però “rotta” dal corpo del poeta che fa ombra, prima “dinanzi” a sé, poi dal “destro canto” (vv. 88-90), a significare che il velame imposto da “quel d’Adamo” è ancora presente.
La “vox magna tamquam tube”, che richiama Giovanni a cose superiori (‘destre’) e lo fa volgere indietro, è quella della sua guida. Con diversa appropriazione dei motivi, Dante si stringe a Virgilio, “in destro” facendo il passo (il poeta pagano cammina alla destra del discepolo, il quale si volge verso di lui), al tuonare della voce dell’invidiosa Aglauro, secondo esempio, sulla montagna, di invidia punita (Purg. XIV, 136-141; lo stringersi, che sempre indica un dubitoso pericolo, e la destra sono già congiunti, per ironia, nei due lebbrosi stretti ai “destri confini” di maestro Adamo: Inf. XXX, 91-93).
È voce che richiama l’Evangelista a cose superiori e più alte (designate dalla destra): così il poeta si volge dal “destro lato” verso Beatrice (che però tace), prima di passare dal cielo di Marte a quello più alto di Giove (Par. XVIII, 52-54).
Nel quinto girone del purgatorio – dove gli avari e i prodighi, che non si elevarono dalle cose terrene a quelle superiori, sono puniti volgendo i propri “diretri” al cielo (‘contrapasso’ del richiamo per cui Maria Maddalena, “conversa retrorsum”, vide Cristo, e per cui Giovanni si volge verso la propria guida) -, alle parole (che si riveleranno essere quelle di Adriano V) che indicano di tenere “le … destre … sempre di fori”, Dante volge gli occhi a quelli di Virgilio (Purg. XIX, 79-87).
■Ancor più della destra, a Cristo spetta il centro. È questo un punto chiave del pensiero escatologico dell’Olivi. La singolare ed esemplare vita di Cristo, imposta agli Apostoli e scritta nei Vangeli, deve essere dalla nostra vita perfettamente imitata e partecipata e porsi come fine di ogni nostra azione (prologo, notabile VII). Cristo è centro intimo della sfera-Chiesa, che si mostra a tutti e a cui guardano tutte le linee degli eletti (Ap 1, 13; 5, 6: il “centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentie partes” di Vita Nova, 5.11 [xii 4]). È “in medio vite”, cioè in mezzo alla vita e alla dottrina evangelica scritta dai quattro evangelisti (Ap 5, 6). È guida che mostra il cammino, che bisogna imitare e seguire partecipando delle sublimi perfezioni costituite dai suoi precetti e consigli (Ap 14, 4). È l’Agnello che sta in mezzo al trono e conduce alle fonti delle acque di eterna vita (Ap 7, 17). Conosce tutti gli atti e pensieri, ogni bene e male (Ap 2, 1). Tiene nella destra sette stelle (i vescovi), che rilucono sui sette candelabri (le chiese), ossia ha potestà sui principi e prelati di tutte le chiese storiche presenti e future, che percorre con la sua mediana “perambulatio” e visita nel suo cammino di guida, signore e pio pastore che tutto scruta e penetra (Ap 1, 13; 2, 1.5). Il suo corpo ha raggiunto per crescita la perfezione dell’età virile, come l’ordine evangelico, suo imitatore, nel sesto stato della Chiesa deve raggiungere la maturità (Ap 6, 12). Questi luoghi sono stati esaurientemente esposti altrove; qui li si cita a proposito dell’invocazione al sole fatta da Virgilio a Purg. XIII, 13-21.
Il poeta pagano, di Cristo “sol mundi” perfetto imitatore, si rivolge fiducioso al sole perché conduca entro i gironi della montagna, ma prima “fece del destro lato a muover centro” (da notare la corrispondenza fra “sacerdos legalis debebat semper sollicitam curam habere … esser dien sempre li tuoi raggi duci”, per cui Virgilio, che appartiene alla vecchia legge, fa tirocinio di vita evangelica nella nuova). ‘Torcere’ è un motivo dall’esegesi dell’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5). Ivi si dice della bilancia (la Scrittura), equilibrata fra dritto e torto (l’interpretazione data dagli eretici): torcere la parte sinistra significa rettificare la parte temporale, modificando il valore negativo del ‘torcere’, insito nel lato sinistro, in positivo (esempio contrario è Ciacco, il quale “li diritti occhi torse allora in biechi”, Inf. VI, 91). Virgilio, con il fissare gli occhi al sole, partecipa anche dei motivi espressi dalla grande esegesi di Ap 19, 17-18.
Nel modo di Virgilio si comporterà anche Pier Damiani il quale, beato, non avrà però bisogno di torcere la sinistra parte come il poeta pagano, perché “del suo mezzo fece il lume centro” (Par. XXI, 80).
Figura per eccellenza del sommo pastore, in tutte le sue manifestazioni, è Beatrice. Si ricordi anche solo il suo venire “quasi ammiraglio … a veder la gente che ministra” (Purg. XXX, 58-60), il suo “bell’occhio tutto vede” del corso della vita dell’amico (Inf. X, 130-132), la sua parola che va “dal centro al cerchio” (Par. XIV, 1-3), muove cioè dal mezzo, come Cristo è centro intimo della sfera-Chiesa, che si mostra a tutti e a cui guardano tutti i raggi degli eletti.
■ (Ap 4, 1-2) In altro punto Giovanni viene elevato a cose superiori. Ad Ap 4, 1-2 – nella parte ‘radicale’ della seconda visione (l’apertura dei sette sigilli; cfr. anche altrove) – ancora la voce che aveva dapprima udito come suono di tromba (Ap 1, 10) lo chiama a più alta visione. Ogni illuminazione dispone la mente a riceverne una più alta e nuova: così vedere il cielo aprirsi e udire la voce possente come una tromba disponevano e stimolavano l’evangelista alle seguenti visioni. Ciò che, nella visione, è maggiore e nuovo richiama ancora, nell’inferno, l’essere ‘destro’: nella prima bolgia, infatti, Virgilio e Dante muovono verso sinistra (che Virgilio ‘tiene’ con potestà ‘vescovile’: cfr. Ap 2, 1), ma è “a la man destra” che Dante vede “nova pieta, / novo tormento e novi frustatori” (Inf. XVIII, 19-24). Così più avanti, nel passaggio dalla prima zona alla seconda della bolgia (dai ruffiani ai seduttori, le cui schiere procedono in senso inverso), i due si volgono a destra salendo un ponte (vv. 70-72). Si tratta dello scoglio gettato sulla bolgia: la destra non è solo una via obbligata dopo l’iniziale svolta a sinistra lungo la ripa; corrisponde infatti a un passaggio verso una nuova e più ardua visione (quale potrà essere il vedere dannato Giasone, colui “che per cuore e per senno / li Colchi del monton privati féne”, vv. 82-87).
■ Un altro significato per ‘destra’ è offerto ad Ap 5, 5, con riferimento alle acque che sgorgano dal lato destro del tempio, secondo Ezechiele, 47, 3-5, passo che rientra fra i molti la cui esegesi concorre a segnare il complesso episodio della corda (Inf. XVI, 106ss.).
[1] Nel commento rifatto da G. VANDELLI, Milano 1987 (1928), ad locum (p. 73).
[2] CHIAVACCI LEONARDI, Inf. IX, 132 (pp. 294-295).
[3] INGLESE, Inf. IX, 132 (p. 127).
[4] “Sicuro” non trae i suoi significati da un unico punto della Lectura. Il principio della collazione analogica fa sì che vi possano rientrare altri luoghi. Ad esempio, le scale di San Miniato, “che si fero ad etade / ch’era sicuro il quaderno e la doga”, sono riconducibili non solo alla sicurezza designata dalla destra, ma anche alla sua inopinata fine, come detto ad Ap 3, 3, dove pace e sicurezza sono tolte a quanti vengono sorpresi per il loro esser tardi, dormienti o non vigilanti, per l’improvviso arrivo del ladro (Cristo giudice): «… dicit Apostolus quod “dies Domini veniet in nocte sicut fur. Cum enim dixerint: pax et securitas, tunc superveniet eis repentinus interitus” (1 Th 5, 2-3)». Il senso allora è simile a quanto ha già detto Iacopo del Cassero, sulla sua eccessiva sicurezza: “ma li profondi fóri / ond’ uscì ’l sangue in sul quale io sedea, / fatti mi fuoro in grembo a li Antenori, / là dov’ io più sicuro esser credea” (Purg. V, 73-76). Così anche Rubaconte di Mandella, il potestà che nel 1237 fece costruire il ponte delle Grazie, rientra nella tematica dell’occulto sopravvenire della fine fura di un tempo pacifico e sicuro.
Tab. App.1
Inf. XXVI, 110-111, 126-128da la man destra mi lasciai Sibilia,
|
Purg. I, 22-24I’ mi volsi a man destra, e puosi mente
|
|
[LSA, cap. I, Ap 1, 16 (Ia visio, radix)] Octava (perfectio summo pastori condecens) est potestativa presidentia et continentia non solum ecclesiarum sed etiam suorum rectorum, unde subdit: “et habebat in dextera sua septem stellas” (Ap 1, 16), per quas ut infra dicetur (cfr. Ap 1, 20) designantur septem episcopi ecclesiarum. Episcopus enim debet sic super ecclesiam sibi subiectam lucere et presidere sicut lux lucerne stabat quasi stella super candelabrum sanctuarii (cfr. Ex 25, 37). Sicut etiam inferiora illuminantur et reguntur per stellas, sic ecclesie per sanctos episcopos.
|
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (IIa visio, radix)] Visus autem est “in dextera” Dei, tum quia est in eius plena potentia et facultate, tum quia continet promissiones Christi gratie et glorie et etiam largitiones et preparationes, que dicuntur spectare ad dexteram sicut adversa vel bona temporalia dicuntur spectare ad sinistram. Erat etiam “in dextera sedentis super tronum”, tum quia continet leges et precepta summi imperatoris et sententias et iudicia summi iudicis, tum quia altam et stabilem et maturam et quietam ac recollectam mentem requirit ad hoc quod intel-lectualiter haberi et intelligi possit, unde et talis est intelligentia Dei.
|
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (Ia visio, Ia ecclesia)] Secundum est Christi alloquentis hanc ecclesiam et eius episcopum introductio, cum subditur (Ap 2, 1): “Hec dicit qui tenet septem stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum”. Utitur autem tentione stellarum, id est episcoporum, et perambulatione candelabrorum, id est ecclesiarum, triplici ex causa. Prima est ut ostendat se intime scire omnia bona et mala ipsorum, quasi diceret: ille qui bene scit omnes vestros actus et cogitatus, tamquam infra se immediate vos omnes tenens et tamquam in medio vestrum existens et omnia vestra continue perambulans et perscrutans et immediate percurrens seu conspiciens, dicit vobis hec que sequuntur. Secunda est ad monstrandum quod merito habent ipsum et eius minas et iudicia metuere eiusque monita et precepta servare, et etiam quod habent ipsum amare et in ipso sperare et ex eius amore et spe omnia verba eius servare, quia ipse est eorum iudex et dominus ipsos prepotenter tenens et circumspectissime examinans. Ipse etiam est pius pastor eos protegens et custodiens, et pro eorum custodia eos semper tenens et visitans. Tertia est quia metropolitano episcopo et eius metropoli ceteras ecclesias sub se habenti hic loquitur, et ideo significat se habere potestatem et curam super omnes septem episcopos et eorum ecclesias. Tentio enim significat potestatem et perambulatio vero curam. […] Ad humiliationem autem sue superbie et manifestationem primatus Christi super legalia et super omnia secula valet quod premittitur Christus tenere in sua dextera “septem stellas” (Ap 2, 1), id est omnes preclaros principes et prelatos omnium ecclesiarum presentialiter precurrere ac visitare omnes ecclesias presentes et futuras. Ex quo patet quod Christus est summus rex et pontifex, et quod multe alie sollempnes ecclesie preter Ierosolimitanam ecclesiam sunt et esse debebant sub Christo, ita quod non oportebat eam superbire de suo primatu (cfr. Ap 2, 5). |
||
|
Inf. XVI, 118-120Ahi quanto cauti li uomini esser dienno
|
|
Tab. App.2
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (radix IIe visionis)] “Et vidi in dextera sedentis super tronum librum scriptum intus et foris, signatum sigillis septem” (Ap 5, 1). Preostensa gloria et magnificentia maiestatis Dei, hic accedit ad ostendendum profunditatem incomprehensibilem libri sui. Qui quidem liber est primo idem quod Dei essentialis prescientia et totius reparationis universe fiende per Christum predestinatio, et per appropriationem est ipsum Verbum Patris prout est expressivum sapientie eius et prout Pater, ipsum generando, scripsit in eo omnem sapientiam suam. […]
|
|
Par. VI, 10-12, 22-27Cesare fui e son Iustinïano,
|
Par. X, 109-114La quinta luce, ch’è tra noi più bella,
|
Purg. IV, 1-4, 67-69Quando per dilettanze o ver per doglie,
|
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 12 (VIIa visio)] Secundum autem Ricardum, per duodecim angulos cuiuslibet porte intelliguntur universi minores et meritis occultiores, quia angulus occultum significat, et duodenarius universitatem.
|
[LSA, cap. XXI, Ap 21, 16 (VIIa visio)] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia” (Ap 21, 16). Stadium est spatium in cuius termino statur vel pro respirando pausatur, et per quod curritur ut bravium acquiratur, secundum illud Apostoli Ia ad Corinthios, capitulo IX°: “Nescitis quod hii, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium?” (1 Cor 9, 24), et ideo significat iter meriti triumphaliter obtinentis premium. Cui et congruit quod stadium est octava pars miliarii, unde designat octavam resurrectionis. Octava autem pars miliarii, id est mille passuum, sunt centum viginti quinque passus, qui faciunt duodecies decem et ultra hoc quinque; in quo designatur status continens perfectionem apo-stolicam habundanter implentem decalogum legis, et ultra hoc plenitudinem quinque spiritualium sen-suum et quinque patriarchalium ecclesiarum. |
Par. VI, 22-27Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,
|
Par. IX, 115-117, 121-123Or sappi che là entro si tranquilla
|
Tab. App.3
[LSA, cap. I, Ap 1, 16 (Ia visio, radix)] Quia vero dextera manus est potentior quam sinistra, ideo dicit quod Christus habet eas “in dextera sua”, tamquam eius summe potentie subiectissimas. Quia etiam dextera designat potentiora bona et poten-tiorem partem, ideo dicuntur esse in dextera Christi quia spiritualem potestatem et statum dedit episco-pis, temporalem vero regibus mundi, et ideo illi sunt quasi in sinistra Christi. Nota etiam per hoc innui quod superior prelatus debet potestative et exem-plariter et causaliter in se habere omnes stellares perfectiones inferiorum prelatorum, quod utique Christus plenissime habet. |
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (IIa visio, radix)] Visus autem est “in dextera” Dei, tum quia est in eius plena potentia et facultate, tum quia continet promissiones Christi gratie et glorie et etiam largitiones et preparationes, que dicuntur spectare ad dexteram sicut adversa vel bona temporalia dicuntur spectare ad sinistram. Erat etiam “in dextera sedentis super tronum”, tum quia continet leges et precepta summi imperatoris et sententias et iudicia summi iudicis, tum quia altam et stabilem et maturam et quietam ac recollectam mentem requirit ad hoc quod intel-lectualiter haberi et intelligi possit, unde et talis est intelligentia Dei. |
Inf. XXX, 91-93, 100-108E io a lui: “Chi son li due tapini
|
Purg. XIV, 139-141“Io sono Aglauro che divenni sasso”;
|
Tab. App.4
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (radix IIe visionis)] Visus autem est “in dextera” Dei, tum quia est in eius plena potentia et facultate, tum quia continet promissiones Christi gratie et glorie et etiam largitiones et preparationes, que dicuntur spectare ad dexteram sicut adversa vel bona temporalia dicuntur spectare ad sinistram.
|
|
Purg. XI, 49-51ma fu detto: “A man destra per la riva
|
[LSA, cap. II, Ap 2, 10 (Ia visio, IIa ecclesia)] Secundo eius ad futuras passiones impavide expectandas et tolerandas confortatio, ibi: “Nichil horum timeas” (Ap 2, 10). Tertio futurarum passio-num eius predictio, ibi: “Ecce missurus est”. Quarto eius ad constantem et invincibilem concertationem et perseverantiam exhortatio, ibi: “Esto fidelis” (ibid.). Quinto ipsius per promissionem singularis glorie confirmatio, ibi: “et dabo tibi” (ibid.). […] “Esto fidelis usque ad mortem”, id est fideliter pro mea fide concerta “usque ad mortem”, id est usque ad ultimum diem vite tue vel usque ad sufferentiam martirii interfectivi tui corporis, “et dabo tibi coronam vite”, scilicet eterne post mortem.[LSA, cap. II, Ap 2, 11 (Ia visio, IIa victoria)] Secunda est victoriosus congressus cum mundo et eius temptamentis, qui correspondet congressui martirum cum paganis et eorum idolis, quibus competit premium de quo secunde ecclesie dicitur: “Qui vicerit non ledetur a morte secunda” (Ap 2, 11). Dignum est enim ut qui mortifera iacula mortis et temptationum et mortificationum victoriose susti-nuerit non ledatur a morte eterna, que respectu predicte et respectu mortis culpe vocatur secunda. Leditur autem ab ea non solum qui ipsam experitur, sed etiam qui terretur ex illa, et maxime si est terror desperativus vel consternativus. Victores autem isti sunt sic securi de regno vite eterne quod non timent incidere in mortem secundam.
|
[LSA, cap. IV, Ap 4, 2-3 (radix IIe visionis)] Quoniam autem presentatio seu descriptio summe magnificentie et reverentie et sapientie maiestatis Dei et assistentium sibi plurimum confert ad advertendum profundam et altam et gloriosam continentiam huius libri a Dei dextera tenti, idcirco in prima parte magnificatur Dei maiestas ex septem. […]
|
|
Tab. App.5
[LSA, cap. I, Ap 1, 16 (Ia visio, radix)] Quia vero dextera manus est potentior quam sinistra, ideo dicit quod Christus habet eas “in dextera sua”, tamquam eius summe potentie subiectissimas. Quia etiam dextera designat potentiora bona et poten-tiorem partem, ideo dicuntur esse in dextera Christi quia spiritualem potestatem et statum dedit episco-pis, temporalem vero regibus mundi, et ideo illi sunt quasi in sinistra Christi. Nota etiam per hoc innui quod superior prelatus debet potestative et exem-plariter et causaliter in se habere omnes stellares perfectiones inferiorum prelatorum, quod utique Christus plenissime habet. |
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (IIa visio, radix)] Visus autem est “in dextera” Dei, tum quia est in eius plena potentia et facultate, tum quia continet promissiones Christi gratie et glorie et etiam largitiones et preparationes, que dicuntur spectare ad dexteram sicut adversa vel bona temporalia dicuntur spectare ad sinistram. Erat etiam “in dextera sedentis super tronum”, tum quia continet leges et precepta summi imperatoris et sententias et iudicia summi iudicis, tum quia altam et stabilem et maturam et quietam ac recollectam mentem requirit ad hoc quod intel-lectualiter haberi et intelligi possit, unde et talis est intelligentia Dei. |
[LSA, cap. I, Ap 1, 10 (VIa-VIIa circumstantia visionum)] Sexta circumstantia est sollempnis iussio sibi facta ut visiones has sollempniter scribat et septem ecclesiis Asie mittat, quasi dicat: non meo motu, sed Dei speciali iussu hec scripsi et mitto. Unde subdit: “et audivi post me vocem” (Ap 1, 10).
|
|
Inf. IX, 132-133; X, 133
|
Purg. XIV, 136-141Come da lei l’udir nostro ebbe triegua,
|
Tab. App.6
[LSA, cap. I, Ap 1, 16 (Ia visio, radix)] Quia vero dextera manus est potentior quam sinistra, ideo dicit quod Christus habet eas “in dextera sua”, tamquam eius summe potentie subiectissimas. Quia etiam dextera designat potentiora bona et poten-tiorem partem, ideo dicuntur esse in dextera Christi quia spiritualem potestatem et statum dedit episco-pis, temporalem vero regibus mundi, et ideo illi sunt quasi in sinistra Christi. Nota etiam per hoc innui quod superior prelatus debet potestative et exem-plariter et causaliter in se habere omnes stellares perfectiones inferiorum prelatorum, quod utique Christus plenissime habet. |
[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (IIa visio, radix)] Visus autem est “in dextera” Dei, tum quia est in eius plena potentia et facultate, tum quia continet promissiones Christi gratie et glorie et etiam largitiones et preparationes, que dicuntur spectare ad dexteram sicut adversa vel bona temporalia dicuntur spectare ad sinistram. Erat etiam “in dextera sedentis super tronum”, tum quia continet leges et precepta summi imperatoris et sententias et iudicia summi iudicis, tum quia altam et stabilem et maturam et quietam ac recollectam mentem requirit ad hoc quod intel-lectualiter haberi et intelligi possit, unde et talis est intelligentia Dei. |
[LSA, cap. VI, Ap 6, 5 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal” (Ap 6, 5), scilicet quod habebat faciem hominis, “dicens: Veni”, scilicet per maiorem attentionem vel per imitationem fidei doctorum hic per hominem designatorum, “et vide. Et ecce equus niger”, id est hereticorum et precipue arrianorum exercitus astutia fallaci obscurus et erroribus luci Christi contrariis denigratus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet imperatores et episcopi arriani, “habebat stateram in manu sua”. Cum statera mensuratur quantitas ponderum, et ideo per stateram designatur hic mensuratio articulorum fidei, que quando fit per rectam et infallibilem regulam Christi et scripturarum suarum est recta statera, de qua Proverbiorum XVI° dicitur: “Pondus et statera iudicia Domini sunt” (Pro 16, 11), et Ecclesiastici XXI°: “Verba prudentium statera ponderabuntur” (Ecli 21, 28); quando vero fit per rationem erroneam et per falsam et intortam acceptionem scripture est statera dolosa, de qua Proverbiorum XI° dicitur: “Statera dolosa abhominatio est apud Deum” (Pro 11, 1), et in Psalmo: “Mendaces filii hominum in stateris” (Ps 61, 10), et Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram impiam et sac<c>elli pondera dolosa” (Mic 6, 11). |
|
Purg. XIII, 13-15Poi fisamente al sole li occhi porse;
|
[LSA, cap. XIX, Ap 19, 17-18 (VIa visio)] “Et vidi unum angelum stantem in sole” (Ap 19, 17). Iste designat altissimos et preclarissimos contemplativos doctores illius temporis, quorum mens et vita et contemplatio erit tota infixa in solari luce Christi et scripturarum sanctarum, et secundum Ioachim inter ceteros precipue designat Heliam*. “Et clamavit voce magna omnibus avibus que volabant per medium celi”, id est omnibus evangelicis et contemplativis illius temporis: “Venite, congregamini ad cenam Dei magnam”, id est ad spirituale et serotinum convivium Christi, in quo quidem devorabitur universitas moriture carnis, ut transeat quod carnale est et maneat quod spirituale est.
|
Tab. App.7
[LSA, cap. IV, Ap 4, 1-2 (radix IIe visionis)] “Post hec vidi” (Ap 4, 1). Hic incipit visio secunda, que est de septem apertionibus septem sigillorum libri signati stantis in dextera Dei. In hac igitur primo narratur spiritualis sublevatio Iohannis ad videndum sequentia. Secundo subditur prima pars huius secunde visionis, describens fontalem radicem et causam septem apertionum libri per septem tempora ecclesiastica complendarum, ibi: “Et ecce sedes posita erat in celo” (Ap 4, 2). Tertio subditur propria apertio uniuscuiusque signaculi, capitulo sexto et septimo.
|
|
LSA, cap. I, Ap 1, 16 (Ia visio, radix)] Quia vero dextera manus est potentior quam sinistra, ideo dicit quod Christus habet eas “in dextera sua”, tamquam eius summe potentie subiectissimas. Quia etiam dextera designat potentiora bona et poten-tiorem partem, ideo dicuntur esse in dextera Christi quia spiritualem potestatem et statum dedit episco-pis, temporalem vero regibus mundi, et ideo illi sunt quasi in sinistra Christi. Nota etiam per hoc innui quod superior prelatus debet potestative et exem-plariter et causaliter in se habere omnes stellares perfectiones inferiorum prelatorum, quod utique Christus plenissime habet.
|
Inf. XVIII, 19-24; 70-72In questo luogo, de la schiena scossi
|