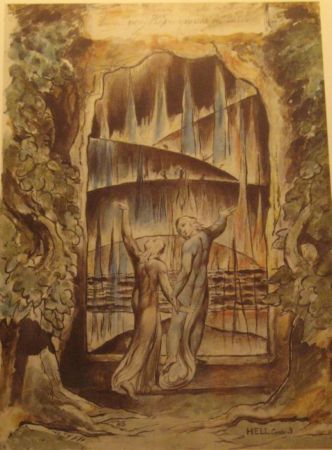La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuoriCanti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXXII, 124-XXXIII, 90
|
Introduzione: Dante “dottore della Chiesa”. 1. “Nel mio bel San Giovanni”. 2. Il fiammeggiante amore fraterno. 3. L’infallibile regola di Cristo. 4. I moderni dottori della Chiesa contro le nuove eresie. 5. La donna che siede sulla bestia scarlatta. 6. “Un tempo, due tempi e la metà di un tempo”. Avvertenze. Abbreviazioni. |
Legenda [3]: numero dei versi; 17, 1: collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]; Not. I: collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. Varianti rispetto al testo del Petrocchi.Viene qui esposto il canto XIX dell’Inferno con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (2013, PDF; cfr. infra), ma si sta procedendo a un esame progressivo e aggiornato dei singoli canti. Ogni tabella sinottica, qui presentata o alla quale si rinvia in quanto già esaminata in altra sede, è preceduta o seguita da una parte esplicativa. Per la posizione di Inf. XIX nella topografia della prima cantica cfr. infra. Sull’uso dei colori cfr. Avvertenze.
|
|
Inferno XIX |
|
O Simon mago, o miseri seguaci
|
Primo ciclo |
Secondo ciclo |
||
Inferno VI |
Inferno XIII |
||
Al tornar de la mente, che si chiuse
|
|||
Terzo ciclo |
Inf. XIX |
O Simon mago, o miseri seguaci
che le cose di Dio, che di bontate
deon essere spose, e voi rapaci [3]
per oro e per argento avolterate,
or convien che per voi suoni la tromba, Not. I
però che ne la terza bolgia state. [6]
Già eravamo, a la seguente tomba,
montati de lo scoglio in quella parte
ch’a punto sovra mezzo ’l fosso piomba. [9]
O somma sapïenza, quanta è l’arte
che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo,
e quanto giusto tua virtù comparte! [12] 16, 6
Io vidi per le coste e per lo fondo
piena la pietra livida di fóri, 6, 5; 2, 12
d’un largo tutti e ciascun era tondo. [15]
Non mi parean men ampi né maggiori
che que’ che son nel mio bel San Giovanni,
fatti per loco d’i battezzatori; [18]
l’un de li quali, ancor non è molt’ anni, 2, 12
rupp’ io per un che dentro v’annegava: 8, 11
e questo sia suggel ch’ogn’ omo sganni. [21]
Fuor de la bocca a ciascun soperchiava
d’un peccator li piedi e de le gambe
infino al grosso, e l’altro dentro stava. [24]
Le piante erano a tutti accese intrambe; 6, 6
per che sì forte guizzavan le giunte, 2, 12
che spezzate averien ritorte e strambe. [27] 6, 5
Qual suole il fiammeggiar de le cose unte 3, 7
muoversi pur su per la strema buccia,
tal era lì dai calcagni a le punte. [30]
« Chi è colui, maestro, che si cruccia
guizzando più che li altri suoi consorti »,
diss’ io, « e cui più roggia fiamma succia? ». [33] 3, 7
Ed elli a me: « Se tu vuo’ ch’i’ ti porti 8, 9
là giù per quella ripa che più giace,
da lui saprai di sé e de’ suoi torti ». [36] 6, 5
E io: « Tanto m’è bel, quanto a te piace:
tu se’ segnore, e sai ch’i’ non mi parto
dal tuo volere, e sai quel che si tace ». [39]
Allor venimmo in su l’argine quarto;
volgemmo e discendemmo a mano stanca
là giù nel fondo foracchiato e arto. [42] 2, 12
Lo buon maestro ancor de la sua anca
non mi dispuose, sì mi giunse al rotto 2, 12
di quel che si piangeva con la zanca. [45]
« O qual che se’ che ’l di sù tien di sotto,
anima trista come pal commessa »,
comincia’ io a dir, « se puoi, fa motto ». [48]
Io stava come ’l frate che confessa Not. XIII
lo perfido assessin, che, poi ch’è fitto,
richiama lui per che la morte cessa. [51]
Ed el gridò: « Se’ tu già costì ritto, 6, 5
se’ tu già costì ritto, Bonifazio?
Di parecchi anni mi mentì lo scritto. [54] 6, 5
Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio 17, 3.6
per lo qual non temesti tòrre a ’nganno
la bella donna, e poi di farne strazio? ». [57]
Tal mi fec’ io, quai son color che stanno,
per non intender ciò ch’è lor risposto, Not. XIII
quasi scornati, e risponder non sanno. [60] 2, 1
Allor Virgilio disse: « Dilli tosto:
“Non son colui, non son colui che credi” »;
e io rispuosi come a me fu imposto. [63]
Per che lo spirto tutti storse i piedi; 6, 5
poi, sospirando e con voce di pianto,
mi disse: « Dunque che a me richiedi? [66]
Se di saper ch’i’ sia ti cal cotanto,
che tu abbi però la ripa corsa,
sappi ch’i’ fui vestito del gran manto; [69]
e veramente fui figliuol de l’orsa, Not. XIII; 8, 10
cupido sì per avanzar li orsatti,
che sù l’avere e qui me misi in borsa. [72] 6, 5
Di sotto al capo mio son li altri tratti 8, 10
che precedetter me simoneggiando, 17, 6
per le fessure de la pietra piatti. [75]
Là giù cascherò io altresì quando
verrà colui ch’i’ credea che tu fossi,
allor ch’i’ feci ’l sùbito dimando. [78]
Ma più è ’l tempo già che i piè mi cossi 12, 14
e ch’i’ son stato così sottosopra,
ch’el non starà piantato coi piè rossi: [81] 12, 14
ché dopo lui verrà di più laida opra, 9, 13; 13, 11
di ver’ ponente, un pastor sanza legge, 2, 1 |
tal che convien che lui e me ricuopra. [84] Not. XIII
Nuovo Iasón sarà, di cui si legge
ne’ Maccabei; e come a quel fu molle
suo re, così fia lui chi Francia regge ». [87]
Io non so s’i’ mi fui qui troppo folle,
ch’i’ pur rispuosi lui a questo metro: 6, 5
« Deh, or mi dì: quanto tesoro volle [90]
Nostro Segnore in prima da san Pietro
ch’ei ponesse le chiavi in sua balìa?
Certo non chiese se non “Viemmi retro”. [93]
Né Pier né li altri tolsero a Matia
oro od argento, quando fu sortito
al loco che perdé l’anima ria. [96]
Però ti sta, ché tu se’ ben punito;
e guarda ben la mal tolta moneta
ch’esser ti fece contra Carlo ardito. [99]
E se non fosse ch’ancor lo mi vieta
la reverenza de le somme chiavi
che tu tenesti ne la vita lieta, [102] 2, 1
io userei parole ancor più gravi;
ché la vostra avarizia il mondo attrista,
calcando i buoni e sollevando i pravi. [105]
Di voi pastor s’accorse il Vangelista, 2, 1
quando colei che siede sopra l’acque 17, 1-2
puttaneggiar coi regi a lui fu vista; [108]
quella che con le sette teste nacque, 17, 3
e da le diece corna ebbe argomento,
fin che virtute al suo marito piacque. [111]
Fatto v’avete dio d’oro e d’argento; 17, 3
e che altro è da voi a l’idolatre,
se non ch’elli uno, e voi ne orate cento? [114]
Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, 8, 10
non la tua conversion, ma quella dote 17, 3
che da te prese il primo ricco patre! ». [117] 17, 6
E mentr’ io li cantava cotai note, 8, 10
o ira o coscïenza che ’l mordesse, 9, 5
forte spingava con ambo le piote. [120]
I’ credo ben ch’al mio duca piacesse,
con sì contenta labbia sempre attese Not. XIII
lo suon de le parole vere espresse. [123] Not. I
Però con ambo le braccia mi prese;
e poi che tutto su mi s’ebbe al petto,
rimontò per la via onde discese. [126]
Né si stancò d’avermi a sé distretto,
sì men portò sovra ’l colmo de l’arco 8, 9
che dal quarto al quinto argine è tragetto. [129]
Quivi soavemente spuose il carco,
soave per lo scoglio sconcio ed erto
che sarebbe a le capre duro varco.
Indi un altro vallon mi fu scoperto. [133]
Non era ancor di là Nesso arrivato,
quando noi ci mettemmo per un bosco
che da neun sentiero era segnato. [3]
Non fronda verde, ma di color fosco; Not. XIII
non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti; 6, 5
non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco. [6]
Non han sì aspri sterpi né sì folti
quelle fiere selvagge che ’n odio hanno
tra Cecina e Corneto i luoghi cólti. [9] 12, 7
Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,
che cacciar de le Strofade i Troiani
con tristo annunzio di futuro danno. [12] 2, 10-11
Ali hanno late, e colli e visi umani,
piè con artigli, e pennuto ’l gran ventre; 2, 22
fanno lamenti in su li alberi strani. [15]
E ’l buon maestro « Prima che più entre,
sappi che se’ nel secondo girone »,
mi cominciò a dire, « e sarai mentre [18]
che tu verrai ne l’orribil sabbione.
Però riguarda ben; sì vederai
cose che torrien fede al mio sermone ». [21] 2, 1
Io sentia d’ogne parte trarre guai
e non vedea persona che ’l facesse;
per ch’io tutto smarrito m’arrestai. [24]
Cred’ ïo ch’ei credette ch’io credesse
che tante voci uscisser, tra quei bronchi,
da gente che per noi si nascondesse. [27] 12, 14
Però disse ’l maestro: « Se tu tronchi 2, 12
qualche fraschetta d’una d’este piante,
li pensier c’hai si faran tutti monchi ». [30] 2, 12
Allor porsi la mano un poco avante
e colsi un ramicel da un gran pruno; 8, 7 2, 12
e ’l tronco suo gridò: « Perché mi schiante? ». [33]
Da che fatto fu poi di sangue bruno, 16, 4; 6, 5
ricominciò a dir: « Perché mi scerpi? 2, 12
non hai tu spirto di pietade alcuno? [36]
Uomini fummo, e or siam fatti sterpi: Not. I
ben dovrebb’ esser la tua man più pia,
se state fossimo anime di serpi ». [39]
Come d’un stizzo verde ch’arso sia 8, 7
da l’un de’ capi, che da l’altro geme
e cigola per vento che va via, [42]
sì de la scheggia rotta usciva insieme 2, 12
parole e sangue; ond’ io lasciai la cima Not. I
cadere, e stetti come l’uom che teme. [45] 12, 16
« S’elli avesse potuto creder prima », 12, 4
rispuose ’l savio mio, « anima lesa, 2, 11
ciò c’ha veduto pur con la mia rima, [48]
non averebbe in te la man distesa;
ma la cosa incredibile mi fece 12, 4
indurlo ad ovra ch’a me stesso pesa. [51] 6, 5
Ma dilli chi tu fosti, sì che ’n vece
d’alcun’ ammenda tua fama rinfreschi
nel mondo sù, dove tornar li lece ». [54]
E ’l tronco: « Sì col dolce dir m’adeschi,
ch’i’ non posso tacere; e voi non gravi 6, 5
perch’ ïo un poco a ragionar m’inveschi. [57] Not. I
Io son colui che tenni ambo le chiavi 2, 1; 3, 7
del cor di Federigo, e che le volsi,
serrando e diserrando, sì soavi, [60]
che dal secreto suo quasi ogn’ uom tolsi; Not. I
fede portai al glorïoso offizio, 2, 10-11; 8, 9
tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e ’ polsi. [63]
La meretrice che mai da l’ospizio
di Cesare non torse li occhi putti, 6, 5
morte comune e de le corti vizio, [66]
infiammò contra me li animi tutti;
e li ’nfiammati infiammar sì Augusto,
che ’ lieti onor tornaro in tristi lutti. [69]
L’animo mio, per disdegnoso gusto, 16, 19-20
credendo col morir fuggir disdegno,
ingiusto fece me contra me giusto. [72] 16, 6
Per le nove radici d’esto legno Not. XIII
vi giuro che già mai non ruppi fede 2, 12
al mio segnor, che fu d’onor sì degno. [75]
E se di voi alcun nel mondo riede,
conforti la memoria mia, che giace 2, 10; 2, 13
ancor del colpo che ’nvidia le diede ». [78]
Un poco attese, e poi « Da ch’el si tace »,
disse ’l poeta a me, « non perder l’ora;
ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace ». [81]
Ond’ ïo a lui: « Domandal tu ancora
di quel che credi ch’a me satisfaccia;
ch’i’ non potrei, tanta pietà m’accora ». [84]
Perciò ricominciò: « Se l’om ti faccia Not. I
liberamente ciò che ’l tuo dir priega, 8, 3
spirito incarcerato, ancor ti piaccia [87] 2, 10
di dirne come l’anima si lega
in questi nocchi; e dinne, se tu puoi,
s’alcuna mai di tai membra si spiega ». [90]
Allor soffiò il tronco forte, e poi 2, 12
si convertì quel vento in cotal voce:
« Brievemente sarà risposto a voi. [93]
Quando si parte l’anima feroce 2, 12
dal corpo ond’ ella stessa s’è disvelta,
Minòs la manda alla settima foce. [96]
Cade in la selva, e non l’è parte scelta;
ma là dove fortuna la balestra,
quivi germoglia come gran di spelta. [99]
Surge in vermena e in pianta silvestra:
l’Arpie, pascendo poi de le sue foglie, Not. III
fanno dolore, e al dolor fenestra. [102]
Come l’altre verrem per nostre spoglie,
ma non però ch’alcuna sen rivesta, Not. I
ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie. [105] 16, 6
Qui le strascineremo, e per la mesta
selva saranno i nostri corpi appesi,
ciascuno al prun de l’ombra sua molesta ». [108]
Noi eravamo ancora al tronco attesi, 2, 12
credendo ch’altro ne volesse dire,
quando noi fummo d’un romor sorpresi, [111]
similemente a colui che venire
sente ’l porco e la caccia a la sua posta,
ch’ode le bestie, e le frasche stormire. [114]
Ed ecco due da la sinistra costa,
nudi e graffiati, fuggendo sì forte, 2, 12
che de la selva rompieno ogne rosta. [117]
Quel dinanzi: « Or accorri, accorri, morte! ».
E l’altro, cui pareva tardar troppo,
gridava: « Lano, sì non furo accorte [120]
le gambe tue a le giostre dal Toppo! ».
E poi che forse li fallia la lena,
di sé e d’un cespuglio fece un groppo. [123]
Di rietro a loro era la selva piena
di nere cagne, bramose e correnti 6, 5; 22, 15
come veltri ch’uscisser di catena. [126]
In quel che s’appiattò miser li denti,
e quel dilaceraro a brano a brano; 22, 15
poi sen portar quelle membra dolenti. [129] 8, 9
Presemi allor la mia scorta per mano,
e menommi al cespuglio che piangea
per le rotture sanguinenti in vano. [132] 2, 12
« O Iacopo », dicea, « da Santo Andrea,
che t’è giovato di me fare schermo?
che colpa ho io de la tua vita rea? ». [135] 17, 6
Quando ’l maestro fu sovr’ esso fermo,
disse: « Chi fosti, che per tante punte
soffi con sangue doloroso sermo? ». [138]
Ed elli a noi: « O anime che giunte
siete a veder lo strazio disonesto 17, 3
c’ha le mie fronde sì da me disgiunte, [141]
raccoglietele al piè del tristo cesto.
I’ fui de la città che nel Batista
mutò ’l primo padrone; ond’ ei per questo [144]
sempre con l’arte sua la farà trista;
e se non fosse che ’n sul passo d’Arno
rimane ancor di lui alcuna vista, [147]
que’ cittadin che poi la rifondarno
sovra ’l cener che d’Attila rimase,
avrebber fatto lavorare indarno.
Io fei gibetto a me de le mie case ». [151] Not. XI
Inf. XIV
Poi che la carità del natio loco
mi strinse, raunai le fronde sparte Not. XI
e rende’le a colui, ch’era già fioco. [3]
Vengono posti a confronto Inf. VI, XIII e XIX, canti nei quali, rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo ciclo settenario dell’Inferno, i temi del terzo stato prevalgono, semanticamente elaborati dalla parodia dantesca. La tematica si estende oltre i confini dei singoli canti e si intreccia con molti motivi propri di altri gruppi esegetici relativi agli status o periodi della storia della Chiesa. Rispetto al più breve sesto canto, il tredicesimo e il diciannovesimo mostrano maggiore sviluppo nelle occorrenze semantiche che rinviano alla Lectura super Apocalipsim (VI: 19; XIII: 34; XIX: 30): prologo (VI: 4; XIII: 8; XIX: 7); terza chiesa (Ap 2, 12-17; VI: 2; XIII: 15; XIX: 6); terzo sigillo (Ap 6, 5-6; VI: 7; XIII: 6; XIX: 9); terza tromba (Ap 8, 10-11; VI: 3; XIII: 0; XIX: 5); terza guerra (Ap 12, 13-16; VI: 2; XIII: 2; XIX: 2); terza coppa (Ap 16, 4-7; VI: 1; XIII: 3; XIX: 1).
La parodia si esercita su luoghi, comuni ai canti, riferibili a stati diversi dal terzo. Essi sono propri, nel confronto tra Inf. VI e XIII, del prologo (Notabile XI); delle parti proemiali alle singole visioni (terza visione: 8, 3; sesta visione: 16, 19-21); del primo stato (prima chiesa: Ap 2, 1; prima tromba: 8, 7; prima guerra: 12, 4); del secondo stato (seconda chiesa: Ap 2, 10-11; seconda guerra: Ap 12, 7.9); del quarto stato (Notabile III; quarta chiesa: 2, 22; quarta guerra, concorrente con la terza: 12, 16); della settima visione (22, 15). Il confronto tra Inf. VI e XIX registra due di tali luoghi: primo stato (prima chiesa: Ap 2, 1); sesto stato (sesta tromba e sesta guerra: Ap 9, 13; 13, 11); quello tra Inf. XIII e XIX è più ricco di coincidenze: primo stato (prima chiesa: Ap 2, 1); secondo stato (seconda tromba: Ap 8, 9); sesto stato (sesta chiesa: Ap 3, 7). Comuni ai tre canti sono le variazioni, più numerose in Inf. XIX, su temi dal capitolo 17: questo riguarda la sesta visione (Ap 16, 18-19, 21), anch’essa come le altre divisibile in sette momenti: 17, 1-3 (primo stato); 17, 4-6 (secondo stato; per maggiore evidenza tutti i riferimenti al cap. 17 sono resi in rosso).
Introduzione
Dante “dottore della Chiesa”
Il terzo stato: la ragione contro l’errore. Il terzo stato della storia della Chiesa, dopo il primo periodo degli apostoli e il secondo dei martiri, va dalla conversione di Costantino per opera di Silvestro papa (312), o dal concilio di Nicea (325), fino a Giustiniano (527-565). In esso, precedendo o posticipando i limiti cronologici per il principio della “concurrentia” fra gli stati, fiorirono i dottori, combattenti contro le eresie: Clemente Alessandrino, il maestro di quell’Origene che cadde nell’eresia come stella ardente dal cielo; Atanasio, Ilario di Poitiers, Ambrogio, Girolamo, Agostino, Basilio e Gregorio di Nazianzo, fino a Gregorio Magno. Gli status non sono però solo periodi storici, ma anche modi di essere degli individui, habitus. Le caratteristiche del periodo, pertanto, si ritrovano in tutti gli altri momenti, possono essere appropriate ad altri tempi e a differenti individui e ridondano nel sesto stato, il punto più importante della storia umana, sua causa finale, che dalla conversione di Francesco all’Anticristo percorre tutto il XIII secolo e oltre, corrispondendo per Olivi (morto nel 1298), e per Dante, ai tempi moderni e contemporanei.
Segnato dal primato dell’intelletto sui sensi, realizzazione dell’uomo razionale, il terzo stato è il luogo della discrezione e dell’esperienza, al cui regime soggiace il falso e nebuloso immaginare; il luogo del sapere (la “cura sciendi”) che è “de veris et de utilibus, seu de prudentia regitiva actionum et de scientia speculativa divinorum”; è il depositario della lingua vera e della vera fede, della Scrittura che non erra, della giusta misura contro ciò che è oscuro e intorto, della bilancia che rettamente pesa la divinità del Figlio di Dio contro gli Ariani che non la ritenevano somma, coeguale e consustanziale a quella del Padre; i suoi dottori (il terzo stato è assimilato al sacramento del sacerdozio) sono perfettamente illuminati nella sapienza; sono maestri del senso morale, “mores hominum rationabiliter et modeste componens”, assimilato al ‘vino’ con il quale ardono contro i vizi e accendono all’amore delle virtù; è il tempo delle leggi e della spada che scinde le eresie e, in genere, l’errore; dell’autonomia della potestà temporale, una delle due ali della grande aquila date alla donna (la Chiesa) per vincere il drago nella terza e quarta guerra (Ap 12, 14): contiene insomma tutti gli elementi che Dante ritiene utili per conseguire la felicità su questa terra. Il terzo dei quattro animali che circondano la sede divina ad Ap 4, 6-8, quello che ha la faccia quasi di uomo, designa il senso morale, ma anche la ragione, l’impero, le leggi: “Tertium rationale et imperiosum seu legislativum”. Dei due fini proposti all’uomo dalla Provvidenza dei quali si tratta nella Monarchia, la beatitudine di questa vita e la beatitudine della vita eterna (III, xv, 7-10), il primo corrisponde alle realizzazioni del terzo stato della Chiesa secondo l’Olivi. A questo fine, al quale presiede l’imperatore, si giunge attraverso la filosofia, seguendola nell’operare secondo le virtù morali e intellettuali: essa è speculare, nel rapporto instaurato tra la Lectura e la Commedia, al lume dei dottori della Chiesa che reggono con la ragione. All’altro fine, la beatitudine della vita eterna che spetta al papa, si perviene attraverso gli insegnamenti spirituali che trascendono la ragione umana, seguendoli nell’operare secondo le virtù teologali: a questi corrisponde la santa vita e la “pascualis refectio”, il “pastus” degli anacoreti, i contemplativi ai quali è appropriato lo stato successivo, il quarto, corrispondente all’altra ala della grande aquila data alla donna. “Spada” e “pasturale”, i “due soli” rimpianti da Marco Lombardo (Purg. XVI, 106-114), come terzo stato (dottori) e quarto (anacoreti), possono concorrere a illuminare l’orbe, ma non identificarsi.
Nell’Inferno ci sono cinque momenti che si riferiscono, per traslazione semantica e variazione parodica, al terzo stato. Un’attenta analisi può dimostrare che queste cinque zone sono precedute da altrettante nelle quali prevalgono i temi del secondo stato (dei martiri) e sono seguite da altre nelle quali prevalgono invece i temi del quarto stato (degli anacoreti o contemplativi). Questi cinque momenti coincidono con le tradizionali cinque età del mondo precedenti il primo avvento di Cristo (sesta età), cioè con l’Antico Testamento.
Per quanto i temi del terzo stato siano presenti anche altrove nella prima cantica, essi sono preminenti nelle predette zone. Le zone riferite agli stati, inoltre, non coincidono con un canto, perché l’ordine spirituale del poema rompe quello letterale diviso per canti, cerchi, gironi, cieli. Né le predette zone mostrano esclusivamente temi del terzo stato, perché ogni stato contiene in sé temi di tutti gli altri.
Nell’Inferno i luoghi ‘terzi’ riguardano le fazioni fiorentine, i suicidi, i papi simoniaci, gli scismatici, i traditori di Cristo e di Cesare. Cerbero, nel graffiare, scuoiare e squartare i golosi, è figura che anticipa il colloquio tra Dante e Ciacco sulle divisioni politiche fiorentine (Inf. VI). Il tema del tagliare, dividere, rompere o scindere, quasi fosse un motivo dall’andamento interno, sotterraneo e insieme ciclico, torna in evidenza nella selva dei suicidi, la cui anima feroce si è divisa dal corpo (Inf. XIII); nella terza bolgia dei simoniaci, che hanno straziato la “bella donna”, cioè la Chiesa (Inf. XIX); nella nona dei seminatori di scandalo e di scisma, dove sta anche il Mosca che fu causa delle discordie fiorentine (Inf. XXVIII); in Lucifero che con ognuna delle sue tre bocche “dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla” e, per maggior pena, graffia Giuda che pende dalla bocca anteriore scorticandogli il dorso, mentre gli altri due traditori sono Bruto e Cassio, gli assassini di Cesare (Inf. XXXIV, 55-67). Questo dividere l’uomo, nei suoi vari aspetti, da Dio e dalla sua giustizia è assimilabile alle eresie, che divisero l’umanità di Cristo dalla sua divinità, degradando la prima o confondendola con la seconda, come quelle di Ario e di Sabellio, i quali, secondo quanto dice Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole, “furon come spade a le Scritture / in render torti li diritti volti” (Par. XIII, 127-129). Non a caso, pertanto, i luoghi dell’Inferno che trattano di divisioni esprimono una semantica parodistica dei motivi propri del terzo stato, nel quale i dottori confutano le eresie che dividono la Chiesa. Ma è zona ‘terza’ anche il terzo girone della montagna, dove si purgano gli iracondi fra i quali è Marco Lombardo, il quale lamenta l’improprio congiungere del potere temporale (la “spada”) da parte del potere spirituale (il “pasturale”), eresia assimilabile a quella di Ario, che divise il Figlio dal Padre ritenendolo non consustanziale, a livello di creatura, o, ancor meglio, a quella di Sabellio, che unificò il Padre e il Figlio nella stessa persona.
La bolgia dei simoniaci, pertanto, si situa nel terzo ciclo settenario della prima cantica; fa seguito a una zona dove prevalgono i temi del secondo stato (Inf. XVIII, soprattutto per quanto riguarda la prima bolgia, dei ruffiani e seduttori) e precede una zona dedicata al quarto stato (la quarta bolgia, degli indovini, descritta in Inf. XX). Inf. VI, XIII e XIX, che corrispondono alle zone ‘terze’ dei primi tre cicli, sono confrontati sinotticamente in apposita tabella.
La “vera lingua”. Per Dante, come per Tommaso d’Aquino (Summa theologiae II/2, qu. 11, a. 2), l’eresia consiste in un’errata interpretazione della Scrittura. Ciò è ben verificabile in luoghi, come la terza bolgia, dove l’eresia non è specificamente punita ma è oggetto della tematica dell’ordito alla quale la trama dei versi rinvia. Nella bolgia dei simoniaci, Dante sta di fronte a Niccolò III (il quale crede trattarsi di Bonifacio VIII venuto a prendere il suo posto nel foro della pietra) come sta un dottore della Chiesa, che possiede la verità evangelica scritta e imposta da Cristo, di fronte a un eresiarca che ha mal pesato gli articoli di fede, torcendo la Scrittura in modo erroneo e menzognero, personificazione di colui che siede sul cavallo nero, nel livido fondo della bolgia, all’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5). Ancor più, parla a un pontefice romano in quanto depositario di quella “prima et vera lingua et confessio fidei” che avrebbe dovuto essere custodita “in domo Petri” (prologo, Notabile XIII). Il volgare del poeta fiorentino è assimilabile alla lingua del pescatore di Galilea, quella di Eber, custodita dapprima nella casa di Abramo e poi nella sede romana. Con questa lingua – “non lingua confusionis, sed gratie” (cfr. De vulgari eloquentia, I, vi, 5-7), di cui si avvalse il nostro Redentore, Dante può far sentire al simoniaco Niccolò III “lo suon de le parole vere espresse” (Inf. XIX, 121-123). Virgilio partecipa di quest’alto patrimonio nell’imporre al discepolo la corretta risposta su chi egli sia realmente, come Cristo impose ai discepoli la regola evangelica.
Il reggente di san Pietro. Dante ha rotto pochi anni prima, “nel mio bel San Giovanni”, il recipiente dell’acqua battesimale per salvare una persona che vi stava annegando, assumendo con tale gesto su di sé la veste del dottore della Chiesa che possiede la rumphea (Ap 2, 12), cioè la spada acuta da entrambi i lati, ed è terribile confutatore dell’erronea dottrina che conduce alla morte molti uomini. Ora si trova in un luogo dove si punisce chi ha ingannato e fatto strazio della “bella donna”, cioè della Chiesa, la sposa di edenica bellezza della quale fa segno l’antico battistero fiorentino (Ap 2, 1). L’arte della divina giustizia ha fatto, nel fondo della bolgia, la pietra “livida di fóri”, immagine perversa dello scavare le fondamenta della Gerusalemme celeste, la Chiesa trionfante verso la quale cammina quella militante (Ap 21, 12). Ivi Niccolò III è confitto “come pal”, perfida controfigura di Cristo angolo e stipite della città superna.
Il poeta impersona l’Ordine evangelico dei discepoli di Francesco suscitati dallo Spirito nel terzo e nel quarto inizio dell’apertura del sesto sigillo, inviati a fondare e a governare la Chiesa rinnovata. Il viaggio verso la beatitudine, fin dall’inizio apparso come una guerra da sostenere, è stato subito segnato dal motivo del seguire Cristo (Virgilio) da parte di Pietro (Dante), secondo Giovanni 21, 19: «“Sequere me”, scilicet ad crucem» – “Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno / che tu mi segui … Allor si mosse, e io li tenni dietro” (Inf. I, 112-113, 136) -, motivo rinfacciato al simoniaco papa Orsini: «Deh, or mi dì: quanto tesoro volle / Nostro Segnore in prima da san Pietro / ch’ei ponesse le chiavi in sua balìa? / Certo non chiese se non “Viemmi retro”» (Inf. XIX, 90-93; cfr. Matteo 4, 19; 16, 19.24).
Il poeta canta “cotai note” all’Orsini consapevole di portare su di sé il «“signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi», conforme all’angelo del sesto sigillo, “piaghe” e “segni” come verranno definite da Virgilio nell’ascesa della montagna della purgazione. L’ira del visitatore d’anime userebbe “parole ancor più gravi” se non lo vietasse “la reverenza delle somme chiavi / che tu tenesti ne la vita lieta” (cfr. Ap 19, 10). Tenere è proprio di Cristo, pio pastore che ha cura delle chiese a lui soggette (Ap 2, 1); di Cristo deve essere imitatrice la nostra vita (prologo, Notabile VII). Ma il “gran manto” sacerdotale è vestito da “pastor sanza legge”, sacrileghi corruttori di sovrani molli come le locuste apocalittiche (Ap 9, 8).
La Chiesa di Dante è assimilata a Maria “povera”, chiamata dalle anime purganti “così nel pianto / come fa donna che in parturir sia” (Purg. XX, 19-24), la “donna vestita di sole” di Ap 12, 1-2, che tiene la luna (le cose temporali) sotto i piedi e designa la Chiesa primitiva, “la sposa di Cristo allevata del sangue” di Pietro, Lino, Cleto, Sisto, Pio, Callisto, Urbano, come affermato nell’ottavo cielo dall’adirato principe degli apostoli (Par. XXVII, 40-45).
Se i papi contemporanei sono da condannare, la “pietra” resta indefettibile almeno sull’orlo, tanto che i margini di pietra consentono di procedere nei passi infernali. Come per Olivi la Chiesa, anche se dai piedi al capo è infetta come una nuova Babilonia, non potrà mai estinguersi perché sempre il seme della fede sarà salvo in pochi eletti [1], così nella terza bolgia è Dante, un laico, a rappresentarla di fronte al falso successore di Pietro. D’altronde Brunetto Latini, proprio mentre Dante cammina sull’argine di pietra, lo definisce “sementa santa” facendo risuonare il motivo del seme purissimo rimasto nella Chiesa di Roma dopo le devastazioni saracene.
Bonifacio VIII. Papa Caetani viene nominato solo nella bolgia dei simoniaci – «Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto, / se’ tu già costì ritto, Bonifazio?”» -: un nome altamente significante per sarcasmo, in quanto ripete quanto viene rimproverato al vescovo di Sardi, la quinta delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione apocalittica, di avere cioè fama di essere giusto e di vivere la vita della grazia, mentre invece è morto per colpa mortale: “habebat nomen boni cum esset malus”. Per questo motivo il quinto vescovo risulta vacante nelle opere di fronte a Dio: «“Non enim invenio opera tua plena coram Deo meo”, id est etsi coram hominibus videntur plena virtute et caritate, sunt tamen istis vacua coram Deo» (Ap 3, 1-2; l’essere vacante è geograficamente figurato dall’Acquacheta, il fiume che una volta precipitato da San Benedetto dell’Alpe nella piana di Forlì “di quel nome è vacante”: Inf. XVI, 94-105). Nell’ottavo cielo, san Pietro porrà il suggello contro il pontefice legittimo per i terreni ma non per Dio, “quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, / il luogo mio, il luogo mio che vaca / ne la presenza del Figliuol di Dio”, utilizzando il tema dell’Anticristo che usurpa il dominio terreno (Par. XXVII, 22-24; Ap 11, 4).
L’Apocalisse aperta. Oltre a quelle che rinviano all’esegesi del terzo stato della storia della Chiesa, Inf. XIX contiene parole-chiave che indirizzano la memoria del lettore accorto (che possiede cioè la chiave per leggerle) ad altri luoghi della vastissima dottrina apocalittica oliviana. L’intero poema è una nuova Apocalisse, parodia della più grande e discussa esegesi contemporanea in materia. Nel canto dei simoniaci, però, l’Apocalisse canonica e il suo autore vengono esplicitamente citati dal nuovo san Giovanni, inviato da Dio come l’antico a convertire il mondo: “Di voi pastor s’accorse il Vangelista, / quando colei che siede sopra l’acque / puttaneggiar coi regi a lui fu vista; / quella che con le sette teste nacque, / e da le diece corna ebbe argomento, / fin che virtute al suo marito piacque” (vv. 106-111). La citazione diretta dal capitolo XVII, 1-3 è però incastonata in un contesto pregno di temi dell’esegesi oliviana, costantemente variati nel corso del poema. Sul capitolo XVII della Lectura (non del solo testo sacro) sono elaborate le parole che il simoniaco Niccolò III, credendo che Dante sia Bonifacio VIII giunto per farlo cadere più giù nella fessura della pietra, gli rivolge facendo risuonare i temi della sazietà (Ap 17, 6), della sfrontatezza (Ap 17, 5-6) e della strage (Ap 17, 3): “Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio / per lo qual non temesti tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio?” (Inf. XIX, 55-57). I temi saranno ripresi con l’episodio di Guido da Montefeltro in Inf. XXVII, l’altro canto nel quale Bonifacio VIII – nominato come “il gran prete” e “lo principe d’i novi Farisei” – è contumace protagonista. L’immagine del pontefice regnante nel 1300 che avrebbe dovuto presentarsi al lettore spirituale era quella di un papa errante, se non eretico nell’interpretazione del Vangelo come lo erano stati i suoi predecessori simoniaci e ancor più il suo successore, Clemente V.
L’Apocalisse è di per sé una visione profetica, all’espressione “un tempo, due tempi e la metà di un tempo”, a sua volta tratta dal profeta Daniele (Ap 12, 14), rinvia la profezia che Niccolò III fa della dannazione dei suoi successori, Bonifacio VIII e Clemente V. Ma, elaborando la struttura semantica di Inf. XIX principalmente sui temi del terzo stato della storia della Chiesa, Dante ha inteso essere, più che un profeta, un suo nuovo dottore.
Ordito e trama. La Lectura super Apocalipsim non è una fonte della Commedia, bensì il libro della storia delle illuminazioni sapienziali con cui tutto deve concordare. Con l’esegesi dell’ultimo libro canonico, esposta in una teologia della storia che comprende per settenari tutta la Scrittura, la quale a sua volta è forma, esempio e fine di ogni scienza, concorda ogni conoscenza, ogni esperienza, ogni soluzione indipendente data a questioni dottrinali. Virgilio, Ovidio o Lucano, Boezio, Aristotele, Alberto Magno o Tommaso d’Aquino, la stessa Scrittura in quanto tale, le più svariate esperienze poetiche o le conoscenze di astronomia sono, nel poema, tutte fonti ordinate alla Lectura. Così, sull’ordito apocalittico di Inf. XIX sono cuciti altri riferimenti alla Scrittura, alcuni palesi altri occulti, inseriti con variazioni più o meno lontane dal tema originario: una trama sulla quale la ricerca rimane aperta [2].
[1] [LSA, prologus, Notabile V] Quia vero ecclesia Christi usque ad finem seculi non debet omnino extingui, ideo oportuit eam in quibusdam suis reliquiis tunc specialiter a Deo defendi … [Ap 6, 12] Tunc enim totus status ecclesie in prelatis et plebibus et religiosis funditus subvertetur, preter id quod in paucis electis remanebit occulte … [Ap 9, 15] … non permittentur totam ecclesiam simpliciter extinguere, immo semper remanebit semen pro parte duplici electorum [i. e. maiorum et minorum], et in eis ecclesia et cultus Christi semper vivet et continuabitur.
[2] Cfr. i riferimenti biblici proposti da ZYGMUNT G. BARAŃSKI, Canto XIX, in Lectura Dantis Turicensis, a cura di Georges Güntert e Michelangelo Picone, I, Inferno, Firenze 2011, pp. 259-275.
1. “Nel mio bel San Giovanni”
■ “E il nome della stella è assenzio” (Ap 8, 11; terza tromba), poiché dopo la caduta dal cielo, al suono della terza tromba, la stella fu amarissima come l’assenzio e per questo restò famosa. “E molti uomini morirono nelle acque”, a causa cioè dell’erronea esposizione della Scrittura molti persero la vita della fede e della grazia per cadere in peccato mortale e nella morte eterna. Qui Giovanni non parla di “terza parte degli uomini”, ma dice “molti uomini” per indicare che in tutto il mondo furono innumerevoli coloro che morirono a causa dell’eresia di Ario e degli altri eresiarchi, che in un primo tempo erano apparsi grandi stelle ardenti in cielo.
Il tema del morire nelle acque della fede erronea trova la sua metamorfosi in un episodio della propria biografia che Dante racconta in Inf. XIX, 16-21, nel canto dei simoniaci della terza bolgia, il cui ordito mostra in più punti il prevalere di fili del terzo stato. I fori della pietra in cui sono confitti i peccatori, dice il poeta, “non mi parean men ampi né maggiori / che que’ che son nel mio bel San Giovanni, / fatti per loco d’i battezzatòri; / l’un de li quali, ancor non è molt’ anni, / rupp’ io per un che dentro v’annegava” [1]. Dante, nel rompere il recipiente dell’acqua battesimale per salvare la persona che vi sta annegando, assume su di sé la veste del dottore che possiede la rumphea (Ap 2, 12), cioè la spada acuta da entrambi i lati, ed è terribile confutatore dell’erronea dottrina che conduce alla morte molti uomini. Quello che è forse l’unico episodio autobiografico della Commedia anticipa in tal modo le gravi parole di condanna usate nei confronti del simoniaco Niccolò III. Lo stesso pontefice, vero “figliuol de l’orsa”, conferma il tema dell’erronea interpretazione della Scrittura dicendo a Dante, da lui creduto Bonifacio VIII venuto a spingerlo più in fondo nel foro: “Di parecchi anni mi mentì lo scritto” (Inf. XIX, 54). Alla simonia sono dunque appropriati, tra molti altri, i motivi dell’eresia di Ario, e di avere avuto questa in Origene “fons et seminator errorum” (“Di sotto al capo mio son li altri tratti / che precedetter me simoneggiando”, vv. 73-74).
I “molti uomini” morti per l’errore sono ricordati due volte da Virgilio: la prima a proposito delle arche degli eresiarchi – “e molto / più che non credi son le tombe carche” (Inf. IX, 127-129) -; la seconda con le turbate parole dette in Purg. III, 34-45 nell’invitare l’“umana gente” a stare “al quia”, a non desiderare cioè di conoscere con la ragione le cose trascendenti (i limiti della ragione umana fondata sul senso, causa dell’errore, vengono sottolineati nel Notabile V del prologo), come fecero invece coloro ai quali questo desiderio inappagato è dato come pena eterna nel Limbo – “io dico d’Aristotile e di Plato / e di molt’ altri”. Ciò non significa, naturalmente, che Dante non distingua fra eretici ed erranti, ma che i motivi dei primi, recati dall’esegesi, invadono parzialmente l’ambito dei secondi.
Il tema dell’assenzio è appropriato, in una zona come la nona bolgia dedicata al terzo stato, a Curione, il quale “con la lingua tagliata ne la strozza” ora non parla più dopo le ardite parole dette a Cesare per indurlo a varcare il Rubicone, e vorrebbe non aver mai visto Rimini, terra che per lui è “veduta amara” (Inf. XXVIII, 93).
■ “Nel mio bel San Giovanni … la bella donna” (Inf. XIX, 17, 57). Il battistero fiorentino e la Chiesa partecipano del nome della quinta chiesa d’Asia, Sardis, interpretato come “principio di bellezza” (principium pulchritudinis), sia perché nei pochi rimasti integri consegue la singolare gloria della bellezza, essendo cosa ardua e difficile mantenersi mondi tra tanta lussuria, sia per lo zelo mostrato dai primi istitutori del quinto stato. Costoro ordinarono le diverse membra e i diversi uffici dei propri collegi con una regola ispirata all’unità ma anche condiscendente in modo proporzionato alle membra stesse, conseguendo una forma di mirabile bellezza che è propria della Chiesa, la quale è come una regina ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei vari doni e nelle varie grazie delle diverse membra (ad Ap 2, 1).
[1] I temi della Gerusalemme celeste (Ap 20, 8; 21, 12), già ampiamente elaborati nel canto precedente, si registrano anche nella terza bolgia: vv. 13 (fondo), 14 (fóri), 18 (loco), 40 (venimmo), 42 (fondo foracchiato e arto), 44 (mi giunse), 47 (pal), 128 (arco). Si tratta della disposizione materiale delle parti della città, ad essa si riferiscono fondo, fóri, loco (“ad hedificandam urbem primo invenitur locus et fodiuntur fossata, secundo ponuntur ibi fundamenta”). Cristo e gli apostoli furono fondamenta della Chiesa, come tali sono designati dal fondo della bolgia. Per quanto concerne la fede, il primo stato o periodo di fondazione della Chiesa è designato dal battesimo (prologo, Notabile XIII). Anche i “battezzatòri”, pertanto, partecipano della descrizione materiale della bolgia, parodia della città superna; si tratta di oggetti materiali che servono all’amministrazione del battesimo, non di persone ad essa preposte (battezzatóri). Da segnalare l’ipotesi di Rachel Jacoff, ripresa con maggiori argomentazioni da Mirko Tavoni, che Dante abbia ripetuto il gesto di Geremia al quale fu ordinato da Dio di rompere un vaso d’argilla (fractio lagunculae) di fronte al popolo in segno della distruzione riservata alla città (Jr 19, 10); nel caso si tratterebbe di recipienti di argilla (più facili a frantumarsi della pietra) collocati in fori circolari nel pavimento del battistero (cfr. M. Tavoni, Qualche idea su Dante, Bologna 2015, pp. 149-181). L’ipotesi è da prendere in considerazione in quanto fa segno di Dante come profeta; il tema farebbe da contrappunto al motivo principale, del poeta che frantuma non la città, come in Geremia, ma la stessa Chiesa corrotta come i dottori confutarono, tagliandole (‘rompendole’) con la spada della ragione, le eresie delle quali partecipa la simonia punita nella bolgia. Non sarebbe il primo caso di riferimenti scritturali che concordano, al modo di altre fonti, con l’esegesi apocalittica oliviana anche se in questa non sono citati (cfr., ad esempio, quanto avviene per i Salmi).
Tab. I
2. Il fiammeggiante amore fraterno
Appartengono al sesto stato della Chiesa, quello più conforme a Cristo, alla sua vita e alla sua evangelica regola, il fiammeggiare dello Spirito e l’unzione spirituale (Ap 3, 7: sesta chiesa; l’esegesi si fonda in gran parte su quella di Gioacchino da Fiore). L’unzione è propria anche dell’estremo sacramento, il quale conviene alla soave pace del settimo e ultimo stato (prologo, Notabile XIII). La sesta chiesa (Filadelfia) viene interpretata, oltre che “colei che salva l’eredità” (Ap 2, 1), anche come “amore fraterno”, verificandosi in essa quanto scritto nel Cantico dei Cantici 8, 1-2 sulla sposa che desidera l’amato come un fratello che succhia il seno della madre, da poter baciare e introdurre nella casa materna (Ap 3, 7). Questi temi, combinati insieme, sono appropriati in modo sarcastico a Niccolò III, “colui … che si cruccia / guizzando più che li altri suoi consorti, / … e cui più roggia fiamma succia”, più rossa di quella che accende i piedi degli altri simoniaci la quale, “qual suole il fiammeggiar de le cose unte / muoversi pur su per la strema buccia”, si muove “dai calcagni a le punte” (Inf. XIX, 28-33) [1]. L’estrema unzione toglie la febbre (prologo, Notabile XIII, con riferimento alla guarigione in Giovanni 4, 52), ma Bonifacio VIII (del quale Niccolò III è prefigurazione) è affetto dalla “superba febbre” di distruggere i Colonna, come afferma Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 97). I temi dell’“amor fratris” si rinvengono in altri luoghi del poema, come nelle parole di Beatrice a Par. VII, 58-60 e nel duetto fra Stazio e Virgilio (Purg. XXI, 130-136).
A Niccolò III è ancora appropriato il tema della Chiesa della fine del quinto stato: “a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta” (prologo, Notabile VII). Il tema tornerà con i due falsari “dal capo al piè di schianze macolati” (Inf. XXIX, 75) e con la “puttana” flagellata dal gigante “dal capo infin le piante” (Purg. XXXII, 156) [2].
La domanda del poeta a Virgilio – «“Chi è colui, maestro, che si cruccia / guizzando più che li altri suoi consorti”, / diss’ io, “e cui più roggia fiamma succia?”» (Inf. XIX, 31-33) -, la mancata risposta di Dante di fronte alle parole di Niccolò III che lo crede Bonifacio VIII venuto a prendere il suo posto nel foro dei simoniaci – “quai son color che stanno, / per non intender ciò ch’è lor risposto, / quasi scornati, e risponder non sanno” (vv. 58-60) -, e il ‘rispondere’ infine come imposto dal poeta pagano (vv. 61-63) sono variazioni su temi da Ap 7, 13, esegesi fonte di numerose agnizioni nel poema.
[1] Il riferimento ad Ap 3, 7, con l’accostamento della fiamma e dell’unto – “sic in tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum” – rende inammissibile la variante “qual suole un fummeggiar”.
[2] Stante l’esegesi “a planta pedis usque ad verticem” (quest’ultimo riferito, al v. 30, non al capo ma alla punta delle dita), è inammissibile la variante “tra’ calcagni e le puncte”.
Tab. II
[LSA, prologus, Notabile VI] Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix visionum proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. Nunc tamen in generali breviter demonstretur. Constat enim quod totum imperium potestatis ecclesiastice (I), ac sacerdotale sacrificium martirizationis sue (II), et sapientiale magisterium sue doctrine (III), ac altivolum supercilium vite anachoritice (IV), et condescensivum contubernium vite domestice seu cenobitice (V), et nuptiale connubium seu familiare vinculum singularis amicitie (VI), ac beatificum convivium divine glorie (VII), sunt in Christo exemplariter et etiam contentive et effective. Contentive quidem, tum quia ab eterno est presens omnibus futuris, tum quia virtus, per quam unumquodque in suo tempore efficit et conservat et continet, est sibi essentialis et eternaliter presens.[LSA, prologus, Notabile VII; V status] Ad istum autem reditum valde, quamvis per accidens, cooperabitur non solum multiplex imperfectio in possessione et dispensatione temporalium ecclesie in pluribus comprobata, sed etiam multiplex enormitas superbie et luxurie et symoniarum et causidicationum et litigiorum et fraudum et rapinarum ex ipsis occasionaliter accepta, ex quibus circa finem quinti temporis a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta.[LSA, prologus, Notabile XIII; VII status] Unctio autem extrema congruit suavitati et paci septimi et ultimi status, in quo verificabitur illud de filio reguli: “Heri hora septima reliquit eum febris” (Jo 4, 52).[LSA, cap. III, Ap 3, 7 (VIa ecclesia)] […] sic in tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum et ut tripudium spiritualium iubilationum et iocunditatum, per que non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris. […] Unde congrue nomen huius sexte ecclesie, scilicet Philadelphia, non solum interpretatur salvans hereditatem, prout tactum est supra, sed etiam amor fratris, prout dicit Ricardus*. Nam in sexto statu, qui est tertius generalis status populi Dei, anthonomasice complebitur illud quod in tertia parte Cantici Canticorum dicit sponsa ad sponsum (Cn 8, 1-2): “Quis michi det te fratrem meum suggentem ubera matris mee, ut inveniam te solum foris et <de>obsculer? Apprehendam te et ducam in domum matris mee”, scilicet sinagoge tunc temporis convertende.* In Ap I, xi (PL 196, col. 742 C). |
||
Purg. XXI, 130-136Già s’inchinava ad abbracciar li piedi 19, 10
|
Inf. XXVII, 94-99
|
|
3. L’infallibile regola di Cristo
All’apertura del terzo sigillo (seconda visione apocalittica), mostratagli dal terzo animale, quello che ha il volto di uomo, Giovanni vede un cavallo nero, che designa l’esercito degli eretici, oscuro per fallace astuzia e fatto nero per gli errori contrari alla luce di Cristo (Ap 6, 5). Colui che siede sopra di esso – designante gli imperatori o i vescovi ariani – ha in mano una bilancia. La stadera misura la quantità dei pesi, e qui sta a indicare la misurazione degli articoli di fede. Quando la misurazione avviene secondo la retta e infallibile regola di Cristo, allora il peso è giusto, come si dice nei Proverbi: “Il peso e la bilancia sono i giudizi del Signore” (Pro 16, 11) e nell’Ecclesiastico: “Le parole dei prudenti sono pesate sulla bilancia” (Ecli 21, 28). Quando invece la misurazione si fonda sull’errore e sul falso e torto accoglimento della Scrittura, allora la stadera è dolosa, e a questa si riferiscono i Proverbi: “La bilancia falsa è in abominio al Signore” (Pro 11, 1), i Salmi: “Sono una menzogna tutti gli uomini sulla bilancia” (Ps 61, 10) e Michea: “Potrò giustificare le false bilance e la borsa dei pesi falsi?” (Mic 6, 11).
■ Nella terza bolgia, le gambe dei simoniaci confitti a capo in giù nei fori della pietra guizzano così forte, per la fiamma che si muove sulle piante dei piedi, “che spezzate averien ritorte e strambe”, cioè legami attorcigliati o funi (Inf. XIX, 25-27). Dante domanda chi sia colui che si cruccia guizzando più degli altri, e Virgilio risponde che, una volta portato là giù nel fondo della bolgia, “da lui” saprà “di sé e de’ suoi torti” (v. 36). Invitata dal poeta a parlare, l’anima confitta di Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini, papa dal 1277 al 1280), che erroneamente crede sia arrivato Bonifacio VIII a prendere il suo posto, grida proseguendo le variazioni del tema della retta e torta misurazione della Scrittura: «Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto, / se’ tu già costì ritto, Bonifazio? / Di parecchi anni mi mentì lo scritto”» (vv. 52-54). Lo stare “ritto”, che nell’esegesi scritturale corrisponde al giusto peso che misura secondo la retta e infallibile regola di Cristo (ma “lo scritto” ha mentito al papa Orsini, un falso profeta), si contrappone alla pena comminata per i “torti”, e il tema viene ripreso poco dopo dallo spirito che, chiarito l’equivoco in seguito alla risposta di Dante imposta da Virgilio, “tutti storse i piedi” (v. 64). Nella bolgia è punita la borsa (saccellus) dei pesi falsi di cui dice il profeta Michea (Mic 6, 11): “Numquid iustificabo stateram impiam et saccelli pondera dolosa”, come confermato da Niccolò III: “che sù l’avere e qui me misi in borsa” (v. 72) [1]. La parodia si esercita anche sulla fiamma accesa – “le piante erano a tutti accese intrambe” (v. 25) -: accendere, però all’amore delle virtù, è proprio del senso morale della Scrittura, tipico dei dottori del terzo stato (Ap 6, 6).
■ Lo “scritto” menzognero non è solo, come si è soliti interpretare, il libro del futuro nel quale i dannati leggono l’avvenire, oppure un vaticinio anti-Orsini come Genus nequam [2]. Queste probabili conoscenze di Dante sono ‘armate’ da ben altra corazza. I simoniaci – usando l’“intorta statera” tenuta in mano dagli eresiarchi designati dal cavallo nero in apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5) – hanno male pesato la regola evangelica, quella osservata da Cristo, imposta agli apostoli e scritta nel Vangelo. Questa regola o scritto è quella francescana, come solennemente attestato dalla Lectura nell’esordio dell’esegesi relativa all’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12, passo simmetrico ad Ap 6, 5 per il comune riferimento alla vera scrittura o regola di Cristo). L’angelo del sesto sigillo, che sale da oriente e che ha il segno del Dio vivente (Ap 7, 2), viene infatti identificato con Francesco piagato dalle stimmate, totalmente trasformato in Cristo e a lui configurato, secondo una tradizione che Olivi ascoltò da san Bonaventura predicante nel 1266 a Parigi nel capitolo generale dei Frati minori. Che la regola di Francesco sia quella veramente evangelica risulta da inconfutabili testimonianze dei libri del Vangelo e delle altre sante scritture. Ne consegue che l’imporre agli apostoli la regola evangelica, come detto ad Ap 6, 12, si trasforma nell’imporre a Dante da parte di Virgilio, imitatore di Cristo, la risposta da dare a Niccolò III, che ripristina la verità dello scritto: «Allor Virgilio disse: “Dilli tosto: / ‘Non son colui, non son colui che credi’”; / e io rispuosi come a me fu imposto» (Inf. XIX, 61-63), secondo la vera Scrittura, della quale antica prefigurazione fu quella di “Livïo … che non erra” (Inf. II, 3-6, 8; cfr. Inf. XXVIII, 12). Più avanti sarà Dante a rispondere all’Orsini “a questo metro” (v. 89), con la giusta misura cantandogli “cotai note” (v. 118).
■ Tutto Inf. XIX è percorso dai temi del terzo stato, propri dei dottori che confutano le eresie. Il motivo del cavallo nero, che appare all’apertura del terzo sigillo, è già nella seconda bolgia, dove gli adulatori stanno attuffati nello sterco: “Lo fondo è cupo sì, che non ci basta / loco a veder …” (Inf. XVIII, 109-110). Nella successiva terza bolgia, la pietra delle coste e del fondo è “livida di fóri” (Inf. XIX, 13-14). Niccolò III afferma che il posto nel foro in cui è confitto come palo coi piedi all’insù verrà preso da Bonifacio VIII, che vi rimarrà però per un periodo di tempo inferiore al suo: “ché dopo lui verrà di più laida opra, / di ver’ ponente, un pastor sanza legge”, Clemente V (vv. 82-83; ad Ap 2, 6 gli eretici Nicolaiti vengono definiti “spurcissimi”; sul passo cfr. anche l’esegesi di Ap 12, 14). L’espressione “di più laida opra” è da confrontare con le “laide colpe” delle quali Beatrice riprende volgendo in fuga la volpe, allusione alle eresie, incuneatasi nel carro-Chiesa a Purg. XXXII, 118-123 (sono le sole due occorrenze dell’aggettivo nel poema; anche il volgere in fuga gli eretici è tema proprio dei dottori, dalla terza vittoria ad Ap 2, 17).
■ Nella terza età del mondo (prefigurazione del terzo stato della Chiesa), a causa della superba torre di Babele, le lingue furono confuse e divise e la lingua prima e retta rimase nella casa di Eber e degli Ebrei, e poi, mentre le altre lingue precipitavano nell’idolatria diabolica, la fede e il culto di un solo vero Dio rimase nella casa di Abramo. Così nel terzo stato della Chiesa, a causa della superbia di molti fedeli, la lingua e la confessione della sola vera fede di Cristo venne divisa e confusa in più eresie, mentre la prima e vera lingua e confessione rimase nella casa di Pietro (prologo, Notabile XIII). Rispondendo a Niccolò III, il poeta prorompe in “parole … gravi” contro i papi simoniaci: il cantare tali note al pontefice, che fu in vita “veramente … figliuol de l’orsa”, è “suon de le parole vere espresse” (Inf. XIX, 70, 103, 123), confessione dell’unica fede di Cristo nella lingua vera che è quella che rimase nella casa di Eber, poi in quella di Abramo, e che avrebbe dovuto essere custodita nella casa romana di Pietro. È proprio dei dottori del terzo stato della Chiesa suonare la tromba (prologo, Notabile I), e ai simoniaci che stanno nella terza bolgia il poeta dichiara che “or convien che per voi suoni la tromba” (vv. 1-6). È probabile che alla stessa tematica appartengano l’atteggiarsi di Dante, piegato col capo sul dannato confitto come palo nel foro della pietra, a frate confessore del “perfido assessin” e il suo restare ‘scornato’, cioè confuso, alle prime incomprensibili parole di Niccolò che l’ha scambiato per Bonifacio VIII arrivato a prendere il suo posto prima del tempo (vv. 49-51, 58-60). “Scornati” è infatti termine singolarmente consonante con l’interpretazione (“dividens cornua”) del nome (Pergamo) della terza chiesa d’Asia, la chiesa dello stato dei dottori che confondono, appunto, l’eresia.
■ La presenza dei motivi dell’angelo del sesto sigillo (Ap 6, 12) concorda con l’essere Dante figura che impersona l’Ordine evangelico dei discepoli di Francesco suscitati dallo Spirito nel terzo e nel quarto inizio dell’apertura del sesto sigillo, inviati a fondare e a governare la nuova Chiesa di Cristo. Tema importante, quello dell’angelo che sale da oriente (Ap 7, 2), e che dovette essere decisivo per l’incontro spirituale tra il frate e il poeta se lo si ritrova già nei primi versi del poema. Il motivo del seguire Cristo (Virgilio) da parte di Pietro (Dante), secondo Giovanni 21, 3-19: «“Sequere me”, scilicet ad crucem» – “Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno / che tu mi segui … Allor si mosse, e io li tenni dietro” (Inf. I, 112-113, 136) – è rinfacciato dallo stesso Dante al simoniaco Niccolò III (Inf. XIX, 90-93): «Deh, or mi dì: quanto tesoro volle / Nostro Segnore in prima da san Pietro / ch’ei ponesse le chiavi in sua balìa? / Certo non chiese se non “Viemmi retro”» (cfr. Matteo 4, 19; 16, 19.24).
Dante sta dunque di fronte al papa simoniaco come sta un dottore della Chiesa, che possiede la verità evangelica scritta e imposta da Cristo, di fronte a un eresiarca. Ancor più, parla a un pontefice romano in quanto depositario di quella “prima et vera lingua et confessio fidei” che avrebbe dovuto essere custodita “in domo Petri”. Virgilio partecipa di quest’alto patrimonio nell’imporre al discepolo la retta risposta, come Cristo impose ai discepoli la regola evangelica [3].
Il poeta canta “cotai note” all’Orsini consapevole di portare su di sé il «“signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi», conforme all’angelo del sesto sigillo, “piaghe” e “segni” come verranno definite da Virgilio nell’ascesa della montagna della purgazione.
[1] Michea 6, 3: “Popule meus, quid feci tibi?” costituiva l’incipit di una lettera perduta di Dante, ricordata dal Bruni.
[2] Cfr. GIAN LUCA POTESTÀ, Dante profeta e i vaticini papali, in “Rivista di Storia del Cristianesimo”, 1 (2004), pp. 67-88.
[3] È noto che Dante perverrà a sostenere, in contrasto con il De vulgari eloquentia (I, vi, 4-7), e anche con la Lectura (prologo, Notabile XIII), che la lingua di Adamo non fosse di origine divina, sopravvissuta nell’ebraico dopo la confusione babelica. Quell’idioma – dice lo stesso progenitore (Par. XXVI, 124-138) – fu spento prima dell’opera della gente di Nembrot; non poté durare, come tutti gli altri effetti del razionale agire umano. Ogni lingua è instabile nell’uso; quella “vera” e perpetua, che consente di parlare gravemente con evangelico suono ai papi simoniaci, è propria della Sacra Scrittura, di cui la Commedia è la versione moderna dell’ultimo libro.
Tab. III
[LSA, prologus, Notabile I (III status)] Tertius (status) est confessorum seu doctorum, homini rationali appropriatus. […] In tertio (statu) sonus predicationis seu eruditionis et tuba magistralis.[LSA, prologus, Notabile XIII (III status)] Sicut etiam tunc propter superbiam turris Babel confuse et divise sunt lingue, remanente recta et prima lingua in domo Heber et Hebreorum, ac deinde linguis ceteris in idolatriam demonum ruentibus in sola domo Abraam fides et cultus unius veri Dei remansit, sic propter superbiam plurium ad fidem introductorum lingua et confessio unius vere fidei Christi est in plures hereses divisa et confusa, remanente prima et vera lingua et confessione fidei in domo Petri.[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (IIIa ecclesia)] Tertia autem commendatur de servando et confitendo fidem inter magistros erroris, in quibus quasi in cathedra pestilentie Sathanas sedet. Increpatur tamen quia ex quorundam suorum negligentia quosdam hereticos habebat. Competunt autem hec tempori tertio, scilicet doctorum. Tunc enim aliqui catholici nimis participabant cum aliquibus hereticis, quamvis ceteri essent constantissimi contra eos. Hec autem ecclesia congrue vocatur Pergamus, id est dividens cornua, quia superbam potentiam et scissuram hereticorum potentissime frangebat et dissolvebat. |
Inf. XIX, 5-6, 49-50, 58-60, 70-72, 121-123or convien che per voi suoni la tromba,
|
[LSA, cap. VI, Ap 6, 5 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal” (Ap 6, 5), scilicet quod habebat faciem hominis, “dicens: Veni”, scilicet per maiorem attentionem vel per imitationem fidei doctorum hic per hominem designatorum, “et vide. Et ecce equus niger”, id est hereticorum et precipue arrianorum exercitus astutia fallaci obscurus et erroribus luci Christi contrariis denigratus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet imperatores et episcopi arriani, “habebat stateram in manu sua”. Cum statera mensuratur quantitas ponderum, et ideo per stateram designatur hic mensuratio articulorum fidei, que quando fit per rectam et infallibilem regulam Christi et scripturarum suarum est recta statera, de qua Proverbiorum XVI° dicitur: “Pondus et statera iudicia Domini sunt” (Pro 16, 11), et Ecclesiastici XXI°: “Verba prudentium statera ponderabuntur” (Ecli 21, 28); quando vero fit per rationem erroneam et per falsam et intortam acceptionem scripture est statera dolosa, de qua Proverbiorum XI° dicitur: “Statera dolosa abhominatio est apud Deum” (Pro 11, 1), et in Psalmo: “Mendaces filii hominum in stateris” (Ps 61, 10), et Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram impiam et sac<c>elli pondera dolosa” (Mic 6, 11).Inf. II, 3-6, 8
|
Inf. XIX, 25-27, 34-36, 52-54, 61-64, 70-72, 88-89Le piante erano a tutti accese intrambe;
|
[LSA, prologus, Notabile VII] Secunda (ratio) est eius singularis et exemplaris vita, quam apostolis imposuit et in se ipso exemplavit et in libris evangelicis sollempniter scribi fecit. Huius autem vite perfecta imitatio et participatio est et debet esse finis totius nostre actionis et vite.[LSA, cap. VI, Ap 6, 12 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Ad evidentiam autem huius sexte apertionis est primo ad memoriam reducendum quod supra in principio est in tredecim notabilibus prenotatum, et specialiter illa in quibus est monstratum quia vita Christi erat in sexto et septimo statu ecclesie singulariter glorificanda et in finali consumatione ecclesie et in omnis Israelis ac totius orbis conversione magnificanda. Ex quo igitur, per romane ecclesie autenticam testificationem et confirmationem, constat regulam Minorum, per beatum Franciscum editam, esse vere et proprie illam evangelicam quam Christus in se ipso servavit et apostolis imposuit et in evangeliis suis conscribi fecit, et nichilominus constat hoc per irrefragabilia testimonia librorum evangelicorum et ceterarum scripturarum sanctarum et per sanctos expositores earum, prout alibi est superhabunde monstratum, constat etiam hoc per indubitabile testimonium sanctissimi Francisci ineffabili sanctitate et innumeris Dei miraculis confirmatum. Et precipue gloriosissimis stigmatibus sibi a Christo impressis patet ipsum fore angelum apertionis sexti signaculi “habentem signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi, et etiam signum totalis transformationis et configurationis ipsius ad Christum et in Christum. Et hoc ipsum per claram et fide dignam revelationem est habitum, prout a fratre Bonaventura, sollempnissimo sacre theologie magistro ac nostri ordinis quondam generali ministro, fuit Parisius in fratrum minorum capitulo me audiente sollempniter predicatum. |
|
Tab. IV
[LSA, cap. II, Ap 2, 21-22 (Ia visio, IVa ecclesia)] Exaggerat autem huius femine impenitentiam, subdens (Ap 2, 21): “Et dedi illi tempus ut penitentiam ageret”, id est ob hoc distuli ipsam occidere et dampnare, “et non vult penitere a fornicatione sua”. Propter quod comminatur ei, subdens (Ap 2, 22): “Et ecce ego mitto eam in lectum, et qui mecantur cum ea in tribulationem maximam”, scilicet mitto. Quidam habent hic “erunt in tribulatione” in ablativo, sed prima littera verior est et antiquior.
|
|
Inf. XIX, 49-51Io stava come ’l frate che confessa
|
[LSA, cap. IX, Ap 9, 20-21 (IIIa visio, VIa tuba)] Sequitur (Ap 9, 20): “Et ceteri homines, qui non sunt occisi in hiis plagis neque penitentiam egerunt de operibus manuum suarum, ut non adorent demonia et simulacra aurea et argentea et erea et lapidea et lignea, que neque videre possunt neque audire neque ambulare, (Ap 9, 21) et non egerunt penitentiam ab homicidiis suis neque a veneficiis suis neque a fornicatione sua neque a furtis suis”, supple, occidentur in flagellis adhuc venturis nisi peniten-tiam egerint.[LSA, cap. XXI, Ap 21, 8 (VIIa visio)] […] “homicidis”, scilicet voluntate vel inductione vel opere […]. |
“Lo perfido assessin”, espressione che allude alla setta araba degli “Assassini” agli ordini del Veglio della montagna, si rispecchia nella “perfidia Sarracenorum” di cui parla Gioacchino da Fiore citato nell’esegesi di Ap 13, 3 (quarta visione, sesta guerra). Mentre Giudei, pagani ed eretici non ebbero una legge di per sé contraria a quella di Cristo, i Saraceni seguono invece una legge carnale e falsa del tutto dissimile, che non accetta le Scritture cristiane e contro la quale non è possibile qualsiasi confutazione sulla base di queste, come con i Giudei e con gli eretici. Né è possibile argomentare contro di essi sulla base della ragione naturale, come avverso i pagani, in quanto i Saraceni non credono in più dèi, ma in un solo Dio. Ancora, la bestia saracena, assimilata alla quarta bestia “diversa” di Daniele 7, 3-7, a differenza delle prime tre non tollera che la fede di Cristo venga predicata fra i seguaci della sua setta o che venga detto qualcosa contro la sua legge, pena la morte immediata. I Saraceni, secondo Gioacchino, sono designati dalla testa della bestia che sembrava uccisa e poi rivive (Ap 13, 3), uccisa perché in un primo tempo convertita a Cristo con uccisione del suo errore. L’esegesi di Ap 13, 3, congiunta con Ap 2, 21-22 (prima visione, quarta chiesa) dove la falsa profetessa Gezabele viene richiamata alla penitenza, sembra far propendere l’interpretazione del verso – “richiama lui per che la morte cessa” – nel senso del confessarsi evitando la “seconda morte”, cioè la dannazione eterna, piuttosto che con lo scopo di ritardare la morte corporale (fatto di per sé implicito nell’intento di far penitenza). |
|
4. I moderni dottori della Chiesa contro le nuove eresie
L’ordine dei dottori del terzo stato, cui spetta suonare la tromba per antonomasia, predicò e insegnò nel mondo già convertito da Costantino. Quanto male seguì al suono della terza tromba (terza visione apocalittica) viene mostrato con queste parole: “e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì la terza parte dei fiumi e le fonti delle acque” (Ap 8, 10). Al tempo di Costantino, Ario, presbitero di Alessandria, anch’egli “grande stella e ardente” per la dottrina scolastica ed ecclesiastica in cui eccelleva, inflato dagli errori del suo maestro Origene, insegnò che il Figlio di Dio non è consustanziale o uguale al Padre bensì una pura creatura. Dalla sua dottrina vennero contaminati non solo molti laici, ma anche grandi chierici, vescovi, religiosi e molti imperatori costantinopolitani nonché i re e i regni dei Goti, dei Vandali e dei Longobardi.
Origene e Ario caddero così sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti. La prima parte della dottrina è infatti la lettera della Scrittura, propria dei semplici e inferiori, siano dottori o discepoli; la seconda consiste nell’alta e profonda sapienza mistica di Cristo che compete solo ai perfetti; la terza è la dottrina erronea.
La caduta di Ario fu in parte concomitante con la predicazione dei dottori, in parte la precedette, in parte fu da essa provocata e aumentata. Fu concomitante perché Ario errò e insegnò l’errore solo a causa della propria temerarietà e presunzione. La precedette in quanto Origene, che storicamente visse prima di Costantino e dunque nel secondo stato della Chiesa (proprio dei martiri), fu fonte e seminatore dell’errore di Ario. L’errore prestò ai dottori l’occasione di cercare in modo più sottile la verità della fede per poterlo impugnare e condannare, e in tal senso precedette la tubicinazione magistrale.
La retta predicazione dei santi dottori fu pure causa dell’errore perché Ario, volendo superbamente imitare le loro sottili ricerche e conseguire con ambizione autorità e fama di magistero, per degno giudizio di Dio cadde in errore e ne divenne maestro. La successiva impugnazione e condanna lo fece indurire e ancor più ostinare nel suo maligno errore, che difese e diffuse insieme ai suoi discepoli.
L’ostinarsi nell’errore di fronte alla condanna dei dottori si trasforma nello scalciare di Niccolò III con entrambi i piedi accesi, morso dall’ira o dalla coscienza mentre Dante lo rimprovera della sua simonia (Inf. XIX, 118-120) [1]. L’errore del papa Orsini ebbe inoltre dei predecessori, come Ario fu preceduto da Origene; costoro sono precipitati sotto il suo capo, “per le fessure de la pietra piatti”, lì dove lui stesso cadrà quando Bonifacio VIII verrà a prendere il suo posto (vv. 73-75). Come Ario errò e insegnò l’errore solo a causa della propria temerarietà e presunzione, così Niccolò III fu causa della sua dannazione: “e veramente fui figliuol de l’orsa, / cupido sì per avanzar li orsatti, / che sù l’avere e qui me misi in borsa” (vv. 70-72) [2].
Come sempre avviene nel rapporto fra Commedia e Lectura super Apocalipsim, a un medesimo luogo della seconda si riferiscono, tramite la compresenza degli elementi semantici, più luoghi della prima; cioè la medesima esegesi di un punto del commento apocalittico è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del “poema sacro” che ad essa rinviano. Così il tema dell’imitare le sottigliezze dei maestri famosi, che precedettero, è dal poeta appropriato con ironia alla misera patria sua: “Atene e Lacedemona, che fenno / l’antiche leggi e furon sì civili (la legge data dai dottori è uno dei temi fondamentali del terzo stato: prologo, Notabile XIII), / fecero al viver bene un picciol cenno / verso di te, che fai tanto sottili / provedimenti, ch’a mezzo novembre / non giugne quel che tu d’ottobre fili” (Purg. VI, 139-144). Alla cittadinanza, che muta aspetto secondo la fazione che vi predomina e manda le altre in esilio, bene si applica il motivo delle perpetue rivoluzioni origeniste e del passare dell’anima da un corpo all’altro: “Quante volte, del tempo che rimembre, / legge, moneta, officio e costume / hai tu mutato, e rinovate membre!” (vv. 145-147).
Una variazione del medesimo tema è nel parlare di Giustiniano, il quale spiega che nel cielo di Mercurio si presentano le anime di coloro che sono stati attivi “perché onore e fama li succeda”, desiderio che erra per difetto del vero amore (Par. VI, 112-117).
[1] Il verso 119 – “o ira o coscïenza che ’l mordesse” – lega insieme due motivi (l’ira e il rimorso della coscienza), propri delle locuste che escono da pozzo dell’abisso al suono della quinta tromba (Ap 9, 5).
[2] L’orso, ad Ap 13, 1-2 (dove viene descritta la bestia che sale dal mare), è assimilato agli imperatori pagani che divorarono le carni dei martiri; ad esso infatti è detto in Daniele 7, 5: “Su, divora molta carne”.
Tab. V
[LSA, cap. VIII, Ap 8, 10 (IIIa visio, IIIa tuba)] Unus autem de primis corruptoribus eius fuit Origenes, primo quidem vita et sapientia preclarus et celebris et maxime auctoritatis in tota ecclesia sicut “stella magna” et “ardens” (Ap 8, 10) ad zelum animarum et eruditionis earum et etiam ad martirium “tamquam facula”, prout patet ex libro ecclesiastice ystorie et etiam ex ystoria tripartita, in tantum ut se ipsum castrasse feratur ut caste et secure posset docere virgines et ob zelum apostolice vite nudis pedibus ambulasse. Errores tamen eius, ante impium dogma Arrii, fuerunt in eius libris sepulti et paucis noti, quorum magnam partem recitat Ieronimus in epistula ad Avitum quantum spectat ad duos libros eius qui dicuntur ‘peri archon’, id est ‘de principiis’. In quibus dicit Filium et Spiritum Sanctum esse minores Patre et substantialiter ab eo diversos et ab eo creatos. Negat etiam veram resurrectionem humane carnis, nec unionem anime ad corpus dicit esse naturalem sed potius penalem. Ponit enim animas substantialiter non differre ab angelis, et omnes cum eis simul fuisse creatas ante mundi corporalis creationem, quem ob solam carceralem punitionem spirituum peccantium dicit esse creatum. Ponit enim animas peccasse antequam corporibus unirentur; ponit etiam eas de uno corpore in aliud, puta de corpore humano in corpora bestiarum, revolvi et postmodum expurgari ab eis. Ponit etiam nullum in statu glorie esse immobiliter sed exinde per culpam cadere et in corpora iterum recludi, nec aliquem eternaliter in inferno esse sed exinde per penitentiam educi gradatim usque ad statum glorie. Has autem revolutiones dicit esse infinities per futura secula fiendas. Dicit etiam Christum non solum occidi in terra pro hominibus sed etiam in aere pro demonibus.
|
|
Et nota quod casus Arrii fuit partim incidentaliter concomitans tubicinatione<m> sanctorum doctorum tertii status, et partim precedens et partim per accidens causatus et augmentatus ab ipsa.
|
Inf. XIX, 70-75, 118-120concomitanse veramente fui figliuol de l’orsa,
|
5. La donna che siede sulla bestia scarlatta
■ La meretrice designa la gente e l’impero dei Romani sia nello stato del paganesimo sia in quello cristiano, durante il quale colpevolmente fornicò molto con questo mondo. Viene chiamata “grande meretrice” (Ap 17, 1) poiché venendo meno al culto fedele, al sincero amore e ai piaceri del suo sposo aderisce alle ricchezze e alle delizie di questo mondo e al diavolo, come pure ai re, ai magnati, ai prelati e a quanti amano questo secolo. Inoltre, nello stato del paganesimo, adorò falsi dèi quasi fossero suoi mariti adulterini (gli “dèi falsi e bugiardi” al tempo dei quali visse Virgilio, Inf. I, 71-72). Si dice che “siede sopra molte acque” poiché si fonda e domina sopra molti popoli, i quali fluiscono come l’acqua. Più avanti, ad Ap 17, 15, viene spiegato a Giovanni che “le acque”, cioè l’acqua che cade, “che vedesti dove siede la meretrice”, sopra le quali domina, “sono i popoli e le genti e le lingue”, in quanto come le acque labili scorrono giù, così i popoli passano morendo e ondeggiano come acque nei loro costumi e passioni. Con la prostituta “fornicarono i re della terra” (Ap 17, 2), da intendere sia secolari che ecclesiastici, i quali si unirono ad essa per partecipare della sua gloria carnale. “E coloro che abitano la terra”, cioè gli amanti delle cose terrene, “si inebriarono del vino della sua prostituzione”, ossia della sua abominevole gloria di prostituta. L’angelo conduce quindi Giovanni “nel deserto” della contemplazione e del disprezzo delle cose terrene, “in spirito”, per mezzo cioè di una visione spirituale (Ap 17, 3). Secondo Gioacchino da Fiore, sono due le cose che non permettono all’uomo di vedere la rovina dei figli di questo mondo: la sollecitudine delle cose terrene e il mortifero senso della lettera. Conviene pertanto abbandonare le prime e trarsi all’intelligenza spirituale e al desiderio delle cose celesti.
Esplicito il riferimento all’Apocalisse in Inf. XIX, 106-108, nelle dure parole rivolte dal poeta al simoniaco Niccolò III: “Di voi pastor s’accorse il Vangelista, / quando colei che siede sopra l’acque / puttaneggiar coi regi a lui fu vista”. La terzina cuce rinvii ad Ap 17, 1 (“que sedet super aquas multas”), 17, 2 (“cum qua fornicati sunt reges terre”) e ancora 17, 1.3 (il vedere in spirito di Giovanni). Di per sé, come sostenne polemicamente Michele Barbi, Dante avrebbe potuto fare a meno del commento di Olivi e fondarsi sul solo testo scritturale [1]. Ma alla Lectura conduce subito il tema dell’adulterio dallo sposo, suonato dalla tromba all’inizio del canto contro i miseri seguaci di Simon Mago “che le cose di Dio, che di bontate / deon essere spose, e voi rapaci / per oro e per argento avolterate” (Inf. XIX, 1-4). L’unirsi dei carnali alla prostituta per molte colpe (Ap 17, 2) corrisponde all’ammogliarsi della lupa con molti animali (Inf. I, 100).
Gli ornamenti della donna, che siede sulla bestia dalle sette teste e dieci corna (Ap 17, 3), possono essere anche intesi come i doni intellettuali che la Chiesa carnale scialacqua con la sua superbia, come rimproverato da Dio in Ezechiele 16, 10-19 alla Sinagoga (e quindi alla Chiesa in essa prefigurata) per avere fatto immagini idolatre delle vesti d’oro e d’argento che le aveva dato e per avere offerto a quelle ogni ornamento e ricchezza precedentemente avuti (Ap 17, 3-6). È quanto Dante rimprovera a Niccolò III, nella bolgia dei simoniaci che attristano il mondo con la loro avarizia idolatra: “Fatto v’avete dio d’oro e d’argento” (Inf. XIX, 112-114). Avarizia e idolatria sono congiunte nella lettera di san Paolo agli Efesini (Eph 5, 5: “avarus, quod est idolorum servitus”; cfr. Ap 21, 8); contro gli avari idolatri parole gravi e interrotte per l’ira vengono scritte ad Ap 9, 20-21 (come Dante interrompe il suo rimprovero a Niccolò III perché, se non fosse per “la reverenza de le somme chiavi”, userebbe “parole ancor più gravi”: Inf. XIX, 100-103). La Chiesa, la “bella donna”, fu “quella che con le sette teste nacque (fu cioè dotata dei doni dello Spirito), / e da le diece corna ebbe argomento” finché ebbe mariti virtuosi, cioè pontefici ligi al decalogo (vv. 109-111; il rapporto fra “corna” e “argomento” è presente, in senso negativo, ad Ap 13, 11 a proposito della bestia che sale dalla terra). Il motivo dei doni dissipati si riverbera sulla condanna della donazione di Costantino, “quella dote / che da te prese il primo ricco patre” (vv. 116-117), dove risuonano variati i temi dell’esegesi della terza tromba (Ap 8, 10).
[1] Raoul Manselli ha espresso il proprio dissenso da posizioni siffatte, pur espresse da un maestro come Michele Barbi: “La Divina Commedia è una profezia, una rivelazione; nessun dubbio – osservava il filologo toscano in Il gioachimismo francescano e il Veltro (1934) -, ma Dante non ebbe bisogno perciò d’ispirarsi né ai sogni del monaco calabrese né a quelli dei seminatori di discordie nell’ordine francescano […] ebbe più sincere fonti d’ispirazione nei profeti veri; gli bastarono per le sue figurazioni del paradiso terrestre gli elementi che gli eran dati dall’Apocalisse; ed anche per tuonare contro la Chiesa carnale aveva ben più alti esempi nella tradizione ecclesiastica stessa. A sentire certi critici, Dante non saprebbe trovare un’immagine né formare un pensiero senza un suggerimento di Giovanni Olivi (sic!) o di fra Ubertino da Casale” (cfr. RAOUL MANSELLI, Dante e l’«Ecclesia Spiritualis» [1965], in ID., Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo. Studi sul francescanesimo spirituale, sull’ecclesiologia e sull’escatologisno bassomedievali, introduzione e cura di Paolo Vian, Roma 1997 [Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici, 36], p. 69, nota 38).
Tab. VI
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 1-3 (VIa visio)] Et nota quod hec mulier stat hic simul pro romana gente et imperio tam prout fuit quondam in statu paganismi quam prout fuit postmodum in fide Christi, multis tamen criminibus cum hoc mundo fornicata. Vocatur ergo ‘meretrix magna’, quia a fideli cultu et sincero amore et deliciis Christi sponsi sui recedens adheret huic mundo et divitiis et deliciis eius et diabolo propter ista, et etiam regibus et magnatis et prelatis et omnibus aliis amatoribus huius mundi, et etiam quia quondam per fornicationem idolatrie coluit falsos deos quasi viros suos seu potius adulteros. Dicitur etiam quod “sedet super aquas multas”, id est principatur seu fundatur super populos multos fluxibiles sicut aque. Infra enim exponitur quod “aque” iste “sunt populi et gentes” (Ap 17, 15). Sequitur (Ap 17, 2): “Cum qua fornicati sunt reges terre”, scilicet tam seculares quam ecclesiastici, qui ut eius carnales glorias et delicias et divitias participent, sibi carnaliter et cum multis criminibus adherent. “Et inebriati sunt qui inhabitant terram”, id est terrena amantes, “de vino prostitutionis eius”, id est de fornicaria et abhominanda gloria eius. “Et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam” (Ap 17, 3), id est sanguine et colore coccineo tinctam et rubricatam. […] “Habentem capita septem et cornua decem”. […] Nota quod per predicta ornamenta possunt mistice intelligi omnia intellectualia dona quibus carnalis ecclesia abutitur in superbiam, iuxta quod et Ezechielis XVI° improperat Deus sinagoge et ecclesie per eam figurate quod de vestimentis et auro et argento, que dederat ei, fecit sibi excelsa et imagines idolorum, et omnia ornamenta et divitias quas sibi dederat obtulit eis (Ez 16, 10-19).[LSA, cap. XIII, Ap 13, 11 (IVa visio, VIum prelium)] “Et habebat duo cornua similia Agni”, id est Christi. Per hec cornua intelliguntur hic primo apparens similitudo gemine perfectionis Christi, scilicet scientie et sanctitatis Christi et suorum electorum. Secundo, apparens fulcimentum seu argumentum ex scientia et auctoritate duorum testamentorum, que utique sunt Christi, id est de Christo et a Christo.[LSA, cap. IX, Ap 9, 20-21 (IIIa visio, VIa tuba)] Sequitur (Ap 9, 20): “Et ceteri homines, qui non sunt occisi in hiis plagis neque penitentiam egerunt de operibus manuum suarum, ut non adorent demonia et simulacra aurea et argentea et erea et lapidea et lignea, que neque videre possunt neque audire neque ambulare, (Ap 9, 21) et non egerunt penitentiam ab homicidiis suis neque a veneficiis suis neque a fornicatione sua neque a furtis suis”, supple, occidentur in flagellis adhuc venturis nisi penitentiam egerint. […] Nota autem quod per simulacra non videntur hic ad litteram designari illa que proprie vocantur idola et quorum adoratio proprie vocatur idolatria, sed potius quecumque erronea dogmata, que quis tunc adorat cum ea credit, veneratur et colit ac si fidem catholicam Dei. Per idola etiam intelliguntur quecumque temporalia que per avaritiam adorantur, unde ad Ephesios V° dicitur quod avaritia “est idolorum servitus” (Eph 5, 5). Locutus est autem sic defective in signum gravissime ire et comminationis penarum ineffabilium. Solent enim multum irati interrumpere verba pre nimio impetu et multitudine spiritus iracundi, et aliquando significamus nos graviora minari per huiusmodi defectivas locutiones. […] Nota etiam quod predictam idolatriam describit et exprob<r>at tripliciter. Nam primo vocat eam adorare opera manuum suarum, secundo adorare demonia, tertio adorare simulacra, id est imagines corporales aliis rebus opere manuum assimilatas. Omnis enim error et peccatum est opus nostrum, non autem Dei. Quecumque etiam nos falso attribuimus quibuscumque personis vel rebus, quas estimamus et veneramur quasi ut deos, sunt in solo falso actu vel habitu estimationis et affectionis nostre. Turpis autem cecitas est proprium opus adorare ut Deum suum, nec minus turpe est adorare malitiam demonum nostre saluti semper invidam et hostilem; sensibilior autem dementia est adorare corpora exteriora a nobis diversimode mobilia et fabricabilia.[LSA, cap. XXI, Ap 21, 8 (VIIa visio)] […] “idolatris”, in quibus et subintelliguntur avari secundum Apostolum (Eph 5, 5) […]. |
|
Inf. XIX, 1-6, 100-117O Simon mago, o miseri seguaci
|
Inf. I, 71-72, 100-101e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto
|
■ La donna che siede sopra la bestia scarlatta (Ap 17, 3), tinta di sangue, un tempo dominò e regnò sulle bestiali genti del mondo e ancora domina su molte di esse a lei suddite, e per questo viene detta sedere sopra la bestia. Questa bestia al tempo dei pagani e degli eretici fu macchiata del sangue dei martiri, ora è macchiata del sangue abominevole della sua lussuria, della strage delle anime e dell’empia persecuzione dello spirito e degli spirituali. È adornata, in modo studioso e pomposo, di monili carnali e mondani (Ap 17, 4). La porpora e il colore scarlatto designano la sua crudeltà verso i martiri e verso quanti la macchiarono col loro sangue. Ha in mano una coppa d’oro, colma degli abomini e delle immondezze della sua prostituzione. Sebbene per ‘prostituzione’ si possa intendere qualsiasi peccato mortale immondo e abominevole per Dio e per i santi, il termine indica tuttavia soprattutto la simonia e la lussuria per il tempo cristiano e l’idolatria e la lussuria per il tempo pagano, allorché maestra e regina diede da bere a sé e alle genti soggette. Tiene in mano un calice aureo perché la sua gloria e il suo potere temporali appaiono a lei e a tutti i mondani preziosissimi e gloriosissimi come l’oro. “Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso” (Ap 17, 5), di grande mistero e significato: “Babilonia la grande, la madre delle prostituzioni e degli abomini della terra”. Si dice che il nome le stava scritto in fronte – sul luogo del corpo e del volto elevato ed evidente – poiché non nasconde la confusione delle sue colpe e della sua lussuria, ma anzi la rende pubblica, la impone e di essa si gloria e gode e ne porta un nome famoso presso tutti. Scrive Giovanni: “E vidi la donna ebbra” (Ap 17, 6), cioè saziata oltre misura, “del sangue dei santi”, cioè dell’uccisione dei santi minori, secondo l’interpretazione di Riccardo di San Vittore, “e del sangue dei martiri di Gesù”, ossia dei maggiori. Poiché li vinse uccidendoli nel tempo del paganesimo, esultò come ebbra. Nel tempo cristiano, si saziò del sangue dei santi in quanto la Chiesa carnale si inebriò della gloria temporale acquisita per i loro meriti e perché disprezzò e conculcò spiritualmente con le sue colpe il sangue di Cristo e dei santi. Il tema dell’ebbrezza compare anche ad Ap 14, 8, sempre riferito a Babilonia, che “ha abbeverato tutte le genti col vino del furore della sua fornicazione”.
Il simoniaco Niccolò III, credendo che Dante sia Bonifacio VIII giunto per farlo cadere più giù nella fessura della pietra, gli si rivolge facendo risuonare i temi della sazietà (Ap 17, 6), della sfrontatezza (Ap 17, 5-6) e della strage (Ap 17, 3): “Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio / per lo qual non temesti tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio?” (Inf. XIX, 55-57; cfr., a Purg. XX, 91-93, Filippo il Bello, “novo Pilato” non saziato dal rinnovarsi della passione di Cristo nel misfatto di Anagni, per cui porta “nel Tempio le cupide vele”).
Il tema dell’ebbrezza è pure nelle parole di Virgilio che chiudono Inf. XVIII – “E quinci sian le nostre viste sazie” – per le quali interviene il passo da Isaia 66, 24 citato ad Ap 19, 17-18 a proposito della dannazione dell’Anticristo e dei suoi seguaci: “Usciranno e vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, e saranno per tutti le viste sazie”. Taide, l’antica “puttana” – della quale Virgilio ha da poco parlato nella seconda bolgia, dove stanno i lusingatori -, è figura della nuova prostituta, cioè della Chiesa carnale e simoniaca, vista “puttaneggiar coi regi” e ripresa con parole gravi nel canto e nella bolgia seguenti.
Nel riferire al poeta come fu “cruda” la sua morte, il conte Ugolino racconta che, facendo il “mal sonno” che gli squarciò il velo del futuro, vide l’arcivescovo Ruggieri, “maestro e donno” della caccia al monte pisano – come Babylon fu maestra e dominatrice delle genti -, nella quale inseguiva “il lupo e ’ lupicini … con cagne magre, studïose e conte” (la prostituta è “studiose … ornata”). Il tema della sfrontatezza appare nell’arcivescovo che “s’avea messi dinanzi da la fronte”, cioè in prima fila, le famiglie ghibelline dei Gualandi, Sismondi e Lanfranchi (Inf. XXXIII, 19-20, 28-33). All’opposto della prostituta stanno le donne della Firenze antica rimpianta da Cacciaguida (Par. XV, 100-102, 112-114).
■ Ad Ap 17, 1 Olivi afferma che la grande meretrice designa la gente e l’impero dei Romani sia nello stato del paganesimo come in quello cristiano, durante il quale colpevolmente fornicò molto con questo mondo. Questa continuità viene sviluppata ad Ap 17, 6, dove il francescano pone la questione del perché vengano menzionate le colpe commesse da questa donna nel suo primo e antico periodo, al tempo dei pagani: per esse non dovrebbe essere condannata la gente carnale e semicristiana che vive nel sesto tempo della Chiesa. La risposta sta nelle parole di Cristo in Matteo 23, 35: “perché venga su di voi il giusto sangue effuso dal sangue di Abele il giusto”. Come un fiume che dura per molto tempo viene sempre considerato uno, per quanto l’acqua dei suoi primi anni sia diversa dall’acqua di questo anno che corre – al modo con cui diciamo che sono ormai cent’anni che questo fiume ha straripato o si è fatto sangue -, così il continuo succedere del popolo romano viene considerato una gente e un popolo, in modo che si possa dire che questo popolo fu prima pagano e poi cristiano, così da attribuire, quasi per sineddoche, quel che è di una parte all’altra parte o al tutto. Così la colpa della prima parte ridonda nella successiva, in quanto recidiva e fatta ingrata della grazia di Cristo che con misericordia l’ha lavata e santificata. Questa donna, pertanto, che dopo i molti e gravi giudizi fatti nella prima parte del suo popolo non temette di cadere in peccati simili o peggiori, deve essere giudicata per il dispregio di tutti i primi giudizi, anche misericordiosi, dati da Dio sui primi suoi padri, e dunque anche su di essa, su cui sarebbero ricaduti se non avesse demeritato. Imitando i peccati dei padri, li ha abbracciati e proseguiti, e pertanto è rea di tutto, come dice Cristo agli Ebrei del suo tempo: “Guai a voi che edificate i monumenti dei profeti, i vostri padri li hanno uccisi, poiché con la vostra opera date testimonianza che consentite alle opere dei vostri padri” (Luca, 11, 47- 48).
Questo passo contenente l’immagine del fiume “per multa tempora durans”, che giustifica teologicamente il connubio fra tempo pagano e tempo cristiano nel giudizio divino, si presta nel poema a molte variazioni. La storia umana che corre al giudizio come un unico grande fiume, anche se le sue acque non sono le stesse attraverso i secoli, rende partecipe – come in una sineddoche – il paganesimo di tutto il bene e il male che ridondano di secolo in secolo e ricadono infine sul sesto stato della Chiesa, cioè sull’età moderna. Questo passo, insieme ai precedenti versetti del capitolo XVII, assume rilievo in Inf. XXVII, l’altro canto nel quale Bonifacio VIII – nominato come “il gran prete” e “lo principe d’i novi Farisei” – è protagonista.
Il consentire alle opere dei padri, cioè alle precedenti colpe, ha condotto alla dannazione Guido da Montefeltro. I motivi dell’esegesi del fiume da Ap 17, 6 punteggiano tutto l’episodio (senza che il fiume sia mai citato). Già nel primo rivolgersi della fiamma al poeta, che Guido ritiene “caduto … di quella dolce terra / latina ond’ io mia colpa tutta reco” (Inf. XXVII, 25-27), si riconoscono il “cadere in peccata” e l’essere “omnium rea” della donna-fiume antica e nuova. Il Montefeltrano accusa Bonifacio VIII – “se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!, / che mi rimise ne le prime colpe” (vv. 70-71) – in quanto istigatore alla colpa recidiva: domandandogli consiglio su come gettare a terra Palestrina, lo ha fatto ricadere nel vecchio peccato di frode per cui si era acquistato fama con le sue opere volpine. La risposta data al pontefice dal vecchio uomo d’arme, che ora porta la corda francescana per fare ammenda del passato, è una testimonianza di consenso alle opere dei padri che caddero in peccato, ossia un edificare, nonostante il divieto di Cristo, un monumento ai profeti: «e dissi: “Padre, da che tu mi lavi / di quel peccato ov’ io mo cader deggio”» (vv. 108-109). Guido chiama Bonifacio “padre”, ed è motivo che concorda col cadere nel peccato antico. Erroneamente crede che da esso il pontefice possa lavarlo, cioè assolverlo: le parole di ammonimento di Beatrice sulla leggerezza nel far voti – “e non crediate ch’ogne acqua vi lavi” (Par. V, 75) – risuonano, a molti versi di distanza dall’episodio infernale, come un suggello. Se Guido ha consentito peccando alle opere dei padri, “la contradizion … nol consente” che ci si possa pentire della colpa e insieme volerla commettere, come argomenta il diavolo “löico” di fronte a san Francesco, venuto invano a prendere l’anima del frate dopo la morte (Inf. XXVII, 112-120). È da notare che cadere nuovamente nella colpa antica è proprio anche dei simoniaci: “Di sotto al capo mio son li altri tratti / che precedetter me simoneggiando, / per le fessure de la pietra piatti. / Là giù cascherò io altresì quando / verrà colui ch’i’ credea che tu fossi, / allor ch’i’ feci ’l sùbito dimando” (Inf. XIX, 73-78).
Non mancano nell’episodio del Montefeltrano altri riferimenti alla meretrice. Alla fiamma di Guido il poeta chiede di rivelarsi augurandole fama tra gli uomini – “se ’l nome tuo nel mondo tegna fronte” (Inf. XXVII, 55-57) – e Guido, credendo di parlare a persona che mai sarebbe tornata al mondo, risponde “sanza tema d’infamia”, non nasconde cioè, come la prostituta apocalittica, il suo nome famoso (vv. 64-66; cfr., a Inf. XIX, 56-57, le parole di Niccolò III al presunto Bonifacio VIII: “per lo qual non temesti tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio”). Le parole di Bonifacio VIII, che chiede al francescano consiglio su come distruggere Palestrina, paiono “ebbre” al vecchio uomo d’arme (Inf. XXVII, 98-99: unica occorrenza dell’aggettivo).
Quanto il papa dice a Guido – «E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti; / finor t’assolvo, e tu m’insegna fare / sì come Penestrino in terra getti. / Lo ciel poss’ io serrare e diserrare, / come tu sai; però son due le chiavi / che ’l mio antecessor non ebbe care”» (Inf. XXVII, 100-105) – per indurlo a dare “’l consiglio frodolente” su come prendere Palestrina ai Colonna – rinvia sinistramente a due precisi passi della Lectura. Papa Caetani, nelle sue parole ebbre, ripete l’invito dato da Cristo alla seconda chiesa, quella dei martiri, a non diffidare poiché egli è Colui che tutto precede e conclude (Ap 2, 8): “Tuo cuor non sospetti; / finor t’assolvo”. La potestà delle chiavi, in virtù della quale il papa può sciogliere e legare – “Lo ciel poss’ io serrare e diserrare” –, è perfezione di Cristo sommo pastore di cui ad Ap 1, 18, passo simmetrico ad Ap 2, 8 per la comune espressione con la quale Cristo dice di essere “primus et novissimus” (Ap 1, 17). Il presentarsi di Cristo alla chiesa di Smirne come “Colui che antecede” viene appropriato in tono beffardo a Celestino V, “’l mio antecessor”, il quale rinunciando “non ebbe care”, cioè non si curò delle chiavi che aprono e chiudono la salvezza. Figura perversa di Cristo in quanto sommo pastore: tale l’immagine di Bonifacio VIII che avrebbe dovuto imprimersi nella mente degli Spirituali francescani, riformatori della Chiesa.
[LSA, cap. XVII, Ap 17, 3-6 (VIa visio)] “Et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam” (Ap 17, 3), id est sanguine et colore coccineo tinctam et rubricatam. Nota quod sicut quodlibet caput bestie aliquando dicitur bestia, aliquando vero distinguitur ab ea sicut caput a corpore vel sicut rex a sua gente, sic mulier ista in quantum est carnalis et bestialis dicitur bestia, in quantum vero quondam prefuit et regnavit super bestiales gentes mundi et adhuc super plures bestiales sibi subditas dominatur, dicitur sedere super bestiam. Que quidem bestia tempore paganorum et hereticorum fuit sanguine martirum cruentata, nunc autem sanguine seu strage animarum et impia persecutione spiritus et spiritualium et etiam quorumcumque quos impie affligit est cruentata, et etiam abhominando sanguin<e> luxuriarum suarum. […] “Et mulier erat circumdata purpura et coccino et inaurata auro et lapide pretioso” (Ap 17, 4), id est studiose et pompose ornata carnalibus ornamentis et deliciis et divitiis et gloria huius mundi. Per purpuram etiam et coccinum, seu vestes coloris coccinei, potest intelligi crudelitas eius in martires et in alios quorum sanguine seu occisione fuit cruentata. “Habens poculum aureum in manu sua plenum abhominatione et immunditia fornicationis eius”. Quamvis per “fornicationem eius” intelligatur hic omne peccatum mortale Deo et sanctis immundum et abhominabile, precipue tamen pro isto tempore crimen sue horrendissime luxurie et symonie, pro tempore vero paganismi crimen idolatrie et etiam luxurie, quibus tamquam omnium regina et magistra potavit non solum se sed etiam omnes gentes sibi subiectas. Eius autem calix seu “poculum” dicitur “aureum”, quia eius temporalis gloria et potestas apparet sibi et omnibus mundanis pretiosissima et gloriosissima sicut aurum. “Et in fronte eius nomen scriptum misterium” (Ap 17, 5), id est magni misterii seu significantie, unde et quidam libri habent “misterii” in genitivo. Quod autem sit hoc nomen subdit, scilicet “Babilon magna, mater fornicationum et abhominationum terre”. Quia enim non abscondit confusionem suorum criminum et luxuriarum, sed etiam publice omnibus aperit et ingerit et de ipsa gloriatur et gaudet, et de hoc habet nomen apud omnes famosum, ideo dicitur hoc habere scriptum in fronte. Frons enim est sublimis et evidens locus corporis et faciei. […] Sequitur: “Et vidi mulierem ebriam” (Ap 17, 6), id est extra mensuram satiatam, “de sanguine sanctorum”, id est de occisione minorum secundum Ricardum, “et de sanguine martirum Ihesu”, scilicet maiorum*. Ex hoc enim quod ipsos occidendo vicit, velut ebria supra modum exultavit. Quod intellige pro illo tempore pro quo fuit in statu paganismi; tempore autem sequenti est satiata sanguine sanctorum quia de temporali gloria illorum meritis acquisita et data se inebriavit, et etiam quia per multa crimina sanguinem Christi et sanctorum contempsit et spiritaliter conculcavit. […] Prima culpa prioris partis redundat pro tanto in postremam pro quanto, per Christi gratiam ab ill<a> misericorditer lota et sanctificata, est recidivando de omnibus facta ingrata. Preterea ex hoc quod post multa gravia iudicia in primas partes sui populi facta non timuit cadere in peccata consimilia vel peiora, debet iudicari tamquam contemptrix omnium priorum iudiciorum et etiam misericordiarum factarum in priores patres eius, ac per consequens et in ipsam, pro quanto redundaverunt in eam vel redundassent si ipsa non demeruisset. Preterea pro quanto in imitando peccata priorum amplexatur et prosequitur illa, pro tanto est omnium rea, unde Christus Luce XI° dicit Iudeis sui temporis: “Ve vobis, qui edificatis monumenta prophetarum; patres autem vestri occiderunt illos” (Lc 11, 47), quod vestro opere pro certo “testificamini quod consentitis operibus patrum vestrorum” et cetera (Lc 11, 48).* In Ap V, ix (PL 196, col. 833 C-D).[LSA, cap. XIV, Ap 14, 8 (IVa visio, VIum prelium)] Unde et hic subditur: “que vino ire fornicationis sue potavit omnes gentes”. Sicut vinum carnaliter delectat et inebriat et suo fervore et ebrietate ad iram effrenatam et furibundam provocat, sic carnalis ecclesia se et omnes gentes sibi subiectas inebriavit et corrupit fedis carnalitatibus et symoniacis cupiditatibus et terrena gloria huius mundi, et dum erat in paganismo inebriavit omnes idolatria sua, et tunc et nunc tamquam ebria exarsit in ira<m> contra viros spiritales et contra vires et influxus Spiritus sancti.[LSA, cap. XIX, Ap 19, 17-18 (VIa visio)] Quantum autem ad Antichristum et eius complices tunc dampnatos, prefata manducatio carnium eorum designat gaudium sanctorum de glorificatione Christi et de ablatione impedimentorum perfecti cultus Dei ex condempnatione reproborum consurgente et clarius illuscente, unde Isaie ultimo dicit Deus quod sancti “egredientur et videbunt cadavera virorum, qui prevaricati sunt in me, et erunt usque ad satietatem visionis omni carni” (Is 66, 24), id est omni homini. Pro utroque autem sensu est illud Iob XXXIX°, ubi de aquila dicitur: “Ubicumque cadaver fuerit, statim adest” (Jb 39, 30). |
||
Inf. VI, 70-72Alte terrà lungo tempo le fronti,
|
||
Inf. XIX, 55-57, 73-78Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio
|
Inf. XXXIII, 19-20, 28-33
però quel che non puoi avere inteso,
cioè come la morte mia fu cruda
Questi pareva a me maestro e donno,
cacciando il lupo e ’ lupicini al monte
per che i Pisan veder Lucca non ponno.
Con cagne magre, studïose e conte
Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi
s’avea messi dinanzi da la fronte.
Purg. XX, 91-93
Veggio il novo Pilato sì crudele,
che ciò nol sazia, ma sanza decreto
portar nel Tempio le cupide vele.
Inf. XXVII, 25-27, 55-57, 64-72, 98-105, 108-111, 118-120
Se tu pur mo in questo mondo cieco
caduto se’ di quella dolce terra
latina ond’ io mia colpa tutta reco
Ora chi se’, ti priego che ne conte;
non esser duro più ch’altri sia stato,
se ’l nome tuo nel mondo tegna fronte.
ma però che già mai di questo fondo
non tornò vivo alcun, s’i’ odo il vero,
sanza tema d’infamia ti rispondo.
Io fui uom d’arme, e poi fui cordigliero,
credendomi, sì cinto, fare ammenda;
e certo il creder mio venìa intero,
se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!,
che mi rimise ne le prime colpe;
e come e quare, voglio che m’intenda.
domandommi consiglio, e io tacetti
perché le sue parole parver ebbre.
E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti;
finor t’assolvo, e tu m’insegna fare
sì come Penestrino in terra getti.
Lo ciel poss’ io serrare e diserrare,
come tu sai; però son due le chiavi
che ’l mio antecessor non ebbe care”.
e dissi: “Padre, da che tu mi lavi
di quel peccato ov’ io mo cader deggio,
lunga promessa con l’attender corto
ti farà trïunfar ne l’alto seggio”.
ch’assolver non si può chi non si pente,
né pentere e volere insieme puossi
per la contradizion che nol consente”.
Par. XV, 100-102, 112-114
Non avea catenella, non corona,
non gonne contigiate, non cintura
che fosse a veder più che la persona.
Bellincion Berti vid’ io andar cinto
di cuoio e d’osso, e venir da lo specchio
la donna sua sanza ’l viso dipinto
[LSA, cap. I, Ap 1, 17-18 (Ia visio)] Deinde explicat sibi illas suas perfectiones ex quarum fide et notitia amplius poterat confortari. Subdit ergo tres binarios suarum perfectionum. Primus est: “Ego sum primus et novissimus” (Ap 1, 17), id est omnium principium et finis, seu principiator et consumator, vel “primus” dignitate et eternitate “et novissimus” humilitate, per quam usque ad mortem crucis me humiliavi. […] Tertius binarius est: “et habeo claves mortis et inferni” (Ap 1, 18), id est habeo potestatem educendi quoscumque a sepulcro mortis, tam corporis quam culpe, et etiam a profundo infernalis gehenne. Potest etiam per has claves intelligi potestas condempnandi et introducendi dampnatos in mortem eterni supplicii et in locum inferni. Per claves enim intelligitur potestas aperiendi et claudendi, quia clave aperimus vel claudimus archam vel domum. Hic tamen potius referuntur claves ad primum, quia illud est confortativum, secundum vero terrificativum.
[LSA, cap. II, Ap 2, 8 (Ia visio, IIa ecclesia)] Hiis autem premittitur primo iussio de scribendo hec episcopo huius ecclesie. Et secundo Christi loquentis introductio, et hoc sub forma sequentibus congruente, ibi (Ap 2, 8): “Hec dicit primus et novissimus”, id est cuius eternitas antecedit et principiat omnia, et est ultra omnia etiam futura, et finit ac consumat omnia, quasi dicat: non diffidas te a tuis passionibus per me salvandum, quia ego sum omnium principium et consumator. Item est “primus” dignitate et “novissimus” humilitate usque ad mortem crucis, unde subdit: “qui fuit mortuus et vivit”, quasi dicat: exemplo mee mortis et spe mee vite, quam per mortem promerui et per meam potentiam obtinui, debes animari ad martiria et non diffidere in eis, sed potius sperare ex eis vitam eternam.
6. “Un tempo, due tempi e la metà di un tempo”
Si esaminano qui le metamorfosi che nel “poema sacro” assume l’espressione apocalittica “per (un) tempo, (due) tempi e la metà di un tempo” – “per tempus et tempora et dimidium temporis”. Queste parole sono riferite al periodo (si tratta, nella quarta visione, dell’esegesi congiunta della terza e della quarta guerra) in cui la donna (la Chiesa) venne nutrita lontano dal serpente nel deserto dei Gentili, il luogo preparatole da Dio come suo, e dove le vennero date le due ali di una grande aquila (Ap 12, 14). Su di esse, secondo Olivi, Gioacchino da Fiore ha fondato tutta la sua Concordia. L’espressione indica un periodo di tre anni e mezzo, formati da quarantadue mesi (12 mesi x 3 anni + 6 mesi) nei quali i trenta giorni dei singoli mesi corrispondono a trenta anni: si ha così una permanenza della donna nel deserto di 1260 anni. “Tempus” sta per un anno, “tempora” per due anni e “dimidium temporis” per sei mesi. I “due anni” derivano dal duale greco, lingua nella quale scrisse Giovanni. Questo numero compare anche ad Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra) per indicare il periodo in cui la donna venne nutrita nel deserto (dove era fuggita dalla durezza dei Giudei), mentre in Daniele 7, 24-25 si dice che il re undicesimo distruggerà i santi dell’Altissimo che gli saranno dati in mano “per un tempo, due tempi e la metà di un tempo” e in Daniele 12, 6-7 che “fra un tempo, due tempi e la metà di un tempo si compiranno tutte queste cose meravigliose”.
Questo numero mistico ha vari significati. I tre anni e mezzo designano il mistero della trinità di Dio unitamente alla perfezione delle sue opere, che rispetto al loro artefice sono qualcosa di dimidiato, imperfetto, parziale e quasi nulla: le opere furono infatti compiute in sei giorni, che corrispondono alle sei età del mondo e ai sei mesi del mezzo anno. Designano anche la perfezione che deriva dalla fede, dalla speranza e dalla carità unita alla pregustazione non completa della gloria eterna, oppure i tre principali consigli di Cristo (povertà, castità, obbedienza) uniti ad una partecipazione non perfetta della vita eterna. I tre anni e mezzo coincidono con il periodo durante il quale Cristo esercitò il suo magistero e la sua predicazione. Essi sono anche distinti in “un anno” (“tempo”) e “due anni” (“tempi”), in quanto nel secondo e nel terzo anno Cristo predicò da solo dopo l’incarcerazione di Giovanni Battista e in modo più solenne. Questa distinzione, tenendo conto della profezia di Daniele, si verificherà forse anche nella predicazione e persecuzione dell’Anticristo. Con Giovanni Battista, come dice Cristo in Matteo 11, 11-12 e in Luca 16, 16, inizia il tempo in cui i violenti si impadroniscono del regno dei cieli (cfr. quanto dice l’aquila a Par. XX, 94: “Regnum celorum vïolenza pate”).
■ Una delle metamorfosi del numero mistico espresso con “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” sta nelle tre facce della testa di Lucifero: “L’una dinanzi, e quella era vermiglia [un tempo]; / l’altr’ eran due [la nera e quella tra bianca e gialla: due tempi], che s’aggiugnieno a questa / sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla [la metà di un tempo]” (Inf. XXXIV, 39-41). È da notare che la prima faccia viene presentata separatamente dalle altre due [1]. Il tema continua con i tre peccatori che Lucifero fa dolenti rompendoli coi denti a guisa di maciulla. Anche in questo caso, il primo – Giuda – viene separato dagli altri due, Bruto e Cassio: “A quel dinanzi [un tempo] il mordere era nulla / verso ’l graffiar [l’esser nulla è motivo che distingue la metà di un tempo] … De li altri due c’hanno il capo di sotto, / quel che pende dal nero ceffo è Bruto … e l’altro è Cassio …” [due tempi] (vv. 58-67).
■ Viene riproposto il medesimo tema in apertura di Inf. XXVIII (7-21), nella complessa similitudine cui il poeta ricorre per descrivere la sozza condizione della nona bolgia, dove sono i seminatori di scandalo e di scisma: se si mettessero insieme tutti i morti e i feriti che insanguinarono nel corso dei secoli le terre del Mezzogiorno d’Italia, e questi mostrassero le loro membra forate o mozze, non si offrirebbe un’idea adeguata alla circostanza. Viene prima “tutta la gente / che già, in su la fortunata terra / di Puglia, fu del suo sangue dolente” a causa dei “Troiani” (per la venuta di Enea in Italia) e della lunga seconda guerra punica, che a Canne “de l’anella fé sì alte spoglie” (gli anelli strappati dalle dita dei Romani caduti). A questo primo gruppo delle genti di Puglia (con la quale si intende la parte continentale del Regno di Sicilia) si dovrebbe aggiungere un secondo, formato a sua volta da due gruppi: la gente che tentò invano di contrastare Roberto il Guiscardo e quella caduta nelle guerre tra Angioini e Svevi. Questo secondo sottogruppo si divide ancora in due parti: la gente caduta a Ceprano, abbandonata per tradimento – “là dove fu bugiardo / ciascun Pugliese” (indiretta allusione alla battaglia di Benevento dove fu sconfitto Manfredi) -, e quella caduta a Tagliacozzo, dove Corradino venne sconfitto per via di un accorto consiglio dato a Carlo d’Angiò dal “vecchio Alardo”. Il primo gruppo – le genti di Puglia – corrisponde al “tempo” (un anno); il secondo, doppio gruppo – i caduti o i feriti nei combattimenti contro Roberto il Guiscardo e quelli nelle guerre svevo-angioine – a “tempi” (due anni); la “metà di un tempo” (mezzo anno) sta nel “nulla” che la riunione di tutti e tre i gruppi di caduti offre rispetto a quanto visto dal poeta nella bolgia: il mezzo anno designa infatti qualcosa di dimidiato, imperfetto e parziale (con “dimidium” concorda anche il “mezzul” del fondo della botte, di cui si dice al verso 22). È da notare la simmetria del motivo dei “due tempi”, che rispecchia il duale greco, in Inf. XXVIII e XXXIV: “S’el s’aunasse ancor tutta la gente … con quella … e l’altra … quel che pende dal nero ceffo è Bruto … e l’altro è Cassio …”.
■ Una variante del tema sembra presente anche in quanto dichiarato dal simoniaco Niccolò III in Inf. XIX, 79-84: il tempo da lui trascorso nella posizione di piantato sottosopra coi piedi accesi nel foro della livida pietra è già quasi di venti anni (agosto 1280 – marzo/aprile 1300), un “tempo” più lungo di quello in cui vi resterà Bonifacio VIII, che alla morte nell’ottobre 1303 prenderà il suo posto e lo farà cadere più giù nelle fessure della pietra, perché Bonifacio, dopo quasi undici anni, verrà a sua volta sostituito nel 1314 da Clemente V, “pastor sanza legge” che ricoprirà entrambi i suoi predecessori per “più laida opra”. Il motivo della “metà di un tempo” si può considerare applicato sia a Bonifacio VIII, che trascorrerà piantato come palo circa la metà del tempo toccato a Niccolò III, sia, nel significato di un’opera parziale e imperfetta che assume qui un sapore amaro, a entrambi i pontefici, l’Orsini e il Caetani, la cui opera, alla fine, risulterà meno laida di quella del guascone Bertrand de Got. È comunque da notare come il medesimo tema venga appropriato sia ai papi simoniaci sia a Lucifero, figure che designano, attraverso un numero mistico loro applicato, la durata della tribolazione (tre anni e mezzo) sotto il regno dell’Anticristo (l’undicesimo re di Daniele 7, 24-25). L’espressione “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” sarà ancora utilizzata da Botticelli alla fine dell’anno 1500, come datazione della Natività mistica ispirata ai sermoni sull’Apocalisse del Savonarola [2]. |
■ Un’altra variazione è nella spiegazione data da Manfredi della penitenza impostagli come scomunicato: chi muore in contumacia di Santa Chiesa, ancorché si penta in fin di vita, “per ognun tempo” che è stato “in sua presunzïon”, ostinato cioè nel non volersi sottomettere all’autorità ecclesiastica, deve restare fuori del purgatorio trenta volte (il numero trenta fa parte del numero mistico 1260), a meno che questo decreto non venga abbreviato (la “metà di un tempo”) per l’intervento delle buone preghiere (Purg. III, 136-141) [3].
■ Il motivo della “metà di un tempo”, cioè di un’opera parziale e imperfetta, viene ancora ironicamente appropriato al vivere civile di Atene e Sparta, “picciol cenno” rispetto alle sottili leggi fiorentine che varate ad ottobre non durano alla metà di novembre (Purg. VI, 139-144). Con esso viene vestita la reminiscenza ovidiana della “folle Aragne”, la tessitrice che sfidò Minerva, raffigurata sul pavimento del primo girone dei superbi “già mezza ragna, trista in su li stracci / de l’opera che mal per te si fé” (Purg. XII, 43-45; cfr. quanto afferma Niccolò III del ‘futuro’ papa Clemente V: “ché dopo lui verrà di più laida opra, / di ver’ ponente, un pastor sanza legge”: Inf. XIX, 82-83). A Par. XIX, 133-138, l’aquila dice di Federico II d’Aragona (re di Sicilia dal 1296 al 1337) che nel libro della vita (cfr. Ap 20, 12) le sue opere saranno scritte con lettere abbreviate “a dare ad intender quanto è poco” [‘metà di un tempo’]; pure all’apertura del libro “parranno a ciascun l’opere [‘metà di un tempo’] sozze / del barba [Giacomo, re di Maiorca] e del fratel [Giacomo re di Sicilia e poi di Aragona], che tanto egregia / nazione [l’Aragona: ‘un tempo’] e due corone [Maiorca e Aragona: ‘due tempi’] han fatte bozze”.
■ I tre anni e mezzo designano il mistero della trinità di Dio unitamente alla perfezione delle sue opere, che rispetto al loro artefice sono qualcosa di dimidiato, imperfetto e parziale e quasi nulla: così nella visione finale il poeta vede “tre giri / di tre colori e d’una contenenza”, ma il suo dire è “corto” e “fioco”, inadeguato rispetto al concetto, a quanto cioè la mente ha ritenuto della visione, concetto che a sua volta è “poco”: il corto, il fioco, il poco esprimono il significato contenuto nella “metà di un tempo” (Par. XXXIII, 115-123).
■ La vicinanza del verbo “pertractare”, riferito nell’esegesi di Ap 12, 6 al quinto libro della Concordia di Gioacchino da Fiore, con il numero mistico “per tempus et tempora et dimidium temporis” (da Daniele, 12, 6-7; cfr. gli incisi “… sub uno quam brevi coart<ar>emus sermone … nisi hoc quod sonat versiculus iste …” con Par. XXXIII, 74, 106 : “e per sonare un poco in questi versi … Omai sarà più corta mia favella”) conduce a Inf. XI, 79-84, dove Virgilio ricorda al discepolo le tre disposizioni peccaminose odiate da Dio – “incontenenza, malizia e la matta / bestialitade” – esposte ampiamente (‘pertrattate’) nell’Etica di Aristotele. Una di queste tre disposizioni, l’incontinenza, offende meno Dio e suscita minor biasimo, e pertanto gli incontinenti stanno fuori della città di Dite meno martellati nelle pene dalla divina vendetta. All’incontinenza è applicato il tema della “metà di un tempo”, mentre la malizia sembra corrispondere a “tempi” (il duale greco), considerato che ai vv. 22-24 si dice che il fine di ogni malizia, che consiste nell’“ingiuria”, cioè nell’infrazione delle leggi divine o naturali, si consegue in due modi, con la forza (i violenti) o con l’inganno (i fraudolenti); quest’ultimo, a sua volta, si distingue nella frode verso chi si fida e in quella verso chi non si fida, con andamento bipartito riscontrabile in principio di Inf. XXVIII (Inf. XI, 52-66: “Questo modo di retro … Per l’altro modo …”). La “matta bestialitade” corrisponderebbe pertanto a “(un) tempo”. Da notare che i violenti hanno un andamento ternario, per non dire trinitario: “ma perché si fa forza a tre persone … a Dio, a sé, al prossimo” (Inf. XI, 28-33).
[1] I tre eserciti contrari a Cristo, designati rispettivamente all’apertura del secondo, del terzo e del quarto sigillo con il cavallo rosso, il cavallo nero e il cavallo pallido, si trasformano nelle tre facce di Lucifero (Inf. XXXIV, 39-45): la prima vermiglia, la seconda nera, la terza tra bianca e gialla.
[2] La Natività mistica della National Gallery di Londra reca in alto, su tre righi, la seguente scritta in greco: «Questo dipinto, sulla fine dell’anno 1500, durante i torbidi d’Italia, io, Alessandro, dipinsi nel mezzo tempo dopo il tempo, secondo l’XI di san Giovanni nel secondo dolore dell’Apocalisse, nella liberazione di tre anni e mezzo del Diavolo; poi sarà incatenato nel XII e lo vedremo [calpestato] come nel presente dipinto» (trad. a cura di G. Mandel in L’opera completa del Botticelli, Milano 1967 [Classici dell’arte], pp. 108-109, n. 148).
[3] La donna (la Chiesa) trova nel deserto dei Gentili, della fede e della contemplazione cristiana “il luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni” (Ap 12, 6). Il suo è un pasto spirituale, con il quale incorpora i Gentili nella fede di Cristo, non potendo incorporare i Giudei, dalla cui durezza è fuggita. È da ricordare che il purgatorio, “lito diserto” (Purg. I, 130), “aspro diserto” (Purg. XI, 14), possiede le caratteristiche del deserto della gentilità (la forma “gentile/i” vi ricorre otto volte [cfr. anche “l’altre genti forme” a Purg. IX, 58], contro quattro occorrenze nell’Inferno e una nel Paradiso); Dante vi rimane tre giorni e mezzo (la cantica si chiude al meriggio del quarto giorno), un periodo di tempo corrispondente ai 1260 anni della permanenza della donna nel deserto, ovvero all’espressione “(un) tempo, (due) tempi e la metà di un tempo” di Ap 12, 14. A questo punto non appare casuale il fatto che siano 1260 i versi dei primi nove canti del Purgatorio, che descrivono il cosiddetto ‘antipurgatorio’, fino alla porta sulla cui soglia siede l’angelo al quale san Pietro ha affidato le chiavi. La porta costituisce la prima meta del viaggio prefissata in Inf. I, 130-135: “… Poeta, io ti richeggio … che tu mi meni là dov’ or dicesti, / sì ch’io veggia la porta di san Pietro …”. La divisione spirituale del poema non coincide però necessariamente con quella esteriore per cantiche e canti: così l’apertura effettiva della porta inizia a Purg. IX, 133, cioè tredici versi prima della fine del canto (che conta 145 versi). Questo spazio viene occupato dai tredici versi finali dell’Inferno (XXXIV, 127-139), che descrivono la risalita alla superficie della terra, una volta usciti dall’abisso, per il “cammino ascoso” segnato non dalla vista ma dal suono di un ruscelletto.
Tab. VIII
[LSA, cap. XII, Ap 12, 14 (IVa visio, III-IVum prelium)] Dicit autem “per tempus et tempora et dimidium temporis”, id est per tres annos et dimidium ex quadraginta duobus mensibus triginta annorum, id est mille ducentis sexaginta annis constantes. Eundem enim numerum sub aliis verbis intendit hic ponere, quem posuit paulo ante (cfr. Ap 12, 6). Per “tempus” enim intelligitur unus annus, et per “tempora” duo ann<i>. Nam Greci, in quorum lingua iste liber est editus, habent tres numeros in suis articulis, scilicet singularem et dualem et pluralem. Quod autem “tempus et tempora et dimidium temporis” sumatur alibi pro tribus annis et dimidio, patet quia Danielis VII° dicitur quod rex undecimus, designatus per undecimum cornu, “sanctos Altissimi conteret et tradentur in manu eius usque ad tempus et tempora et dimidium temporis” (Dn 7, 25). In hoc autem libro et infra, XIII° capitulo, dicitur quod “data est illi potestas facere malum per menses quadraginta duos” (Ap 13, 5) et idem dicitur supra, XI° (Ap 11, 2.9.11). Quod autem “tempus et tempora”, id est tres anni, non sumantur hic pro annis dierum seu mensium ex solis triginta diebus constantium, se<d> potius pro annis duodecim mensium ex triginta annis quasi ex triginta diebus constantium, patet non solum ex supradictis, sed etiam quia in tertio et quarto statu ecclesie non apparuit talis persecutio vel mansio in deserto per solos tres annos dierum perdurans. Preterea hic non dicit ‘ubi aletur per tempus et tempora’, sed “ubi alitur”, tamquam monstrans se loqui de toto tempore pastus eius, de quo supra dixerat quod “habet” in deserto “locum paratum a Deo, ut ibi pascat eam mille ducentis sexaginta diebus” (Ap 12, 6).
|
|
Inf. XXXIV, 22-24, 37-45, 55-67Com’ io divenni allor gelato e fioco,
|
Inf. XXVIII, 7-24S’el s’aunasse ancor tutta la gente
|
[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio, III-IVum prelium)] Notandum autem quod Ioachim totum librum suum Concordie veteris et novi testamenti fundavit super numero hic posito. Unde libro V° Concordie, circa finem pertractans verba illa angeli dicta Danieli, quod “in tempus et tempora et dimidium temporis” erit “finis horum mirabilium” (Dn 12, 6-7), dicit: «Verba hec Danielis ita a lectore huius operis pensari debere vellem, ut quicquid a principio huius operis usque huc late et diffuse contulimus sub uno quam brevi coart<ar>emus sermone. Nichil enim aliud nos intimasse credimus, nisi hoc quod sonat versiculus iste: ‘in tempus et tempora et dimidium temporis omnium istorum mirabilium esse finem’. Quia sicut iam per multas vices nos dixisse meminimus, in hiis quadraginta duabus generationibus septem signacula continentur, nichilque aliud est dicere “in tempus et tempora et dimidium temporis” complebuntur quam illud quod, sub sexto angelo tuba canente, alter angelus aut forte unus et idem ait: “tempus iam non erit amplius, sed in voce septimi angeli, cum ceperit tuba canere” (Ap 10, 6-7)»*.* Concordia, V 6, c. 4 § 8; Patschovsky 3, pp. 1009, 10-17–1010, 1-6. |
|
AVVERTENZE
■ Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, Olivi suggerisce, nel prologo della Lectura, un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato sui sette stati (status), cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, prefigurate nell’Antico Testamento.
L’Apocalisse si articola in sette visioni: le sette chiese d’Asia, i sette sigilli, le sette trombe, la donna vestita di sole (le sette guerre sostenute dalla Chiesa), le sette coppe, il giudizio di Babylon nelle sette teste del drago, la Gerusalemme celeste. Le prime sei visioni possono essere a loro volta divise in sette momenti, ciascuno dei quali riferibile a uno dei sette stati. Assembrando, per le prime sei visioni, tutti i primi elementi (chiesa, sigillo, tromba, guerra, coppa, momento del giudizio di Babylon), tutti i secondi, i terzi e così di seguito, si ottengono sette gruppi di materia teologica, corrispondenti al complesso dei temi afferenti a ciascuno dei sette stati. A questi sette gruppi si aggiungono altri due: l’esegesi della settima visione (senza articolazioni interne) e l’esegesi di capitoli del testo scritturale, o di parti di essi, introduttivi delle successive specificazioni delle singole visioni per settenari, che Olivi definisce “radicalia” o “fontalia”. Si ottengono in tal modo nove gruppi: le parti proemiali, i sette assembramenti di settenari e la settima visione. Il grande prologo della Lectura, articolato in tredici notabilia, può essere anch’esso aggregato secondo i sette stati. Un libro (la Lectura) contiene dunque princìpi e criteri affinché l’accorto lettore possa trarne un altro libro, fatto con lo stesso materiale ma ricomposto e distribuito in forma diversa.
■ La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati della storia della Chiesa, cioè alle categorie con cui Olivi organizza la materia esegetica. Questo ordine interno è registrabile per zone progressive del poema dove prevale, tramite parole-chiave, la semantica riferibile a un singolo stato. È un’intima struttura dirompente i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ogni stato, che ha differenti inizi, è concatenato per concurrentia, come le maglie di un’armatura, con quello che precede e con quello che segue. Si possono in tal modo redigere mappe che comprendano l’ordine spirituale della Commedia. La ricerca è pervenuta a una Topografia spirituale della Commedia, dove quasi per ogni verso, o gruppo di versi, collegamenti ipertestuali conducono al “panno” esegetico fornito dalla Lectura super Apocalipsim, sul quale il “buon sartore” ha fatto “la gonna” (cfr. Par. XXXII, 139-141).
■ A ogni gruppo è arbitrariamente assegnato un diverso colore: Radici (verde), I stato (verde acqua), II stato (rosso), III stato (nero), IV stato (viola), V stato (marrone), VI stato (blu), VII stato (indaco), VII visione (fucsia). Dei gruppi sono stati integralmente studiati il terzo stato e la settima visione. Mentre la diversità dei colori è rispettata nella tabella complessiva contenente i collegamenti ipertestuali, nelle sinossi i colori possono essere variati per maggiore evidenza.
■ Non di rado nei versi alcune parole o incisi-chiave possono rinviare a più luoghi esegetici. Questo perché il testo dottrinale contenuto nella Lectura, prima di travasarsi semanticamente nella Commedia, è stato sottoposto a una duplice riorganizzazione. La prima, sulla base delle indicazioni dello stesso Olivi, secondo il materiale esegetico attribuibile ai singoli stati. La seconda, seguendo il principio applicato nelle distinctiones ad uso dei predicatori, sulla base di lemmi analogicamente collazionati. La “mutua collatio” di parti della Lectura arricchisce il significato legato alle parole e consente uno sviluppo tematico amplificato. Si vedano, ad esempio, le variazioni eseguite sul tema della “voce” o sull’espressione “in medio”, temi più volte iterati nel sacro testo, oppure il modo con cui Ap 1, 16-17 (l’esegesi della decima e undecima prefezione di Cristo come sommo pastore) percorre i versi in collazione con altri passi. A ciò predispone lo stesso testo scritturale, poiché l’Apocalisse contiene espressioni, come Leitmotive, che ritornano più volte. È determinata da parole-chiave che collegano i passi da collazionare. È suggerita dallo stesso Olivi, nel prologo, per una migliore intelligenza del testo.
■Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di WARREN LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in ALBERTO FORNI – PAOLO VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.
Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di GIORGIO PETROCCHI, Firenze 1994. Si tiene anche conto della recente edizione a cura di GIORGIO INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA.
Si fa riferimento ai seguenti commenti:
Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno. Commento di ANNA MARIA CHIAVACCI LEONARDI, Milano 2007 (19911).
Dante Alighieri, Commedia. Inferno. revisione del testo e commento di GIORGIO INGLESE, Roma 2007.
ABBREVIAZIONI
Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.
LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.
Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).
Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.
Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.
In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.
Note sulla “topografia spirituale” della Commedia
Per quanto segua l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, Olivi suggerisce un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo esegetico, fondato sui sette stati, cioè sui periodi nei quali si articola la storia della Chiesa. L’Antico Testamento corrisponde alle prime cinque età del mondo, secondo la divisione tradizionale [1]: è l’età del Padre secondo Gioacchino da Fiore. Con il primo avvento di Cristo, nella carne, inizia la sesta età (l’età del Figlio), nella quale la Chiesa, come fosse un individuo, cresce e si sviluppa in sette stati. Al primo, apostolico periodo, succede il secondo dei martiri; poi, al tempo di Giustiniano, il terzo stato dei dottori che confutano con l’intelletto le eresie concorre con il quarto stato degli affettuosi anacoreti devoti al pasto eucaristico, alti per la contemplazione ma anche attivi come reggitori delle genti; a partire da Carlo Magno subentra il quinto stato aperto alla vita associata delle moltitudini, bello nel principio ma poi corrottosi fino a trasformare quasi tutta la Chiesa in una nuova Babilonia; la riforma interviene, a partire da Francesco, con il cristiforme sesto stato, fino alla sconfitta dell’Anticristo; subentra infine il silenzio e la quiete del pacifico settimo stato. Il sesto e il settimo stato (la terza età di Gioacchino da Fiore) coincidono con il secondo avvento di Cristo, nello Spirito, cioè nei suoi discepoli spirituali inviati a convertire il mondo con la predicazione; al termine del settimo stato ci sarà il terzo avvento, nel giudizio.
L’Apocalisse si articola in sette visioni: le sette chiese d’Asia, i sette sigilli, le sette trombe, la donna vestita di sole (le sette guerre sostenute dalla Chiesa), le sette coppe, il giudizio di Babylon nelle sette teste del drago, la Gerusalemme celeste. Le prime sei visioni possono essere a loro volta divise in sette momenti, ciascuno dei quali riferibile a uno dei sette stati. Assembrando, per le prime sei visioni, tutti i primi elementi (chiesa, sigillo, tromba, guerra, coppa, momento del giudizio di Babylon), tutti i secondi, i terzi e così di seguito, si ottengono sette gruppi di materia teologica, corrispondenti al complesso dei temi afferenti a ciascuno dei sette stati [2]. A questi sette gruppi se ne aggiungono altri due: l’esegesi della settima visione (senza articolazioni interne) e l’esegesi di capitoli del testo scritturale, o di parti di essi, introduttivi delle successive specificazioni delle singole visioni per settenari, che Olivi definisce “radicalia” o “fontalia”. Si ottengono in tal modo nove gruppi: le parti proemiali, i sette assembramenti di settenari e la settima visione. Il grande prologo della Lectura, articolato in tredici notabilia, può essere anch’esso aggregato nelle sue parti secondo i sette stati.
L’intenso travaso di parole-temi dalla Lectura nella Commedia si accompagna a un fatto strutturale. La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati oliviani. È un ordine registrabile per zone progressive del poema dove prevalgono i temi di un singolo stato, che rompe i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ogni stato, che ha differenti inizi, è concatenato per “concurrentia”, come le maglie di un’armatura, con quello che precede e con quello che segue. Ciascuno stato ha in sé una grande ricchezza di motivi e contiene inoltre temi di tutti gli altri, consentendo innumerevoli intrecci e variazioni. La Commedia appare, come l’Apocalisse, “libro scritto dentro e fuori” (Ap 5, 1), con duplice struttura, linguaggio e senso, letterale e spirituale. Il viaggio di Dante e la visione di Giovanni hanno la stessa causa finale, che è la beatitudine, alla quale si perviene con diverse guide, per gradi segnati da visioni sempre più nuove e ardue delle precedenti, attraverso una sempre maggiore apertura dell’arcano coperto dal velame dei sette sigilli fino al punto più alto in cui, in questa vita, è possibile vedere la verità.
Tutti i modi del linguaggio interiore al poema esprimono un processo, un viaggio dal più chiuso al più aperto, e in questo andare hanno una loro precisa collocazione ‘topografica’, uno ‘stato’ (nel senso di momento storico che ricade sulla coscienza individuale) al quale appartenere. Si possono in tal modo stendere vere e proprie mappe tematiche che comprendano l’ordine spirituale di tutta la Commedia che aderisce, parodiandola semanticamente, a una precisa teologia della storia, sia pure modificandone profondamente le prospettive. La ciclicità dei temi permette di stabilire collegamenti inusitati tra le diverse zone; il procedere per gradi dell’illuminazione divina fa sì che episodi oscuri e quasi ermeticamente chiusi si chiariscano poi, aprendosi all’intelligenza in modo più alto.
A ogni gruppo è arbitrariamente assegnato un diverso colore: Radici (verde), I stato (verde acqua), II stato (rosso), III stato (nero), IV stato (viola), V stato (marrone), VI stato (blu), VII stato (indaco), VII visione (fucsia). Dei gruppi sono stati integralmente studiati il terzo stato e la settima visione.
INFERNO
(le prime cinque età del mondo)
La ‘topografia spirituale’ del poema mostra nell’Inferno cinque cicli settenari corrispondenti agli stati della Chiesa descritti da Olivi e ai loro temi contenuti nella Lectura. Questi cinque cicli designano le prime cinque età del mondo (riunite a loro volta nel primo stato generale, che corrisponde all’età del Padre di Gioacchino da Fiore), in quanto prefigurazione del primo avvento di Cristo e della Chiesa.
I cinque cicli settenari che si susseguono nell’Inferno a partire dal quarto canto (i primi tre canti hanno una tematica particolare) sono preceduti da cinque zone che possono essere definite ‘snodi’, dove cioè confluiscono temi provenienti da più stati, intrecciati insieme ad altri ad avviare il procedere settenario. Il centro di questi ‘snodi’ coincide con un canto (Inf. IV, X, XVII, XXVI, XXXII), ma la zona è più vasta e supera l’ambito dato dalla divisione letterale del poema.
Inf. I-III sono da considerare al di fuori dei cicli. Inf. I e II sono profondamente segnati dai temi del sesto stato. Inf. III è riferibile al settimo stato (per gli ignavi) e in parte al quinto (per l’episodio di Caronte). |
|||
canti |
I ciclo |
stati |
cerchi |
IV |
Limbo |
Radici, I (I snodo) |
I |
V |
lussuriosi |
II |
II |
VI |
golosi |
III |
III |
VII |
avari e prodighipalude Stigia
|
III–IV
V |
IV
|
VIII |
palude Stigia (orgogliosi)
|
V |
V |
IX |
apertura della porta di Dite |
V–VI |
|
canti |
II ciclo |
stati |
cerchi |
IX-X-XI |
eretici, ordinamento dell’inferno |
I (II snodo) |
VI |
XII |
violenti contro il prossimo |
II |
VII (girone 1) |
XIII |
violenti contro sé |
III |
(girone 2) |
XIV |
violenti contro Dio: bestemmiatori |
IV |
(girone 3) |
XV-XVI |
violenti contro Dio: sodomiti |
V |
|
XVIXVII |
ascesa di GerioneGerione, violenti contro Dio: usurai |
VI |
canti |
III ciclo |
stati |
cerchi |
XVII |
volo verso Malebolge |
I (III snodo) |
|
XVIII |
ruffiani, lusingatori |
Radici – II |
VIII (bolgia 1, 2) |
XIX |
simoniaci |
III |
(bolgia 3) |
XX |
indovini |
IV |
(bolgia 4) |
XXI-XXII |
barattieri |
V |
(bolgia 5) |
XXIII |
ipocriti |
V–VI |
(bolgia 6) |
XXIV-XXV |
ladri |
VI |
(bolgia 7) |
canti |
IV ciclo |
stati |
cerchi |
XXVI |
consiglieri di frode (greci) |
I (IV snodo) |
(bolgia 8) |
XXVII |
consiglieri di frode (latini) |
II |
|
XXVIII-XXIX |
seminatori di scandalo e di scisma |
III |
(bolgia 9) |
XXIX |
falsatori |
IV |
(bolgia 10) |
XXX |
falsatori |
IV–V |
|
XXXI |
giganti |
V–VI |
|
canti |
V ciclo |
stati |
cerchi |
XXXII |
Cocito: Caina, Antenora |
I (V snodo) |
IX |
XXXIII |
Antenora, Tolomea |
II |
|
XXXIV |
Giudecca |
III–IV–V |
|
XXXIV |
volgersi di Virgilio sull’anca di Lucifero |
VI |
|
Il sesto stato è per Olivi la fase più importante nella costruzione dell’edificio della Chiesa. In esso “renovabitur Christi lex et vita et crux”. Corrisponde ai tempi moderni. Ha quattro diversi inizi temporali: uno profetico, con Gioacchino da Fiore, il quale lo vide in spirito concependo la sua terza età; il secondo con la conversione di Francesco (1206), che seminò la pianta; il terzo con la predicazione degli uomini spirituali, per la quale la pianta si rinnovella; il quarto con la distruzione storica di Babylon. Dura fino alla sconfitta dell’Anticristo, il cui avvento si collocherebbe, secondo i numeri della profezia di Daniele 12, 11-12 combinati con Ap 12, 6 e 14, fra il 1290 e il giubileo di pace del 1335.
Una ‘vita nuova’ si instaura nel sesto stato, per eccellenza il momento dell’imitazione di Cristo. I rami dell’albero si dilatano producendo il frutto della carità, l’acqua che proviene da Cristo-fonte attraverso il condotto che percorre i primi cinque stati della Chiesa si effonde in un lago; è il tempo, assimilato al sacramento del matrimonio, della letizia nuziale, della familiarità, dell’amicizia. Corrisponde al sesto giorno della creazione, in cui vennero creati prima i rettili e le bestie irrazionali, poi l’uomo razionale che, come l’ordine evangelico, è fatto a immagine e somiglianza di Dio e domina tutti gli animali.
Le espressioni di Olivi relative al sesto stato – “quoddam sollempne initium novi seculi … renovaretur et consumaretur seculum”, nel quale il sacerdozio apostolico “redeat et assurgat ad ordinem primum”, la “nova Ierusalem”, interpretata come “visione di pace”, viene vista “descendere de celo” e la Chiesa descritta come la donna vestita di sole con la sua “virginea proles” – sono la veste spirituale dei versi della quarta egloga virgiliana che celebrano la rinnovata età dell’oro: “Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo / iam redit et Virgo; redeunt Saturnia regna; / Iam nova progenies caelo demittitur alto” (Egloga IV, 5-7). Olivi completa la Lectura super Apocalipsim nel 1298, poco prima di morire, il 14 marzo, a Narbonne. Quel felicissimo stato segnato dalla pace sotto il divo Augusto, che rese l’umanità disposta al primo avvento di Cristo, si sta rinnovando nel sesto stato della Chiesa, nel secondo avvento nello Spirito. Scrive Arsenio Frugoni: “[…] quell’escatologismo, oltre che ideologia di lotta e di riforma del gruppo spirituale, era anche un vero e proprio sentimento storico […] una tensione di rinnovamento, una ansia di salvezza, che nel 1300, l’anno centenario della Natività, aveva trovato come una attivazione, in un senso di pienezza dei tempi, cui doveva corrispondere un fatto, un accadere meraviglioso e nuovo” [3].
All’apertura del sesto sigillo, l’eletta schiera dei riformatori – i 144.000 segnati dalle dodici tribù d’Israele – guida la turba innumerevole di ogni gente, tribù, popolo e lingua (Ap 7, 3-4.13). Questi eletti e magnanimi duci, separati dalla volgare schiera per più alta milizia, vengono destinati a difendere liberamente la fede – ad essi è data la “plena libertas ad innovandam christianam religionem” -; sono gli amici di Dio a lui noti per nome, configurati in Cristo crocifisso e votati al martirio.
All’interno della Chiesa del sesto stato, l’Ordine dei Minori – “ordo plurium personarum” – è assimilabile alla persona umana di Cristo. Come questa si sviluppò fino all’età virile, così dovrà essere per l’ordo evangelicus piantato da Francesco, che avrà bisogno (a differenza di Cristo che stette poco tempo nel mondo) di due o tre generazioni per svilupparsi prima di subire una condanna simile a quella di Cristo [4]. La sua maturità coincide, verso il 1300, con il terzo inizio del sesto stato, cioè con il rinnovarsi per opera dello Spirito di Cristo, nel suo secondo avvento, della pianta seminata da Francesco. Questa concezione dell’Ordine francescano come individuo in sviluppo che, perfettamente maturato, diventa il novus ordo preconizzato da Gioacchino da Fiore per l’età dello Spirito, si differenzia da quella di Bonaventura, che aveva invece distinto i Francescani del proprio tempo – e quindi anche gli Spirituali – dall’Ordine finale che dominerà fino ai confini della terra. Alla terza apertura del sesto sigillo nuovi san Giovanni vengono inviati a predicare al mondo come nel tempo degli Apostoli. Ma Giovanni non designa solo un Ordine, perché Olivi lascia aperta la possibilità di rivelazioni individuali, avute da “singulares persone”, perfetti imitatori di Cristo votati, con la loro “lingua erudita”, al compito della conversione universale.
[LSA, cap. X, Ap 10, 11] “Et dixit michi: Oportet te iterum prophetare in gentibus et populis et linguis et regibus multis”. In ipsa sapientia libri expresse continetur quod oportet iterum predicari evangelium in toto orbe, et Iudeis et gentibus, et totum orbem finaliter converti ad Christum. Sed quod per istum hoc esset implendum non poterat sciri nisi per spiritualem revelationem, et hoc dico prout per Iohannem designantur hic singulares persone quia, prout per ipsum designatur in communi ordo evangelicus et contemplativus, scitur ex ipsa intelligentia libri quod per illum ordinem debet hoc impleri.
Nei cinque cicli settenari della prima cantica il sesto stato è segnato dall’apertura della porta della città di Dite (Inf. IX, 89-90); dall’ascesa di Gerione dall’abisso (Inf. XVI, 106-136); dal precipitoso passaggio dalla quinta alla sesta bolgia (Inf. XXIII, 1-57) e poi dalle trasformazioni della settima, dove i ladri fiorentini si mutano in serpenti e viceversa (Inf. XXIV-XXV); dal chinarsi di Anteo sul fondo dell’inferno (Inf. XXXI, 136-145); dal passaggio del centro della terra, con la conversione di Virgilio sull’anca di Lucifero, che è passaggio verso la sesta età, quella della Chiesa, descritta nel Purgatorio.
Ma i temi propri del sesto stato sono diffusi ovunque, intrecciati con quelli degli altri stati, e alla loro esegesi rinviano precise parole-chiave incardinate nel senso letterale dei versi. L’esegesi dell’angelo del sesto sigillo (Ap 7, 2) è già centrale nel primo canto del poema.
La novità che il sesto stato, per eccellenza stato di rinnovamento di questo secolo, arreca nell’inferno è una novità fittizia: l’apertura della porta della città di Dite non è vera novità, perché essa è stata chiusa dall’ostinazione dei diavoli, recidivi dopo l’apertura della porta dell’inferno da parte di Cristo prefigurata dalla venuta di Ercole all’Ade, per cui Cerbero “ne porta ancor pelato il mento e ’l gozzo”; Gerione viene su ad un “novo cenno” di Virgilio, ma è figura della frode dalla velenosa coda aculeata; il nuovo prodotto dalle trasformazioni reciproche di serpenti e uomini è qualcosa di incompiuto perché l’uomo razionale, creato nel sesto stato, regredisce allo stato precedente.
L’Inferno è il luogo della durezza lapidea, dell’impetrarsi, del parlare duro di cose dure a dirsi, del duro giudizio, del senso duro della scritta al sommo della porta, dei duri lamenti, dei duri demoni, dei duri veli del gelo, della gravezza. Nell’Inferno vige l’imposizione data a Daniele dall’angelo sotto il sesto sigillo dell’Antico Testamento: “Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro fino al tempo stabilito” (Dn 12, 4), che era la sesta età nella quale apparve Cristo e in particolare il sesto stato della sua Chiesa nella quale il libro doveva essere più pienamente aperto, non però ai malevoli e ai maldisposti. Questa durezza è rotta dall’invito di Dante ai dannati perché parlino. Far parlare liberamente, per dettato interiore, è la principale prerogativa del sesto stato – la nuova età che tanto s’aspetta, quella che ode del “dolce stil novo” e delle “nove rime” -, ed è tema che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo, anche nella vecchia roccia infernale. Appartiene alla sesta chiesa il parlare liberamente di Cristo – ad essa è dato l’“ostium apertum”, che è “ostium sermonis” – , il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà. Appartiene alla sesta chiesa anche il far venire quelli che si dicono Giudei senza esserlo, mutati nel cuore e disposti a farsi battezzare e governare. Questo far venire a parlare equivale al cortese e liberale invito dello Spirito di Cristo a convivare, a venire con desiderio e volontario consenso, con “disio” e con “velle”, in una pausa di pace nell’eterna dannazione. All’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono “dal voler portate” verso un momento di mutazione, sebbene limitata al successivo colloquio. Tutto l’Inferno è un contrappunto fra la durezza del giudizio e l’apertura per la parola dirompente, fin che essa dura, la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi per poi ricadere, sollevarsi da atti bestiali per ritornare a essi dopo aver parlato, come nel conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per sé stesse mosse, sta un solo desiderio, il vivere ancora nel libro che è stato altrui aperto.
Se nell’Inferno il sesto stato non si realizza mai compiutamente, anche il settimo, che gli è strettamente connesso, non può trovare un luogo autonomo. Ciò non toglie che temi del settimo stato (e della settima visione) siano ben presenti in modo diffuso. Ad esempio, quelli relativi alla settima chiesa assumono particolare rilievo nella descrizione degli ignavi a Inf. III. Tempo del silenzio, della serena pace, del riposo dalle ansiose fatiche, il settimo stato subentra dopo le terribili tentazioni inferte, con un martirio non corporale ma psicologico, dai carnefici dell’Anticristo nel sesto. Come ogni momento della storia umana partecipa dell’imitazione di Cristo, che raggiunge l’acme nel sesto stato, così in ogni periodo si verifica una sua “quietatio”, una pausa di pace, di quiete, di silenzio propria del settimo. Così Francesca parla e ascolta “mentre che ’l vento, come fa, ci tace”. Il vento – “la bufera infernal, che mai non resta” – designa il fluttuare tempestoso delle passioni nel cuore.
PURGATORIO
(sesta età del mondo)
Dopo le prime cinque età del mondo (corrispondenti all’Antico Testamento, la gioachimita età del Padre), che hanno segnato la discesa a spirale per i cinque cicli settenari dell’Inferno, con il Purgatorio inizia la sesta età, quella di Cristo (l’età del Figlio), che ha sette stati, corrispondenti ai sette stati della Chiesa. Dapprima, nel cosiddetto ‘antipurgatorio’, si registrano in successione temi prevalenti dei primi cinque stati. Il sesto stato della sesta età (con cui si apre l’età dello Spirito) inizia con l’apertura della porta di san Pietro (la porta del purgatorio). Questo sesto stato procede anch’esso con andamento settenario, per cui ha sette momenti, coincidenti principalmente con un girone della montagna, ma non del tutto, perché sempre l’ordine spirituale del poema rompe i confini letterali e le divisioni materiali, concatenando i temi di uno stato prevalente con quelli dello stato che precede e con quelli dello stato che segue e intrecciandoli con temi di tutti gli altri stati.
È spiegato nel Notabile VII del prologo della Lectura che il sesto stato della Chiesa è il secondo stato di Cristo e ha i suoi sette tempi per cui la Chiesa, come fosse una sfera, si ricongiunge circolarmente al primo apostolico tempo. Il settimo dei sette momenti del sesto stato della Chiesa coincide con il settimo stato generale della Chiesa, che nel poema corrisponde in parte all’ultimo girone della montagna (il settimo, dove si purgano i lussuriosi) e in parte all’Eden, con cui si chiude la seconda cantica.
Il Purgatorio dunque, secondo il senso spirituale, è la storia della Chiesa che corre verso il suo sesto stato, punto di riferimento di tutte le vicende umane, antiche e moderne, che ad esso cooperano. Non è casuale che nel sesto girone della montagna sia chiarificata e riconosciuta, nel colloquio con Bonagiunta da Lucca, la poetica delle “nove rime” di Dante, già “sesto tra cotanto senno” cooptato nella “bella scola” dei poeti del Limbo.
La vasta zona dedicata al sesto momento del sesto stato della Chiesa ha il suo inizio nel forte terremoto che scuote la montagna mentre Dante e Virgilio si trovano ancora nel quinto girone (Purg. XX, 124-141). Essa è stata compiutamente esaminata altrove.
Il settimo stato dell’Olivi si realizza parte in questa vita (come pregustazione in terra della gloria eterna, cioè fin sulla cima della montagna) e in parte nella futura (nel senso della quiete delle anime beate in attesa della resurrezione, che è la materia del Paradiso).
canti |
I ciclo – fino al sesto sato |
stati |
|
I |
Catone |
Radici, I |
|
II |
angelo nocchiero, Casella |
I – II |
|
III |
scomunicati |
III |
“Antipurgatorio” |
IV |
salita al primo balzo, Belacqua |
IV – V |
|
V |
negligenti morti per violenza |
V |
|
VI |
Sordello |
V |
|
VII-VIII |
valletta dei principi |
V |
|
IX |
apertura della porta |
VI – sesto stato |
|
canti |
II ciclo – il sesto stato della sesta età |
stati |
gironi |
X-XII |
superbi |
I |
I |
XIII-XIV-XV |
invidiosi |
II |
II |
XV-XVIII |
iracondiordinamento del purgatorio,amore e libero arbitrio |
III |
IIIIV |
XVIII-XIX |
accidiosi |
IV |
IV |
XIX-XX |
avari e prodighi |
V |
V |
XX (terremoto) -XXV |
Stazio, golosi, generazione dell’uomo |
VI |
VI |
XXV-XXVI |
lussuriosi |
VII – settimo stato |
VII |
XXVIIXXVIII-XXXIII |
muro di fuoconotte stellata, termine dell’ascesaEden |
|
PARADISO
(settimo stato della Chiesa)
Il Primo Mobile è il nono e penultimo cielo, ma è il sesto se si parte dal cielo del Sole. È anche il cielo più segnato dal tema del “punto”, cui è assimilato il sesto stato. Questo consente di ricostruire l’ordine spirituale del Paradiso ponendo la cerniera nel quarto cielo del Sole. Con il terzo cielo di Venere termina infatti il cono d’ombra gettato dalla terra, secondo la dottrina di Alfragano (Par. IX, 118-119), mentre prima di descrivere l’ascesa al cielo del Sole il poeta invita il lettore a rivolgersi “a l’alte rote” (Par. X, 7-27). Senza la cesura recisa che, nella prima cantica, divide i dannati puniti all’interno della città di Dite da quelli che ne stanno fuori e, nella seconda cantica, separa le anime purganti nei sette gironi della montagna dalle anime che attendono fuori della porta (il cosiddetto ‘antipurgatorio’), anche nel Paradiso gli spiriti che si manifestano nei primi tre cieli della Luna, di Mercurio e di Venere (spiriti che mancarono ai voti, spiriti che furono attivi per conseguire onore e fama, spiriti amanti) si distinguono per minore perfezione rispetto a quelli che appaiono nei cieli seguenti.
I dieci cieli del Paradiso si mostrano pertanto ordinati in due gruppi di settenari, corrispondenti agli stati della Chiesa (e alle loro prerogative) secondo Olivi, parzialmente combacianti (da 1 a 7 e da 4 a 10: coincidono gli ultimi quattro numeri del primo gruppo e i primi quattro del secondo).
I Se si considera il primo settenario, nel primo cielo della Luna si affronta la questione dell’inadempienza dei voti, che ha corrispondenza con i temi propri della prima chiesa di Efeso, il cui nome, se interpretato, oscilla tra la fervida volontà iniziale e la remissione (l’essenza del voto consiste nella volontà).
II Nel secondo cielo di Mercurio, le battaglie sostenute dal “sacrosanto segno” dell’aquila corrispondono allo stato dei martiri, che è dei combattenti, e anche la dottrina dell’incarnazione e della passione di Cristo, esposta successivamente da Beatrice, fa parte della tematica, perché l’intera Chiesa, fondata sulla passione di Cristo, imita con i martiri la sua croce, e questo giova assai al suo radicamento.
III Nel terzo cielo di Venere, Carlo Martello spiega al modo di un dottore del terzo stato la diversità delle indoli umane e come gli uomini, non assecondandole, errino; nello stesso cielo compare Folchetto di Marsiglia, che da vescovo di Tolosa combatté l’eresia albigese.
IV – I Al quarto cielo del Sole, primo del secondo gruppo di settenari per l’esaltazione della vita apostolica (propria del primo stato e rinnovata nel sesto), si può connettere il tema stesso del sole inteso nell’esegesi della quarta tromba (Ap 8, 12): “Per solem videtur hic designari solaris vita et contemplatio summorum anachoritarum, qui fuerunt patres et exempla aliorum, vel solaris sapientia et doctrina summorum doctorum”. Sapienza e contemplazione, dottori del terzo e anacoreti del quarto stato, concorrono, come Domenico e Francesco – “L’un fu tutto serafico in ardore; / l’altro per sapïenza in terra fue / di cherubica luce uno splendore” (Par. XI, 37-39) – con mutua cortesia a infiammare il meriggio dell’universo.
V – II Il quinto cielo di Marte, secondo (come il secondo stato dei martiri) per l’esaltazione della croce di Cristo formata dai lumi dei combattenti per la fede, reca in sé il tema del condiscendere proprio del quinto stato sia nel pio discendere per la croce di Cacciaguida verso Dante, sia nella decadenza degli “alti Fiorentini”, cioè delle antiche famiglie, assimilate agli anacoreti, un tempo alti e poi vòlti in basso.
VI – III Il sesto cielo di Giove, terzo (come il terzo stato dei dottori) per la spiegazione di profonde verità di fede, sviluppa il motivo, proprio della sesta chiesa, della “porta aperta”. Aprire la porta significa illuminare e rendere acuto l’intelletto che penetra nell’occulto delle Scritture, e anche dare efficacia spirituale a penetrare nel cuore di chi ascolta: così l’aquila apre la “latebra” di Dante, così l’occhio di Rifeo Troiano fu da Dio aperto alla futura redenzione.
VII – IV Nel settimo cielo di Saturno, quarto (come il quarto stato degli anacoreti), “si tace … la dolce sinfonia di paradiso” (Par. XXI, 58-60), e il tacere è tema del settimo stato. Ivi si mostrano gli spiriti contemplativi, principali soggetti del quarto stato, proprio degli anacoreti: se si conta a partire dal quarto cielo del Sole, considerando questo come primo ovvero come nuovo avvio del ciclo settenario, il cielo di Saturno è appunto quarto.
VIII (V) Il settimo cielo di Saturno è seguito dal cielo delle Stelle fisse – ottavo e quinto -, dove si mostrano le schiere del trionfo di Cristo che discendono dall’Empireo (il quinto stato è caratterizzato dalla “condescensio”) e si celebra il trionfo di Maria (sviluppo del tema, proprio della quinta chiesa, della mirabile bellezza della Chiesa, regina ornata di veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei doni e nelle grazie delle diverse membra). È inoltre ricapitolazione dei precedenti sette, secondo un’interpretazione più volte presente nella Lectura dell’essere ‘ottavo’. Per questo Dante, stando nel segno dei Gemelli, riguarda in giù e torna col viso per tutte quante le sette precedenti sfere (Par. XXII, 124-154).
IX (VI) Segue il Primo Mobile o Cristallino – nono e sesto cielo –, dove il poeta vede il punto luminosissimo – Dio – da cui dipende il cielo e la terra, circondato dai nove cerchi di fuoco (Par. XXVIII, 16-18, 40-42, 94-96). Il sesto stato, secondo quanto Olivi afferma nel Notabile VIII, è il “punto” da cui dipendono gli altri stati, perché appare nel testo dell’Apocalisse in modo più evidente degli altri, che da esso assumono chiarezza quanto alla loro manifestazione nella storia, come l’intelligenza delle cose ordinate ad un fine dipende dal fine.
X (VII) La quiete e l’immobilità dell’Empireo, decimo cielo – il “ciel de la divina pace” -, corrispondono al settimo stato, di cui è propria la “quietatio”, il silenzio (tema anticipato dal tacere di Beatrice in apertura del canto XXIX), e la pace.
Il Paradiso avrebbe pertanto un ordine spirituale del seguente tipo:
cielo |
stato |
cielo |
||
I |
LUNA |
I |
||
II |
MERCURIO |
II |
||
III |
VENERE |
III |
||
IV |
SOLE |
IV |
I |
SOLE |
V |
MARTE |
V |
II |
MARTE |
VI |
GIOVE |
VI |
III |
GIOVE |
VII |
SATURNO |
VII |
IV |
SATURNO |
VIII |
V |
STELLE FISSE |
||
IX |
VI |
PRIMO MOBILE |
||
X |
VII |
EMPIREO |
||
Oltre ai luoghi sopra indicati, i temi del sesto e del settimo stato si rinvengono in più punti, intrecciati con altri.
[1] Cfr. LSA, cap. XVII, Ap 17, 9: «Et subdit Ricardus quod per septem reges, et per septem capita designatos, designatur hic universus populus malorum, qui secundum septem status huius seculi determinantur. Primus scilicet ab Adam usque ad Noe. Secundus a Noe usque ad Abraam. Tertius ab Abraam usque ad Moysen. Quartus a Moys<e> usque ad David. Quintus a David usque ad Christum. Sextus a Christo usque ad Antichristum. Septimus autem sub Antichristo attribuitur». Cfr. PETRI IOHANNIS OLIVI Lectura super Lucam, Lc 1, 26, ed. F. Iozzelli, Grottaferrata 2010 (Collectio Oliviana, V), pp. 187-188: «Signanter autem dicitur in sexto mense, quia Christus uenit in sexta mundi etate, et iterum post quinque notabiles synagoge decursus: nam primo, cum sola circumcisione fuit sub patribus per quadringentos annos; secundo, accepta lege, fuit sub iudicibus per tantumdem temporis; tertio, proficiens in regnum, fuit sub regibus; quarto, assumpto plenius spiritu prophetico, fuit sub prophetis sollempnioribus, scilicet sub Elia, Ysaia et Yeremia etc.; quinto, restituto templo et urbe, fuit sub pontificibus quibus, per Aggeum et Zachariam et Malachiam iterata prophetia de Christo et eius precursore Elia, factum est silentium prophetarum, ita quod obmutuit cetus sacerdotum usque ad Iohannis ortum; et iterum in eiusdem quinti temporis sexto centenario conceptus est Christus. Sicut etiam sexto die factus est homo ad ymaginem Dei, sic conuenienter sub consimili senario factus est Christus homo, plenior Dei ymago: nam et perfectio numeri senarii, que ex omnibus partibus suis aliquotis et iterum ex ternario cum suis partibus, scilicet binario et unitate, consurgit, competit sibi et etiam reflexio ternarii per binarium, id est cultus fidei et Trinitatis per geminam caritatem».
[2] Il principio è chiaramente affermato nel notabile VIII del prologo della LSA: «[…] si omnia prima membra visionum ad invicem conferas et consimiliter omnia secunda et sic de aliis, aperte videbis omnia prima ad idem primum concorditer referri et consimiliter omnia secunda ad idem secundum et sic de aliis. Et hoc in tantum quod plena intelligentia eiusdem primi multum clarificatur ex mutua collatione omnium primorum, et idem est de omnibus secundis et tertiis et sic de aliis».
[3] ARSENIO FRUGONI, La Roma di Dante, tra il tempo e l’eterno, in ID., Pellegrini a Roma nel 1300. Cronache del primo Giubileo, presentazione di C. Frugoni, a cura e con Introduzione di F. Accrocca, Casale Monferrato 1999, pp. 102-103.
[4] LSA, cap. VI, Ap 6, 12: «Secunda ratio est quia persone Christi correspondet in sexta apertione unus ordo plurium personarum sic secundum suam proportionem augendus, sicut Christus secundum suum corpus fuit usque ad perfectam etatem viriliter auctus. […] Quarta est quia, prout super evangelia ostendi, Christus parvo tempore debuit inter nos vivere et pauciori predicare […]. Nisi autem ordo evangelicus, per Franciscum renovatus, esset in multis et saltem sub duabus vel tribus generationibus propagatus et sollempnizatus, non esset nec ipse nec populus ab eo ducendus sufficienter dispositus ad tam autenticam condempnationem condempnationi Christi consimilem subeundam».